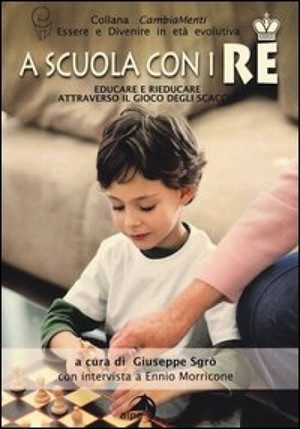Improving knowledge of mental health: The Role of Literacy
The bridge between research and practice: updates from Open Minds.
Improving knowledge of mental health and the Access to Mental Health Service: The Role of Literacy

Mental health literacy (MHL) is a term that refers to the ‘knowledge and beliefs about mental disorders which aid their recognition, management or prevention’
It is now well recognised that up to 70% of individuals with mental health disorders do not seek help (Farrer, Leach, Griffiths, Christensen, Jorm, 2008).
The advantages of early help seeking have been clearly articulated, with early help seeking providing the opportunity for early intervention and improved long-term outcomes for mental disorders.

One reason for this observation may in part lie in practical and financial constraints—actually having sufficient treatment resources available in the places where they are needed. This alone, however, does not explain the unchecked rates of mental disease. One recent and significant development in the study of mental health that has the potential to help explain and more importantly, alleviate the difficulty of ensuring people get appropriate help when they need it has been the field of mental health literacy.
Mental health literacy (MHL) is a term that refers to the ‘knowledge and beliefs about mental disorders which aid their recognition, management or prevention’ ( Jorm, Korten, & Jacomb, 1997).
MHL consists of different components, including:
- the ability to recognize specific mental disorders and the attitudes that promote this recognition;
- knowledge of psychological distress risk factors and self-help interventions;
- knowledge of how to seek mental health information and the available professional
MHL has been studied in many countries and the results have shown poor levels of mental disease recognition and beliefs about treatment that differ from those of health care professional.
In the first significant study of mental health literacy in Australia, Jorm, et al. (1997) presented over 2000 subjects with two case vignettes (one of a person with depression, and one with schizophrenia). Only 39% could correctly identify depression, while only 27% of subjects could correctly label schizophrenia. In the same study they also asked to subjects which could be the best solution for this kind of problem and the results show that only half of the respondents thought that a psychiatrist or psychologist would be helpful for the person in the depression vignette, a proportion less than that cited for GPs, counsellors, close friends, family, and telephone counselling. While psychiatrists and psychologists were rated as relatively more helpful for the person in the schizophrenia vignette, they were nevertheless less likely to be rated as helpful than counsellors or GPs. This suggests that public perceptions of mental health specialists need to be changed.
However more recent studies suggest that there are age and gender differences in Mental Health Literacy.
The survey company AC Nielsen conducted, in 2003-2004, a national clustered household survey of Australian adults reporting that the age differences occurred primarily between the oldest age group and all other ages. In particular, respondents in the oldest age group were less likely to correctly identify the mental illness described in the vignette, endorsed fewer sources of treatment as helpful, and were more likely to believe that schizophrenia was related to character weakness. Younger people have better mental health literacy concerning depression than schizophrenia. Although the 18– 24 years age group were superior at correctly identifying depression, they were less competent at correctly identifying schizophrenia, and were more likely to misdiagnose schizophrenia as depression. Younger people also tend to identify informal treatment sources as helpful, while the elderly rate fewer sources as helpful overall (Farrer, et al. 2008)
Mela, Tartani, Forsner, Edhborg, Forsell (2009) adapted the established vignettes developed by Jorm et al (1997) to evaluate the MHL in a group of adolescent. In fact among the many mental health problems, adolescent depression remains the most concerning for its link to suicide and because of the earlier age of onset (Rutter & Smith, 1995). The results show that only 42.7% of the respondents were able to identify depression and significantly fewer, 34.7%, were able to identify schizophrenia.
In this study, they also found that females, compared to males, were better at identifying depression in line with previous studies (Burn & Rapee, 2006) but with no gender differences in the schizophrenia vignette. Respondents in our study, who failed to recognize depression and schizophrenia, often misattributed the symptoms to stress, loneliness and a bad lifestyle. Only a minority of the respondents suggested help offered by health care professionals for managing depression (22.5%) or schizophrenia (32.6%).
The majority suggested non-standard forms of help, including social and physical activities, ways of entertain-ment, or lifestyle improvements. This fact could be important to implement Mental health awareness programms in schools that have been shown to be effective in changing young people’s opinions about mental health matters and help-seeking (Battaglia, Coverdale, & Bushong, 1990) and psychoeducation programms should be considered by the authorities as part of the mandatory school curriculum; this in order to increase levels of MHL among adolescents and prevent the development of stigmatizing attitudes towards mental illness (Melas et al, 2009).
LEGGI ANCHE:
- ENGLISH ARTICLES
- ARTICOLI SU: PSICOLOGIA E PSICHIATRIA PUBBLICHE
- ARTICOLI SU: STIGMA
REFERENCES:
- Battaglia, J., Coverdale, J. H., & Bushong, C. P. (1990). Evaluation of a mental illness awareness week program in public schools. The American Journal of Psychiatry, 147(3), 324–329.
- Farrer L, Leach L, Griffiths KM, Christensen H, Jorm AF (2008). Age differences in mental health literacy. BMC Public Health, 8:125.
- Jorm AF, Korten AE, Jacomb PA, Christensen H, Rodgers b, & Pollitt P. Mental health literacy: a survey of the public’s ability to recognize mental disorders and their beliefs about the effectiveness of the treatment (1997). Medical Journal of Australi, 166(4): 182.
- Kupfer DJ, Frank E, perel JM: The advantage of early treatment intervention in recurrent depression (1989) Archives of General Psychiatry, 46:771-775.
- Melas PA, Tartani E, Forsner T., Edhborg M., Forsell, Y (2013). Mental health literacy about depression and schizophrenia among adolescents in Sweden. European Psychiatric, http://dx.doi.org/10.1016/j.eurpsy.2013.02.002.
- Rutter, M., & Smith, D. J. (1995). Psychosocial disorders in young people: Time trends and their causes. London: Wiley.
A scuola con i Re: Educare e rieducare attraverso il gioco degli scacchi
Recensione del libro:
A scuola con i Re. Educare e rieducare attraverso il gioco degli scacchi
di Giuseppe Sgrò
LEGGI TUTTE LE RECENSIONI DI STATE OF MIND
Il gioco degli scacchi può migliorare la concentrazione, la pazienza e la perseveranza e può svilupparne il senso di creatività, l’intuito e la memoria oltre alle capacità analitiche e decisionali; Gli scacchi insegnano inoltre determinazione, motivazione e spirito sportivo
“Scacco matto!”. Quante volte abbiamo sentito esclamare questa espressione, o l’abbiamo usata noi stessi, magari davanti ad una scacchiera oppure come metafora all’interno di un discorso? Probabilmente molte, ma poche volte ci siamo forse fermati a riflettere sul valore che gli scacchi possono avere nella formazione e nell’educazione dei ragazzi, specialmente all’interno del contesto scolastico.
LEGGI ANCHE ARTICOLI SU: BAMBINI
Recentemente, in una direttiva, il Parlamento Europeo ha posto l’accento sul valore socio psico educativo di questo gioco/sport. Riprendendo diversi studi e ricerche nel campo, infatti, l’Unione Europea ha invitato gli stati membri ad introdurre il gioco degli scacchi nei sistemi di istruzione e nei piani formativi a partire dal 2012.
Nella direttiva si legge che: “[…] Il gioco degli scacchi è accessibile ai ragazzi di ogni gruppo sociale, può contribuire alla coesione sociale e a conseguire obiettivi strategici quali l’integrazione sociale, la lotta contro la discriminazione, la riduzione del tasso di criminalità e persino la lotta contro diverse dipendenze. […] Indipendentemente dall’età dei ragazzi, il gioco degli scacchi può migliorarne la concentrazione, la pazienza e la perseveranza e può svilupparne il senso di creatività, l’intuito e la memoria oltre alle capacità analitiche e decisionali; considerando che gli scacchi insegnano inoltre determinazione, motivazione e spirito sportivo”.
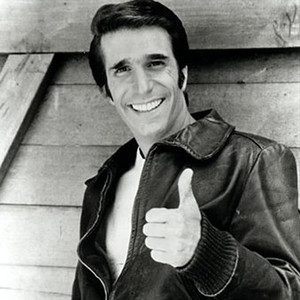
Da queste considerazioni e da un lungo lavoro di ricerca clinica, nasce il manuale “A scuola con i Re. Educare e rieducare attraverso il gioco degli scacchi”, a cura di Giuseppe Sgrò, psicologo clinico ed esperto in psicologia dello sport del CONI.
LEGGI ANCHE ARTICOLI SU: PSICOLOGIA DELLO SPORT
Il volume presenta un’offerta integrata, modulare e flessibile di tutte le attività educative, rieducative e formative in contesto scacchistico e propone contributi di personaggi autorevoli in diversi campi, da quello della ricerca clinica a quello sportivo.
Il volume, infatti, può essere consultato nella sua completezza, che prende le mosse da un monumentale lavoro di meta analisi di tutte le ricerche condotte, ad oggi, sul gioco degli scacchi. Oppure può essere consultato per i moduli, autoconclusivi, che consentono di declinare il modello scacchistico nei più svariati ambiti: preventivo, scolastico, di ricerca, ma anche di formazione aziendale.
L’obiettivo, come sottolinea il dott. Sgrò nel manuale e nella presentazione dello stesso, è di utilizzare gli scacchi come strumento educativo, in particolare ma non solo nel contesto scolastico in ottica supportiva e preventiva, senza puntare all’insegnamento del gioco in sé.
Il progetto può essere impiegato in ogni grado della scuola, adattandosi facilmente alle diverse esigenze di sviluppo ed utilizzando strumenti vicini alle capacità tipiche di ogni fascia di età.
Esperienze di gioco-sport, narrazione, psicomotricità su scacchiera gigante da pavimento, oltre che da tavolo, sono solo alcune delle possibili declinazioni degli scacchi come strumento psico-educativo, che va a potenziare la meta cognizione e a prevenire il disagio, attraverso la trasmissione di concetti fondamentali quali limite, responsabilità e rispetto, specialmente a livello non verbale, fondamentali per l’espressione e la modulazione dell’aggressività già dall’infanzia [Sgrò, 2012].
Come sostiene il dott. Sgrò nella prefazione del manuale: “Il gioco/sport, e in particolar modo il gioco degli scacchi, favorisce, a livello etico e sociale, l’acquisizione, soprattutto sul piano della comunicazione non verbale, di alcuni concetti fondamentali alla convivenza civile, quali la regola, la responsabilità e il limite, che permettono sia al bambino che all’adulto di incanalare e modulare l’aggressività e la competitività, che connotano ogni percorso di crescita, in forme socialmente accettabili, favorendo l’instaurarsi di relazioni sociali positive e/o nuovi inizi e negoziazioni di esse”.
LEGGI ANCHE ARTICOLI SU: VOCE E COMUNICAZIONE PARAVERBALE
In una società in cui proprio la mancanza di limite e incapacità di gestione dell’aggressività sembrano connotare le relazioni umane, così come il vissuto personale, mi sembra utile pensare ad uno strumento declinabile nei più differenti contesti e avvicinabile a tutte le diverse fasce di età.
Il lavoro del dott. Sgrò prende le mosse sia da una lunga attività di ricerca clinica sul gioco degli scacchi, sia dal lavoro condotto dalla UONPIA della ASL Roma H/4 Pomezia e dal gruppo di ricerca ad essa afferente EllePi, coordinato dal dott. Miletto, neuropsichiatra infantile.
Il gruppo di ricerca, sin dagli anni ’90, ha realizzato esperienze psicoeducative in svariati ambiti sperimentali, utilizzando, in particolare, la scacchiera gigante come spazio di mediazione educativa, nell’ambito di una didattica interdisciplinare.
Il Manuale “A scuola con i Re” è diviso in due sezioni: la prima riguarda i Fondamenti teorico-scientifici e si compone di nove capitoli, mentre la seconda riguarda Progetti, esperienze e ricerche e si compone di diciassette capitoli. Si pone come un punto di riferimento a cavallo tra la ricerca teorica e l’applicazione pratica di uno strumento che a volte può essere considerato – nell’immaginario collettivo – “solo” un gioco da cervelloni, ma che in realtà, in Italia, rappresenta una realtà sempre in crescita.
Si stima, infatti, che in Italia i tesserati della Federazione (FSI) siano circa 14.000, numero al quale vanno ad aggiungersi i giocatori amatoriali.
La disciplina degli scacchi, che per concentrazione e attivazione fisica può essere considerata un vero e proprio sport, contribuisce allo sviluppo delle facoltà logico-razionali, intuitive e di fantasia. I giocatori, infatti, sono chiamati a misurarsi con le proprie capacità e i propri limiti, non tanto sul piano fisico, quanto più su quello intellettivo, nell’ambito del rigore scientifico, del metodo e del calcolo.
Gli scacchi sembrano coniugarsi molto bene con l’attività scolastica: non richiedono l’utilizzo di spazi particolarmente attrezzati; possono essere praticati anche da alunni diversamente abili (ipovedenti e/o ipoacusici); assicurano una validità educativa perfino nelle situazioni di degrado sociale e di recupero di giovani pre-devianti come efficace mezzo per la lotta alla dispersione scolastica.
Chi pratica questa disciplina, infatti, acquisisce una più profonda capacità di concentrazione e potenzia senza sforzo le caratteristiche elaborative del cervello, con notevoli effetti benefici anche in altri campi (organizzazione del proprio lavoro e apprendimento delle materie scolastiche).

Il gioco degli Scacchi, quindi, agisce positivamente su diverse capacità meta cognitive [Sgrò, 2012]: Attenzione, Immaginazione e previsione, Memorizzazione, Creatività, Logica matematica, Pianificazione.
Il tutto inserito in una cornice di regole e di rispetto per l’avversario, per le sue tempistiche e le sue mosse, che consentono di sviluppare anche abilità di negoziazione, di controllo dell’ impulsività e di gestione del conflitto.
Il messaggio del manuale redatto dal dott. Sgrò e dai suoi collaboratori è molto chiaro: non è necessario e non serve diventare campioni di scacchi per trarre beneficio dalla cornice di un gioco di tradizione millenaria, che consente di sedersi e di astrarsi dai propri problemi quotidiani ma che, al contempo, consente di apprendere capacità che saranno utili per affrontarli. E’ importante, invece, in ottica preventiva, cominciare a prendere in considerazione un’intersecazione tra il gioco inteso come momento ludico-istruttivo e la scuola, ambiente da sempre deputato alla formazione psico-sociale dell’individuo.
LEGGI:
BAMBINI – PSICOLOGIA DELLO SPORT – LETTERATURA
LEGGI TUTTE LE RECENSIONI DI STATE OF MIND
BIBLIOGRAFIA:
- Martinengo L, Sgrò G. (2010), Intensità e direzione dell’ansia competitiva in un gruppo di giocatori di scacchi. GIPS- Il Giornale Italiano di psicologia dello Sport, 7 Gen/Apr. 2010: 3-10. (DOWNLOAD)
- Miletto R., Pompa A., Fucci M. R., Morrone F. (2005), I bambini e gli scacchi. Armando Editore, Roma.
- Miletto R. (a cura di, 2010), Per una scuola amica. Curricoli speciali per potenziare la mente. Alpes Italia, Roma.
- Sgrò G. (a cura di, 2012), A scuola con i Re. Educare e rieducare attraverso il gioco degli scacchi. Alpes Italia, Roma.
- http://www.giocandoconire.it
- Tribuiani R. (2006), Il Massimo rendimento negli scacchi e in altri sport della mente. Prisma Editori, Roma.
Alcool in adolescenza: il ruolo predittivo dei fattori temperamentali

Una nuova ricerca messa a punto dal team di Danielle Dick (Virginia Commonwealth University) ha mostrato alla comunità scientifica il ruolo predittivo dei fattori temperamentali nello spiegare problemi legati all’abuso di alcool in adolescenza.
LEGGI ANCHE ARTICOLI SU: BAMBINI & ADOLESCENTI
Dick e colleghi hanno indagato un ambito poco approfondito dalle ricerche passate, ovvero quello relativo ai fattori di personalità che già durante l’infanzia contribuiscono allo sviluppo di disturbi legati all’abuso di alcool. Il panorama scientifico di riferimento concerne perlopiù lo studio su soggetti in età adolescenziale.
LEGGI ANCHE ARTICOLI SU: ALCOOL
Questa ricerca, invece, mira ad esplorare le differenze di personalità in soggetti tra i sei mesi e i 5 anni d’età. Il periodo adolescenziale rappresenta un momento critico durante il quale si sviluppano problematiche legate all’abuso di alcool, in quanto è storicamente un periodo di rilevanti scoperte e cambiamenti.

Valutare, però, i fattori predittivi a partire dall’adolescenza rischia di oscurare il ruolo delle precoci esperienze del soggetto, esperienze di fondamentale importanza per definire le differenze di personalità. I soggetti sperimentali provengono da un campione della Avon Longitudinal Study of Parents and Children (ALSPAC), un vasto campione epidemiologico di donne gravide con termine di gravidanza compreso tra l’Aprile 1991 e il Dicembre 1992.Le caratteristiche temperamentali del campione, mediamente diviso tra maschi e femmine, furono identificate attraverso 6 valutazioni, effettuate tra i 6 ed i 69 mesi d’età. I problemi legati all’abuso alcoolico furono invece valutati a 15 anni.
LEGGI ANCHE ARTICOLI SU: DIPENDENZE
I risultati identificarono i diversi stili temperamentali, che emergono prima dei 5 anni, in grado di predire problemi di abuso. Queste caratteristiche temperamentali precoci risultano piuttosto diversificate, evidenziando come sia soggetti con consistenti problemi emotivi e comportamentali sia quelli con un buon livello di socievolezza erano a rischio rispetto a storie di abuso di alcool.
LEGGI ANCHE ARTICOLI SU: PERSONALITA’ – TRATTI DI PERSONALITA’
Questi dati mostrano quanto sia variegato l’insieme dei fattori implicati nello sviluppo di problemi di questa entità. L’elemento interessante è rappresentato dalla scelta di indagare gli aspetti temperamentali precoci, rispetto ai fattori di personalità, che si sviluppano invece nel corso della crescita dell’individuo.
Inoltre, il risultato per cui gli aspetti di socievolezza siano correlati all’abuso di alcool in adolescenza rimanda alla questione relativa agli aspetti più “sociali” del consumo di alcool tra giovani. Il gruppo di ricerca pone allora l’accento sulla necessità di approfondire e riconoscere quei fattori precoci che possono predire il fenomeno dilagante dell’eccessivo consumo di alcoolici in età adolescenziale, con l’obiettivo di poter identificare i soggetti a rischio già nelle prime fasi dello sviluppo.
LEGGI:
BAMBINI & ADOLESCENTI – PERSONALITA’ – TRATTI DI PERSONALITA’ – DIPENDENZE – ALCOOL
BIBLIOGRAFIA:
- Dick, D. M., Aliev, F., Latendresse, S. J., Hickman, M., Heron, J., Macleod, J., Joinson, C., Maughan, B., Lewis, G., & Kendler, K. S. (2013). Adolescent Alcohol Use is Predicted by Childhood Temperament Factors Before Age 5, with Mediation Through Personality and Peers. Alcoholism: Clinical and Experimental Research, 2013; DOI: 10.1111/acer.12206.
Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” Istituto Di Ricovero E Cura cerca Bando Concorso Psicologo – BARI
La Redazione di State of Mind segnala questo bando pubblico:
ATTENZIONE! SCADENZA BANDO 26 LUGLIO 2013
Bando Concorso per Psicologi – BARI – Istituto di Ricovero e Cura Tumori “Giovanni Paolo II”Consigliato dalla Redazione
Per continuare la lettura sarete reindirizzati all’articolo originale … Continua >>



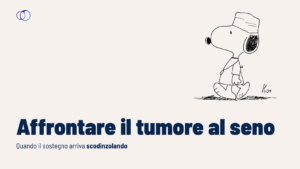


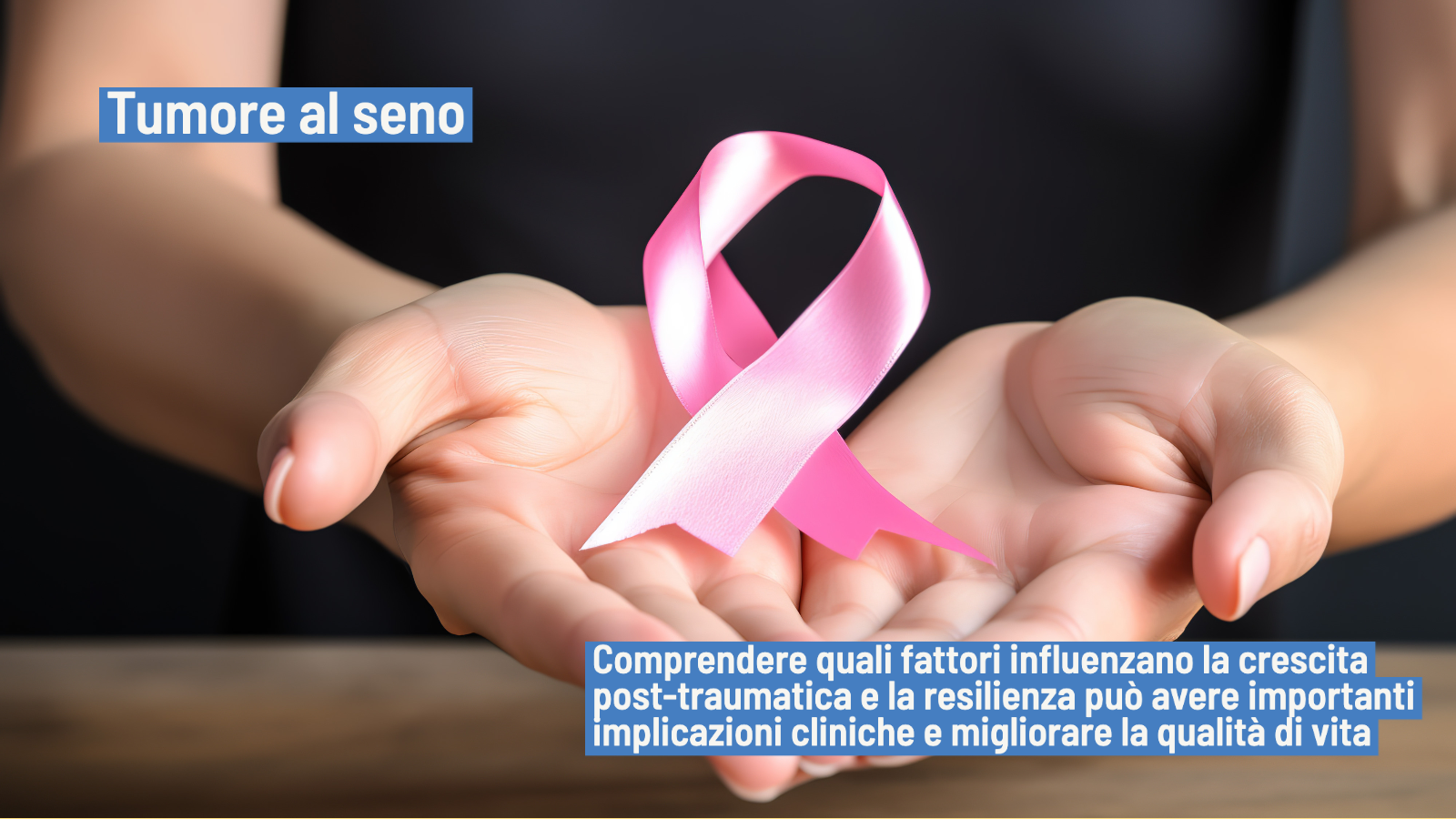
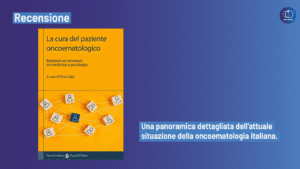



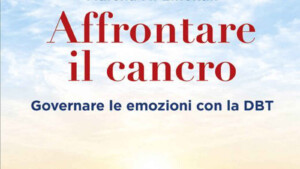



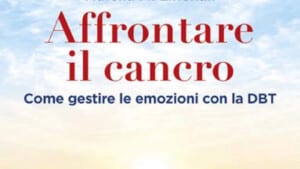




Terapia cognitivo-comportamentale con le coppie e le famiglie – RECENSIONE
RECENSIONE DEL LIBRO
Terapia cognitivo-comportamentale con le coppie e le famiglie
di Frank M. Dattilio
LEGGI TUTTE LE RECENSIONI DI STATE OF MIND
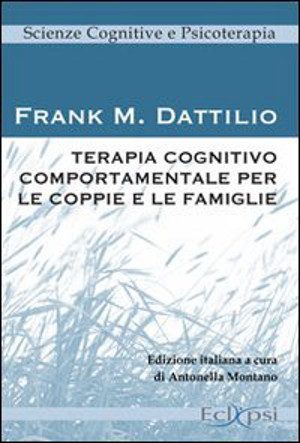 Terapia cognitivo-comportamentale con le coppie e le famiglie di Frank M. Dattilio è curato, nell’edizione italiana, dalla dottoressa Montano, direttrice dell’Istituto Beck.
Terapia cognitivo-comportamentale con le coppie e le famiglie di Frank M. Dattilio è curato, nell’edizione italiana, dalla dottoressa Montano, direttrice dell’Istituto Beck.
LEGGI ANCHE ARTICOLI SU: PSICOTERAPIA COGNITIVA
LEGGI ANCHE ARTICOLI SU: FAMIGLIA
In questo testo l’autore si propone di fornire agli psicoterapeuti, che si trovano a lavorare con le coppie o a dover gestire all’interno di un percorso di terapia individuale temi legati alla crisi di coppia, una serie di tecniche in origine utilizzate nella terapia cognitivo-comportamentale e adattate al percorso di coppia.
LEGGI ANCHE ARTICOLI SU: TERAPIA DI COPPIA
Il manuale, integrando la CBT con i concetti chiave delle teorie neurobiologiche, sistemicho-relazionali, dell’attaccamento e della regolazione emozionale, guida passo per passo il terapeuta nel percorso con la coppia e la famiglia, facendo uso di molti esempi clinici, a cui è dedicato anche il capitolo finale del libro.
LEGGI ANCHE ARTICOLI SU: PSICOTERAPIA SISTEMICO – RELAZIONALE
Per chi abbia una formazione sistemica relazionale e conosca la letteratura sul lavoro con coppie e famiglie la sensazione è quella che il lavoro con la coppia descritto in questo volume sia in parte sovrapponibile a quello di un terapeuta sistemico relazionale. La ricostruzione dei propri modelli di relazione all’interno della famiglia di origine e della storia di attaccamento e di come questi impattino sul problema attuale della coppia è però solo una parte del lavoro, che si concentra poi, con modalità tipiche della CBT, sull’identificazione e la ristrutturazione di schemi, distorsioni cognitive e pensieri automatici che danno vita alle dinamiche relazionali problematiche per la coppia e la famiglia, con l’obiettivo di modificare le aspettative irrealistiche che ciascuno ha nei confronti degli altro/altri, correggere le interpretazioni errate che impediscono una corretta e funzionale comunicazione, diminuire le interazioni distruttive.
Per usare termini cari alla terapia cognitivo-comportamentale gli schemi (Beck et al. 1979), che le persone utilizzano come modelli sui quali elaborare le informazioni relative alle esperienze di vita, hanno anche una componente “familiare”, cioè rivelano come le persone all’interno della famiglia di origine hanno percepito le ripetute interazioni familiari nel corso degli anni.
Gli schemi familiari, credenze condivise sulla maggior parte degli eventi che accadono in famiglia, danno vita a gran parte delle interazioni familiari quotidiane, infatti le componenti cognitive, emotive e comportamentali degli schemi familiari di ciascuno sono in grado di elicitare risposte, spesso prevedibili, negli altri membri della famiglia.
LEGGI ANCHE ARTICOLI SU: CREDENZE – BELIEFS
Gli schemi familiari, insieme a quelli sulla relazione di attaccamento con le figure significative dell’infanzia, fungono da modello di interpretazione e previsione delle realtà relazionali successive, influenzando la vita di coppia e le relazioni coni figli e stanno alla base di molte delle distorsioni nella percezione dell’altro.

Gli schemi hanno anche una componente intergenerazionale, cioè si tramandano attraverso le generazioni con meccanismi di proiezione familiare boweniani, ben esplorati dal modello sistemico-relazionale. Gli schemi individuali e quelli familiari, centrali nei conflitto/disagio di coppia e familiare devono essere affrontati nelle fasi iniziali del trattamento, già nella fase di assestment. L’autore indica anche uno strumento ad hoc che guida il terapeuta in questa indagine, il Family of Origin Inventory di Richard Stuart.
LEGGI ANCHE ARTICOLI SU: IN TERAPIA
Il piano generale di trattamento prevede di aiutare la coppia a prendere consapevolezza di come il passato relazionale di ciascuno influenzi il presente – con l’assunzione di ruoli e lo strutturarsi di credenze e schemi cognitivi disfunzionali – distorcendo la percezione che si ha dell’altro e influenzando la comunicazione disfunzionale in coppia.
LEGGI ANCHE ARTICOLI SU: LINGUAGGIO – COMUNICAZIONE
Il passo successivo è aiutare i membri della coppia a prendere distanza dalle proprie credenze e ristrutturare i propri schemi; favorendo al contempo una ricontrattazione della relazione che comprenda una certa dose di accettazione dell’altro.
LEGGI ANCHE ARTICOLI SU: ACCETTAZIONE
Un capitolo è dedicato all’assessment in cui sono elencati, oltre all’uso del genogramma familiare, molti questionari utili a raccogliere informazioni sul funzionamento generale della coppia e della famiglia e che possono servire da traccia per l’approfondimento, nei colloqui successivi, di alcuni temi e dinamiche interpersonali salienti.
LEGGI ANCHE ARTICOLI SU: RAPPORTI INTERPERSONALI
Inoltre molte sottoscale forniscono un profilo nelle aree di forza e in quelle di debolezza all’interno delle relazioni. Nonostante la parte più consistente della valutazione avvenga all’inizio, la concettualizzazione del caso procede per il corso dell’intero trattamento. Nella parte del volume dedicata all’assesment vengono anche date indicazioni su alcune situazioni e alcuni elementi del sistema cui è necessario, fin dalla fase di valutazione iniziale, porre particolare attenzione: la richiesta di mantenere informazioni riservate, la presenza di segreti familiari, l’analisi dei confini, i meccanismi di triangolazione, l’assunzione di ruoli rigidi, la distribuzione del potere e del controllo all’interno della coppia o della famiglia.
L’osservazione diretta delle interazioni di coppia e familiari da parte del terapeuta è un elemento molto importante, perchè permette al terapeuta di cogliere il non verbale della comunicazione e di identificare i pattern di comunicazione più significativi che contribuiscono a mantenere il problema relazionale. Particolare attenzione viene data alle azioni costruttive e collaborative e a quelle distruttive, oppositive e manipolative. Una tecnica usata per osservare un interazione familiare strutturata è quella del problem solving familiare, che permette al terapeuta di osservare direttamente, ed eventualmente di intervenire, sulle difficoltà di comunicazione della coppia o della famiglia.
La motivazione al cambiamento è un altro degli elementi che deve essere testato fin dall’inizio del percorso, a questo scopo vengono assegnati dei compiti da svolgere a casa (homework): lo svolgimento di questi compiti è un buon indicatore della volontà dei pazienti di impegnarsi; inoltre il come questi compiti vengono svolti fornisce ulteriori informazioni sulle dinamiche di coppia e familiari.
Molta attenzione viene data alla comprensione di come i propri schemi, le distorsioni cognitive, le attribuzioni e le doverizzazioni influenzino i pensieri automatici.
LEGGI ANCHE ARTICOLI SU: DOVERIZZAZIONI
L’identificazione dei pensieri automatici e delle risposte emozionali e comportamentali, che fanno da sfondo ai temi relazionali problematici che la coppia porta in terapia, è uno dei passaggi fondamentali del protocollo di coppia del manuale; uno strumento ad hoc per usato per familiarizzare con questa pratica è il Dysfunctional Tought Record, una scheda di registrazione dei pensieri disfunzionali.
LEGGI ANCHE ARTICOLI SU: AMORE – RELAZIONI SENTIMENTALI
Questo lavoro, che viene svolto sia in seduta che a casa, ha lo scopo di aumentare la consapevolezza di come le reciproche risposte emotive e comportamentali negative possano essere controllate, grazie all’identificazione dei pattern di pensieri che le elicitano. Ciascuno, insomma, dovrà assumersi maggiore responsabilità in merito alle proprie reazioni emotive e comportamenali nei confronti del partner. Segue il processo di disputing e ristrutturazione dei pensieri automatici grazie al quale la coppia inizia a mettere a fuoco le distorsioni nel proprio ragionamento e viene incoraggiata a considerare gli eventi relazionali da una prospettiva differente.
LEGGI ANCHE ARTICOLI SU: DISPUTING E RISTRUTTURAZIONE COGNITIVA
Un ampia parte del volume è dedicata alle tecniche cognitivo comportamentali: oltre agli immancabili homework – che vanno dall’identificazione dei pensieri automatici, all’automonitoraggio degli stati interni tra una seduta e l’altra, alla programmazione di attività congiunte, alla lettura di testi specifici, fino videoregistrazione delle interazioni casalinghe – vale la pena citare il training di comunicazione, in cui i partners imparano ad esprimere pensieri ed emozioni e ad ascoltarsi reciprocamente, empatizzando e validando ciò che l’altro sente; questa tecnica aiuta a ridurre le distorsioni cognitive e a modulare l’espressione delle emozioni, migliorando le interazioni comportamentali problematiche; il problem solving congiunto; i contratti di scambio dei comportamenti
desiderati, in cui ciascuno viene incoraggiato a farsi avanti nei confronti degli altri; il training di assertività, in cui la coppia impara a riconoscere la differenza tra risposte assertive, passive e aggressive e come l’assertività favorisca interazioni più sane; gli interventi paradossali, generalmente efficaci nei casi di stallo e maggiore gravità e da usare solo dopo che il paziente ha appreso e utilizzato con successo le abilità di comunicazione e problem solving; l’inversione di ruolo, in cui, per facilitare il decentramento di ciascun membro della famiglia, ciascuno è incoraggiato, in un role playng, ad assumere la prospettiva dell’altro.
La parte finale del volume è dedicata a come affrontare i più comuni ostacoli terapeutici e situazioni particolari come il divorzio, la coppia omosessuale, le violenze domestiche, l’uso di sostanze, le relazioni extraconiugali.
LEGGI ANCHE:
PSICOTERAPIA COGNITIVA – FAMIGLIA – TERAPIA DI COPPIA – PSICOTERAPIA SISTEMICO – RELAZIONALE
AMORE – RELAZIONI SENTIMENTALI – DOVERIZZAZIONI – IN TERAPIA – ACCETTAZIONE – DISPUTING E RISTRUTTURAZIONE COGNITIVA – RAPPORTI INTERPERSONALI
BIBLIOGRAFIA:
- D’Attilio F. M. (2013) Terapia cognitivo-comportamentale con le coppie e le famiglie, Eclipsi
Why do people not access mental health services? The role of Public Stigma and Self-Stigma.
The bridge between research and practice: updates from Open Minds.
Why do people not access mental health services?
The role of Public Stigma and Self-Stigma

Although each year approaching 30% of the population worldwide has some form of mental illness, at least two thirds receive no treatment. This under-treatment occurs even in countries with the best resources, while the proportions of people with mental illness who are treated in low and medium resource countries (LAMIC) are far less (Wang et al., 2007).
Two factors which contribute towards this degree of neglect are the reluctance of many people to seek help for mental illness related problems because of their anticipation of stigma should they be diagnosed, and the reluctance of many people who do have a diagnosis of mental illness to advocate for better mental health care for fear of shame and rejection if they disclose their condition (Kohn et al., 2004a).
Stigma is believed to be one of the major barriers to seeking treatment, because both possession of a psychological diagnosis and the act of seeking treatment appear to be stigmatizing.
Stigma is related to treatment avoidance in at least two ways: First, people wish to avoid possibly being publically identified and labeled as “mentally ill” by seeking mental health counseling. Second, by seeking treatment people implicitly accept the label of “someone who needs psychological help” which can threaten self-esteem.
Public stigma may be defined as the typical societal response that people have to stigmatizing attributes, and self-stigma represents the internalized psychological impact of public stigma. Through self-stigmatization, people can experience losses in self-esteem and self-efficacy. Though common, such losses are not the automatic consequences of possessing a stigmatizing characteristic. Awareness and endorsement of public stigma as well as application to the self are thought to be necessary to generate self-stigma and the emotions of shame, fear, embarrassment, and alienation are central to self-stigma.
In which way it can be assumed that self-stigma and public stigma would influence attitudes toward help-seeking?
In a study from Bathje & Pryor (2011) self-stigma was found to fully mediate the relationship between awareness of public stigma and attitudes toward help-seeking and partially mediate the relationship between the most prominent component of endorsement of public stigma (sympathy) and attitudes toward help-seeking. Thus, simply being aware that mental illness is stigmatizing does not directly impact attitudes toward help-seeking. Instead, it appears that it is the internalization of stigmatizing beliefs and the resulting harm to self-esteem (self-stigma) that leads an individual to have negative attitudes toward help-seeking.
Self-stigma only partially mediated the relationship between endorsement of public stigma and attitudes toward help-seeking, meaning that both the sympathy and controllability components of endorsement directly influence attitudes.
Finally, attitudes toward help-seeking were found to fully mediate the relationship between self-stigma and intentions to seek counseling when mental health concerns are experienced.
LEGGI ANCHE:
- ENGLISH ARTICLES
- ARTICOLI SU: PSICOLOGIA E PSICHIATRIA PUBBLICHE
- ARTICOLI SU: STIGMA
REFERENCES
- Bathje, G. J., & Pryor, J. B. (2011). The relationships of public and self-stigma to seeking mental health services. Journal of Mental Health Counseling, 33(2), 161-176.
- Kohn R., Saxena S., Levav I. & Saraceno B. (2004a). Treatment gap in mental health care. Bulletin of the World Health Organization 82, 858-866.
- Wang P.S., Guilar-Gaxiola S., Alonso J., Angermeyer M.C., Borges G., Bromet E.J., Bruffaerts R., de Girolamo G., de Graaf R., Gureje O., Haro J.M., Karam E.G., Kessler R.C., Kovess V., Lane M.C., Lee S., Levinson D., Ono Y., Petukhova M., Posada-Villa,J., Seedat S. & Wells J.E. (2007). Use of mental health services for anxiety, mood, and substance disorders in 17 countries in the WHO world mental health surveys. Lancet 370(9590):841-850.
Invecchiamento Cerebrale – Una mente allenata oggi è una mente più attiva domani
Di Francesca Fregno
Il fenomeno dell’invecchiamento cerebrale è naturale e fisiologico ma è confermato che tenere allenata la mente riduce l’invecchiamento e potenzia la memoria.
LEGGI ANCHE ARTICOLI SU: TERZA ETA’
Con l’avanzare dell’età le strutture dell’organismo si indeboliscono gradualmente con la conseguenza che le capacità funzionali diminuiscono. Uno dei primi sintomi dell’invecchiamento è la perdita della memoria a breve termine. Si possono dimenticare parole o nomi di persone che prima ci risultavano più semplici diventano più difficoltose.
LEGGI ANCHE ARTICOLI SU: MEMORIA
Il fenomeno dell’invecchiamento cerebrale è naturale e fisiologico ma è confermato che tenere allenata la mente riduce l’invecchiamento e potenzia la memoria, “prendere parte ad attività di questo tipo durante tutta la vita di una persona, dall’infanzia alla vecchiaia, è importante per la salute del cervello in età avanzata”, ha dichiarato l’autore dello studio Robert S. Wilson, del Rush University Medical Center di Chicago.

Una nuova ricerca suggerisce che possiamo rallentare questo procedimento tenendo in allenamento costante il cervello tramite la lettura di libri, la scrittura e la partecipazione alle attività che stimolano il cervello a qualsiasi età, può preservare la memoria. Lo studio è stato pubblicato il recentemente sulla rivista on line Neurology ®, la rivista medica dell’American Academy of Neurology.
Per lo studio, 294 persone sono state sottoposte a test che misuravano la memoria e il pensiero, ogni anno per circa sei anni prima della loro morte a un’età media di 89 anni. Queste persone inoltre, hanno risposto a un questionario per verificare se hanno letto libri, si sono dedicati alla scrittura o hanno partecipato ad altre attività mentalmente stimolanti durante l’infanzia, l’adolescenza, la mezza età ed alla loro età attuale.
Dopo la morte, i loro cervelli sono stati esaminati con l’autopsia per la prova dei segni fisici di demenza, quali lesioni, placche cerebrali e grovigli.
LEGGI ANCHE ARTICOLI SU: DEMENZA
La ricerca ha scoperto che le persone che hanno partecipato alle attività mentalmente stimolanti sia durante la vecchiaia che nel corso della vita, avevano un ritmo più lento di declino della memoria rispetto a coloro che non avevano partecipato a tali attività nel corso della loro vita, dopo aggiustamento per diversi livelli di placche e grovigli nel cervello. L’attività mentale rappresenta quasi il 15 per cento della differenza nel declino, al di là di ciò che viene specificato da placche e grovigli nel cervello.
LEGGI ANCHE ARTICOLI SU: NEUROPSICOLOGIA
Sulla base di questi risultati, non dobbiamo sottovalutare gli effetti delle attività di tutti i giorni, come la lettura e la scrittura, per i nostri figli, noi stessi ed i nostri genitori o nonni sottolineano i ricercatori.
Lo studio ha rilevato che il tasso di declino è stato ridotto del 32 per cento nelle persone con attività mentale frequente nella vita, rispetto alle persone con attività mentale media, mentre il tasso di declino delle persone con attività poco frequenti è stato del 48 per cento più veloce rispetto a quelli con attività media .
Lo studio è stato sostenuto dal National Institute of Aging e il Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Illinois.
LEGGI:
TERZA ETA’ – MEMORIA – DEMENZA – NEUROPSICOLOGIA
BIBLIOGRAFIA:
- R. S. Wilson, P. A. Boyle, L. Yu, L. L. Barnes, J. A. Schneider, D. A. Bennett. Life-span cognitive activity, neuropathologic burden, and cognitive aging. Neurology, 2013; DOI
PROYOUTH: LA PREVENZIONE DEI DISTURBI ALIMENTARI VIA WEB
Progetto PROYOUTH
Video di presentazione del ProYouth, un Progetto Europeo per la prevenzione dei Disturbi Alimentari e la promozione del benessere psicologico in adolescenza.
Il ProYouth è attivo dal 2011 in sette Paesi Europei e in Italia è promosso dalla Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo-Comportamentale “Studi Cognitivi”.
Il ProYouth si propone come supporto agli adolescenti, che potranno usufruirne in modo gratuito e anonimo interfacciandosi con la piattaforma che si trova all’indirizzo proyouth.eu
GUARDA ANCHE LA PAGINA DEL PROGETTO PROYOUTH SU STATE OF MIND
Influence of Stigma on Help Seeking Behavior
The bridge between research and practice: updates from Open Minds.
Influence of Stigma on Help Seeking Behavior

Stigma is a word which has evaded clear, operational definition: it can be considered as an amalgamation of three related problems: a lack of knowledge (ignorance and misinformation), negative attitudes (prejudice), and excluding or avoiding behaviors (discrimination) (Thornicroft, 2006b).

People with mental disorders often wait for a long time before looking for help, with average delays before seeking help of 8 years for mood disorders, and at least 9 years for anxiety disorders. Those who wait longer than average before receiving care are more likely to be young, old, male, poorly educated, or a member of a racial/ethnic minority (Morgan & Fearon, 2007).
How do people judge where to go for help? A large national survey in Germany described vignettes of people with depression or schizophrenia and asked about how to find help. Revealingly the general public thought that mental health staff is useful for treating people with schizophrenia, but not for depression. The reason for this is that most people felt that schizophrenia was caused by biological or uncontrollable influences, while they understood depression to be a consequence of ‘social disintegration’ (including unemployment, drug or alcohol misuse, marital discord, family distress or social isolation) so that people with depression were more often recommended to seek help and social support from a friend or confidant (Angermeyer et al., 1999).
Similar findings also emerged from a study in Iowa where people living in the most rural environments were more likely to hold stigmatizing attitudes toward mental health care than people in towns, and such views strongly predicted willingness to seek care (Hoyt et al., 1997). So it seems to be true that stigma about mental illness is no less in many rural areas, and it may be even stronger than in towns and cities. In part this may be based upon fears that a rural community will learn details about a period of mental illness, while it is easier in cities to remain anonymous. But relatively little research has been done in rural areas to understand these processes in more detail.
It seems to be clear, however, that stigma plays an important role in determining people’s Help Seeking Behavior.
LEGGI ANCHE:
- ENGLISH ARTICLES
- ARTICOLI SU: PSICOLOGIA E PSICHIATRIA PUBBLICHE
- ARTICOLI SU: STIGMA
REFERENCES:
- Angermeyer M.C., Matschinger H. & Riedel-Heller S.G. (1999). Whom to ask for help in case of a mental disorder? Preferences of the lay public. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology 34(4), 202-210. (DOWNLOAD)
- Hoyt D.R., Conger R.D., Valde J.G. & Weihs K. (1997). Psychological distress and help seeking in rural America. American Journal of Community Psychology 25(4), 449-470. (DOWNLOAD)
- Morgan C. & Fearon P. (2007). Social experience and psychosis insights from studies of migrant and ethnic minority groups. Epidemiologia e Psichiatria Sociale 16(2), 118-123.
- Thornicroft G. (2006b). Shunned: Discrimination against People with Mental Illness. Oxford University Press: Oxford.
Le nuove tecnologie possono supportare la comunicazione di persone autistiche? Esempi applicativi – Parte 2
 Diversi sono i progetti nati per assistere e compensare le difficoltà che possono presentare le persone con una sindrome dello spettro autistico. Le Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (TIC) promuovono la capacità di anticipazione e la strutturazione del tempo e delle attività.
Diversi sono i progetti nati per assistere e compensare le difficoltà che possono presentare le persone con una sindrome dello spettro autistico. Le Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (TIC) promuovono la capacità di anticipazione e la strutturazione del tempo e delle attività.
LEGGI ANCHE ARTICOLI SU: DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO – AUTISMO
Inoltre lo sviluppo di competenze sociali è potenziato dagli strumenti multimediali e dalle realtà virtuali, in grado anche di favorire il gioco di finzione.
LEGGI ANCHE ARTICOLI SU: TECNOLOGIA E PSICOLOGIA
Grazie all’uso di dispositivi tecnologici è possibile generare degli ambienti intelligenti in grado di promuovere i processi di percezione – azione, comprensione, pianificazione, problem-solving e relazione. Inoltre, grazie alla portabilità di alcuni dispositivi, è possibile riprodurre gli ambienti virtuali intelligenti nei diversi contesti in cui una persona con autismo vive. Alcuni studi hanno dimostrato come, a differenza dei mezzi convenzionali, le nuove tecnologie offrano la possibilità di aumentare il livello di attenzione durante la presentazione degli stimoli e nello svolgimento dei compiti, adattandosi alle capacità individuali e allo stile e al ritmo di apprendimento personale.
LEGGI ANCHE ARTICOLI SU: APPRENDIMENTO
Progetto Tic–Tac
Tic-Tac è un software per facilitare la comprensione e la gestione del tempo in soggetti autistici. Il concetto di tempo è rappresentato utilizzando un codice visibile, udibile e tangibile (vibrazione del dispositivo su cui è installato), accompagnato da pittogrammi o fotografie che identificano l’attività svolta o la situazione sperata. Nella modalità visiva, ad esempio, il passare del tempo si rappresenta attraverso la diminuzione o l’aumento di bastoni, cerchi o da clessidre che si riempiono progressivamente. Tutte le opzioni presenti nell’orologio (come ad esempio i colori, il tipo di immagine usata, la durata) possono essere adattate alla situazione e alla persona che ne usufruisce.
Visualizzazioni di sostegno

Si tratta di un portale web studiato per facilitare l’uso delle metodologie della Pianificazione Centrata nella Persona (PCP) seguendo le quali è la persona con disabilità che deve scegliere obiettivi, necessità e aspettative, contando sul supporto dell’altro per il raggiungimento delle mete prefissate. Famiglia, amici e operatori permetteranno la costituzione del Piano di Sviluppo Personale del soggetto, inserendo informazioni che permettano di conoscere la persona con autismo da diversi punti di vista. Ciascuno ha a disposizione uno spazio in cui inserire le informazioni rilevanti, la storia, le preferenze, i sogni, le paure e i progressi della persona autistica. Lo spazio è mediato da un facilitatore, figura utile per la pianificazione delle attività, per la coordinazione dei diversi interlocutori e di eventuali incontri o riunioni.
TAAC
Si tratta di un’applicazione “Touch Augmentative and Alternative Communication” nata con l’obiettivo di aiutare chi fatica a comunicare verbalmente, promuovendo le capacità di entrare in relazione di chi questi problemi li vive quotidianamente. Con l’obiettivo di aiutare nel comporre frasi, ricorre alle immagini e al text to speech. Per certi aspetti, funziona come la tastiera di un Blackbarry, predicendo la parola o il concetto che si vuole esprimere, in base a quello che si scrive, lavorando però con le immagini: quando si clicca su un’immagine, appaiono quelle correlate. Taac sintetizza le parole e trasforma i concetti in voce, ma non solo: un aspetto interessante è la possibilità di personalizzare le carte usate, associando -ad esempio- al concetto di genitori le foto della mamma e del papà del ragazzo.
LEGGI ANCHE ARTICOLI SU: LINGUAGGIO E COMUNICAZIONE
T4A
T4A è un acronimo per indicare una piattaforma “Touch for Autism” nata per favorire il coordinamento dei diversi attori in dialogo con la persona autistica, riducendo il rischio di frammentazione a cui si può assistere nella presa in carico della persona stessa. Si tratta di un progetto di educazione e riabilitazione che prevede la gestione dell’intero processo da parte di un operatore case manager che, attraverso l’uso di un banco madre (tavolo multitouch interattivo-riabilitativo), può dialogare con uno strumento portatile (tablet) che accompagna il bambino e gli adulti di riferimento. Dopo una prima fase sperimentale, T4A è oggi una piattaforma tecnologica altamente innovativa in grado di guidare l’apprendimento, la comunicazione, le abilità sociali e personali del bambino con autismo attraverso strumenti utilizzabili con il tocco.
ZO’E’
Zo’è è un comunicatore dinamico che mira a supportare i processi comunicativi di tutte le persone che non sono in grado di utilizzare voce o gesti per esprimersi. E’ attualmente utilizzato in progetti riabilitativi ed educativi, con l’obiettivo di sviluppare l’autonomia dell’utente.
Si tratta di un’applicazione fornita su tablet, con la quale è possibile interagire attraverso il display touchscreen. E’ uno strumento adattabile all’utente, in base alle sue esigenze specifiche. E’ infatti possibile personalizzare le immagini utilizzate e i testi associati ad ognuna di queste. Per aumentare la personalizzazione è anche possibile attivare la sintesi vocale dei testi inseriti o della propria voce.
LULA
Un altro software riabilitativo per lo sviluppo di abilità comunicative e linguistiche, rivolto a tutti i soggetti con deficit della comunicazione e problemi relazionali, nello specifico persone autistiche, è LULA. Questo software sfrutta la cosiddetta ‘modalità animata rallentata’ per presentare azioni ed emozioni in un modo maggiormente comprensibile per questo target.
Il progetto cerca di favorire soprattutto le abilità pragmatiche, che risultano dall’integrazione e dalla corretta contestualizzazione di informazioni verbali, non verbali e contestuali. In questo senso, le persone autistiche non sono in genere in grado di cogliere gli elementi socialmente rilevanti della comunicazione, ma si soffermano piuttosto su quelli irrilevanti.
Lula cerca di sviluppare queste abilità pragmatiche attraverso un approccio integrato che tenga conto, allo stesso tempo, degli stati mentali, della struttura dell’evento, della funzione dialogica e dell’empatia.
Per raggiungere questo obiettivo, Lula utilizza un linguaggio fumettistico che facilita la comprensione e attribuzione di emozioni e l’animazione come tecnica di rappresentazione delle situazioni sociali.
ALPACA
Alpaca (Alternative Literacy with PDA and Augmentative Communication for Autism) è invece un palmare multimediale per bambini autistici che, attraverso un software in grado di gestire immagini e suoni, coinvolge allo stesso tempo i sensi del tatto, della vista e dell’udito. Immagini e suoni sono personalizzabili in base alle esigenze dell’utente, con lo scopo di supportare maggiormente l’insorgere delle abilità linguistiche e comunicative.
IMMAGINARIO
Immaginario è un’applicazione pensata per gli adulti che interagiscono con persone con un disturbo dello spettro autistico. Il supporto alla comunicazione mira, in questo caso, a sostenere la comprensione attraverso l’uso di immagini.
I dispositivi mobili su cui questa applicazione può essere installata consentono di avere sempre con sé il materiale necessario per comunicare. Le immagini sono associate a concetti, a loro volta categorizzati in base a criteri semantici. Anche in questo caso, gli sviluppatori hanno puntato sulla possibilità di personalizzare le immagini, creando nuove carte, testi e registrazioni audio.
PROLOQUO2GO
Proloquo2Go è un’applicazione che sfrutta un vocabolario di simboli e icone che permette all’utente di costruire frasi che sono lette verbalmente dal tablet. Obiettivo di questa applicazione non è solo quello di supportare la comunicazione, ma anche di agevolare l’apprendimento di competenze sociali, abilità motorie, logopediche, etc.
LEGGI:
DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO – AUTISMO – TECNOLOGIA E PSICOLOGIA – APPRENDIMENTO – LINGUAGGIO E COMUNICAZIONE
BIBLIOGRAFIA:
- Baron-Cohen, S. (1995). Mindblindness: An Essay on Autism and Theory of Mind. Cambridge, MA: MIT Press.
- Barthelemy, C., Hameury, L., & Lelord, G. (1995): L’autismo del bambino: la terapia di scambio e sviluppo. Paris: E.S.F.
- De Meo, T., Vio, C. & Maschietto, D. (2000). Intervento cognitivo nei disturbi artistici e di Asperger. Trento: Edizioni Erickson.
- Frith, C. D., Frith, U. (1999). Interacting minds, a biological basis. Science, 286, 1692–1695.
- Frith, U. (1989). Autism: explaining the enigma. Oxford: Blackwell.
- Golan, O., & Baron-Cohen, S. (2006). Systemizing empathy: Teaching adults with Asperger syndrome or high-functioning autism to recognize complex emotions using interactive multimedia. Development and Psychopathology, 18(2), 591–617.
- Herrera, G., Labajo, G.; Fernandez, M. (2001). Dispositivos de Asistencia Portátiles: Funcionalidad perseguida para ayudar a las personas con retraso mental y/ o autismo en su comunicación con el entorno. Jornadas ISAAC-España. 2001: Odisea de la comunicación.
- Howlin, P. (1997). Prognosis in autism: do specialist treatments affect long-term outcomes? European Child and Adolescent Psychiatry (6), 2, 55–72.
- Klin, A., Chawarska, K., Rubin, E. & Volkmar, F. (2004). Clinical assessment of young children at risk for autism. In Handbook of Infant, Toddler,and Preschool Mental Health Assessment, ed. R Del Carmen-Wiggins, A Cater, pp. 311–36. Oxford: Oxford Univ. Press.
- Levorato, M. C. & Nesi, B. (2001). Imparare a comprendere e produrre testi. In L. Camaioni (a cura di), Psicologia dello sviluppo del linguaggio. Bologna: Il Mulino.
- Paulus, J. (2013). Anche i ragazzi autistici desiderano avere amici. Psicologia Contemporanea, Giunti, Marzo – Aprile.
- Pavone, M. (2010). Dall’esclusione all’inclusione. Lo sguardo della Pedagogia Speciale. Mondadori Università.
- Riviére, A. (2001). Autismo. Orientaciones para la intervención educativa. Madrid: Trotta.
- Sellin B. (1995). Prigioniero di me stesso. Viaggio dentro l’autismo. Torino: Bollati Boringhieri.
- Van Der Geest, J. N., Kemner, C., Cafferman, G., Verbaten, M. N. & Van England, H. (2002). Looking at Images with Human Figures: Comparison between Autistic and Normal Children. Journal of Autism and Developmental Disorders 32(2), 69–75.
- Wing, L. (1988). The continuum of autistic characteristics. In E. Schopler & G. B. Mesibov (Eds.): Diagnosis and assessment in autism. New York: Plenum Press.
- Wing, L. (1996). The autistic spectrum: a guide for parents and professionals. London: Constable.
Le regioni del cervello correlate alla depressione

Il disturbo depressivo maggiore è associato a una disregolazione di regioni cerebrali tra cui la corteccia prefrontale e il sistema limbico.
LEGGI ANCHE ARTICOLI SU: DEPRESSIONE
LEGGI ANCHE ARTICOLI SU: NEUROSCIENZE
La relazione tra anomalie strutturali e funzionali in questi regioni cerebrali in pazienti depressi è tutt’altro che chiara. Tuttavia, entrambi i tipi di cambiamenti possono esservi alla base dei sintomi di questo disturbo.
Questa mancanza di comprensione ha indotto il dottor Bart de Kwaasteniet e colls. presso il Centro Medico Accademico di Amsterdam a utilizzare un approccio di neuroimaging multimodale per chiarire tale rapporto.
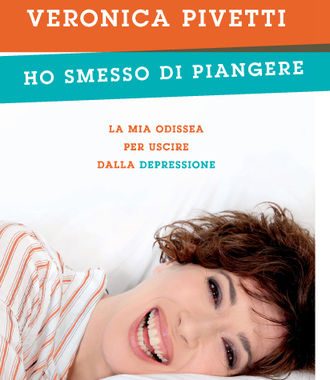
I ricercatori, guidati dal professor Damiaan Denys, hanno reclutato 18 pazienti con disturbo depressivo maggiore e 24 individui sani. Tutti i partecipanti hanno subito molteplici scansioni di neuroimaging. Loro hanno focalizzato specificamente la connettività strutturale e funzionale tra il corteccia subgenuale cingolata anteriore (ACC) e il lobo temporale mediale, due regioni che sono collegate dal fasciculus uncinato. Queste regioni sono note per essere coinvolte nella regolazione delle emozioni e della memoria.
LEGGI ANCHE ARTICOLI SU: MEMORIA
I ricercatori hanno spiegato che c’è una diminuita integrità strutturale del fasciculus uncinato che collega il lobo temporale mediale e il la corteccia subgenual ACC. Inoltre, hanno identificato un aumento del collegamento funzionale tra questi regioni in depressione rispetto ai controlli. È importante sottolineare che hanno identificato una correlazione inversa tra l’integrità del fasciculus uncinato e il collegamento funzionale tra l’ippocampo ACC e bilaterale subgenual nella depressione maggiore.
LEGGI ANCHE ARTICOLI SU: DEPRESSIONE MAGGIORE
Questi risultati suggeriscono che i disturbi strutturali del fasciculus uncinato contribuiscono a un incremento delle interazioni funzionali tra i circuiti del cervello associati con i sintomi della depressione. Questo porta ad ipotizzare che le anomalie nella struttura del cervello portano a differenze nella connettività tra aree cerebrali nei disturbi depressivi.
Tuttavia, i ricercatori hanno anche ipotizzato che il contrario può essere vero. In altre parole, che l’aumento della connettività funzionale tra queste regioni del cervello porta a cambiamenti strutturali nelle fibre della sostanza bianca del cervello per mezzo di un aumento anomalo di trasduzione del segnale. Questa ipotesi è supportata da recenti studi che suggeriscono che nella schizofrenia l’iperattività del circuito può essere un fattore predittivo di una successiva atrofia corticale.
LEGGI ANCHE ARTICOLI SU: SCHIZOFRENIA
Questo interessante studio suggerisce che le anomalie nei collegamenti strutturali tra le regioni del cervello, in particolare della sostanza bianca, sono associati con attività anomala all’interno di un circuito cerebrale implicato nei sintomi della depressione. Questa osservazione solleva una questione importante: “quali sono le implicazioni del trattamento delle anomalie funzionali del circuito senza il riparo dei difetti strutturali?“.
E’ probabile che le anomalie strutturali contribuiscono al rischio per la ricaduta della depressione tra gli individui la cui attività del circuito cerebrale ha risposto ai farmaci antidepressivi.
LEGGI ANCHE ARTICOLI SU: PSICOFARMACOLOGIA
Ulteriori ricerche saranno necessarie per testare le teorie generate dai risultati di questo studio.
LEGGI ANCHE:
DEPRESSIONE – NEUROSCIENZE – DEPRESSIONE MAGGIORE
BIBLIOGRAFIA
- De Kwaasteniet, B., Ruhe, E., Caan, M., Rive, M., Olabarriaga, S., Groefsema, M., Heesink, L., van Wingen, G., & Denys, D. (2013). Relation Between Structural and Functional Connectivity in Major Depressive Disorder. Biological Psychiatry, 74 (1): 40 DOI
Associate fellowship: il terzo livello di specializzazione nella REBT
 Negli altri articoli di questa serie vi abbiamo raccontato i primi due livelli di specializzazione nella terapia razionale-emotiva (Rational Emotive Behavioral Therapy, REBT). Nei giorni che vanno dal 10 al 15 luglio 2013 alcuni membri della redazione di State of Mind hanno affrontato il terzo livello, ovvero il cosiddetto “Associate Fellowship Practicum”. E oggi possiamo raccontarvelo.
Negli altri articoli di questa serie vi abbiamo raccontato i primi due livelli di specializzazione nella terapia razionale-emotiva (Rational Emotive Behavioral Therapy, REBT). Nei giorni che vanno dal 10 al 15 luglio 2013 alcuni membri della redazione di State of Mind hanno affrontato il terzo livello, ovvero il cosiddetto “Associate Fellowship Practicum”. E oggi possiamo raccontarvelo.
LEGGI ANCHE ARTICOLI SU: RATIONAL – EMOTIVE BEHAVIOUR THERAPY
I primi due livelli (Primary e Advanced Practicum, rispettivamente) erano introduttivi e consistevano nell’insegnamento dei principi base e in esercitazioni di peer-counseuling tra partecipanti dello stesso Practicum. In breve, nel Primary e Advanced i partecipanti utilizzano e si somministrano tra loro il modello ABC-DEF, portando materiale personale reale e non simulato. Secondo gli operatori dell’Ellis Institute, il materiale psicologico simulato risulta irrealisticamente impermeabile a una disputa REBT.
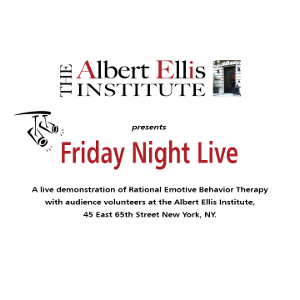 Nel terzo livello si porta materiale clinico, ovvero file audio di sedute registrate da ascoltare insieme a supervisori REBT ufficiali. Nel caso di sedute non in inglese (come era il nostro caso e quello di un collega turco) si portano le trascrizioni di segmenti significativi delle sedute. Quest’anno siamo stati in quattro ad affrontare l’Associate Fellowship: due italiani, il collega turco a cui abbiamo già accennato e una collega indiana. I nostri supervisori erano tre esponenti storici della REBT formati direttamente da Albert Ellis –Raymond DiGiuseppe, Windy Dryden e James MacMahon- e un collega più giovane, Daniel David.
Nel terzo livello si porta materiale clinico, ovvero file audio di sedute registrate da ascoltare insieme a supervisori REBT ufficiali. Nel caso di sedute non in inglese (come era il nostro caso e quello di un collega turco) si portano le trascrizioni di segmenti significativi delle sedute. Quest’anno siamo stati in quattro ad affrontare l’Associate Fellowship: due italiani, il collega turco a cui abbiamo già accennato e una collega indiana. I nostri supervisori erano tre esponenti storici della REBT formati direttamente da Albert Ellis –Raymond DiGiuseppe, Windy Dryden e James MacMahon- e un collega più giovane, Daniel David.
LEGGI ANCHE ARTICOLI SU: ELLIS
Durante le supervisioni ci siamo chiariti le idee su qualche concetto clinico e pratico. In particolare, è emersa un’indicazione: focalizzarsi soprattutto sui pensieri di tipo valutativo e considerarli come credenze disfunzionali.
LEGGI ANCHE ARTICOLI SU: CREDENZE – BELIEFS
Questa è una differenza significativa con la terapia cognitiva alla Beck. Per la REBT i pensieri che generano sofferenza sono valutazioni e non inferenze più o meno errate sulla realtà. Ovvero, non si tratta di previsioni più o meno errate su fatti e/o eventi accaduti o che potranno accadere (chiamati “inferences” all’Ellis Institute), ma di giudizi di valore intensamente negativi idiosincratici ed emotivi (le terribilizzazioni, gli “awfulizing”) oppure convinzioni su come le cose dovrebbero andare o dovrebbero essere fatte, i famosi “must”. Questi sono chiamati “beliefs”.
LEGGI ANCHE ARTICOLI SU: CATASTROFIZZAZIONE
LEGGI ANCHE ARTICOLI SU: DOVERIZZAZIONE
Questa attenzione per i giudizi di valore rigidamente auto-somministrati invece che alle descrizioni inaccurate della realtà generate da errori logici, come pensato da Beck, rende la terapia molto meno astratta e distaccata dalle emozioni di quella di Beck. Non si tratta di andare a caccia dell’errore, ma di individuare questi giudizi idiosincratici e di porli in discussioni con un atto al tempo stesso volontaristico (“where is written this?” “dove sta scritto questo?”) ed emotivo.
La disputa a sua volta la si concepisce non più come un processo impersonale di revisione logica delle informazioni a disposizione, ma come un processo di separazione emotiva da convinzioni ritenute vere per il semplice fatto che ci passano per la testa. Sarà per questo che nella terapia di Beck si parla di “questioning” invece che di “disputing”?
LEGGI ANCHE ARTICOLI SU: DISPUTING E RISTRUTTURAZIONE COGNITIVA
LEGGI LE ALTRE CRONACHE DA NEW YORK
LEGGI ANCHE:
RATIONAL – EMOTIVE BEHAVIOUR THERAPY – TECNICA ABC (ELLIS) – CREDENZE – BELIEFS – CATASTROFIZZAZIONE – DOVERIZZAZIONE – DISPUTING E RISTRUTTURAZIONE COGNITIVA
Accessing mental health services: I want to solve the problem on my own (pt. 2)
The bridge between research and practice: updates from Open Minds.
Accessing mental health services:
I want to solve the problem on my own
Part 2

Considering the previous literature, studies have been conducted based on the assumption that equity of access can be achieved only if available services are acceptable to diverse populations of potential users.
It is well known that individuals progress through several stages before seeking mental health treatment. These stages include experiencing symptoms, evaluating the severity and consequences of the symptoms, assessing whether treatment is required, assessing the feasibility of and options for treatment, and deciding whether to seek treatment.
An interesting study (Lovell, K. & Richard, D., 2000) conducted in the UK, for example, shows that providing briefer treatments can lead to overall increases in service delivery and more cost-effective services.
The authors argue that evidence exists for service protocols that promote equity, accessibility and choice and that CBT services should be organized around multiple levels of entry and service delivery rather than the more usual secondary care referral system.
First, where promising evidence exists, less therapist intensive treatments should be the first choice for the majority of clients. In most cases therapy should be routinely initiated by the provision of brief therapies such as self-help materials and guidance – delivered through accessible alternative channels such as bibliotherapy or telephone advice lines. These services should be accessed by potential clients without reference to complex referral systems and artificial gateways.
Second, in circumstances where a patient is deemed to be at serious risk, or for individuals with more complex needs, or for those who have been unsuccessful in following a brief treatment regime, more intensive therapist guided and therapist aided packages of care should be provided. Third, therapist assisted multi-strand and/or complex therapies should be used where the previous stages have been unsuccessful or where clients with a previous history of treatment failure present for assistance.
In a study published on The British Journal of Psychiatry, the authors (Richards & Bower, 2011), illustrate the Australian Better Access initiative, a program designed to improve access to psychological therapies for affective and anxiety disorders. The main aim of the project was based on the assumption that therapies shouldn’t be given in private clinics and in the traditional face to face sessions, but psychological therapy should be provided by the State trying to accessing whose will benefit from treatment but can’t be reached by traditional models. The strength of the program was to base treatments considering questions relating to five core issues: access (who got treatment?), equity (were services targeted appropriately at need?), utilization (what treatments did people receive?), effectiveness and cost-effectiveness (did they improve outcomes at a sustainable cost?) and patient-centeredness (did the service meet patient needs?).
As we see in the previous part of this article, one of the main reasons people state as not accessing mental health services seems to relate to the fact that they want to solve the problem on their own; considering this issues in a more details way, the finding that people not seeking help ‘preferred to manage themselves’ raises many questions about their decision-making. Those decisions often reflect the way that services are perceived to respond to distress, rather than a deficit in patient knowledge. Persuading more people with common mental health problems to access psychological therapies is unlikely to be a simple matter of public education. Instead, it will require the design and delivery of services that minimize the material and psychological costs of accessing care, while maximizing their potential impact.
LEGGI ANCHE:
- ENGLISH ARTICLES
- ARTICOLI SU: PSICOLOGIA E PSICHIATRIA PUBBLICHE
- ARTICOLI SU: STIGMA
REFERENCES:
- Lovell, K., & Richards, D. (2000). Multiple Access Points & Levels of Entry (MAPLE): Ensuring Choice, Accessibility & Equity for CBT Services. Behavioural and Cognitive Psychotherapy, 28(4), 379-392.
- Richards, D. A., & Bower, P. (2011). Equity of access to psychological therapies. The British Journal of Psychiatry, 198(2), 91-92.
Nostalgia: uno stato psicologico che favorisce l’ottimismo

La nostalgia incrementa l’ottimismo. Questa è la conclusione di una serie di 4 studi pubblicati recentemente on line sul Personality and Social Psychology Bulletin.
Secondo Cheung e colleghi, la nostalgia non sarebbe esclusivamente uno stato emotivo orientato al passato, ma il suo campo d’azione si estenderebbe al futuro, influenzandone la percezione in termini positivi.
I dati ottenuti nel primo studio suggeriscono infatti un profondo legame tra i due costrutti. In particolare, è emersa la presenza di una percentuale maggiore di espressioni legate all’ottimismo all’interno di racconti di eventi autobiografici attivanti nostalgia rispetto a racconti di eventi ordinari, indipendentemente dalle emozioni positive scaturite dal ricordo emotivamente rilevante.
LEGGERE ANCHE ARTICOLI SU: MEMORIA

La seconda ricerca, che ha previsto l’induzione di uno stato di nostalgia attraverso il ricordo di eventi emotivamente rilevanti, ha mostrato come un maggior coinvolgimento nostalgico aumenti i livelli di ottimismo non solo attraverso un incremento dell’affettività positiva, ma anche tramite un rapporto diretto.
Al fine di approfondire i possibili mediatori di tale relazione, un terzo esperimento ha chiesto a 664 partecipanti di ascoltare, in modo randomizzato, una canzone dal contenuto nostalgico o una canzone di controllo. I risultati indicano che: l’effetto positivo della nostalgia sui livelli di ottimismo è generalizzabile per età e genere; la nostalgia accresce l’ottimismo sia direttamente sia tramite un aumento dei livelli di autostima e non attraverso maggiori livelli di emotività positiva.
Nel quarto e ultimo studio, gli autori hanno ipotizzato che autostima e senso di connessione sociale fungessero da mediatori della relazione tra nostalgia e ottimismo. Infatti, il nostro senso di autostima origina prevalentemente da processi sociorelazionali come il senso di connessione sociale. Quest’ultimo, a sua volta, è spesso oggetto di rêverie nostalgiche, come possono essere quelle riguardanti la famiglia o i rapporti sentimentali.
LEGGI ANCHE ARTICOLI SU: FAMIGLIA
Durante la ricerca, i soggetti dovevano leggere il testo di una canzone precedentemente identificata da loro come nostalgica rispetto ad una condizione di controllo in cui leggevano una canzone scelta da altri. I dati hanno confermato il modello di mediazione proposto. Uno stato nostalgico è in grado di innescare un più profondo senso di connessione sociale che, a sua volta, sfocia in una più elevata autostima. Quest’ultima diventa una sorta di lente positiva capace di infondere maggior ottimismo per il futuro.
Ripensare nostalgicamente a ciò che è passato può quindi farci rivivere una positività sepolta nei nostri ricordi, che ci permette, nel presente, di avere uno sguardo più ottimista nei confronti di ciò che ci aspetta in futuro.
LEGGI ANCHE ARTICOLI SU: PSICOLOGIA POSITIVA
LEGGI ANCHE:
MEMORIA – FAMIGLIA – PSICOLOGIA POSITIVA
BIBLIOGRAFIA:
- Cheung, W. Y., Wildshut, T., Sedikides, C., Hepper, E. G., Arndt, J., & Vingerhoets, A. J. J. M. (forthcoming). Back to the Future: Nostalgia increases Optimism. Personality and Social Psychology Bulletin.
Accessing mental health services: I want to solve the problem on my own
The bridge between research and practice: updates from Open Minds.
Accessing mental health services:
I want to solve the problem on my own

It has been shown that people from economically deprived and socially marginalised groups or ethnic minorities are more likely to have higher rates of psychiatric morbidity but less access to the services (Dionisi et. al 2013). The factors implicated in the choice of not accessing the mental health services are complex and still not very well defined, as researches show that these factors are clearly influenced by many variables and cultural differences (Kovandzic et al, 2012). Multiple stigma(s) and lack of effective information are identified as the main barriers to accessing services for ‘hard-to-reach’ groups (Richards, D. & Bower, 2011).
Studies focused on this topic (Richards, D. & Bower, 2011) show that emotionally distressed individuals most commonly identify attitudinal barriers (such as wishing to solve the problem on their own and thoughts that the emotional problem would go away) for not seeking mental health treatment. Although fear of stigmatization is commonly thought to be an important reason for not seeking mental health treatment, the limited number of studies have not found fear of stigmatization to be a commonly reported barrier to seeking treatment for emotional problems. Structural barriers, such as financial cost for mental health treatment, also may affect use of mental health services (although this issue has been highly controversial).
In a study that surveys people from three different countries (Sareen et. al, 2007), researchers have found that the long delays between onset of mental disorders and initial contact with a mental health professional can be explained by people’s attitude of thinking “I want to solve the problem on my own”, followed by “Help would probably be any good”.
Important associations between particular socio demographic factors and types of mental disorders have been found:
-
younger age was positively associated with fear of involuntary hospitalization and concerns about embarrassment from using mental health services;
-
the presence of an anxiety disorder was positively associated with endorsement of the item that help probably would not do any good. These findings suggest that individuals in the community may not be aware of the treatable nature of anxiety symptoms and disorders;
-
the presence of a past-year mood disorder and substance use disorder was positively associated with a fear of involuntary hospitalization;
-
the presence of a substance use disorder was associated with concerns of embarrassment about using mental health services.
Considering these findings some research has been conducted on implementing services and programs facilitating the access to mental health services by acting on these barriers. In the next article we will go through some of the programs have been conducted so far.

LEGGI ANCHE:
- ENGLISH ARTICLES
- ARTICOLI SU: PSICOLOGIA E PSICHIATRIA PUBBLICHE
- ARTICOLI SU: STIGMA
REFERENCES:
- Sareen, J., Jagdeo, A., Cox, B., Clara, I., ten have, M., Belik, S., de Graaf, R., M. (2007). Perceived barriers to mental health service utilization in the United States, Ontario, and the Netherlands. Psychiatric Services, 58:3, 357-364. DOWNLOAD PDF
- Donisi, V., Tedeschi, F., Percudani, M., Fiorillo, A., Confalonieri, L., De Rosa, C., … & Amaddeo, F. (2013). Prediction of community mental health service utilization by individual and ecological level socio-economic factors. Psychiatry research.
- Kovandžić, M., Funnell, E., Hammond, J., Ahmed, A., Edwards, S., Clarke, P., … & Dowrick, C. (2012). The space of access to primary mental health care: A qualitative case study. Health & place, 18(3), 536-551.
- Richards, D. A., & Bower, P. (2011). Equity of access to psychological therapies. The British Journal of Psychiatry, 198(2), 91-92.
Sogni a bassa risoluzione. Di Andrea Cacciavillani – Recensione
Recensione del libro
SOGNI A BASSA RISOLUZIONE
di Andrea Cacciavillani
(2011)
LEGGI TUTTE LE RECENSIONI DI STATE OF MIND
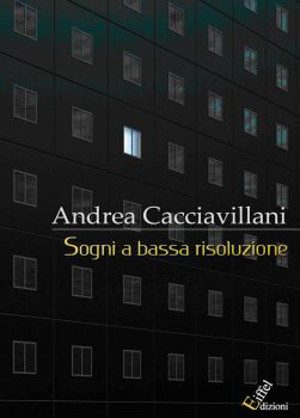 La risoluzione dei sogni, foto più o meno nitide della nostra realtà, del nostro futuro o di ciò che vorremmo accadesse? Risoluzione che indica la densità dei punti elementari, parti di un’immagine che non ammette disegni, perché frutto di punti, di minuscoli punti, percepibili nel loro insieme, solo da occhi attenti e da cuori aperti ai più reconditi istinti, desideri e bisogni, svelatisi senza riserve né menzogne.
La risoluzione dei sogni, foto più o meno nitide della nostra realtà, del nostro futuro o di ciò che vorremmo accadesse? Risoluzione che indica la densità dei punti elementari, parti di un’immagine che non ammette disegni, perché frutto di punti, di minuscoli punti, percepibili nel loro insieme, solo da occhi attenti e da cuori aperti ai più reconditi istinti, desideri e bisogni, svelatisi senza riserve né menzogne.
LEGGI ANCHE GLI ARTICOLI SU: SOGNI
Solo allora, la risoluzione dei nostri sogni, veicolata da coraggio e coerenza, migliorerà la qualità dei singoli istanti-scatti di vita, fotografandoli in noi con la stessa nitidezza che garantirebbe uno sguardo diretto sulla realtà. Sogni, dunque, in grado di mutare in tangibili verità. Sogni partoriti da nuovi scatti, probabilmente mossi, ma audaci, allineati a nuove prospettive, madri di un percorso di crescita in parvenza “cronicizzato” sulle ansiose inquietudini dell’uomo moderno.
Una storia suggestiva che – così si legge nell’incipit – inizia “con un sogno e finisce con la verità”. Imprevedibilità della vita che può travolgere chiunque, come ha travolto Tulio, protagonista del libro “Sogni a bassa risoluzione”, di Andrea Cacciavillani, scrittore, poeta, paroliere musicale, autore di testi da cui sono state tratte sceneggiature teatrali e monologhi. La trama, decisa e coinvolgente, si snoda attraverso tre fasi esistenziali della vita dell’uomo, tessute, seppur in un gioco di rimbalzi temporali, sul filo del presente, su cui “galleggia”, pressoché sospeso, un trentacinquenne, guardia giurata in un centro commerciale.
A tormentarlo è l’insonnia, patologia ormai ventennale, di temuta irreversibilità, ma che, si scoprirà poi, esser legata ad un orribile incubo che ne aveva congelato la crescita emozionale ed i sogni, a quattordici anni, proprio nel giorno della morte di suo padre.
LEGGI ANCHE ARTICOLI SU: INSONNIA
Coincidenza o sovrapposizione di eventi? Realtà o fantasia? Forse entrambi, ma lo scopriremo seguendo il cammino del protagonista. Sarà lui che, diretto dalla toccante penna del Cacciavillani, ci racconterà sia della sua infanzia – descritta per monologhi, in prima persona, durante le sedute di psicoanalisi, volte a tamponarne il notturno malessere – che del suo ieri più immediato, colorato dalla nascita di una profonda amicizia con un collega.
LEGGI ANCHE ARTICOLI SU: PSICOANALISI

Narrazione che si muove attorno al filo conduttore, teso sulle notti insonni di Tulio, compulsivamente chiuso a chiave nella sua stanza, in una solitudine costellata da sporadici dialoghi con la madre e dal ricorrente mostruoso incubo, morsa di sogni che “alitano sul collo delle nostre paure” (da “Sogni”, in Icaro cuori di cera, Raccolta di poesie, 2001, Gallina Editore). Ritmo stanco il suo, rassegnato, ma stravolto, improvvisamente, dal ritrovamento di un cellulare e da un sms – “una dolce carezza per te” – che l’uomo riceve, su quel telefono, da una misteriosa Altea, unica voce in rubrica.
In preda a sensazioni sconosciute, le risponderà “grazie della carezza, mi aiuterà a sognare”. Seguirà un “allora quest’altra carezza entrerà nei tuoi sogni…” ed un “è già nei miei sogni” (pagg. 28-29). Di qui, un rincorrersi di sms, mms, foto “a bassa risoluzione” di particolari femminili, una mano, delle labbra, scateneranno un rapporto, impetuoso e morboso, nato causalmente (o forse no?) con una sconosciuta, da cui Tulio è attratto, inspiegabilmente legato, basito di “come fosse a suo agio in quella situazione” (pag. 52).
Una preconoscenza di anime, che riporta a quel “non ti ho inventata, ti ho trovata subito dopo il crollo della mia anima pronto a capire chi noi fossimo” o a quel dialogo tra corpi distanti, pronti a dirsi “tu sei reale, tanto quanto non sei qui” (frasi rispettivamente tratte da “Scivola”, in Minore di Diesis, Appunti di Poesia, 2013, Galassia Arte Editore, e “Cammino”, in Icaro cuori di cera, Raccolta di poesie, 2001, Gallina Editore).
Questi, gli input che indurranno il vigilantes – mosso da un represso ma intenso desiderio di Amare, forse, più che di essere amato – a riflettere, a rimescolare le carte in tavola, a ridiscutere tutte le scelte e reimpostare totalmente la sua vita. Era bastato un sms, un segno del destino, un evento che Tulio non aveva fatto nulla perché gli si catapultasse addosso.
LEGGI ANCHE ARTICOLI SU: AMORE – RELAZIONI SENTIMENTALI
Del resto, “la verità è che abbiamo il vizio di credere che quando arriviamo ad una conclusione qualcosa è stato trovato solo perché abbiamo cercato” (pag. 95). Tema, quello dell’incrocio tra casualità e scelta, tra staticità e provocata dinamicità, che lo scrittore dipinge consegnandoci teneri frammenti di pensiero di un Tulio bambino, incantato ad “osservare l’aquilone nell’istante subito precedente il volo” con “l’impressione che in quell’attimo tutto si fermasse. Un piccolo istante durante il quale” in lui “nasceva la consapevolezza dell’esistenza di un cielo” (pag. 15). Un Tulio che, adolescente, ed infine adulto, saprà guardare con nostalgia la sua infanzia, perché “quando sei bambino non devi dimostrare niente”, ma a un certo punto “ti ritrovi, senza che tu lo abbia chiesto, in un posto che non è più solo tuo ma è di tutti. Devi lottare, sgomitare per essere notato. Tutti quegli sguardi amorevoli e gratuiti non ti sono più dispensati” (pag. 46).
LEGGI ANCHE ARTICOLI SU: BAMBINI
Ma non tutto è perso, forse quella magia che si respira da bambini, la si può rivivere in un amore, come accadrà a Tulio, incredulo e ansioso – nel rispondere a quel primo sms di Altea – di calcare il primo passo che lo allineerà al mondo, per “far parte di nuovo dell’essenza umana. Sentirsi uno dei tanti” (pag. 113). Terminerà così la sua attesa, con un sogno di realtà, assassino di quell’incubo bestiale che l’aveva pietrificato per vent’anni, ad “aspettare un tram che non sai mai se e quando passerà. Forse per questo che nonostante tutto – riflette – mi distendo sul letto. Così sono pronto se il sonno dovesse arrivare” (pag. 10). L’attesa. Tutto ruota attorno all’attesa di un anello mancante, in una catena di episodi e di vissuto composto di attimi anonimi, sfocati, immortalati in immagini a bassa risoluzione, nei quali Tulio era abituato a muoversi, come un prodotto matematico, come somma vivente di tutto ciò che per troppo tempo, aveva negato a sé stesso.
Anello mancante che – incastrandosi in un intrigante incedere di eventi – arriverà a chiudere il cerchio con un semplice avviso sonoro, un bip luminoso che lo metterà all’angolo, quando il suo cuore impazzito leggerà l’ultimo messaggio di Altea: “…è arrivato il momento di vederci. Non ti scriverò né richiamerò. Ti aspetto. Stanotte” (pag. 183). Ecco che, spinto dalla sua imbavagliata ansia di vivere, l’uomo – in un finale a sorpresa – ne conoscerà l’identità, comprenderà le ragioni delle sue inquietudini infantili, e suturerà le ferite del conflittuale rapporto con la madre, donna capace, non di plateali dimostrazioni d’amore per il figlio, ma di piccole grandi attenzioni, di “gesti che assumono importanza non per quello che danno ma per quello che sottraggono” (pag. 103).
LEGGI ANCHE ARTICOLI SU: FAMIGLIA
E mi si consentirà di immaginare la voce di Tulio, sussurrare, finalmente stretto ad Altea, un lei “mi tocca la vita, lo fa con un gesto” (da Portatemi via, Tabula Osca, testo di Andrea Cacciavillani). O forse, se quell’uomo avesse avuto inchiostro, avrebbe scritto “l’istante in cui ho udito la tua voce spostare l’aria attorno alla mia bocca ho capito il potere del suono” (da Diesis Minore, in Minore di Diesis, appunti di poesia, 2013, Galassia Arte Editore). Qualsiasi fosse il suo pensiero, o la sua parola, dinanzi a se, in quel momento, poteva godere della luce giusta per poter scattare una foto, questa volta sul suo futuro, nitida come l’amore e la libertà, inatteso frutto di quei “sogni a bassa risoluzione”, e di un miracolo che accade “nel momento in cui capisci una cosa importante: i sogni non devono essere esauditi ma raccontati” (pag. 46).
Molteplici, dunque, gli ingredienti del romanzo, l’amore, l’avventura, una nota di noir e di mistero, e segreti sapientemente accennati dallo scrittore, abile nel regalare al lettore suspense ed emozioni, stregandolo fino all’ultima pagina e all’ultima lettera dell’opera. Lettere, simboli, strumenti che il Cacciavillani dosa con stile, maestria e sentimento, per comunicare, ad ampio spettro, con chi, immerso tra le righe del romanzo, avrà provato le stesse intense emozioni di Tulio. E se, come afferma l’Autore, la scrittura è un mezzo quasi atavico di comunicazione, tanto che “i bimbi disegnano prima di parlare”, ben presto ci accorgeremo che non saremo più noi a leggere il romanzo, ma sarà il romanzo a scavarci dentro, a divorare le nostre inquietudini, e far riemergere assopite serenità.
Così, l’introspezione e il viaggio di Tulio, diventeranno il nostro più intimo itinerario, scevro da banali cliché o da mediocri perbenismi. Tulio è un uomo, vive nella sua società, nel tempo di tutti, dove nulla manca e niente si ha per davvero. Tulio è nessuno e siamo tutti, uomini, donne, ragazzi. Ad impreziosire l’opera, poi, è la matura e riuscitissima ricerca di un linguaggio onesto, in grado di descrivere con immediatezza ambienti e personaggi. Infine, nota eccelsa del romanzo, seppur non autobiografico, è il posarsi su carta, goccia a goccia, della personalità, istintiva e profonda, dello scrittore. Una storia – da cui è stata già tratta una sceneggiatura cinematografica – che, ricordiamo, “inizia con un sogno e finisce con la verità”, perché se non si sogna – sostiene, intervistato, il Cacciavillani – non si potranno mai vivere i desideri. Sognare un amore, il futuro, un progetto, è il primo passo per viverlo. Il sogno resta l’elemento che contraddistingue l’essere umano, e se condiviso con un complice, con il nostro incastro perfetto, può trasformarsi in realtà. Si chiudono così, su una realtà dapprima sognata, e poi vissuta, le 198 pagine di un romanzo che graffia il cuore.
LEGGI TUTTE LE RECENSIONI DI STATE OF MIND
LEGGI ANCHE:
SOGNI – INSONNIA – RELAZIONI SENTIMENTALI – FAMIGLIA
BIBLIOGRAFIA:
- Cacciavillani A. (2013), Minore di Diesis, appunti di poesia, Galassia Arte Editore
- Cacciavillani A. (2011), Sogni a bassa risoluzione, Eiffel Edizioni
- Cacciavillani A. (2010), Assolo per clarinetto (Raccolta di poesie), Sovera Editore
- Cacciavillani A. (2001), Icaro cuori di cera (Raccolta di poesie), Gallina Editore
Pensare alla morte può stimolare l’umorismo?
Dal momento che l’umorismo è utile per una varietà di scopi, tra cui la difesa psicologica contro l’ansia, gli autori hanno ipotizzato che l’attivazione di pensieri riguardanti la morte potrebbe stimolare l’umorismo.
LEGGI ANCHE ARTICOLI SU: MORTE
L’umorismo è una parte intrinseca dell’esperienza umana, eppure, poca ricerca è stata condotta fino ad oggi sulla funzione psicologica dell’umorismo.
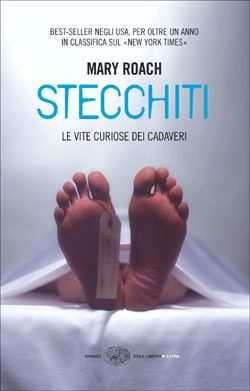
Secondo la Terror Management Theory, la conoscenza della propria transitorietà crea una dirompente ansia esistenziale, che l’individuo tiene sotto controllo con due meccanismi di coping: la rigida aderenza ai valori culturali dominanti, e il rafforzamento dell’autostima.
Un nuovo studio pubblicato sulla rivista Humor indaga se l’attivazione di pensieri sulla morte influenzi la propria capacità di generare creativamente umorismo.
Dal momento che l’umorismo è utile per una varietà di scopi, tra cui la difesa psicologica contro l’ansia, gli autori hanno ipotizzato che l’attivazione di pensieri riguardanti la morte potrebbe stimolare l’umorismo.
LEGGI ANCHE ARTICOLI SU: ANSIA
Nello studio 117 studenti sono stati suddivisi in quattro gruppi sperimentali, ciascuno dei quali si è confrontato con i temi del dolore e della morte, mentre mentre svolgeva dei compiti. Due dei gruppi, mentre svolgevano i compiti, sono stati esposti, inconsapevolmente, a parole lampeggianti (dolore e morte) per 33 millesimi di secondo. Gli altri due gruppi hanno svolto un compito di scrittura per esprimere emozioni riguardanti la propria morte o una visita dolorosa dal dentista. In seguito, tutti e quattro i gruppi hanno dovuto scrivere la didascalia di una vignetta del The New Yorker.
LEGGI ANCHE ARTICOLI SU: DOLORE
Le didascalie delle vignette sono state poi presentate ad una giuria indipendente che non sapeva nulla dell’esperimento. I risultati indicano che le didascalie scritte da individui stimolati con la parola morte sono state votate come nettamente più divertenti dalla giuria.
Il risultato opposto è stato ottenuto dagli gli studenti che hanno invece scritto sulla morte: le loro didascalie erano le meno divertenti.
Sulla base di questo esperimento, i ricercatori hanno concluso che l’umorismo aiuta l’individuo a tollerare l’ansia latente che potrebbe altrimenti essere destabilizzante. In accordo anche con studi precedenti che indicano che l’umorismo è una componente integrale della resilienza.
L’attivazione di pensieri coscienti riguardanti la morte sembra invece compromettere la generazione creativa di umorismo.
Gli autori sottolineano la necessità di ulteriori ricerche, non solo per esplorare l’efficacia dell’umorismo come un meccanismo di coping in varie circostanze, ma anche per identificarne i vantaggi emotivi, cognitivi e sociali in condizioni di avversità.
LEGGI:
BIBLIOGRAFIA:
- Christopher R. Long, Dara N. Greenwood. Joking in the face of death: A terror management approach to humor production, Humor. International Journal of Humor Research, 2013 DOI: 10.1515/humor-2013-0012