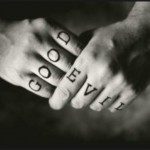Insonnia: fattori predisponenti e pratiche di cura
Antonella Sanzò – OPEN SCHOOL.
L’insonnia è un fenomeno molto diffuso: si ritiene rappresenti un problema comune a circa il 10%-15% della popolazione (Drake, Roehrs e Roth, 2003) e nonostante ciò poche persone decidono di rivolgersi ad uno specialista per porre rimedio al proprio malessere.
L’insonnia è una condizione in cui il sonno è alterato per durata, quantità e qualità: è caratterizzata da una difficoltà di addormentamento, sonno superficiale con diverse interruzioni, risveglio precoce, qualità del sonno insoddisfacente. Tali criteri possono essere compresenti in alcuni quadri clinici, come nel caso dei disturbi dell’umore, in cui si riscontra difficoltà di addormentamento, risvegli frequenti durante la notte, difficoltà a prendere nuovamente sonno dopo risvegli precoci al mattino. (Nowell e Buysse, 2001). In altre condizioni psichiche morbose, come nel disturbo di ansia generalizzata, è prevalente una difficoltà a dormire in maniera continuativa, mentre in genere non è presente una difficoltà a prendere sonno (Monti, J. e Monti, D. 2000).
Alcune malattie somatiche come l’asma bronchiale e l’ipertensione arteriosa inducono a frequenti risvegli durante la notte; altre condizioni fisiche morbose come l’ulcera duodenale e l’artrite reumatoide possono causare difficoltà a prendere sonno. Inoltre, si riscontrano differenze anche rispetto all’età: mentre le persone giovani o di mezza età hanno prevalentemente difficoltà a prendere sonno, le persone più anziane riportano con maggiore frequenza risvegli notturni, risvegli precoci al mattino ed un sonno non ristoratore (Drake, Rohers e Roth, 2003).
Le ricerche mostrano come coloro che soffrono di insonnia presentano un’eccessiva sonnolenza diurna, decremento della produttività in campo lavorativo con deficit di attenzione, concentrazione e memoria (Zisapel, 2007); ciò ha un’influenza negativa sulla qualità della vita. L’insonnia può essere transitoria quando si estende da giorni a settimane: in questo caso è un fenomeno temporaneo che si verifica in soggetti definiti “dormitori normali” oppure cronica quando il disturbo di sonno si protrae per mesi o anni.
Quali sono i fattori che influiscono maggiormente sull’insorgere dell’insonnia? Essa si può presentare come un disturbo reattivo a specifiche situazioni psicosociali: avere un lavoro poco remunerativo o condizioni di lavoro poco soddisfacenti, preoccupazioni per lo stato di salute di un familiare, nervosismo e tensione sono tutti fattori che influiscono positivamente con l’insorgere di problemi di insonnia (Martikainen, Partinen, Hasan, Laippala, Urponen, e Vuori, 2003). Altre ricerche hanno rilevato che un fattore determinante per l’insorgere del disturbo è rappresentato dalla risposta dei soggetti ad eventi di vita stressanti, piuttosto che la frequenza con cui questi si presentano (Drake, Roehrs e Roth, 2003): può accadere che gli individui con insonnia continuino a presentare disturbi del sonno dopo la dissipazione dello stress acuto che inizialmente avrebbe potuto innescare il disturbo stesso.
Invece, i fattori che influiscono maggiormente a determinare una durata negli anni del disturbo sono prevalentemente i disturbi medici e psichiatrici oppure condizioni di vita generalmente alterate. Le ricerche scientifiche dimostrano che l’insonnia ricorre nel 60% dei casi nei pazienti con depressione (Ohayon, 2007). In uno studio fatto sulla popolazione europea (Ohayon, 2007) è stato riscontrato che l’insonnia precede l’inizio del primo episodio di depressione il 41% delle volte ed è ad esso successivo il 28,9% delle volte. Inoltre, l’insonnia è associata anche ai disturbi d’ansia. Secondo gli studi condotti da Anderson et al., non meno del 60-70% dei pazienti affetti da disturbo d’ansia generalizzato presenta problemi di insonnia (Monti, J.M. e Monti, D., 2000). La maggior parte delle volte tale disturbo del sonno segue l’inizio del primo episodio d’ansia e la sua ricaduta, a differenza degli stati depressivi. Comunque, è difficile stabilire un preciso rapporto di causa-effetto tra insonnia e problemi psichiatrici.
Tra le malattie fisiche, invece, l’ipertensione e problemi cardiaci sono frequentemente associati all’insonnia (Martikainen, Partinen, Hasan, Laippala, Urponen e Vuori, 2003).
Ma quali sono i comportamenti messi in atto più frequentemente per far fronte al disturbo? Nonostante l’insonnia sia un disturbo del sonno molto comune, spesso le persone che ne soffrono sottovalutano il loro problema e non si rivolgono ad uno specialista per un trattamento.
Un progetto di ricerca condotto nel 2007 e nato da una collaborazione tra l’Università “G. D’Annunzio” di Chieti e l’Università “La Sapienza” di Roma ha indagato la relazione tra disturbi del sonno e pratiche di cura: nello specifico, lo studio aveva come scopo quello di analizzare quali fossero i comportamenti di cura messi in atto dai soggetti che percepivano di avere un disturbo del sonno, verificando se tali comportamenti variavano in relazione alla gravità del disturbo. Si è considerato se i soggetti richiedevano un aiuto ad uno specialista per il loro disturbo e se essi assumevano farmaci o altri prodotti per far fronte al problema. Tra gli obiettivi dello studio vi è stato quello di effettuare uno screening dei disturbi del sonno attraverso il “Questionario sui disturbi del sonno” (Violani, Devoto, Lucidi, Lombardo e Russo, 2004), il quale discrimina soggetti insonni e buoni dormitori; parallelamente, si è indagato il rapporto tra percezione del disturbo del sonno e pratiche di cura attraverso una scheda in cui i soggetti dovevano indicare il modo in cui affrontavano l’eventuale problema di sonno manifestatosi.
Lo studio è stato effettuato su un campione di 349 soggetti aventi un’età media di 47 anni, i quali sono stati contattati nelle sale di attesa di alcuni medici di base delle città di Pescara e provincia, Chieti e provincia e Salerno e provincia. I soggetti non sono stati selezionati sulla base della presenza di sintomi di insonnia. Ad essi è stato chiesto di compilare dei questionari auto somministrati, citati precedentemente, che indagavano la presenza di un problema di sonno e le pratiche di cura per porvi rimedio. Dai risultati è emerso che su un campione di 349 soggetti, il 57,6% presentavano un’insonnia transitoria, mentre il 24,5% presentavano un’insonnia cronica e solo il 17,9% non accusavano alcun disturbo.
Tra i soggetti nei quali è stato riscontrato un disturbo del sonno, i dati dimostrano che la percentuale di pazienti in cura presso uno specialista risulta essere bassa: essa è solo del 10% nei soggetti con insonnia cronica: precisamente, il 75% di essi era in cura dal medico di famiglia; inoltre, all’interno di questa categoria, circa il 44% assumeva prodotti per curare la malattia, prevalentemente farmaci descritti dal medico di base. Invece, tra coloro che rientrano nel gruppo di soggetti che riferiscono i sintomi dell’insonnia con frequenza inferiore ai criteri diagnostici del DSM – IV (Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali, quarta edizione) e dell’ICSD-R (Classificazione Internazionale dei Disturbi del Sonno – versione Revisionata), l’1% dei soggetti ha riferito di essere in cura presso il medico di base per il problema di sonno e il 16% assumeva prodotti per il sonno sia prescritti da un medico (27% dei soggetti), sia auto prescritti (27% dei soggetti).
Inoltre, analizzando i tipi di farmaci usati per curare l’insonnia tra coloro che riferivano di assumere prodotti per facilitare il sonno, il 47% dei soggetti ha dichiarato di usare ansiolitici, il 35% faceva uso di benzodiazepine ed il restante 18% faceva uso di antistaminici e antidepressivi. Non sono state riscontrate differenze sostanziali tra sesso maschile e femminile nei risultati riportati, né differenze rilevanti rispetto all’età, né sono state riscontrate differenze tra piccoli centri e grandi aree urbane.
Dallo studio sembrerebbe che la percentuale di insonni che chiede aiuto ad uno specialista è molto bassa e sono i soggetti che riportano sintomi di insonnia cronica a far ricorso prevalentemente al medico di base per il trattamento del disturbo di sonno rispetto ai soggetti che presentano i sintomi dell’insonnia al di sotto dei criteri diagnostici.
Il ricorso a farmaci per il sonno è frequente e questo comportamento è comune soprattutto tra coloro che presentano un quadro d’insonnia cronica.
Nello studio descritto sono presenti alcuni limiti, poiché non è stata fatta una distinzione nella percezione del disturbo del sonno e comportamenti di cura prendendo in considerazione anche la presenza o l’assenza di disturbi psichici o fisici nei soggetti: si potrebbe ipotizzare, sulla base degli studi precedentemente riportati, che siano le persone con problematiche psichiche o fisiche ad avere per lo più un problema di insonnia cronica e a ricercare maggiormente un aiuto per tale disturbo o ad assumere più farmaci che facilitano il sonno.
I risultati della ricerca descritta, sono simili a quelli rilevati in un altro studio che allo stesso modo ha analizzato i comportamenti di cura adottati dalle persone per far fronte ai sintomi di insonnia. Tale ricerca è stata svolta in Canada su campione di 2000 soggetti contattati per un sondaggio telefonico sul sonno, stato di salute ed uso di prodotti per il sonno (Morin, LeBlanc, Bélanger, Ivers, Mérette e Savard, 2011). I criteri dell’insonnia sono stati valutati mediante il DSM – IV (Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali, quarta edizione) e l’ICD – III (Classificazione Internazionale dei Disturbi, terza edizione).
Dai risultati della ricerca è emerso che il 40,2% dei soggetti presentava uno o più sintomi dell’insonnia con una frequenza di almeno tre notti a settimana nel mese precedente il sondaggio, il 19,8% si dichiarava insoddisfatto del proprio sonno ed il 13,4% soddisfaceva tutti i criteri per l’insonnia. Il 13% dei soggetti ha dichiarato di aver consultato un medico nella sua vita per i problemi di insonnia. Inoltre, il 10% ha fatto uso di medicine prescritte dal medico per favorire il sonno, il 9% ha usato prodotti naturali, il 5,7% prodotti da banco e il 4,6% ha fatto uso di alcol per stimolare il sonno. L’insonnia era associata positivamente in prevalenza al sesso femminile, all’età e alla presenza di malattie fisiche e psichiche.
Da questi dati emerge che i sintomi di insonnia sono frequenti nel campione; tuttavia, in linea con quanto è stato riscontrato nello studio sull’insonnia e sulle pratiche di cura descritte in precedenza, pochi soggetti hanno chiesto un consulto dello specialista per i loro problemi di sonno e l’uso di farmaci prescritti dal medico è la pratica terapeutica adottata con maggiore frequenza.
Spesso, i sintomi dell’insonnia sono sottovalutati sia dai pazienti, che nascondono il problema o rifiutano il trattamento, sia dai medici di base (Terzano, Cirignotta, Mondini, Ferini-Strambi e Parrino, 2006). Infatti, la grande maggioranza di persone con insonnia non sembra ricevere un trattamento adeguato e ciò ha delle conseguenze rilevanti, spesso sottovalutate, sulla salute: nel corso del tempo possono insorgere disturbi psichici e si può riscontrare un aumento dell’ uso di sostanze (Drake, Rohers, e Roth, 2003). In uno studio è stato rilevato che circa il 30% delle persone con insonnia persistente fa uso di sostanze alcoliche per favorire il sonno. Come si può facilmente supporre, questo comportamento di auto medicamento induce ad effetti di tolleranza all’etanolo e all’esigenza di assumere dosi più elevate di alcol nel tempo (Drake, Rohers, e Roth, 2003). In conclusione, l’insonnia è un problema che non è sempre riconosciuto e valutato accuratamente.
Per questa ragione, sarebbe opportuno incrementare la consapevolezza del disturbo nelle persone che soffrono di insonnia affinché esse possano adottare misure di trattamento efficaci al fine di migliorare la qualità della loro vita. Numerosi studi hanno rilevato come un trattamento di tipo cognitivo – comportamentale risulta essere efficace per migliorare la sintomatologia del disturbo, in quanto esso mira a modificare i comportamenti disfunzionali legati al sonno e a correggere le credenze distorte su di esso (Morin e Espie, 2004).
Tuttavia, non bisogna sottovalutare l’importanza dell’assunzione di farmaci per la cura dell’insonnia. Le ricerche che hanno esaminato l’associazione tra la terapia cognitivo comportamentale e l’uso di farmaci per il miglioramento dell’insonnia hanno rilevato che nei pazienti che presentano un disturbo di insonnia persistente nel tempo, si rileva un notevole miglioramento della sintomatologia se in una prima fase si ha un’unione del trattamento farmacologico con un trattamento cognitivo – comportamentale, seguito da una seconda fase di solo trattamento cognitivo – comportamentale che consente di mantenere i risultati raggiunti nel tempo. (Morin, Vallières, Guay, Ivers, Savard, Mérette, et al., 2009).
ARTICOLO CONSIGLIATO:
Insonnia: lasciami dormire ancora
BIBLIOGRAFIA:
- Drake, C. L., Rohers, T., e Roth, T. (2003). Insomnia causes, consequences, and therapeutics: an overview. Depression and Anxiety, 18, 163-176.
- Martikainen, K., Partinen, M., Hasan, J., Laippala, P., Urponen, H., e Vuori, I. (2003). The impact of somatic health problems on insomnia in middle age. Sleep Medicine, 4, 201-206.
- Monti, J. M., e Monti, D. (2000). Sleep disturbance in generalized anxiety disorder and its treatment. Sleep Medicine, 4(3), 236-276.
- Morin, C. M., LeBlanc M., Bélanger L., Ivers H., Mérette C., e Savard J. (2011). Prevalence of insomnia and its treatment in Canada. Canadian Journal of Psychiatry, 56(9), 540-8.
- Morin, C. N., e Espie, C. A. (2004). Insonnia. Guida alla valutazione e all’intervento psicologico. Edizione italiana a cura di D. Coradeschi e C. Sica. McGraw-Hill: Milano.
- Morin, C. M., Vallières, A., Guay, B., Ivers, H., Savard, J., Mérette, C., et al. (2009). Cognitive-behavior therapy, singly and combined with medication, for persistent insomnia: acute and maintenance therapeutic effects. The Journal of American Medical Association, 301(19).
- Nowell, P. D., e Buysse, D. J., (2001). Treatment of insomnia in patients with mood disorder. Depression and Anxiety, 14, 7-18.
- Ohayon, M. M. (2007). Insomnia: A ticking clock for depression? Journal of Psychiatric Research, 41, 893-894.
- Sanzò, A. (2007). L’insonnia: il materiale bibliografico nel contesto di una ricerca psicologico-clinica (Tesi di laurea non pubblicata). Facoltà di Psicologia, Università “G.D’Annunzio”, Chieti, Italia.
- Terzano, M. G., Cirignotta, F., Mondini, S., Ferini-Strambi, L., e Parrino, L. (2006). Studio Morfeo 2: survey on the management of insomnia by Italian general practitioners. Sleep Medicine, 7, 599-606.
- Violani, C., Devoto, A., Lucidi, F., Lombardo, C., e Russo, P.M. (2004). Validity of a Short Insomnia Questionnaire: the SDQ. Brain Research Bulletin, 63, 415-421.
- Zisapel, N. (2007). Sleep and sleep disturbances: biological basis and clinical implications. Cellular and Molecular Life Sciences, 64, 1174-1186.