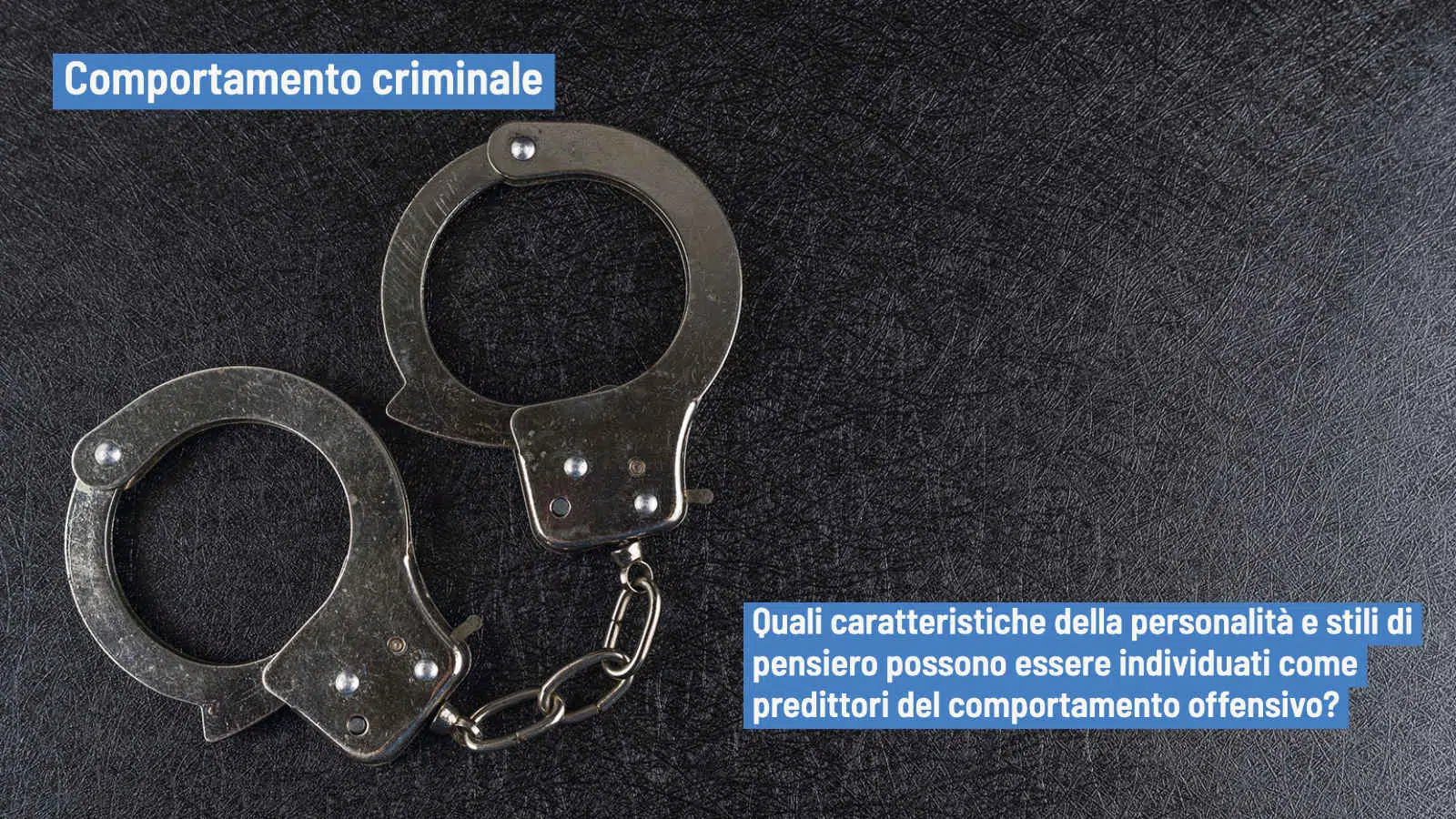La ricerca in psicologia ha indagato la personalità e gli stili di pensiero criminale insieme ad altre variabili psicosociali, per capire se possono essere individuati dei predittori del comportamento offensivo, tuttavia sono disponibili pochissimi studi.
Alcune persone sono inclini al crimine?
Lo stile di pensiero criminale è definito da Walters (2006) come “contenuto, materia e processo di pensiero che porta all’inizio e al mantenimento del comportamento caratterizzato dalla violazione abituale della legge”.
La personalità è definita come “un’unità dinamica, di quei sistemi psicofisici e sociali che determinano i modelli di comportamento, i pensieri e i sentimenti caratteristici della persona” (Allport, 1961).
Il Modello di personalità a tre fattori di Eysenck, descrive la vulnerabilità a commettere un crimine attraverso tre dimensioni della personalità:
- Psicoticismo, delinea individui aggressivi, egoisti e impulsivi;
- Nevroticismo, rappresenta individui preoccupati e tendenti agli sbalzi d’umore;
- Estroversione, descrive individui propensi a prendere parte ad attività sociali e alla continua ricerca di sensazioni nuove e intense.
Alti livelli di questi tratti si trovano solitamente negli individui con precedenti di reclusione (Caspi et al., 2006). Uno studio di Cauffman (2016) sui tratti della personalità psicopatologica, condotto su 130 maschi detenuti nelle carceri svedesi condannati per reati gravi, ha rilevato una correlazione tra criminalità e alcuni tratti quali impulsività, ostilità, aggressività, ricerca di sensazioni, tensione, stress e ansia sociale. Inoltre, altri studi collegano anche la dipendenza (ad es. di sostanze psicoattive, alcol, gioco d’azzardo) al comportamento delinquenziale (Brochu et al., 2001; Jennings et al., 2015; Lind et al., 2015). Come mostrato da Fehrman e collaboratori (2019) su 1885 intervistati (tossicodipendenti), tratti della personalità quali impulsività e ricerca di sensazioni sono più alti nei tossicodipendenti rispetto ai non consumatori. Tuttavia sono necessari ulteriori studi per testare le proposte di Eysenck.
Walters (1990) ha osservato che “i modelli di pensiero criminale possono essere definiti come integrazione di pensieri irrazionali negativi (errori di pensiero) e distorsioni della realtà (strategie di coping patologiche)”. L’autore ha suggerito che lo stile di pensiero criminale comporta processi decisionali che riflettono pensieri contrari alle norme sociali.
La personalità antisociale è il concetto che è stato utilizzato più spesso per riferirsi alla personalità criminale. Secondo Kruger et al. (2005), il disturbo antisociale di personalità è caratterizzato da disprezzo per gli altri, per le norme e per le regole. Di solito inizia durante l’infanzia o l’adolescenza e continua nella vita adulta.
Il modello dei sistemi duali di Steinberg (2008) dell’assunzione di rischi adolescenziali propone che l’aumento del comportamento a rischio durante la tarda infanzia e la prima adolescenza sia spiegato da un aumento della ricerca di sensazioni, dovuto al rimodellamento del sistema dopaminergico durante la pubertà, mentre la diminuzione del comportamento a rischio nella tarda adolescenza e nella prima età adulta è attribuibile alla diminuzione dell’impulsività sostenuta dallo sviluppo del sistema di controllo cognitivo del cervello. Il modello dei sistemi duali è stato usato anche per spiegare il crimine. In un’analisi longitudinale Burt, Sweeten e Simons (2014) hanno scoperto che l’impulsività e la ricerca di sensazioni erano associate a 11 diversi atti illegali. Anche altri lavori hanno mostrato che i tratti che spiegano il comportamento rischioso all’interno del modello dei sistemi duali sono associati a comportamenti problematici, incluso il crimine (Morgan e Lilienfeld, 2000; Ogilvie, Stewart, Chan e Shum, 2011). I comportamenti rischiosi e criminali condividono un aspetto: entrambi possono essere elettrizzanti e avere gravi conseguenze. Pertanto, ci aspetteremmo che sia i comportamenti criminali che quelli rischiosi siano più probabili tra gli individui con una maggiore ricerca di sensazioni e una maggiore impulsività. Altri autori hanno rilevato che tratti quali egocentrismo, narcisismo, machiavellismo, insensibilità, mancanza di empatia sono associati a problemi di condotta e comportamento criminale in campioni di comunità, clinici e forensi di diverse età (Dadds, Fraser, Frost , & Hawes, 2005; Frick & White, 2008; Kahn, Byrd, & Pardini, 2013; Pardini, Obradovic, & Loeber, 2006).
Criminalità e malattia mentale
L’opinione che esista una stretta connessione tra crimini violenti e malattia mentale è molto diffusa. Se è vero che a volte malattia mentale e criminalità sono contemporaneamente presenti è anche vero che nella maggior parte dei casi, malattia mentale e criminalità sono fenomeni del tutto indipendenti l’uno dall’altro. Dunque la possibilità di commettere reati riguarda tanto le persone mentalmente sane quanto quelle affette da disturbi psichiatrici (Greco et al., 2007). Come evidenziato da uno studio (Widiger & Sankis, 2000), la malattia mentale grave è spesso associata a disregolazione o discontrollo degli impulsi, rabbia, ostilità o aggressività, che in alcuni casi possono sfociare in comportamenti violenti più o meno gravi. Inoltre, alcuni soggetti durante un episodio psicotico acuto possono diventare violenti quando credono che qualcuno li stia minacciando, oppure certi soggetti durante un episodio maniacale diventano violenti o commettono un reato, perché incapaci di frenare un impulso irresistibile. Anche i disturbi di personalità antisociale, borderline, narcisistico, istrionico e paranoide, sembrano essere direttamente correlati ad alcune forme di comportamento criminale. Ma sono soprattutto le droghe e l’alcool ad essere direttamente responsabili di comportamenti criminali.
Swanson e coll. (2006) hanno esaminato un campione di 1410 individui affetti da schizofrenia reclutati in 56 luoghi differenti negli Stati Uniti, registrando un tasso di violenza pari al 19.1%, con un 3.6% di violenza grave (aggressione armata, violenza sessuale e violenza che aveva comportato lesioni alla vittima). I sintomi psicotici, in particolare l’ideazione paranoide, in combinazione con altri fattori, quali una storia di problemi della condotta nella fanciullezza, erano fortemente correlati ai comportamenti gravemente violenti. In uno studio condotto ad Istanbul, in cui sono stati esaminati 85 casi di figlicidio commessi tra il 1995 e il 2000, il 61% degli autori del crimine aveva una diagnosi di schizofrenia (in alcuni casi sotto il comando di una voce che indicava al genitore di uccidere il proprio figlio) (Karakus e coll., 2003). Alcuni studi inoltre hanno individuato come fattore di rischio la presenza in comorbidità di abuso di sostanze o di un disturbo di personalità (Andersen e coll., 1996; Côtè, Hodgins, 1990; 1992; Eronen, Hakola, Tiihonen, 1996 a; 1996 b; Hodgins, 1992; Hodgins, Côtè, 1993; Hodgins e coll., 1996; Karakus e coll., 2003; Lindqvist, Allebek, 1990; Modestin, Ammann, 1995; Räsänen e coll., 1998; Steadman e coll., 1998; Swanson, Holzer, Ganju, Jono, 1990; Swartz e coll., 1998; Volavka e coll., 1995). Per quanto riguarda invece la prevalenza di disturbi affettivi tra i detenuti, essa potrebbe essere reattiva alla condizione di detenzione. Infine, i disturbi d’ansia risultano non associati ad un rischio elevato di violenza (Greco et al., 2007).
Le credenze popolari, rinforzate anche dai mass media, si sono focalizzate sull’idea che esista una forte connessione tra malattia mentale e crimini violenti. Tuttavia l’associazione tra violenza e malattia mentale è solo in termini di maggiore rischio, ed è paragonabile al rischio riguardante l’associazione tra violenza e giovane età, basso livello di educazione e genere maschile (Link et al., 1992; Swanson et al., 1990) o rispetto ad altre caratteristiche socio-culturali (come livello di scolarità, appartenenza etnica o locazione urbana) e nettamente inferiore al rischio associato all’abuso di sostanze e al disturbo antisociale di personalità. Dunque è bene sottolineare che la maggioranza delle persone affette da disturbi mentali non commette violenza in misura maggiore rispetto alla popolazione generale (Greco et al., 2007).