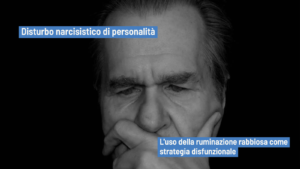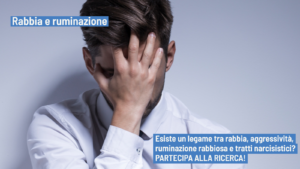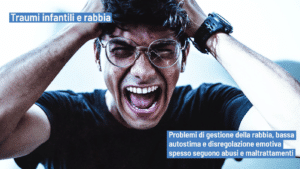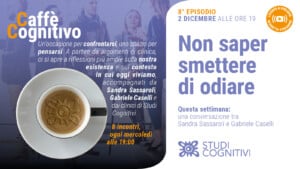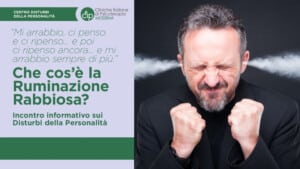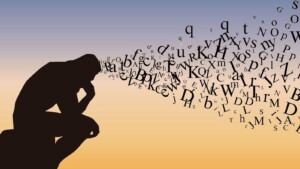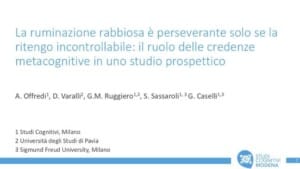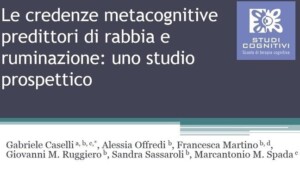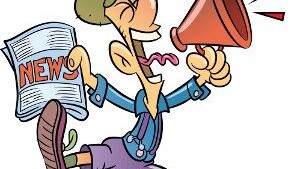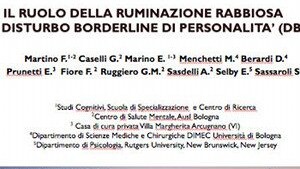Tracce del Tradimento Nr. 04 – Relazioni familiari & relazioni d’amore
RUBRICA TRACCE DEL TRADIMENTO – 04
Sosterremo una tesi forte, quella che il cercatore ha problemi personali e dolori antichi e in qualche misura indipendenti dalla storia amorosa, mentre chi lascia ha spesso da dire delle cose all’interno del rapporto, a chi sta cercando ossessivamente le tracce.
Possiamo cercare nel nostro passato la radice delle sofferenze d’amore del presente? E forse dei tradimenti che perpetriamo e che subiamo? Se nell’infanzia il proprio padre ha spesso avuto la tendenza a umiliare a urlare a rimproverare, e se non si trovano le risorse per cambiare strada, è facile trovare qualcosa di non diverso da un marito distante o maltrattante o alcolista, che rimprovera e che tratta male in modo continuativo. Se si è cresciuti con una madre insoddisfatta, critica, perfezionista e lontana si può diventare insoddisfatti, critici verso il proprio partner, freddi, distanzianti.
È altrettanto vero che la via che si sceglie non è prevedibile in modo matematico, influiscono risorse inaspettate (una maestra elementare affettuosa e vicina, un apparato genetico benevolo e favorente) oppure effetti negativi altrettanto inaspettati (un’irritabilità genetica, una scarsa tendenza al dialogo, una compagna di banco severa intransigente e invadente).
I figli apprendono le modalità emotive e affettive dai propri genitori e questo apprendimento viene modulato dall’apparato genetico del figlio e dalla sua struttura mentale ed emotiva.
Un genitore che umilia un figlio geneticamente irritabile e un figlio pauroso otterrà diverse reazioni e modalità affettive che possono andare da modalità impulsive autodistruttive e maltrattanti del figlio irritabile a modalità evitanti e controllanti del figlio pauroso.
Non vi è una matematica dell’intreccio gene/ambiente familiare/ambiente sociale, ma in terapia molte storie hanno una loro coerenza narrativa. E molte spiegazioni razionali si possono dare.
Noi sappiamo bene che una parte di queste sofferenze attiene al nostro essere della razza umana, capaci di ricordi, desideri, memoria e tormento. In terapia incontriamo spesso una qualità del dolore esagerata, ossessiva, ripetitiva e autodistruttiva.
La tendenza di alcune persone ad amare in modo ripetitivo e procurandosi sofferenze estreme, persone indegne d’amore, o ambigue o assenti o addirittura maltrattanti è da ormai qualche decennio studiata e ben approfondita dai ricercatori delle relazioni. Dove si dice che è in un’infanzia con relazioni difficili, o con genitori complessi o umilianti o maltrattanti che s’impara a conoscere l’asprezza e l’eccesso della passione e dell’amore verso persone, che come i genitori, non rispondono con altrettanto affetto, o non desiderano condividere un progetto solidale. Ma ovviamente mai nessuno è puramente vittima, perché queste vittime di amanti ambigui spesso sono insistenti, ossessionanti o maltrattanti, e nessuno (a parte rari casi di resa in schiavitù) è del tutto un persecutore.
Noi non vorremmo occuparci però di questi aspetti già ampiamente raccontati in letteratura , ma del tradimento in un suo aspetto -a nostro giudizio intrigante e pieno di suggestioni- che è quello di chi cerca o lascia tracce del proprio tradimento.
Sosterremo una tesi forte, quella che il cercatore ha problemi personali e dolori antichi e in qualche misura indipendenti dalla storia amorosa, mentre chi lascia ha spesso da dire delle cose all’interno del rapporto, a chi sta cercando ossessivamente le tracce.
Carlo era cresciuto in una famiglia disgregata e poco disponibile, spesso veniva lasciato in collegio e abbandonato a se stesso. Una delle ragazze che facevano le pulizie aveva dimostrato un certo affetto e una tenerezza verso di lui. Aveva pena per quel ragazzone sempre solo che giocava al computer a videogiochi di guerra. Lui si era innamorato e la storia era cominciata, lei aveva 20 anni e lui 17. All’inizio si erano consolati e fatti compagnia, lei veniva da una situazione familiare dolorosa, sua madre era morta e suo padre era violento e litigioso umiliandola spesso e sminuendo l’aiuto che cercava di dare in casa.
Dopo un poco di tempo lui aveva cominciato a fare sogni di vita insieme e si era legato a lei in una relazione piena di pretese, spesso mostrandosi prepotente e invadente.
Voleva sposarla subito, e quando uscì dal collegio per fare il muratore le propose di andare a vivere insieme. Sembrava poco consapevole dei desideri di lei e alle sue resistenze si faceva fosco e preoccupato e accusante. Lei alla fine cominciò a distanziarlo. La relazione si andava facendo dura e troppo piena di rimproveri reciproci, lei aveva voglia di leggerezza e stava cominciando a frequentare persone nuove e a sognare di lasciare la casa del padre per cambiare città.
Un giorno lui andò a trovarla a casa e vide la bicicletta di un suo amico appoggiata al portone. Lui fu immediatamente certo del tradimento, entrò a cercarla e non trovandola a casa cominciò a vagare per il paese in preda alla furia.
Vide due suoi conoscenti che chiacchieravano dandogli le spalle e interpretò questo comportamento come un segno di un complotto ai suoi danni per lasciarlo da solo, umiliarlo e riportarlo alla vita orrenda alla quale non voleva tornare. Entrò nel bar e trovò che la ragazza stava bevendo con un amico incontrato per caso. Le saltò al collo tentando di ucciderla e soltanto la velocità e la forza di un ragazzo presente la salvarono, lei già a terra e in preda a difficoltà respiratorie. Lui si fece bloccare a fatica ma cominciò a urlare dicendo che per colpa di lei la sua vita era rovinata e che voleva suicidarsi. Afferrò un coltello e se lo puntò al collo. Soltanto la guardia psichiatrica e la presenza d’animo dei presenti che non si lasciarono intimorire e lo bloccarono gli salvò la vita. E soltanto un lungo ricovero gli permise di capire la sua situazione e tentare nel tempo di costruirsi una nuova vita.
Questo caso è particolarmente grave ed è finito bene per una serie di circostanze casuali: la ragazza non era sola, nel bar vi erano altre persone vivaci e presenti, e forse una titubanza nell’usare il coltello contro di sé permise al ragazzo di sopravvivere. Spesso però non è così.
Queste tragedie della vita finite per colpa di una cieca gelosia e di una radicale impossibilità a immaginare la propria vita senza l’altro sono abbastanza frequenti, spesso con il coinvolgimento di figli che vengono uccisi “per fare dispetto all’altro”.
BIBLIOGRAFIA:
- Bowlby, J. (1988). A Secure Base. Routledge, Londra. Una base sicura. Tr. it. Raffaello Cortina Editore, Milano, 1989.