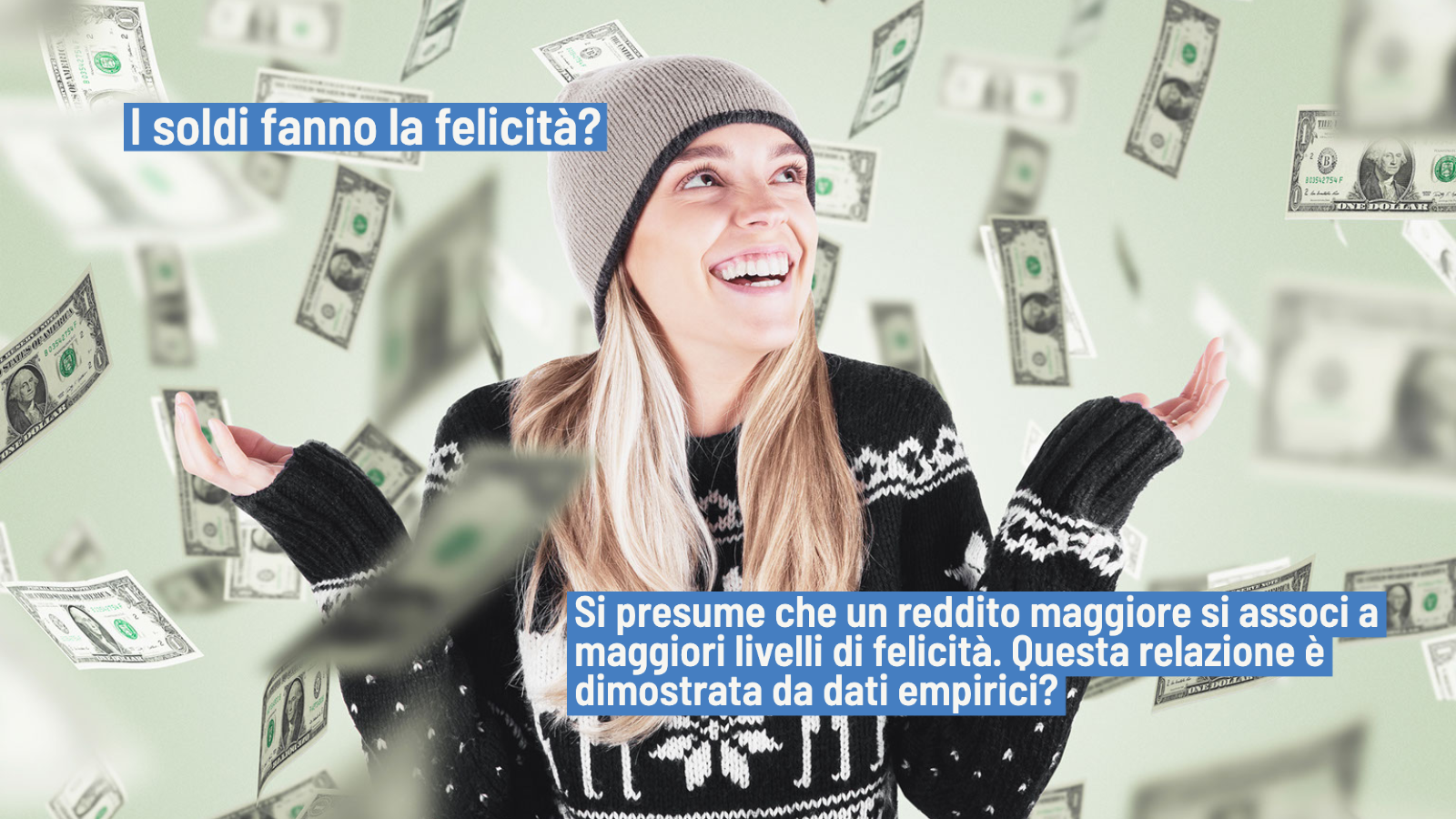Stando a quanto riportato dalla letteratura scientifica, un reddito (income) elevato, quindi una maggiore ricchezza, predice livelli elevati di felicità, ma con un’utilità marginale decrescente (Dolan et al., 2008).
Ricchezza e felicità nel senso comune
Ricchezza è sinonimo di felicità? La risposta a questa domanda ha implicazioni non solo sulle modalità con cui il singolo individuo conduce la propria esistenza, ma anche sulle strutture attorno alle quali intere società vengono organizzate. Nel senso comune, si presume che un reddito maggiore porti con sé una maggior felicità, qui intesa in senso lato come l’accumulo di sentimenti edonici, pur riconoscendo l’esistenza di costrutti similari, quali la soddisfazione e l’eudaimonia (Angner, 2010; Dolan e Kudrna, 2016). Non è un caso che in gran parte delle società contemporanee, la ricchezza venga incoraggiata e valorizzata, mentre la povertà rappresenti un motivo di esclusione, stigmatizzazione e discriminazione. Un reddito individuale elevato offre a chi lo possiede maggiori opportunità di consumo e quindi un numero più alto di occasioni in cui poter soddisfare le proprie preferenze e i propri desideri, fino a ottenere di più di ciò che si desidera o di quanto si ha effettivamente bisogno (Harsanyi, 1997; Nussbaum, 2008); aspetto della vita che risulta invece precluso ai meno abbienti. Per questa ragione si presume che un reddito maggiore si associ a maggiori livelli di felicità e, viceversa, che un reddito minore si associ a minori livelli di felicità. Ma questo è stato dimostrato in termini empirici? Cosa dice la scienza in merito?
Evidenze empiriche sulla relazione tra ricchezza e felicità
Stando a quanto riportato dalla letteratura scientifica, un reddito (income) elevato predice livelli elevati di felicità, ma con un’utilità marginale decrescente (Dolan et al., 2008), cioè le variabili reddito e felicità sono maggiormente associate tra loro se rilevate in un campione avente un reddito basso, mentre risultano minormente associate tra loro se rilevate in un campione avente un reddito elevato (Layard et al., 2008). Tuttavia, è necessario tenere a mente che la relazione tra reddito e felicità dipende fortemente dal modo in cui la felicità viene concettualizzata e misurata. A tal proposito, il premio Nobel per l’economia Daniel Kahneman (2004) ha dimostrato che il possesso di un reddito elevato si associava ad una migliore valutazione complessiva della vita, ma non a livelli più elevati di benessere emotivo. Questa relazione appariva statisticamente significativa solo per quei residenti negli Stati Uniti d’America aventi un reddito annuo inferiore ai 75’000 $. Al contrario, coloro che possedevano un reddito annuo superiore ai 75’000 $ mostravano sì una miglior valutazione complessiva della propria vita, ma non un maggior benessere emotivo (Kahneman & Deaton, 2010). A livello statistico, si era verificato un mero effetto tetto, si è giunti a un punto in cui la variabile indipendente, il reddito annuo, non produceva più alcun effetto sulla variabile dipendente, la felicità.
Tuttavia, in una ricerca successiva, Killingsworth (2021) ha dimostrato come ricchezza e felicità fossero significativamente associate non solo in soggetti aventi un reddito annuo inferiore a 75’000 $, ma anche in individui con reddito annuo maggiore di 75’000 $. Interessanti sono infine i risultati ottenuti da Jebb et al. (2018), i quali hanno osservato il medesimo effetto tetto riscontrato da Kahneman & Deaton (2010) anche in altri paesi, tra cui Australia, Nuova Zelanda, Norvegia, Svezia, Danimarca e Finlandia. In aggiunta, Jebb et al. (2018) hanno evidenziato persino alcuni “punti di svolta” (“turning points”), in cui le persone più ricche arrivavano a valutare la propria vita in maniera peggiore rispetto ai meno abbienti. Questi risultati contrastanti potrebbero essere frutto delle diverse modalità di analisi dei dati impiegate nei vari studi, ma la relazione tra ricchezza e felicità resta comunque un tema degno di ulteriori approfondimenti.
Delay discounting e felicità: una prospettiva futura per la ricerca
Premesso che ricchezza e felicità siano positivamente associate, è lecito chiedersi se esistano delle variabili, o meglio dei meccanismi, che contribuiscono ad alterare la natura di questa relazione. Il delay discounting può essere senz’altro uno di essi. Si tratta di una funzione cognitiva tale per cui il valore che un individuo fornisce ad una ricompensa, per esempio a una certa quantità di denaro, tenda a decrescere progressivamente nel corso del tempo (Odum, 2011). Questo fenomeno è stato osservato sia nell’essere umano che in svariate specie animali ed è stato dimostrato che in esso siano coinvolti molteplici circuiti cerebrali, soprattutto a livello della corteccia prefrontale (Frost, 2017; Moro et al., 2023). La ricerca ha messo in luce come una rapida svalutazione della ricompensa si associ a una cattiva gestione finanziaria, nonché a dei livelli inferiori di benessere emotivo (Hamilton & Potenza, 2012; Kennedy, 2020). Per questa ragione è possibile ipotizzare che il delay discounting rappresenti un mediatore della relazione tra reddito e felicità, anche se ciò resta da ancora dimostrare.