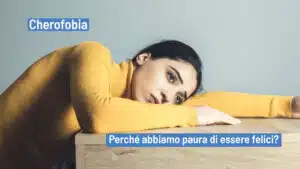A quale età siamo più felici?
Il tema della felicità ha storicamente attratto filosofi – da Aristotele a Platone, da Schopenhauer a Nietzsche – economisti, statistici e psicologi. Tuttavia, la risposta all’interrogativo sulla possibile relazione tra età e felicità sembra ancora controversa (Blanchflower & Oswald, 2008). Diversi studi hanno infatti provato a spiegare cosa accade alla felicità man mano che invecchiamo.
Facciamo un passo indietro. Che cos’è la felicità? E com’è definita nel campo della ricerca psicologica?
La felicità secondo la psicologia
Nel dominio della psicologia, sono state elaborate varie definizioni della felicità.
Attualmente, la ricerca in campo psicosociale intende la felicità come sinonimo di benessere soggettivo, un costrutto che racchiude una componente cognitiva, ovvero la valutazione della soddisfazione generale di vita, e una componente affettiva distinta in emozioni positive ed emozioni negative sperimentate (Kahneman et al., 1999; Veenhoven, 2012). Il benessere affettivo include quello che i teorici chiamano positive affect, tradotto alla lettera “affetto positivo”, vale a dire la frequenza e l’intensità delle emozioni positive, tra cui sentirsi coinvolti, attenti, gioiosi, e il negative affect, espresso come frequenza e intensità di emozioni negative, ad esempio sentirsi spaventati, arrabbiati o tristi (Buecker et al., 2023). I principali avvenimenti della vita sembrano impattare maggiormente e in modo più duraturo sulla componente cognitiva del benessere soggettivo, mentre tratti di personalità, come estroversione e nevroticismo, correlano maggiormente con il benessere affettivo. Il benessere cognitivo, al contrario, tende a essere legato a circostanze di vita come il reddito e la posizione lavorativa (Soto, 2015; Luhmann, Hofmann et al., 2012; Tov, 2018)
La branca della psicologia positiva ha aggiunto alle tre precedenti un’ulteriore componente, cosiddetta eudaimonica, relativa al significato e allo scopo di vita (Heintzelman & King, 2014; Lyubomirsky, 2007).
Perché studiare la felicità
L’interesse della scienza per come cambia la felicità nel corso della vita degli esseri umani nasce dalla stretta connessione riscontrata tra felicità, intesa come si è detto in termini di benessere soggettivo, e altri indici ritenuti essenziali per lo sviluppo di un Paese. Ad esempio, il benessere soggettivo predice la salute e la longevità delle persone. In altri termini, più siamo felici, più siamo in salute e viviamo a lungo (Diener & Chan, 2011; Howell et al., 2007). Non solo, il benessere soggettivo è considerato tra gli indicatori di ricchezza di una nazione e, per molti governi, rappresenta il punto di partenza per le decisioni politiche (Diener et al., 2015).
Se la ricerca della felicità (pursuit of happiness) è menzionata all’interno della Dichiarazione d’Indipendenza degli Stati Uniti d’America come diritto inalienabile dell’uomo, comprendere come il livello di felicità cambi in funzione dell’età, permetterebbe alla ricerca di individuare quali fasce della popolazione sono maggiormente esposte al rischio di riduzione del benessere soggettivo, con le annesse conseguenze relative, favorendo interventi di sostegno e promozione (Buecker et al., 2023).
Felicità e arco di vita
Quale traiettoria assume la felicità nel corso della vita?
Per alcuni studi condotti su campioni nordamericani ed europei, la felicità sembra seguire una traiettoria a U, diminuendo dall’infanzia all’età adulta, raggiungendo il suo minimo tra i 40 e i 50 anni, per poi risalire nuovamente (Blanchflower & Oswald, 2008; Blanchflower & Graham, 2001). Numerosi dibattiti di natura metodologica hanno smentito questa ipotesi, suggerendo che la traiettoria a U fosse relativa alle sole dimensioni di soddisfazione di vita e affetto positivo, tralasciando il negative affect (Buecker et al., 2023).
Secondo la teoria del set point, invece, la felicità rappresenterebbe una condizione piuttosto stabile ed immutabile nella vita, determinata al 50% da un’ereditarietà genetica. In tale ottica, eventi salienti della vita, come matrimonio, nascita dei figli, divorzio, perdita del lavoro, possono portare a temporanei aumenti o diminuzioni del benessere soggettivo; tuttavia, meccanismi psicologici di omeostasi riportano il benessere a un livello stabile, il set point appunto (Brickman & Campbell, 1971).
Per altri autori, l’adolescenza potrebbe rappresentare un periodo di drastico ma temporaneo calo della felicità. Secondo l’ipotesi della disruption, infatti, gli adolescenti – in particolare le ragazze – mostrerebbero una flessione di alcuni tratti socialmente desiderabili della personalità, come estroversione e stabilità emotiva, favorendo all’opposto un aumento delle emozioni negative e minore benessere soggettivo in generale (Soto & Tackett, 2015).
Di converso, la teoria della selettività socio-emotiva suggerisce che quando gli orizzonti temporali sono percepiti come lunghi e ampi (come accade nella prima età adulta), le persone sono più motivate a perseguire obiettivi legati alla conoscenza (viaggi, nuove esperienze ecc.) e alla socializzazione; al contrario, quando gli orizzonti futuri sono percepiti più brevi e limitati nel tempo, come in età avanzata, si tende a valorizzare obiettivi emotivamente significativi, selezionando esperienze che massimizzino le emozioni positive e assaporando il presente attraverso contesti e stimoli “sicuri” (Carstensen et al., 2003; Carstensen et al., 1999).
Dunque, si diventa più felici invecchiando?
Una recente meta-analisi ha confrontato i risultati di 443 studi che esplorano la relazione tra felicità e arco di vita, scomponendo il concetto di felicità nei suoi tre aspetti di soddisfazione di vita, affetto positivo e affetto negativo (Buecker et al., 2023). I risultati sono stati suddivisi dai ricercatori in quattro età della vita: infanzia e adolescenza (fino a 18 anni), giovane età adulta (18-40 anni), età adulta media (40-65 anni) e tarda età adulta (oltre 65 anni).
Felicità in infanzia e adolescenza
Soddisfazione di vita ed emozioni positive mostrano una diminuzione dai 9 ai 18 anni, con un calo dell’affetto positivo che si protrae fino a tarda età adulta. In parallelo, le emozioni negative tendono ad aumentare dai 12 ai 22 anni. L’adolescenza costituirebbe un periodo di minore felicità, stando agli autori. Le ragioni potrebbero risiedere negli innumerevoli cambiamenti fisici, sociali, psicologici associati all’adolescenza, nei compiti evolutivi tipici di questa età, come il passaggio all’indipendenza, che potrebbero porre gli adolescenti di fronte a sfide emotive in grado di far sperimentare minore felicità.
Giovane età adulta
Questa età è denominata “ora di punta della vita” (Zannella et al., 2019), in quanto comporta sfide e compiti multipli e contrastanti. Ad esempio, fare scelte oculate per il proprio percorso di studi, la carriera lavorativa, le relazioni sentimentali e l’eventuale formazione di una famiglia. Tali compiti evolutivi simultanei possono tradursi in stress, con conseguente diminuzione del benessere emotivo. Al contempo, raggiungere i primi traguardi di vita (ad esempio, la stabilità finanziaria, la famiglia ecc.) contribuiscono a un miglior controllo percepito dagli individui, più soddisfazione generale di vita e minore affetto negativo.
Età adulta media
La ricerca rivela che questa età è caratterizzata da elevata soddisfazione di vita e minori affetto negativo e positivo. Il benessere emotivo, pertanto, sembra diminuire, probabilmente a causa del ridimensionamento delle reti sociali delle persone.
Tarda età adulta
In tale fase, la soddisfazione di vita e l’affetto positivo diminuiscono, mentre l’affetto negativo aumenta. Cosa significa? Gli adulti più anziani sono in genere soggetti a maggiori perdite in ambiti importanti della loro vita, dalla salute ai rapporti sociali, valutando la loro vita meno soddisfacente e sperimentando maggiori fragilità. Altri studi, inoltre, aggiungono che gli stereotipi negativi sull’età e la discriminazione percepita in base all’età possono interferire con il benessere psicofisico degli anziani (Kornadt & Rothermund, 2011 ; Kotter-Grühn & Hess, 2012 ; Wurm et al., 2017 ).
Generalizzando i risultati esposti, possiamo concludere che la felicità, intesa come benessere soggettivo, cresce in termini di soddisfazione, con meno frequenti e meno intense emozioni negative, dalla fine dell’adolescenza fino ai 70 anni circa. Al contrario, dopo l’adolescenza si sperimentano tendenzialmente meno emozioni positive.
Come sostiene la psicologa V. LoBue, docente alla Rutgers University-Newark, potremmo provare meno gioia crescendo, ma possiamo avere tutti la speranza che la felicità tornerà da noi quando invecchieremo.