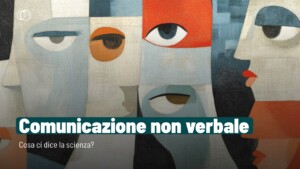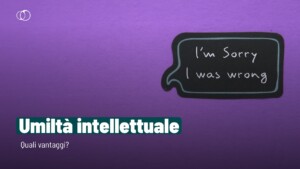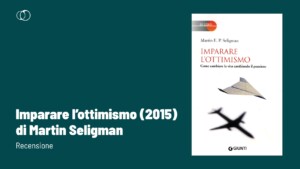Le strategie di Coping e l’ottimismo – Psicologia
 Gli orientamenti più recenti considerano il coping come un processo che nasce da interazioni che superano o sfidano le risorse di un soggetto e che è formato da molteplici componenti, quali la valutazione cognitiva degli eventi, le reazioni di disagio, le risorse personali e sociali, etc.
Gli orientamenti più recenti considerano il coping come un processo che nasce da interazioni che superano o sfidano le risorse di un soggetto e che è formato da molteplici componenti, quali la valutazione cognitiva degli eventi, le reazioni di disagio, le risorse personali e sociali, etc.
La storia delle ricerche sul coping è contrassegnata dal continuo confrontarsi e alternarsi di due distinti approcci, uno che enfatizza il ruolo dei fattori disposizionali e l’altro che sottolinea invece il ruolo dei fattori situazionali.
Il coping, inteso come l’insieme di strategie mentali e comportamentali che sono messe in atto per fronteggiare una certa situazione, è stato tradizionalmente considerato come una caratteristica piuttosto stabile di personalità. In seguito le modalità di coping sono state analizzate come reazioni flessibili e mutevoli a sfide normative o a eventi di vita quotidiana stressanti.
Gli orientamenti più recenti considerano il coping come un processo che nasce da interazioni che superano o sfidano le risorse di un soggetto e che è formato da molteplici componenti, quali la valutazione cognitiva degli eventi, le reazioni di disagio, le risorse personali e sociali, etc.
Questi processi sono considerati ciclici e cumulativi, pertanto le diverse componenti si modellano reciprocamente nel tempo e gli esiti ottenuti di volta in volta influenzano il repertorio e le risorse di coping disponibili all’individuo per negoziare le successive interazioni e situazioni stressanti.
La prima generazione di ricercatori sul coping concentrò gli sforzi e gli interessi a identificare e studiare solo alcune risposte di coping di base, anche se potenzialmente ogni soggetto ha a disposizione un numero illimitato di strategie. In particolare furono identificate due dimensioni principali: le strategie centrate sul problema (problem-focused), quali ad esempio adoperarsi per modificare la situazione prevenendo o riducendo la fonte dello stress, e quelle centrate sulle emozioni (emotion-focused), volte a ridurre i disturbi affettivi e psicologici che accompagnano la percezione dello stress, come prendere le distanze dalla situazione, cercare un sostegno sociale. Un’ulteriore dimensione fu poi identificata, si tratta della strategia orientata all’evitamento (avoidance-oriented), che prevede comportamenti quali la fuga di fronte alla situazione stressante.
All’interno di questo quadro, una strategia di grande interesse riguarda il coping proattivo, attuato cioè prima di incontrare eventuali eventi stressanti.
Aspinwall e Taylor, nello specifico, hanno posto in evidenza che l’attuazione del coping proattivo ha importanti benefici per la persona, in quanto minimizza l’ammontare complessivo di stress che il soggetto potrebbe incontrare, aumenta il numero di opzioni possibili per affrontare una situazione e consente infine di preservare risorse personali, come tempo ed energia, agendo preventivamente.
Nonostante le controindicazioni che si possono verificare, per esempio l’evento stressante potrebbe anche non verificarsi mai, i vantaggi per chi mette in atto forme proattive di coping sono indubbiamente elevati. Il coping di tipo preventivo più efficace è sempre attivo, e può esprimersi sia con attività cognitive come la pianificazione, sia comportamentali, come l’intrapresa di un’iniziativa. Il grado in cui il coping proattivo può essere attuato è moderato dall’ambiente immediato e dal carico cognitivo che comporta, dall’esperienza passata e dalle opportunità avute in precedenza di esercitare l’abilità di questo tipo di coping. Questa prospettiva pone particolare attenzione sui due aspetti principali capaci di influenzare il coping e la gestione dell’attivazione emotiva.
Da un lato c’è il ruolo delle differenze individuali come l’ottimismo, la repressione o le credenze di controllo sugli eventi; dall’altro gli aspetti ambientali che rendono più o meno probabile l’apprendimento efficace e la realizzazione dei compiti proattivi, quali le risorse, le richieste e il carico cognitivo o il peso cronico. Ne emerge che quanto le persone imparano durante la gestione degli stress e come affrontano l’attivazione emozionale scaturita dalla percezione di un possibile evento negativo influenza le modalità con cui saranno affrontate le situazioni stressanti successive. Questa proposta di Aspinwall e Taylor punta inoltre a valorizzare il coping attivo. Infatti, mentre inizialmente il coping attivo era considerato positivo per gli eventi stressanti soggetti a cambiamento e il coping di evitamento era più utile nel caso di eventi incontrollabili, in realtà l’uso continuato di strategie di evitamento si rivela un fattore di rischio, in quanto non produce nuove informazioni sui problemi e compromette alcune risorse come il sostegno sociale.
Nell’ambito della psicologia del benessere, le strategie di coping messe in atto nell’affrontare gli eventi stressanti della vita quotidiana sono state approfondite con lo scopo di mettere in luce eventuali differenze tra ottimisti e pessimisti. In generale si potrebbe dire che l’esperienza affligge meno gli ottimisti rispetto ai pessimisti quando questi hanno a che fare con delle difficoltà nella loro vita.
Questo tipo di differenze non è solo dovuto al livello di ansia presente prima di incontrare una situazione stressante, bensì è principalmente dovuto alle diverse strategie che ottimisti e pessimisti mettono in atto nel far fronte agli eventi. Innanzitutto, le persone che hanno più fiducia nel futuro, come gli ottimisti, producono uno sforzo continuo, anche quando si trovano di fronte a gravi avversità. Viceversa, le persone più dubbiose e preoccupate nei confronti del futuro tendono a provare ad allontanare da sé o a evitare le avversità. In questo senso, i pessimisti tendono principalmente a compiere azioni che diano loro temporanee soluzioni o distrazioni, che in realtà non li aiutano a risolvere il problema.
Sembrerebbe dunque che l’ottimismo porti a una più frequente focalizzazione sul problema, con un impegno prevalente di strategie problem-focused, piuttosto che emotion-focused.
Questa ipotesi, tuttavia, è stata confermata solo parzialmente sul piano empirico. Infatti, nonostante ci sia evidenza del fatto che i soggetti ottimisti ricorrano maggiormente a strategie problem-focused, in letteratura sono presenti anche ricerche che mettono in evidenza un’associazione tra ottimismo e strategie emotion-focused sia di segno positivo, sia di segno negativo.
Gli ottimisti dunque non solo usano strategie di coping centrate sul problema, ma anche differenti tecniche centrate sulle emozioni, inclusi gli sforzi per accettare la realtà di situazioni difficili e per metterle sotto la miglior luce possibile. Questo indica che gli ottimisti possono trarre dei vantaggi nel coping, rispetto ai pessimisti, anche nelle situazioni che non possono essere modificate.
Altri ricercatori hanno indagato le differenze nelle disposizioni in merito ai diversi stili di coping tra pessimisti e ottimisti. Come per gli stili situazionali, gli ottimisti mostrano una tendenza disposizionale alle risposte attive, al coping centrato sul problema e si dimostrano più portati alla pianificazione quando affrontano eventi stressanti. I pessimisti, invece, tendono maggiormente ad abbandonare l’obbiettivo che stavano perseguendo, con cui l’evento stressante interferisce.
Sebbene poi gli ottimisti si caratterizzino per la tendenza ad accettare la realtà, essi provano comunque a vedere il meglio anche nelle situazioni peggiori e a imparare sempre qualcosa anche dagli eventi stressanti. Al contrario, i pessimisti riportano la tendenza a rifiutare palesemente la situazione e ad abusare di sostanze: strategie che diminuiscono la loro consapevolezza del problema. Quindi, in termini generali, si può sostenere che gli ottimisti si caratterizzino principalmente per stili di coping attivi, laddove i pessimisti appaiono maggiormente evitanti.
Questi risultati sono stati anche confermati da una meta-analisi condotta da Nes e Segerstrom, la quale ha messo in evidenza come i soggetti ottimisti si distinguano dai pessimisti per l’impiego di modalità di regolazione attiva (approach coping), piuttosto che evitante (avoidance coping), differenza che si riscontra sia per le strategie problem-focused sia per quelle emotion-focused.
Altri studi hanno inoltre indagato il rapporto tra l’ottimismo e gli stili di coping in contesti specifici. Ad esempio, Strutton e Lumpkin hanno approfondito le loro ricerche nell’ambito lavorativo. Dai risultati da loro ottenuti è emerso che gli ottimisti sono soliti utilizzare strategie centrate sul problema, come la risoluzione diretta del problema, più dei pessimisti. Questi ultimi, ancora una volta, si sono invece caratterizzati per la messa in atto di strategie evitanti.
Tutti questi risultati sono in linea con il quadro concettuale dell’ottimismo disposizionale in cui le aspettative positive portano a un maggiore coinvolgimento e a una maggiore persistenza nel raggiungimento dei propri obiettivi. Allo stesso modo, aspettative negative, come quelle dei pessimisti, conducono a un minore coinvolgimento e a una maggiore desistenza.
Queste associazioni emerse tra ottimismo e strategie di coping non sembrano essere dovute solo al modo in cui ottimisti e pessimisti valutano gli eventi. In questa ottica Chang ha recentemente esaminato l’impatto dell’ottimismo e delle valutazioni della situazione sulle strategie adottate nel fronteggiare uno stimolo stressante come un esame di ammissione a un corso. Nei casi da lui osservati, gli ottimisti non si distinguevano dai pessimisti nella valutazione primaria dell’evento, bensì nelle valutazioni secondarie. Gli ottimisti, cioè, percepivano l’esame come un evento maggiormente controllabile e i loro sforzi per tentare di fronteggiarlo risultavano più efficaci di quanto non fossero quelli dei pessimisti.
LEGGI ANCHE:
PSICOPATOLOGIA DELLA VITA QUOTIDIANA – STRESS – PSICOLOGIA SOCIALE
BIBLIOGRAFIA:
- Anolli, L. (2005). L’ottimismo. Bologna: Il Mulino.
- Aspinwall, L. G., & Taylor, S. E. (1997). A stitch in time: Self-regulation and proactive coping. Psychological Bulletin, 121, 417-436.
- Billingsley, K. D., Waehler, C. A., & Hardin, S. I. (1993). The stability of optimism and choice of coping strategy. Perceptual and Motor Skills, 76, 91-97.
- Carver, C. S., Scheier, M. F., & Weintraub, J. K. (1989). Assessing coping strategies: A theoretically based approach. Journal of Personality and Social Psychology, 56, 267-283. (DOWNLOAD)
- Chang, E. C. (1998). Distinguishing between optimism and pessimism: A second look at the “optimism neuroticism hypothesis”. In R. R. Hoffman, M. F. Sherrik, & J. S. Warm (Eds.), Viewing Psychology as a whole: The integrative science of William N. Dember (pp. 415-432). Washington, DC: American Psychological Association.
- Eckenrode, J. (1991). The social context of coping. New York: Plenum.
- Fontaine, K. R., Manstead, A. S., & Wagner, H. (1993). Optimism, perceived control over stress, and coping. European Journal of Personality, 7(4), 267-281.
- Lazarus, R. S., Averill, J. R., & Opton, E. M. (1974). The Psychology of Coping: Issue of Research and Assessment. In G. V. Coelho, D. A. Hamburg, & J. E. Adams (Eds.). Coping and Adaptation, Basic Books, New York.
- Scheier, M. F., & Carver, C. S. (1986). Coping with stress: Divergent strategies of optimism and pessimism. Journal of Personality and Social Psychology, 51, 1257-1264.
- Scheier, M. F., Carver, C. S., & Bridges, M., W. (2000). Optimism, Pessimism, and Psychological Well-being. In C. E. Chang (Ed.), Optimism & Pessimism. Indications for theory, research, and practice (pp.189-216). Washington: American Psychological Association.
- Segerstrom, S.C., Solberg Nes, L. (2007). Heart rate variability indexes self-regulatory strength, effort, and fatigue. Psychological Science, 18, 275-281.
- Skinner, E. A., & Edge, K. (1998). Reflections on coping and development across the lifespan. International Journal of Behavioral Development, 22, 357-366. (DOWNLOAD)
- Strutton, D., & Lumpkin, J. (1992). Relationship between optimism and coping strategies in the work environment. Psychological Reports, 71(3), 1179-1186.
- Suls, J., & Flechter, B. (1985). The relative efficacy of avoidant and nonavoidant coping strategies: A meta-analysis. Health Psychology, 4, 249-288.





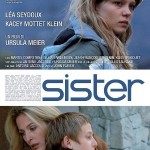


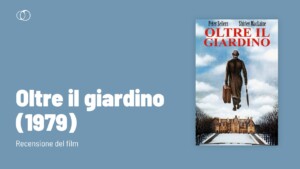
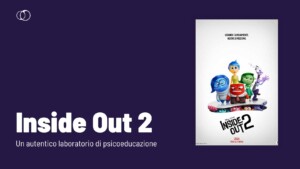
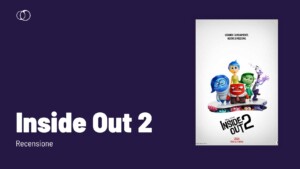
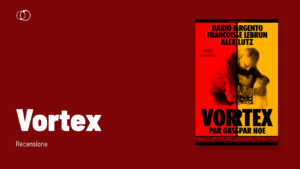

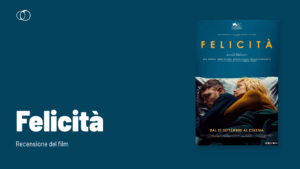

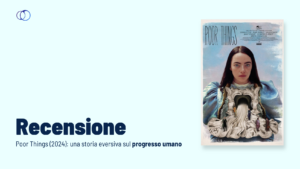
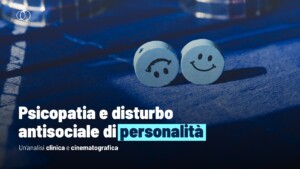
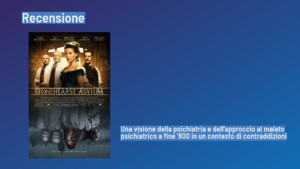
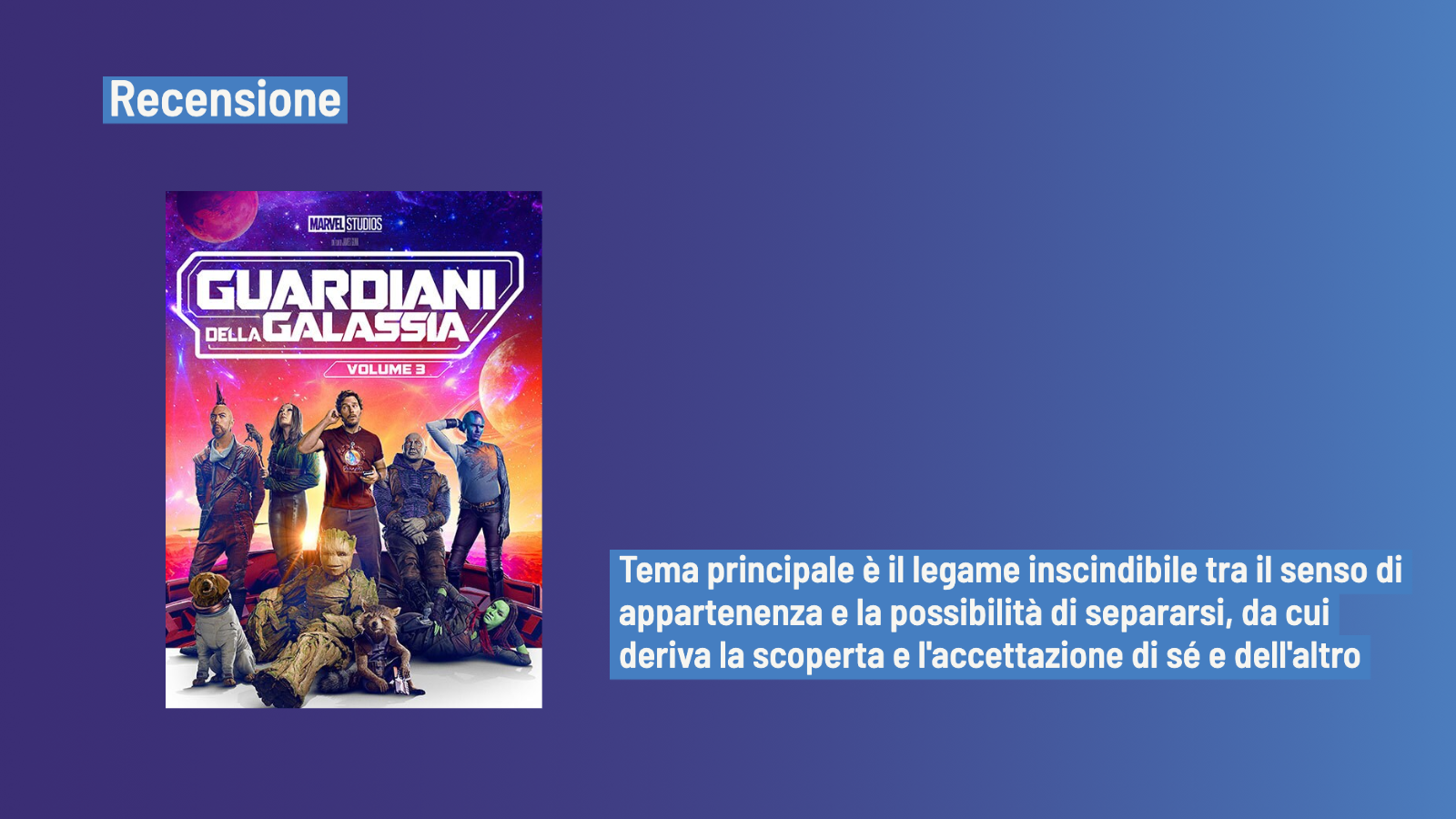
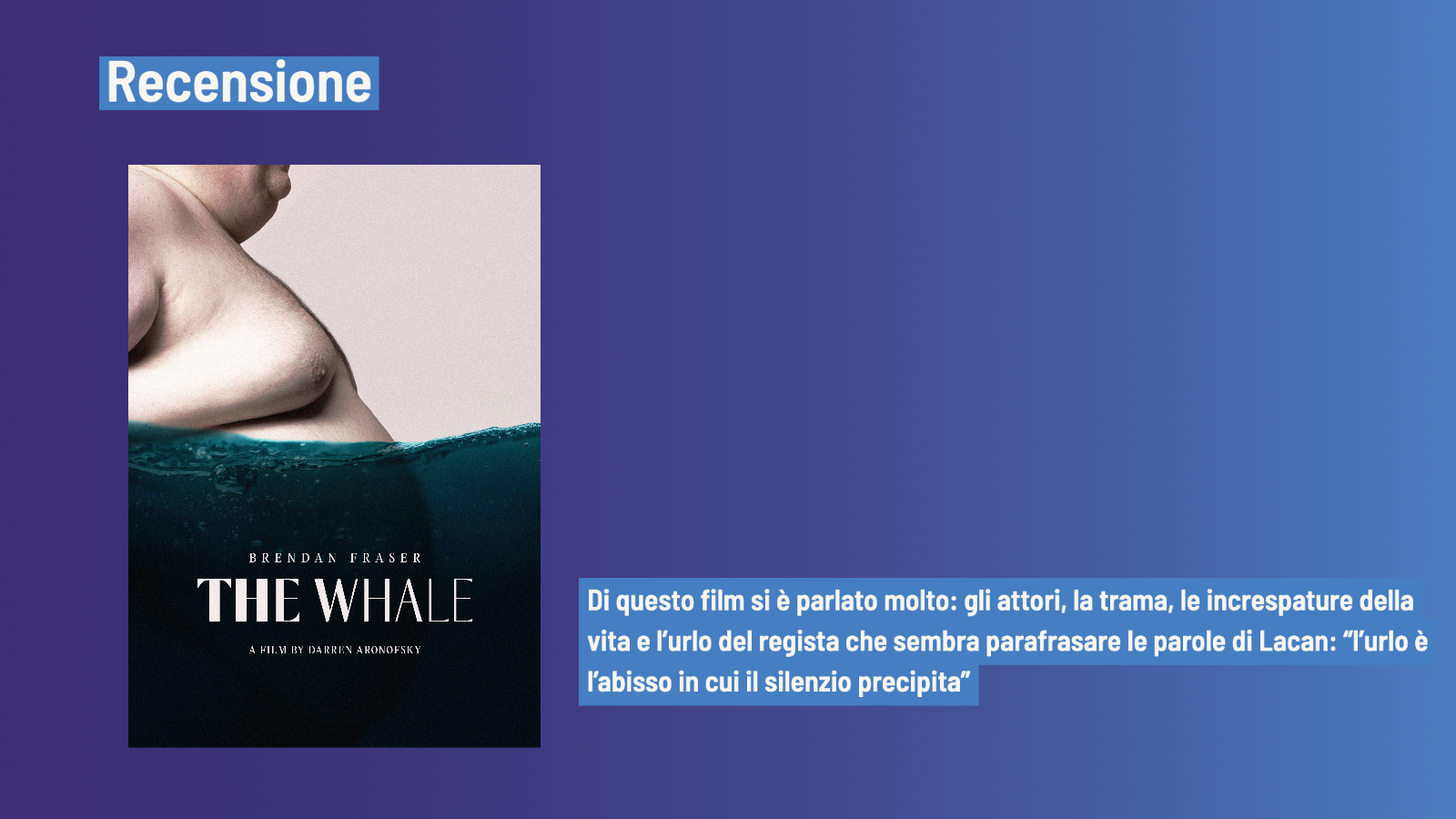
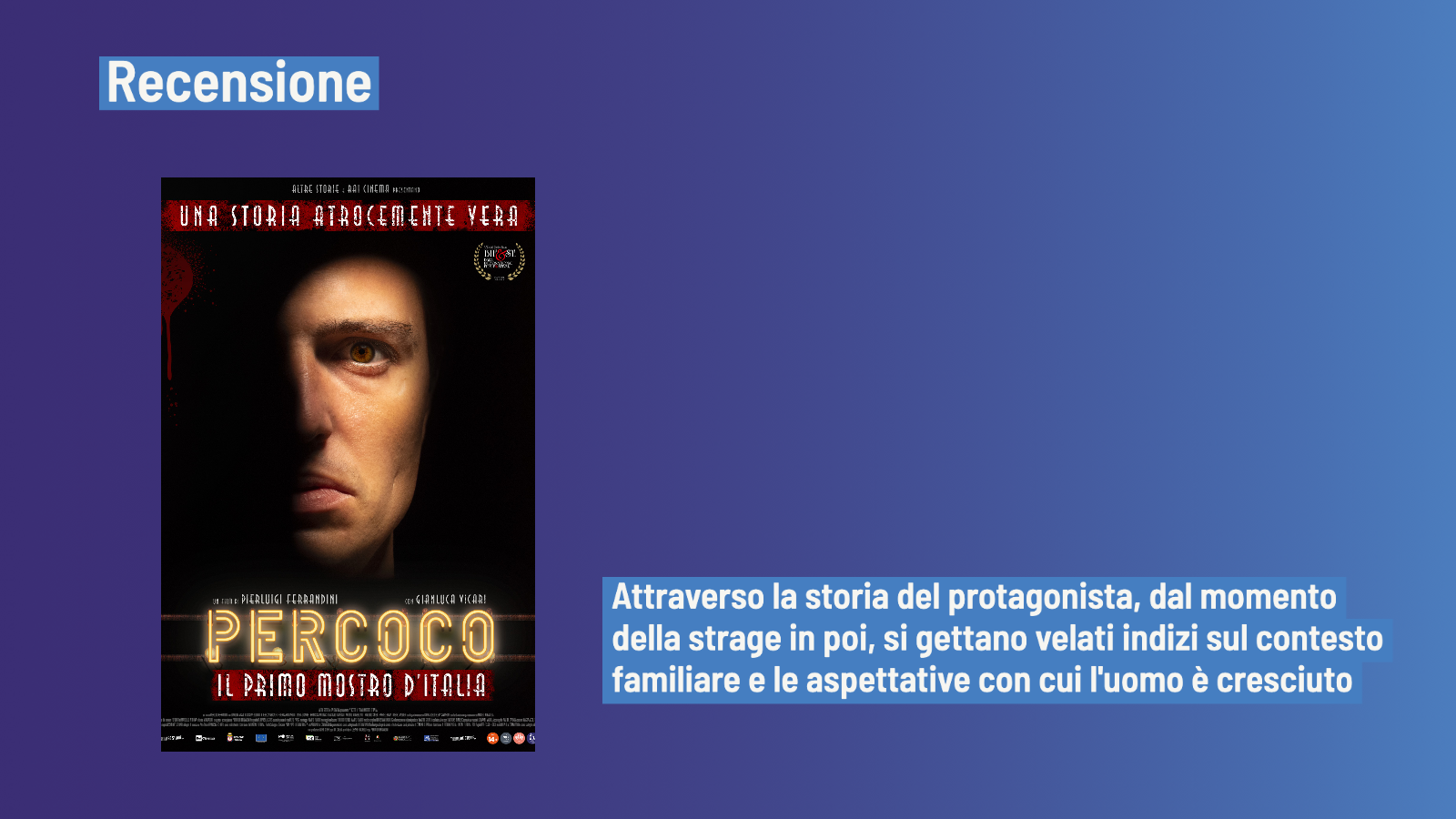
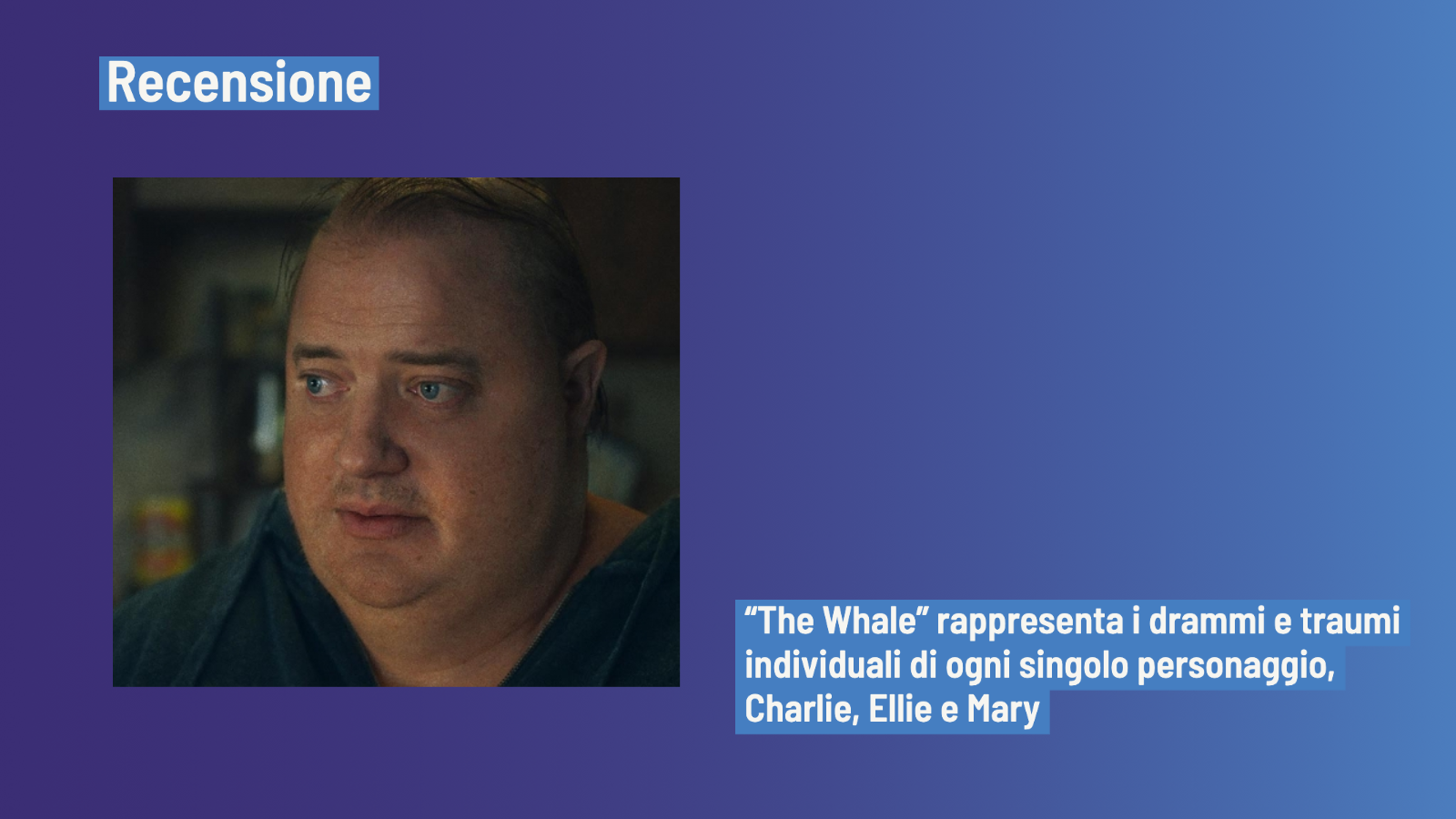
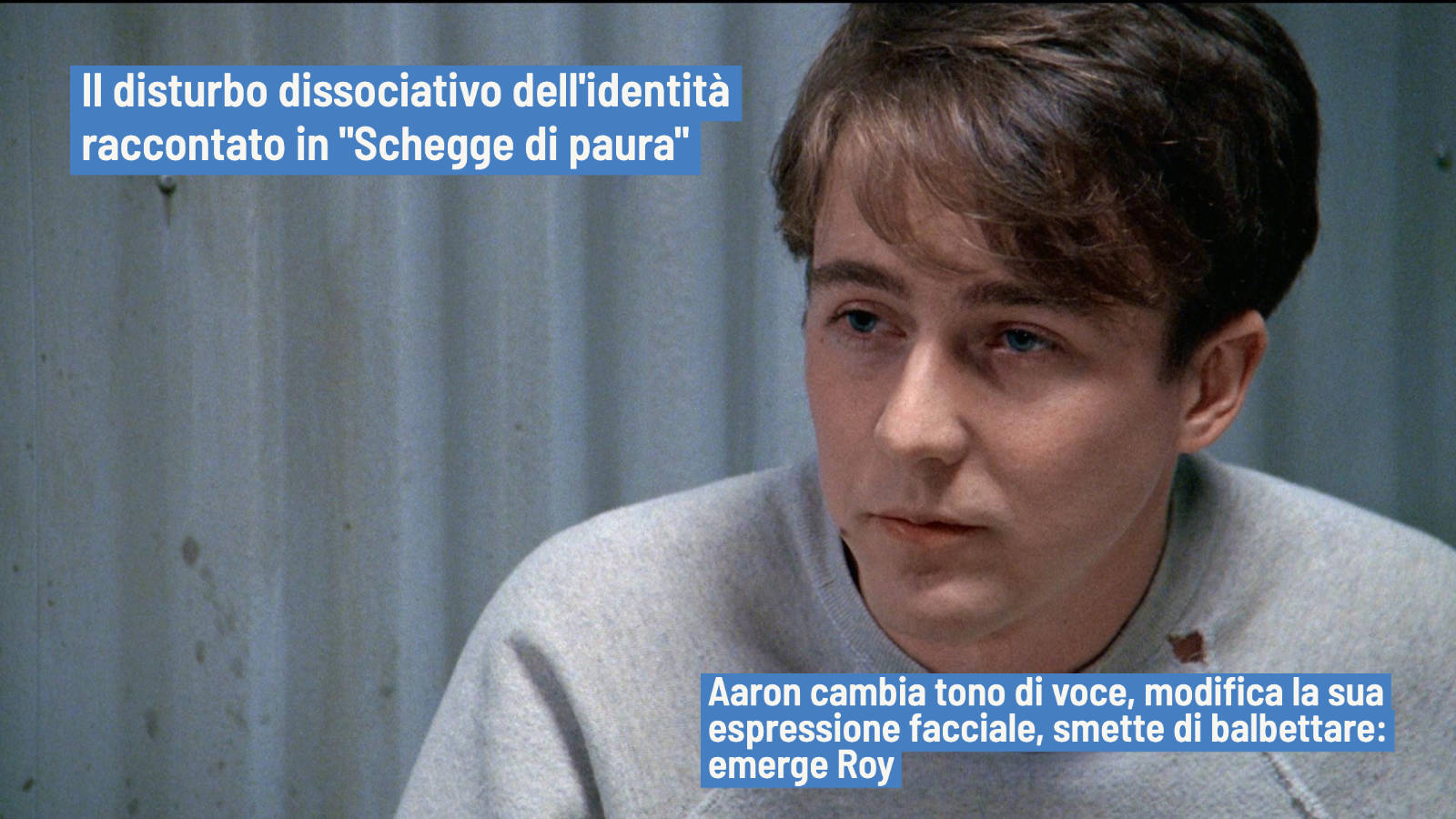
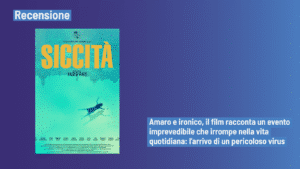
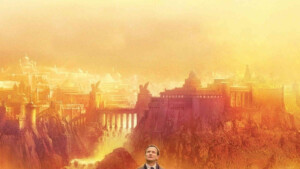
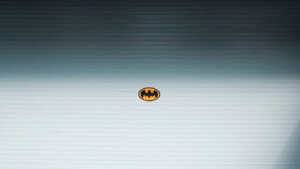

 La scorsa settimana il sogno è diventato realtà: a Villa Igea è stato presentato un CD contenente le canzoni nate negli anni nei laboratori di musicoterapia, dal titolo appunto “Inimmaginabile”. La presentazione del disco ha avuto luogo nel bel giardino della clinica, il luogo dove i pazienti solitamente passeggiano quando non ci sono attività nei reparti. La clinica è stata aperta a tutti per l’occasione ed è stato possibile visitare anche il Museo dell’albero della memoria, un singolare edifico costruito attorno a un albero, dove sorgeva la vecchia portineria.
La scorsa settimana il sogno è diventato realtà: a Villa Igea è stato presentato un CD contenente le canzoni nate negli anni nei laboratori di musicoterapia, dal titolo appunto “Inimmaginabile”. La presentazione del disco ha avuto luogo nel bel giardino della clinica, il luogo dove i pazienti solitamente passeggiano quando non ci sono attività nei reparti. La clinica è stata aperta a tutti per l’occasione ed è stato possibile visitare anche il Museo dell’albero della memoria, un singolare edifico costruito attorno a un albero, dove sorgeva la vecchia portineria. La presentazione del CD è stata una vera festa, con centinaia di partecipanti. Sono venuti tanti gruppi di pazienti di altre strutture, accompagnati dagli operatori, insieme a famigliari, autorità locali, studenti e semplici curiosi. Quasi tutti gli utenti presenti sono transitati in passato da Villa Igea, come tappa del proprio percorso di cure. Alcuni nel frattempo sono guariti, altri hanno fatto passi avanti significativi, ed è stato bello riincontrarsi in un’occasione così positiva.
La presentazione del CD è stata una vera festa, con centinaia di partecipanti. Sono venuti tanti gruppi di pazienti di altre strutture, accompagnati dagli operatori, insieme a famigliari, autorità locali, studenti e semplici curiosi. Quasi tutti gli utenti presenti sono transitati in passato da Villa Igea, come tappa del proprio percorso di cure. Alcuni nel frattempo sono guariti, altri hanno fatto passi avanti significativi, ed è stato bello riincontrarsi in un’occasione così positiva. Shocking Truth (Verità sconvolgente) è un documentario della regista svedese Alexa Wolf sul mondo della pornografia ha fatto discutere molto per la feroce denuncia nei confronti dell’industria del sesso.
Shocking Truth (Verità sconvolgente) è un documentario della regista svedese Alexa Wolf sul mondo della pornografia ha fatto discutere molto per la feroce denuncia nei confronti dell’industria del sesso.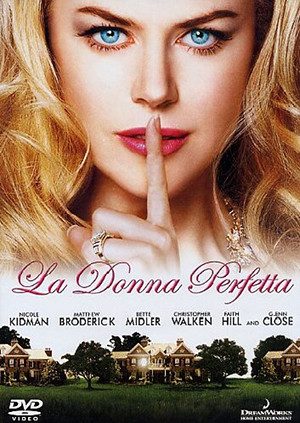
 Dal gemello “sacrificato” alla rinascita della individualità – Il lavoro dei Danzamovimento terapeuti per un’analisi delle prime interazioni e del movimento del bambino.
Dal gemello “sacrificato” alla rinascita della individualità – Il lavoro dei Danzamovimento terapeuti per un’analisi delle prime interazioni e del movimento del bambino.
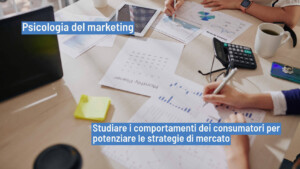

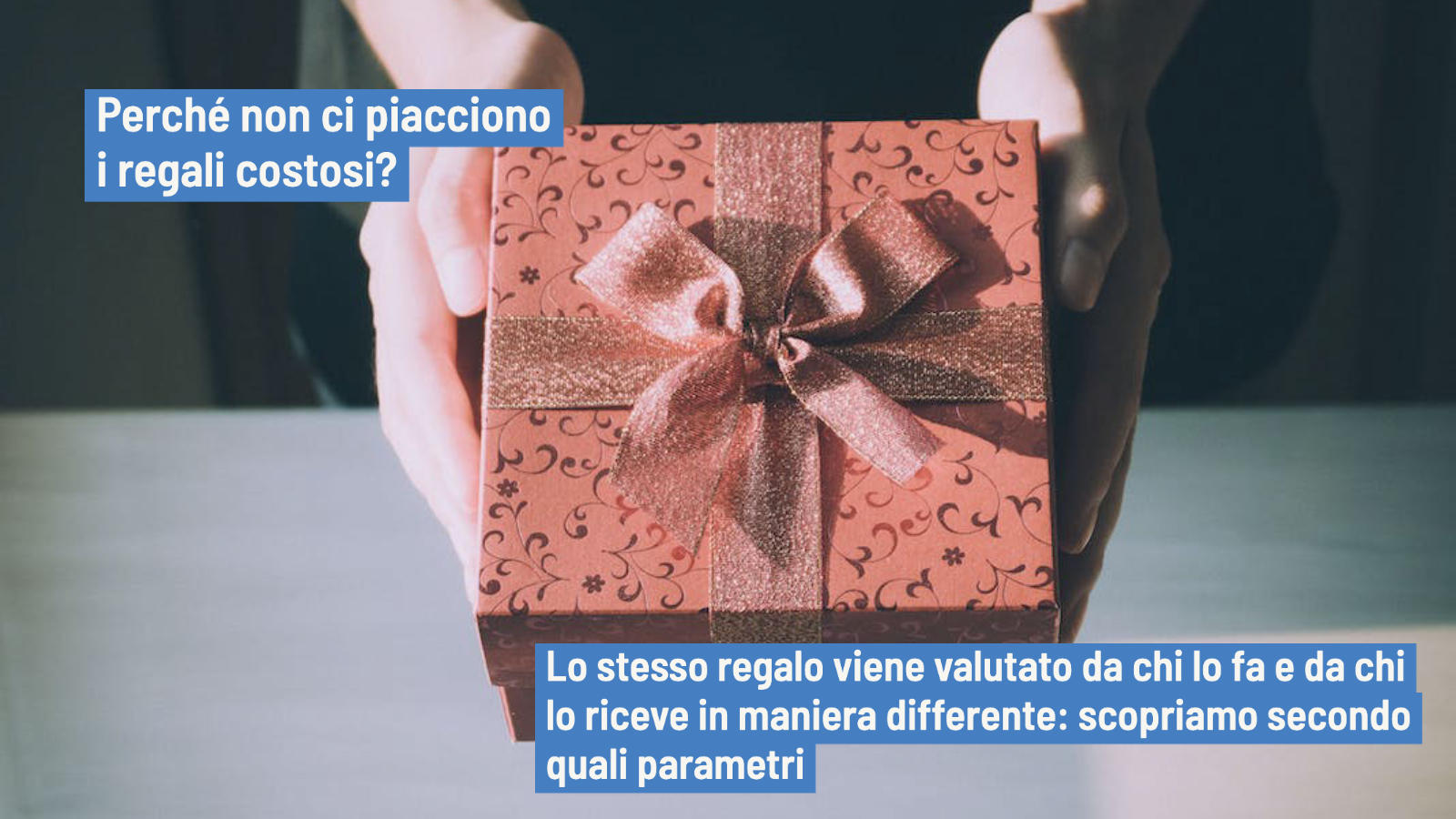

















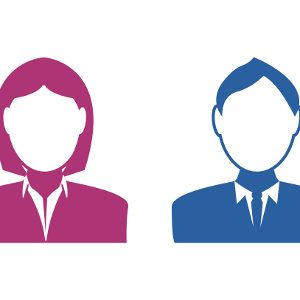 Se le forme di rifiuto e di astensione dal sesso, generalmente definite come castità, sono sempre state dichiarate oltre che valorizzate in alcune culture religiose, negli ultimi anni è emerso l’interesse scientifico per quello che vuole essere descritto come un fenomeno “nuovo”: l’asessualità.
Se le forme di rifiuto e di astensione dal sesso, generalmente definite come castità, sono sempre state dichiarate oltre che valorizzate in alcune culture religiose, negli ultimi anni è emerso l’interesse scientifico per quello che vuole essere descritto come un fenomeno “nuovo”: l’asessualità.