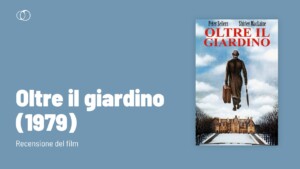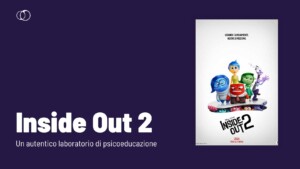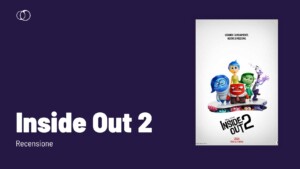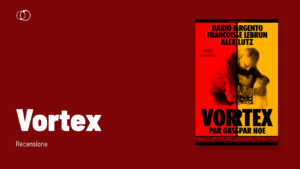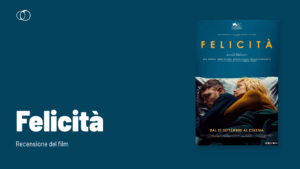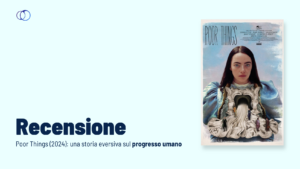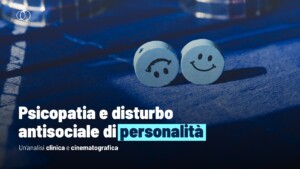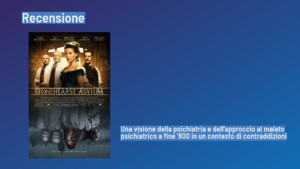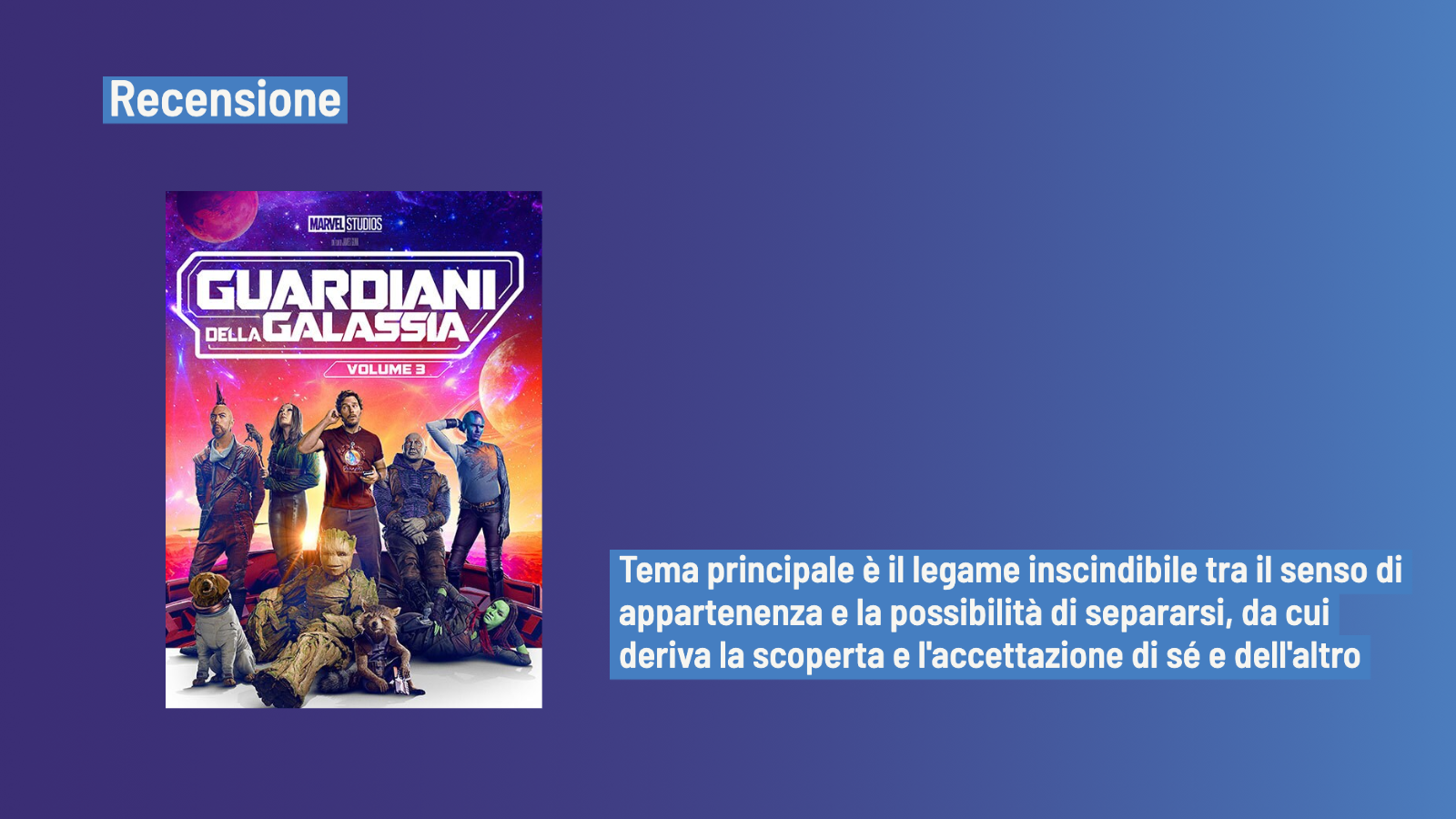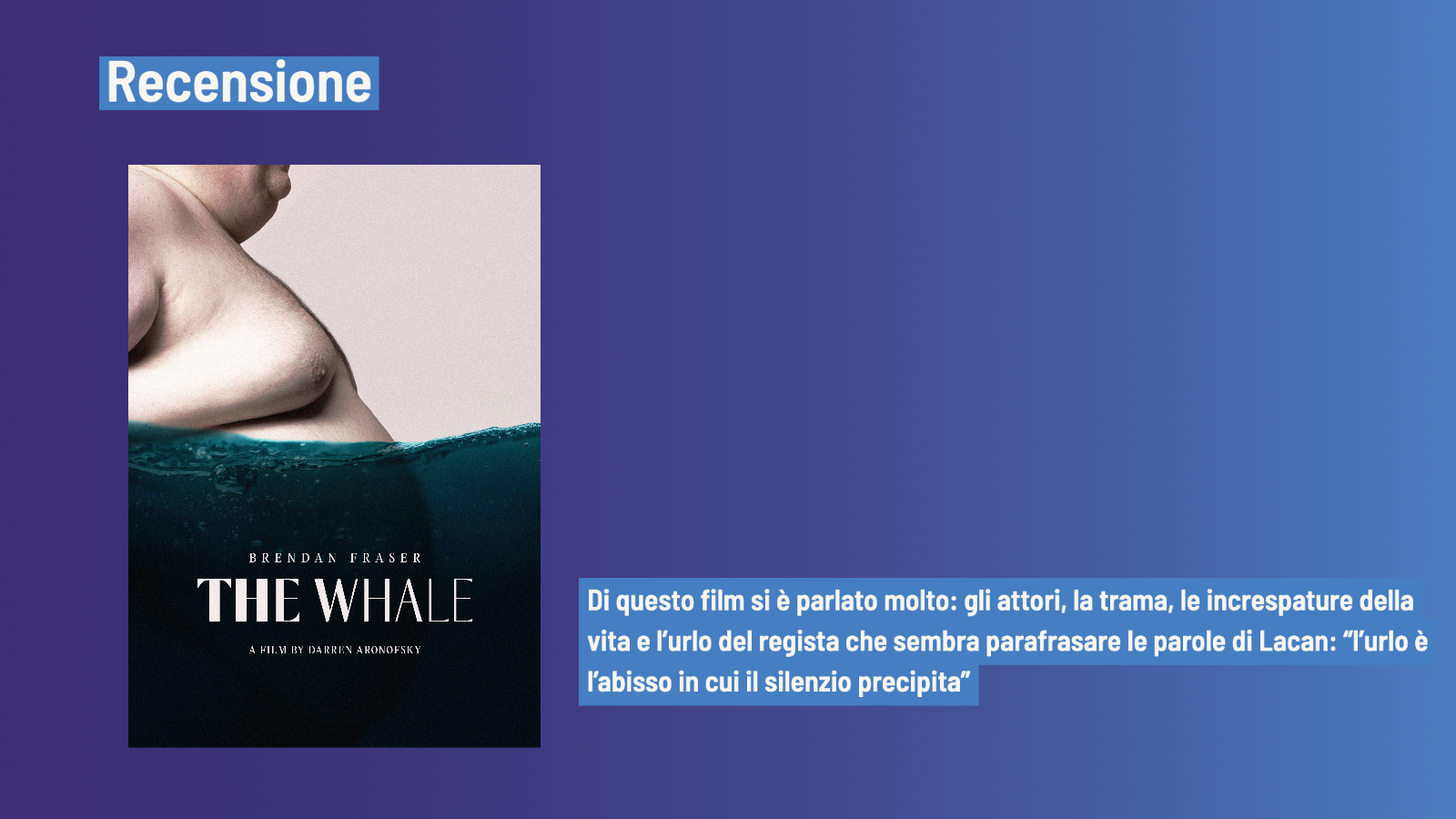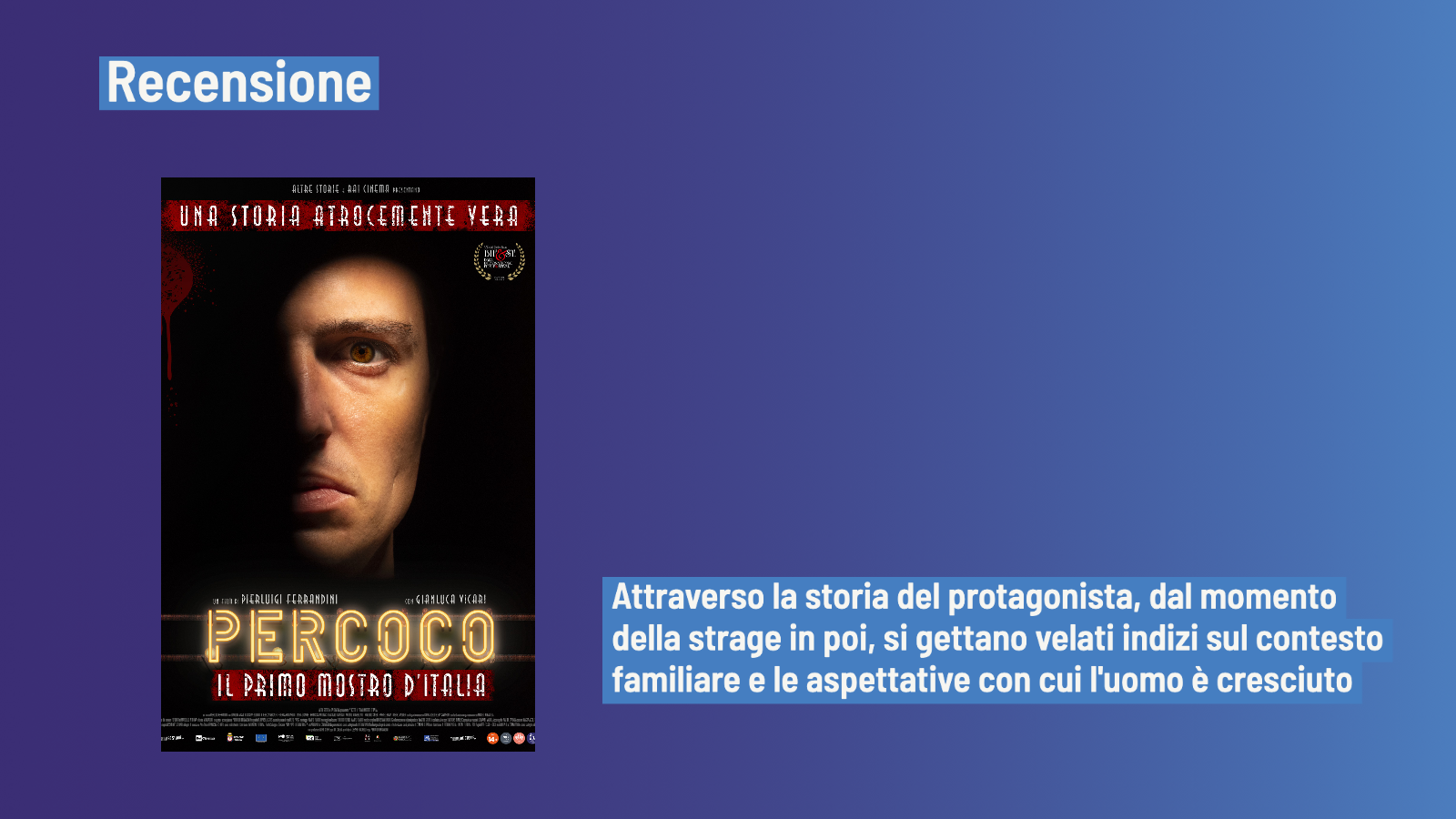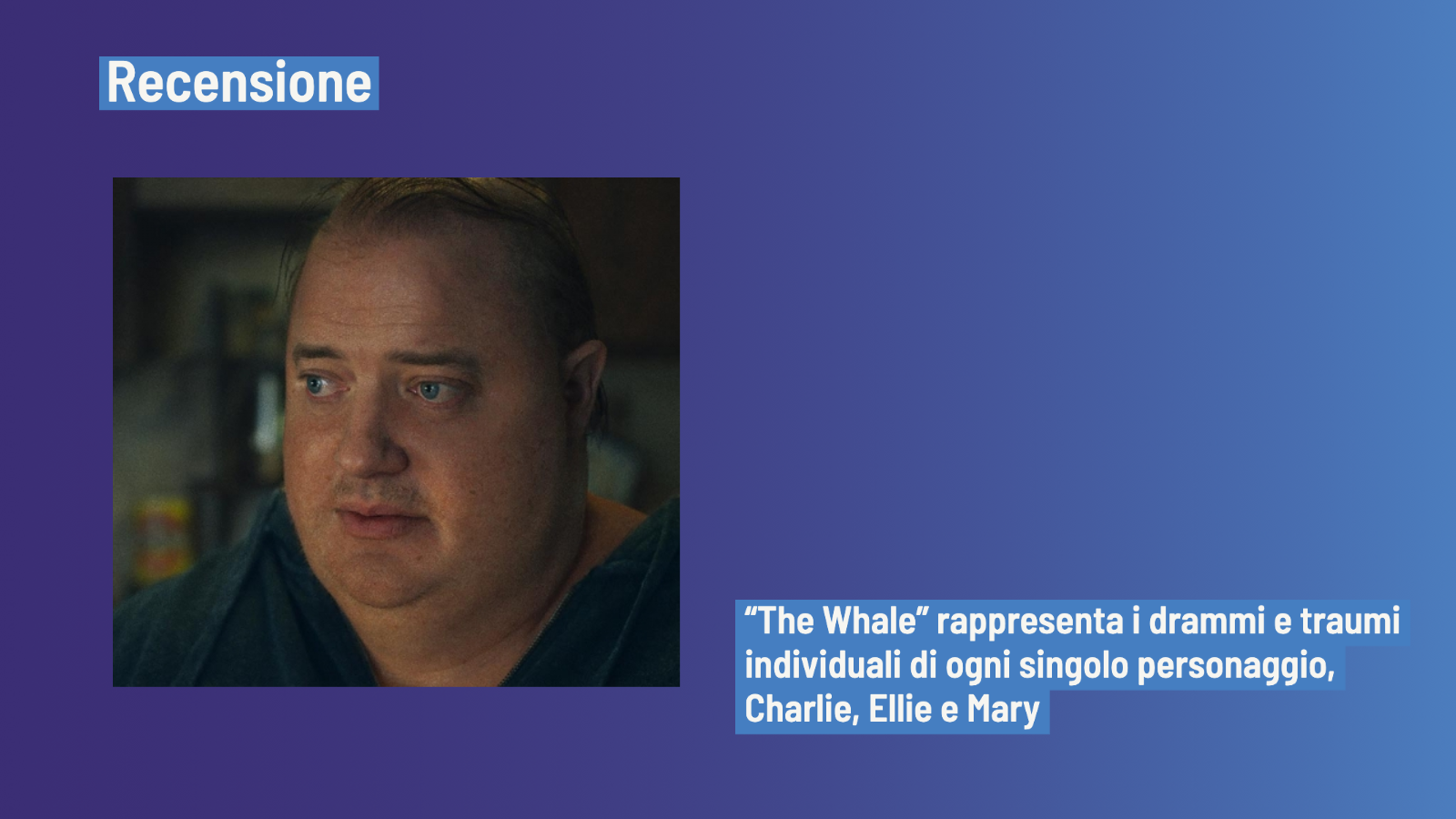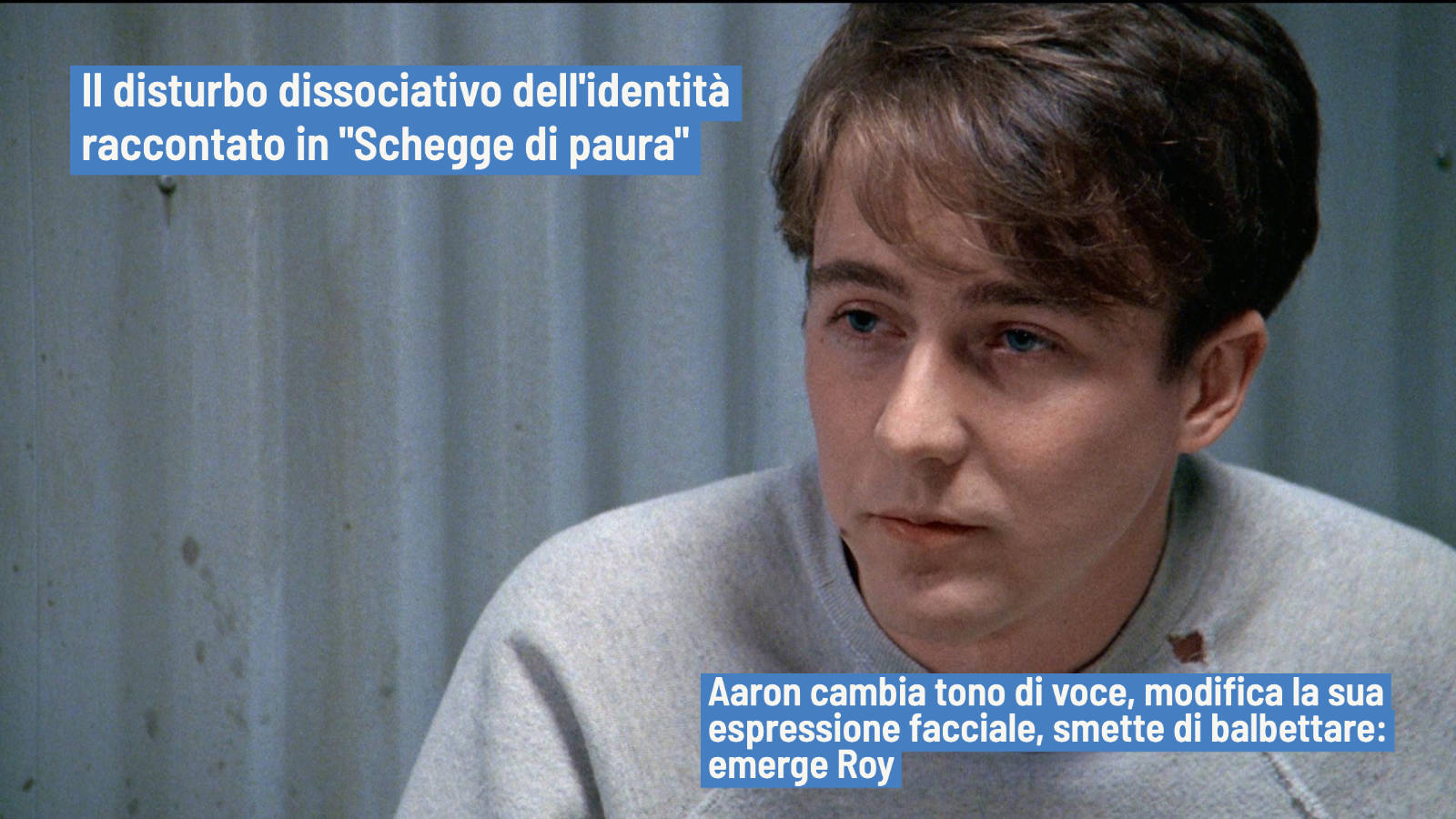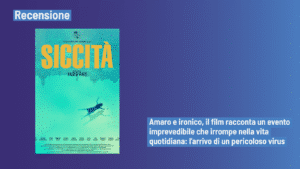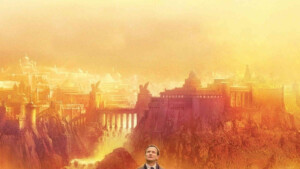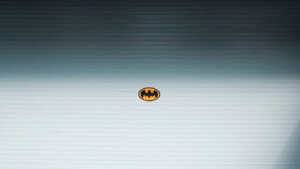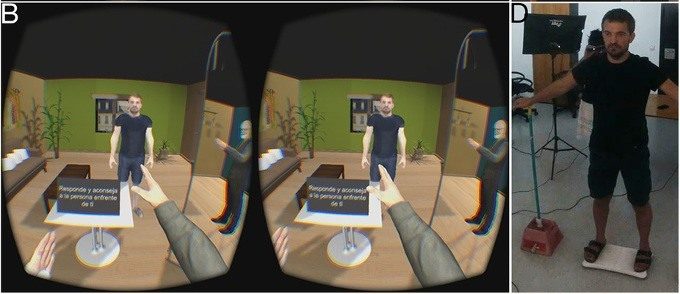Relazioni di coppia: l’altra faccia della violenza
Francesco Romeo, Elena Sirotti, OPEN SCHOOL STUDI COGNITIVI
Con il termine violenza si fa riferimento a quella situazione nella quale uno dei due contendenti ha più potere ed utilizza quest’ultimo per imporre i propri interessi e le proprie scelte all’altro.
Una relazione di coppia dovrebbe basarsi su uno scambio reciproco di attenzioni ed amore, ciò nonostante è normale che tra due persone si sviluppino dinamiche conflittuali. Il conflitto è ritenuto comunemente un elemento dannoso e disgregante per la coppia, in realtà può essere un elemento per sviluppare e maturare il rapporto stesso. Il conflitto diventa un processo distruttivo solo con la ritualità e la frequenza nel tempo.
La relazione coniugale accompagna tutto lo sviluppo della vita familiare, ed è per tanto soggetta a molti passaggi critici e a nuovi compiti per la realizzazione degli obiettivi che di volta in volta è chiamata a raggiungere. Essi possono essere riassunti nel compito complessivo di impegnarsi a rinnovare, riformulare e rilanciare il patto coniugale nei momenti critici della vita di coppia (Scabini e Iafrate, 2003).
Costruire l’identità di coppia non è un compito che si esaurisca agli inizi del matrimonio o che si concluda in tempo breve: essa è sottoposta a prove ed a crisi che i due partner devono affrontare costantemente. Il conflitto viene definito come quel processo interpersonale che si verifica ogniqualvolta il raggiungimento di uno scopo di uno dei partner è incompatibile con il raggiungimento di uno scopo dell’altro (D’Amico, 2006).
É però importante sottolineare che il processo conflittuale assume connotazioni differenti a seconda che sia inserito in una relazione cooperativa o in una relazione competitiva.
La cooperazione permette la negoziazione e la risoluzione del problema nel modo più soddisfacente per entrambi i coniugi. Fanno parte degli stili relazionali cooperativi la negoziazione, il compromesso, l’accondiscendenza, le modalità affiliative e le abilità di problem solving. La competizione, al contrario, esalta l’opposizione tra le parti e conduce al mantenimento o all’esasperazione di un circolo vizioso di ostilità, portando verso forme ancora più negative e aggressive di scambio. Gli stili relazionali competitivi sono l’aggressività verbale, la violenza fisica, la coercizione e il dominio.
Si può osservare, inoltre, che alcuni stili comportamentali possono essere ricondotti ad entrambe le logiche a seconda del loro utilizzo: rientrano infatti in una logica cooperativa se utilizzati moderatamente, ma danno luogo a comportamenti competitivi se utilizzati massicciamente.
Per esempio l’assenza d’impegno può essere associata all’espansione del conflitto, ma anche il suo eccessivo impiego può diventare una modalità rigida di relazione, provocando attacchi all’identità personale del partner e favorendo la tendenza ad accumulare una gran quantità di problemi.
Attualmente, però, l’attenzione degli studiosi si sta rivolgendo sempre meno all’esame del singolo stile di conflitto cercando, in alternativa, una spiegazione che faccia riferimento alla struttura del conflitto e al livello di dipendenza dei partner.
Ci sono molte controversie in letteratura sul peso che il genere ha nel modo in cui uomini e donne risolvono i conflitti. Si crede comunque che la diversità nel comportamento di uomini e donne nella gestione dei conflitti non sia da attribuire ad una diversità biologica, quanto piuttosto all’argomento che origina il conflitto, o alla mancanza di equità presente nella relazione, o a entrambe.
Altre ricerche hanno mostrato che le strategie di gestione dei conflitti utilizzate nei due sessi sono abbastanza simili ed in alcuni casi vanno addirittura nella direzione opposta a quella prevista dagli stereotipi sessuali. Si è riscontrato ad esempio, che gli uomini usano maggiormente strategie di tipo cooperativo, mentre le donne usano più frequentemente strategie che includono un’ampia gamma di comportamenti competitivi quali insultare, minacciare, criticare e intimidire il partner; modi di fare che – ovviamente – non corrispondono allo stereotipo della donna sensibile, cooperativa e attraente.
Il conflitto fa parte della sfera relazionale, della logica di complementarietà della coppia ma nella società attuale viene spesso considerato come un evento negativo e quindi si tende a negarlo oppure a valutarlo come un segno premonitore di una possibile separazione (Fruggeri, 1997). Non si pensa quindi che in realtà il conflitto possa risultare un elemento di evoluzione attraverso cui confrontarsi e mettere alla prova l’autenticità del legame.
Un ulteriore aggravio della conflittualità all’interno della coppia avviene quando dal conflitto si passa a situazioni perverse di violenza.
Come abbiamo visto il conflitto fa parte della vita di coppia, e man mano che il rapporto diviene più intimo aumentano le circostanze che possono far scaturire discussioni.
Con il termine violenza si fa riferimento a quella situazione nella quale uno dei due contendenti ha più potere ed utilizza quest’ultimo per imporre i propri interessi e le proprie scelte all’altro. Così facendo inevitabilmente lo danneggia (Godenzi, 1993). A tutti capita, prima o poi, di biasimare, aggredire verbalmente, sminuire, rimproverare o compiere azioni che ledono in parte l’altro. Esso diventa un processo distruttivo solo con la frequenza e la ripetizione nel tempo. Il conflitto nella coppia violenta assume infatti una dimensione di ritualità, divenendo un vero e proprio insieme di atteggiamenti e comportamenti che si replicano nella medesima modalità tanto da diventare difficili da respingere, soprattutto perché danno origine ad una dinamica di interazione quotidiana che si cristallizza nel tempo (Christopher e Lloyd, 2000).
Ciò che disorienta la vittima e che spesso la induce a reputarsi colpevole della violenza e quindi a non denunciare l’abuso è il fatto che a perpetuare questi soprusi siano persone a lei care, persone che dovrebbero amarla e proteggerla.
La relazione perversa è quella che unisce le persone non nel segno dell’amore e della costruttività ma nel segno di un legame tossico, che fa soffrire anziché dare gioia, che sottrae energie anziché crearle e che conduce alla distruzione (Bernardini de Pace, 2004).
L’aggressore e l’aggredito funzionano secondo lo stesso meccanismo totalizzante. In entrambi i casi c’è un’esacerbazione delle funzioni critiche: verso l’esterno nel caso dell’aggressore, verso se stessi nel caso della vittima (Hirigoyen, 2000).
L’abuso si manifesta nei momenti di crisi, quando il maltrattante deve prendere una decisione e non vuole assumersene la responsabilità che viene così delegata al partner.
Anche quando il maltrattante ritiene che un comportamento della vittima sia inadeguato può reagire in modo violento. In questo caso l’aggressore si sente di solito giustificato, e non attribuisce a se stesso la responsabilità della violenza, che in quel momento considera un modo di agire appropriato (Ponzio, 2004).
La violenza a questo punto può assumere diverse forme che con il tempo tendono ad intrecciarsi. La più conosciuta è sicuramente la violenza fisica. Essa comprende tutte quelle azioni che comportano l’aggressione fisica come percuotere (con e senza oggetti), spingere, scuotere, mordere, strangolare, legare, bruciare con sigarette, privare del sonno e privare delle cure mediche. Ne fanno parte anche quei gesti intimidatori che terrorizzano l’altra persona come spaccare oggetti o uccidere animali a cui la vittima è affezionata. Questo tipo di violenza è la più facile da riconoscere perché le sue conseguenze sono ben visibili sui corpi delle vittime. Un altro tipo di violenza molto conosciuto è la violenza sessuale. Essa comprende tutti gli atti sessuali imposti con la forza dalla coazione fino alla violenza carnale e alla prostituzione coatta.
La violenza si può attuare anche a livello economico. Essa comprende il divieto di lavorare, la costrizione a lavorare, il sequestro del salario nonché la facoltà di disporre esclusivamente delle risorse finanziarie arrogatosi da uno/una dei/delle partner.
Un ulteriore tipo di violenza è quella psicologica. Quest’ultima è la più subdola di tutte perché non lascia ferite visibili ma nascoste nell’animo della vittima. Essa comprende sia minacce gravi, privazione della libertà, nonché forme che di per sé non costituiscono nessuna minaccia immediata ma che, se sommate, debbono essere considerate alla stregua di un atto di violenza vero e proprio. In questo ambito rientra la violenza di carattere discriminatorio sotto forma di disprezzo, offesa, umiliazione, biasimo, critica che infonde sensi di colpa, intimidazione o insulto. Vi rientrano pure gli impedimenti imposti alla vita sociale di una persona, quali il divieto di uscire di casa, il divieto o il controllo severo dei contatti con i familiari e/o con conoscenti ed amici.
Una delle forme più recenti di violenza, riconosciuta ormai anche dalla giurisprudenza italiana in seguito ad eventi fin troppo noti, è quella relativa allo stalking. Stalking è un termine inglese, il cui significato letterale è “inseguimento”, che indica un insieme di comportamenti di sorveglianza e controllo ripetuti ed intrusivi volti a ricercare un contatto con la vittima (Bernardini de Pace, 2004). Questa sindrome si può manifestare in varie modalità: attraverso lettere, telefonate, e-mail, messaggi sul cellulare, pedinamenti; e può essere rivolta a personaggi diversi (come personaggi di successo o datori di lavoro) anche se nella maggior parte dei casi gli aggressori sono ex-conviventi o ex-coniugi che non si rassegnano alla separazione.
Diverse sono le classificazioni di violenza intrafamiliare a seconda dei destinatari dei maltrattamenti subiti:
-maltrattamento infantile: già alla fine del XIX secolo si era formato un movimento contro i maltrattamenti gravi nei confronti dei minori.
In tempi più recenti, la violenza intrafamiliare contro i minori ritorna alla ribalta negli anni ’70. Oggi il dibattito pubblico è focalizzato soprattutto sulla violenza sessuale, mentre le punizioni fisiche, anche di grave entità, sembrano suscitare meno interesse seppure possano portare, nelle forme più estreme, alla morte del bambino.
-violenza tra coppie sposate o conviventi: una porzione consistente della violenza domestica è rappresentata dalla violenza interna alla coppia. In base alle conoscenze odierne le persone che usano violenza all’interno delle relazioni di coppia sono nel 80% dei casi uomini (Romito, 2000). Gli episodi violenti possono avvenire anche dopo l’eventuale separazione. Anche fra partner omosessuali possono verificarsi episodi di violenza del tutto simili a quelli che si verificano in seno alle coppie eterosessuali. Più di una coppia su quattro (il 28%) riporta casi di violenza durante la sua vita coniugale (Creazzo, 2003), arrivando nei casi più estremi all’omicidio del partner.
-violenza su persone anziane/ violenza tra fratelli/ violenza sui genitori: le conoscenze e l’entità delle ricerche in questi tre ambiti sono a tutt’oggi scarse, anche se negli ultimi anni si sta scoprendo un “mondo sommerso” che desta preoccupazione.
L’entità del fenomeno “violenza intrafamiliare” è significativa e in crescita, inoltre difficile da quantificare con esattezza in quanto oltre ai dati evidenti studiati è necessario riflettere su quelli che non vengono alla luce e che costituiscono una zona d’ombra rilevante.
Quando si tratta di azioni che la società non permette o non tollera, come in caso di violenza domestica, infatti, le cifre riflettono solo in modo molto limitato l’entità effettiva del fenomeno. Le indicazioni che una persona fornisce ad un ricercatore o ad un agente di polizia riguardo le esperienze fatte in materia di violenza domestica sono influenzate dai più svariati fattori. A titolo d’esempio, basti pensare che una donna può voler serbare il silenzio perché teme ulteriori repressioni; una madre non sporge denuncia contro il marito che abusa del figlio perché ritiene che “i panni sporchi vadano lavati in casa”. Un uomo può vergognarsi a deporre perché ritiene poco maschile l’essere maltrattato dalla propria moglie. Simili esempi contribuiscono a far sì che accanto alla cosiddetta zona chiara, ossia ai fatti noti, vi sia sempre una zona oscura di cui non è semplice quantificare l’entità.
La violenza più conosciuta e studiata all’interno delle dinamiche familiari è la violenza sulla donna. Molti studi ed anni di lavoro dei Centri anti-violenza, infatti, testimoniano come questo tipo di violenza si sia manifestato in moltissime case e secondo modalità molto differenti.
È ormai nella mentalità comune classificare con il termine aggressore solo persone di sesso maschile, e invece includere nella categoria vittima solo persone di sesso femminile.
Negli ultimi anni però un nuovo filone di ricerche ha evidenziato un fenomeno ignorato da sempre: la violenza femminile sui mariti. È stato infatti riscontrato che in molti casi la donna è l’elemento violento della coppia e che questa violenza non sia sempre giustificata da maltrattamenti precedenti.
Sicuramente la violenza nei confronti delle donne è un fenomeno di portata rilevante, nonché considerabile come una vera piaga sociale, però è necessario prestare attenzione a non farsi condizionare dagli stereotipi culturali e considerare e studiare pertanto anche quelle forme di violenza intrafamiliare meno conosciute, ma di pari importanza. Su questa linea ormai da anni stanno procedendo le ricerche nei paesi anglosassoni dove, oltre alla violenza sulle donne viene analizzata anche quella che le donne fanno sui loro compagni.
È stato infatti riscontrato che in molti casi la donna è l’elemento violento della coppia e che questa violenza non sia sempre giustificata da maltrattamenti precedenti. Se è infatti accertato che l’80% delle vittime di violenza in casa sono donne, è pur vero che rimane una fetta del 20% che è composta da bambini, anziani ed anche da uomini.
Negli anni ’80 Straus creò la “Conflict Tactics Scale” (CTS) per valutare da più angolazioni il fenomeno del conflitto. Questo strumento era formato da tre scale relative alle seguenti aree: ragionamento, aggressioni verbali ed aggressioni fisiche od atti violenti. È un test autosomministrato: all’intervistato viene chiesto di rispondere se e quanto spesso ha attuato determinati comportamenti verso il proprio partner, per esempio: gettare un oggetto, spingere, schiaffeggiare, dare calci o mordere, minacciare o usare un coltello o una pistola. Ad ogni risposta positiva del soggetto viene attribuito il punteggio di uno, se la risposta è negativa il punteggio attribuito è zero. In seguito al soggetto preso in esame viene nuovamente somministrato il CTS ma relativamente alle azioni che il partner attua nei suoi confronti. Di nuovo, ad ogni risposta positiva del soggetto viene attribuito il punteggio di uno, se la risposta è negativa il punteggio attribuito è zero. Questo strumento fu molto criticato, così Straus (1990) e i suoi collaboratori lo ampliarono e perfezionarono: aggiunsero domande su chi iniziava il conflitto e sulle conseguenze dello stesso.
Basandosi sulle risposte date alla CTS Straus e Gelles conclusero che gli indici di violenza delle mogli sono notevolmente simili agli indici di violenza dei mariti. Gli Autori mostrano che 11,6% dei mariti intervistati ammettono di aver compiuto almeno un atto di violenza nei confronti delle loro compagne nell’anno precedente la ricerca, nello stesso lasso di tempo però le mogli che ammettono di aver fatto altrettanto sono il 12,4%. Anche queste ricerche sono state soggette a forti critiche, innanzitutto perché il CTS tende a ridurre le differenze dei due tipi di violenza (maschile e femminile). Le domande del questionario, facendo riferimento ad un numero limitato di azioni aggressive, equiparano la violenza maschile a quella femminile e non tengono ad esempio conto del fatto che gli uomini utilizzino la violenza sessuale molto più spesso delle donne.
Un’altra critica mossa a questo tipo di ricerche è di non tenere conto della motivazione dell’aggressione, cioè se la violenza aveva lo scopo di ferire il partner, di auto-difesa o di rappresaglia.
La motivazione dell’auto-difesa è la giustificazione più utilizzata dai gruppi di femministe che gestiscono i Centri anti-violenza. Gli studi di questi Centri riportano solo casi nei quali l’unico ad essere colpevole è l’uomo, ed è davvero rarissimo che un addetto a questi Centri ponga alla vittima domande sulle sue possibili violenze contro il marito.
Esistono però dati contro la giustificazione dell’auto-difesa come unica motivazione della violenza femminile. Per esempio dal National Family Violence Survey (Jurik e Gregware, 1989) svolto in America nel 1985 su 495 coppie violente emersero questi dati rispetto all’anno precedente:
-nel 25,9% dei casi solo l’uomo era violento;
-nel 25,5% dei casi solo la donna era violenta;
-nel restante 48,6% erano violenti entrambi i partner.
È difficile quindi affermare che nel quarto delle coppie in cui la donna è l’unica ad usare violenza lo faccia solamente per autodifesa, mentre nel quarto di coppie in cui è l’uomo ad essere violento lo sia per una supposta “cattiveria”.
Nel 1991 il Dipartimento di Giustizia americano riportava i seguenti dati: 680 uomini (tra mariti e fidanzati) che avevano ucciso nel corso dell’anno le loro compagne e 1300 mogli o fidanzate che avevano assassinato i loro partner. Anche da una ricerca di Straus del 2005 emerge che in un anno in America le aggressioni verso le donne da parte dei mariti sono state 122 su 1000 contro le 124 aggressioni su 1000 che le donne hanno effettuato sui loro partner.
Sempre Strauss in uno studio più recente (2008) condotto su 13.601 studenti universitari di 32 diversi paesi che hanno partecipato all’ internazionale di Dating Violence Study. Dall’analisi di questi dati è emerso che quasi un terzo della ragazze, allo stesso modo dei compagni maschi, aveva aggredito fisicamente il partner negli ultimi 12 mesi. Inoltre emerge che la forma di violenza è quella bidirezionale (nella quale entrambi i partner sono violenti), seguita dalla violenza di tipo “femminile” nei confronti dei compagni. La violenza dell’uomo sulla compagna è risultata quella meno frequente secondo i partecipanti sia uomini che donne. Inoltre Strauss sottolinea che la violenza è determinata dal maggior predominio di un partner sull’altro e che questo non è legato in alcun modo al genere del soggetto.
Purtroppo questo ambito di ricerca è relativamente recente e seriamente limitato dai pregiudizi che colpiscono questo tipo di argomenti. Quasi tutta la letteratura e le ricerche sulla violenza sui mariti è in lingua inglese e sviluppata negli Stati Uniti o in Canada. Si pensi solo alle difficoltà ancora presenti in Italia a parlare del maltrattamento femminile per immaginare quanta strada bisogna ancora percorrere per discutere e fare ricerca sul maltrattamento maschile.
Le ricerche, purtroppo, non danno risposte definitive e negli anni futuri bisognerà procedere con esse in varie direzioni per capire come si svolgono, effettivamente, le dinamiche violente all’interno di una coppia.
L’immaginazione umana non ha limiti quando si tratta di umiliare e soggiogare il prossimo. Questa “abilità” ha purtroppo pervaso tutta la società ed è entrata persino nelle nostre case.
L’esperienza di essere vittima è entrata a far parte della vita di ogni uomo: sconfitte, mortificazioni od umiliazioni sono esperienze quotidiane di sottomissione allo strapotere esercitato principalmente da altri uomini. Ma anche le madri, le insegnanti o le partner possono rendere vittime i ragazzi e gli uomini.
Per i maschi è però più problematico vivere questa situazione, perché essere sottomesso ad una donna contrasta con gli stereotipi prevalenti riguardo i ruoli sociali, con l’idea comune che vede l’uomo come forte e dominante.
Nel mondo occidentale infatti l’idea predominante è quella secondo la quale l’essere vittima di un abuso e l’essere uomo si escludono a vicenda. Un uomo abusato fatica ad essere preso sul serio, e di conseguenza ha pochissime possibilità di analizzare ed elaborare le lesioni fisiche e psichiche derivanti dall’esperienza del maltrattamento.
Le attiviste femministe, in particolare, continuano a sostenere che la violenza domestica è unilateralmente esercitata verso la donna e continuano a negare la realtà degli uomini vittima. Esse non capiscono che i ricercatori nell’ambito della violenza femminile non vogliono sminuire la drammaticità dell’esperienza che le donne maltrattate hanno vissuto, ma vogliono sviluppare conoscenze e progetti riabilitativi e di prevenzione adatti al sesso maschile.
Come già detto, è molto comune che in caso di violenza domestica le persone colpite non vogliano che le autorità si occupino di quanto è successo. Questo tabù blocca moltissime donne dal denunciare i soprusi che hanno subito.
Per gli uomini la situazione è ancora peggiore. Come abbiamo visto, infatti, la violenza sull’uomo è molto comune; viene però considerata quasi inesistente perché purtroppo non se ne parla affatto. Visto che non si parla di uomini vittima non si parla nemmeno di donne carnefici e così non esistono né centri di ascolto per gli uomini né gruppi o programmi di supporto per le donne violente che continuano a vivere nella società come se niente fosse. Infine se le donne vittime di violenza non hanno il coraggio di denunciare il partner per paura di essere isolate dai conoscenti, questa paura per gli uomini è ancora più reale a causa degli schemi di genere che hanno le persone, che vedono come responsabile della violenza subita lo stesso uomo.
È importante per tutta la società che questo nuovo fenomeno esca allo scoperto, per poter attuare adeguati protocolli preventivi e riabilitativi. È essenziale inoltre, che in tutte le case, uomini e donne imparino che la violenza sui propri cari non “accade” e basta e che abusare di un proprio congiunto non è mai accettabile.
ARTICOLO CONSIGLIATO:
Teen dating violence: la violenza nelle relazioni di coppia tra adolescenti
BIBLIOGRAFIA:
- Bernardini de Pace A. (2004). Calci nel cuore – storie di crudeltà e mobbing familiare. Milano: Sperling & Kupfer Editori.
- Christopher F.S. & Lloyd S.A. (2000). “Phisical and Sexual Aggression Relationship”, in AA.VV. Close Relationship: a soucebook . Ed. Hendrick C., Hendrick SS. Thousand Oakes (CA), pp. 331-342
- Creazzo G. (2003). Mi prendo e mi porto via – Le donne che hanno chiesto aiuto ai centri anti-violenza in Emilia-Romagna-. Milano: FrancoAngeli.
- D’Amico R. (2006). Le relazioni di coppia -potere, dipendenza, autonomia- Roma: Editori Laterza.
- Fruggeri L. (1997), Famiglie -Dinamiche interpersonali e processi psico-sociali- Roma: La Nuova Italia Scientifica.
- Godenzi A. (1993). Gewalt im sozialen Nahraum. Basilea/Francoforte sul Meno.
- Hirigoyen M.F. (2000). Molestie morali -La violenza perversa nella famiglia e nel lavoro- Torino: Grandi Tascabili Enaudi.
- Jurik N.C. & Gregware P. (1989). A method for murder: An interactionist analysis of homicides by women. Tempe: Arizona State University, School of Justice Studies.
- Ponzio G. (2004). Crimini segreti. Maltrattamento e violenza alle donne nella relazione di coppia. Milano: Baldini Castoldi Dalai.
- Scabini E. & Iafrate R. (2003). Psicologia dei legami familiari. Bologna: Il Mulino.
- Straus M.A. (2005). “Women’s violence torward men is a serious social problem” in Current controversies on family violence, 2nd Edition (2nd Edition ed.,pp.55-77) di Loserke D.R., Gellers R.J. & Cavanaugh M.M. Newbury Park: Sage Pubblications DOWNLOAD
- Straus M.A. & Gelles R.J. (1990). Physical violence in American families: Risk factors and adaptations to violence in 8145 families. New Brunswick, NJ: Transaction.
- Straus M.A., Gelles R.J. & Steinmentz S. (1980). Behind Closed Doors: Violence in the American Family. Garden City, New York: Anchor.
- Straus M.A (2008). Dominance and symmetry in partner violence by male and female university students in 32 nations. Children and Youth Services Review, Volume 30, Issue 3, pp.252-275. DOWNLOAD