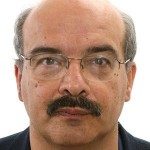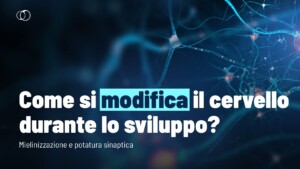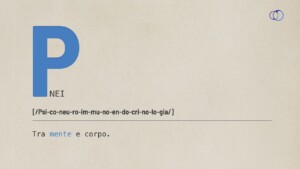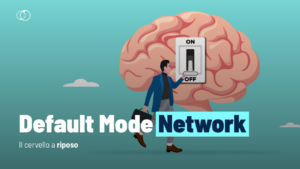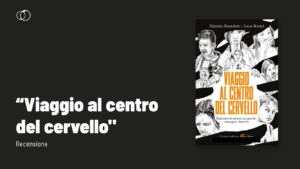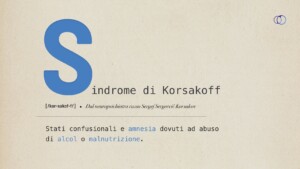Relazione terapeutica, alleanza e outcome: il ruolo del terapeuta alla luce della teoria dell’attaccamento e dei sistemi motivazionali interpersonali
Valentina Carnevali, OPEN SCHOOL STUDI COGNITIVI
I dati di ricerca hanno ripetutamente dimostrato come l’alleanza terapeutica sia un potente fattore predittivo dell’esito del trattamento psicoterapeutico (per una recente meta-analisi, si veda Horvath, Del Re, Flückiger et al., 2011).
Essa rappresenta infatti il fattore terapeutico aspecifico (non correlato all’uso di tecniche proprie di specifici orientamenti e modelli psicoterapeutici) con maggiore capacità di predire il buon esito del trattamento, configurandosi così come un nucleo concettuale e clinico di estrema rilevanza.
Secondo Bordin (1979) l’alleanza terapeutica è costituita da tre componenti: (1) l’esplicita condivisione di obiettivi da parte di paziente e terapeuta, (2) la chiara definizione di compiti reciproci all’inizio del trattamento (la negoziazione di obiettivi e compiti tra paziente e terapeuta è un momento cruciale nella costruzione dell’alleanza) e (3) il tipo di legame affettivo che si costituisce fra i due, caratterizzato da fiducia e rispetto. Da tale definizione è possibile evincere che l’alleanza e, conseguentemente, la psicoterapia in senso lato, si delineano come un lavoro collaborativo tra due soggetti interagenti ed entrambi attivi, ciascuno nel proprio ruolo. In particolare, il legame affettivo tra paziente e terapeuta, terzo elemento costitutivo dell’alleanza nonché fattore aspecifico di grande efficacia clinica, emerge dall’interazione tra due variabili principali: da una parte i comportamenti, le emozioni e i pensieri del terapeuta, dall’altra le proiezioni transferali che nascono dalle esperienze passate del paziente. Ecco che dunque entrambi gli elementi della diade clinica, paziente e terapeuta, ciascuno dotato di una propria storia evolutiva e di un proprio mondo interno, divengono di estrema importanza nella costruzione dell’alleanza e nella conduzione di una terapia avente buon esito.
La teoria dell’Attaccamento di Bowlby (1988) offre un’interessante cornice all’interno della quale esplorare il concetto di “alleanza terapeutica”, in quanto la sua costruzione e il suo mantenimento non possono prescindere dall’attivazione dei sistemi motivazionali (tra cui quello dell’attaccamento) di paziente e terapeuta, all’interno del dialogo clinico.
Tale teoria postula l’esistenza nell’uomo di una tendenza innata a ricercare per tutto l’arco di vita la vicinanza protettiva di una figura ben conosciuta ogni volta che si costituiscano situazioni di pericolo, dolore, fatica, solitudine, offrendo così all’individuo un notevole vantaggio in termini di sopravvivenza e adattamento all’ambiente.
L’ Attaccamento è dunque ascrivibile al concetto di “Sistema Motivazionale Interpersonale (SMI)”, definibile come una tendenza innata a base evolutiva capace di regolare comportamenti ed emozioni in vista di specifiche mete, plasmata, nella sua espressione, dalle memorie di quanto è precedentemente accaduto durante il suo esercizio. Tale SMI regola la richiesta di cura e si coordina con lo speculare sistema dell’Accudimento, adibito all’offerta di cura. Gli altri sistemi motivazionali dell’uomo sono il sistema agonistico (competizione per il rango), quello cooperativo (cooperazione tra pari, cruciale nella costruzione di una buona alleanza terapeutica) e quello sessuale: molti di essi entrano in gioco proprio durante lo scambio clinico tra terapeuta e paziente.
Bowlby propone inoltre che, come risultato dell’interazione con il caregiver durante l’infanzia, gli individui sviluppino specifiche rappresentazioni mentali relative al sé, all’altro e alla relazione. Tali Modelli Operativi Interni (MOI), memorie implicite e non verbalizzabili, guidano il comportamento di attaccamento successivo del bambino e, soprattutto, controllano il modo in cui i membri di una diade, anche in età adulta, anticipano, interpretano e dirigono le relazioni con i partner quando diviene attivo il sistema motivazionale dell’attaccamento.
A partire dalla teorizzazione di Bowlby e da studi osservazionali di interazioni madre-bambino, Ainsworth e colleghi (1978) hanno identificato tre diversi pattern di attaccamento (successivamente ampliati a quattro da Main e Solomon (1986) con l’introduzione del pattern disorganizzato), relativi a diversi MOI e correlati a specifiche modalità di gestione dell’angoscia nelle relazioni col caregiver: sicuro (B), insicuro evitante (A) e insicuro ansioso-ambivalente (C). Un caregiver sensibile e rispondente alle esigenze del bambino consentirà lo sviluppo di un attaccamento sicuro, caratterizzato da piena fiducia in sé, nell’altro e nelle relazioni. Caregivers insensibili o non rispondenti, al contrario, comporteranno un’insoddisfazione del bisogno innato di accudimento e determineranno da un lato l’evitamento della relazione (pattern A, le richieste di cura non sono mai soddisfatte) e dall’altro il desiderio ambivalente di vicinanza ed evitamento del contatto (pattern C, il caregiver è incostante e imprevedibile).
In un contesto terapeutico, ogni volta che nel dialogo clinico affiorino memorie e aspettative di difficoltà e dolore mentale, l’attivazione del sistema di attaccamento diviene praticamente inevitabile. Il rapporto clinico tra psicoterapeuta e paziente si presenta dunque frequentemente come un vero e proprio legame di attaccamento, e in esso si possono rintracciare alcune delle caratteristiche specifiche di tale relazione, quali la ricerca di vicinanza, la protesta nei confronti della separazione e la ricerca di una base sicura (Weiss, 1982). Il paziente, in almeno alcuni momenti del dialogo clinico, racconta la propria sofferenza, paura o angoscia e lo stato mentale che accompagna questa narrazione implica pressoché sempre l’attivazione del sistema motivazionale di attaccamento. Il paziente tenderà quindi ad applicare alla relazione con il terapeuta le memorie, le aspettative e i significati costruiti nella relazione con i genitori (MOI degli attaccamenti precoci) e gli stati mentali relativi all’attaccamento adulto.
Da un lato ciò comporta una minaccia all’alleanza terapeutica, perché sposta la relazione dal sistema cooperativo (il migliore per il mantenimento di buoni livelli di alleanza, in cui paziente e terapeuta lavorano insieme sullo stesso piano per il conseguimento di obiettivi condivisi) a un altro sistema, per di più gravato da MOI insicuri o disorganizzati. Dall’altro, proprio la comparsa di strutture e dinamiche mentali relative all’attaccamento nel dialogo clinico, è condizione che potenzialmente permette esperienze relazionali correttive nel paziente, di regola accompagnate dallo sviluppo delle capacità metacognitive (Liotti e Monticelli, 2014). Lo stesso Bowlby (1988) ha sottolineato che la relazione psicoterapeutica può costituire un importante fattore di cambiamento dello stile di attaccamento, consentendo al paziente di passare da uno stile insicuro a uno stile sicuro. In questo processo, il ruolo del terapeuta è anche quello di agire come una figura di attaccamento, creando una base sicura che consenta al paziente di procedere nell’esplorazione delle proprie esperienze e dei propri vissuti di attaccamento, favorendo esperienze emozionali correttive capaci di disconfermare i MOI insicuri: i vissuti di attaccamento del clinico andranno quindi ad agire specularmente già in questa fase.
Specularmente, come sottolinea Baldoni (2008), la relazione terapeutica può configurarsi come una potenziale condizione di minaccia anche per il clinico, esposto a possibili frustrazioni narcisistiche, incapacità o difficoltà diagnostica, eventuali fallimenti terapeutici o anche a disorientamento e sofferenza emotiva conseguenti all’entrare in contatto con gli stati mentali del paziente. Anche nel terapeuta possono così attivarsi comportamenti di attaccamento e MOI specifici, correlati alle esperienze passate e capaci di influire in modo significativo all’interno della relazione clinica e nella costruzione/ mantenimento/ riparazione dell’alleanza.
Lavoro terapeutico e alleanza non possono così non risultare profondamente influenzati anche dal terapeuta e dai suoi attributi personali e professionali. Le caratteristiche personali e le capacità individuali del terapeuta che favoriscono l’alleanza o che, al contrario, ne rendono più probabile la compromissione, sono state oggetto di numerose indagini (Backeland, Lundwall, 1975; Bein, Anderson, Strupp et al., 2000; Dunkle, Friendlander, 1996; Kvilinghan, Patton, Foote, 1998; Safran, Muran, 2000). Un’ampia rassegna (Ackerman, Hilsenroth, 2001, 2003) ha evidenziato numerosi attributi favorenti l’alleanza, tra i quali: capacità di esplorare temi interpersonali, elevato livello di metacognizione, tendenza a favorire l’espressione di emozioni in un’atmosfera di sostegno e attivo incoraggiamento, capacità di assumere un ruolo collaborativo nel dialogo col paziente al fine di perseguire insieme obiettivi specifici, genuinità dell’interesse per l’esperienza del paziente, accuratezza e parsimonia nelle interpretazioni. Sull’altro versante, sono stati individuati anche i fattori ostacolanti l’alleanza, tra cui: autoreferenzialità del terapeuta, tendenza a distrarsi quando il paziente parla, scarso coinvolgimento emotivo nello scambio clinico, sfiducia nelle proprie capacità di aiutare il paziente, tendenza a criticarlo e a colpevolizzarlo, uso inappropriato dell’autosvelamento e del silenzio, uso eccessivo di interpretazioni di transfert. Inoltre, i risultati di una prolungata ricerca curata da Norcross (2011) hanno messo in luce, quale “fattore di efficacia terapeutica promettente ma ancora non sufficientemente supportato da dati di ricerca”, proprio lo stile di attaccamento, capace di influenzare alleanza terapeutica e outcome.
Nonostante questo campo sia stato per ora solo parzialmente esplorato, è possibile individuare, tra le altre, alcune prospettive cliniche che hanno cercato di approfondire le correlazioni tra lo stile di attaccamento del terapeuta e alcuni aspetti della relazione terapeutica, quali la costruzione dell’alleanza, il suo mantenimento nel corso della terapia e i possibili esiti dell’intervento.
Secondo Wilkinson (2003), medici e psicologi con stile di attaccamento insicuro si rivelano meno efficaci nella relazione clinica e sono maggiormente esposti al burn-out. Il distanziamento della rabbia e il diniego della vulnerabilità e della paura limitano l’espressione autentica della sofferenza e favoriscono lo spostamento sugli aspetti somatici, tecnici e specialistici (esami, test, farmaci…). I clinici con stile di attaccamento sicuro, invece, si adattano meglio alle diverse condizioni terapeutiche e riescono ad avvicinarsi ai bisogni specifici del paziente, integrando le proprie capacità riflessive con le informazioni cognitive e la comunicazione emotiva. Ne consegue una migliore qualità della relazione clinica e una maggiore soddisfazione personale del lavoro svolto (Dozier, Cue, Barnett, 1994).
Secondo Baldoni (2008), poichè un colloquio clinico è da considerarsi una relazione complessa in un contesto di relativa minaccia, in una situazione terapeutica i comportamenti e le reazioni emotive dei due partecipanti saranno significativamente influenzate dalle rappresentazioni relative alle esperienze di pericolo attivate nei reciproci modelli operativi interni. A partire da tale premessa, Baldoni ha delineato come i diversi stili di attaccamento del terapeuta possano influenzare la relazione clinica. Un clinico con uno stile insicuro distanziante (tipo A), si potrebbe caratterizzare per i tratti tipici di tale pattern: distanziamento dai propri bisogni e dagli affetti vissuti come negativi e pericolosi per il sé; tendenza ad assumere in modo compiacente il punto di vista degli altri, senza però riuscire a comprenderne a pieno i bisogni psicologici (scarsa funzione riflessiva e scarsa empatia); propensione a svolgere compiti tecnici privi di coinvolgimento emotivo (privilegiando la cognizione rispetto all’affettività); possibilità di intrusioni improvvise di emozioni distanziate e acting out.
Quando un clinico insicuro distanziante incontra un paziente con le stesse caratteristiche, i loro stili di attaccamento con ogni probabilità colluderanno e la relazione tenderà ad essere caratterizzata da un approccio rigidamente tecnico-cognitivo (spiegazioni razionali, ma superficiali, dei vari disturbi, visti soprattutto da un punto di vista biologico), con conseguente evitamento delle aree problematiche e distanziamento delle emozioni negative e tendenza a falsificare gli affetti pericolosi per il Sé.
I clinici con attaccamento insicuro preoccupato (tipo C) potrebbero manifestare invece uno stile opposto: drammatizzazione dei problemi ed enfatizzazione degli affetti, con conseguente ricerca di aiuto e comprensione da parte dei colleghi; rischio di fronteggiare le situazioni con aggressività o, al contrario, mostrando dipendenza e fuga dalle responsabilità; difficoltà nella costruzione di relazioni stabili e soddisfacenti; scarsa funzione riflessiva; difficoltà a tollerare frustrazioni e ambiguità, con tendenza a imporre le proprie idee ai pazienti.
Quando un terapeuta preoccupato incontra un paziente avente caratteristiche distanzianti, o viceversa, potrà verificarsi una parziale compensazione delle tendenze di entrambi, ma più frequentemente si manifesteranno incomprensioni riguardanti le aree trascurate dai reciproci stili di attaccamento (l’affettività per i soggetti distanzianti e la cognizione per quelli preoccupati), con il risultato di una difficoltà di comprensione reciproca e di condivisione dei risultati. Una delle conseguenze potrà essere la scarsa compliance terapeutica o l’interruzione improvvisa della terapia.
Inoltre, la scarsa capacità di mentalizzazione dei clinici con stile di attaccamento insicuro potrebbe portarli a svolgere con difficoltà un’adeguata funzione riflessiva all’interno della relazione. I terapeuti distanzianti rischierebbero di non riuscire a tenere debitamente conto delle proprie risposte emotive e a confrontarle con la percezione degli stati mentali dei pazienti, mentre quelli preoccupati potrebbero risultare concentrati sui propri stati mentali e avere difficoltà a rappresentarsi quelli degli altri.
In queste condizioni si verificherebbero con facilità fallimenti nella percezione del Sé e dell’altro (in termini di emozioni, desideri, aspettative e credenze), con conseguenze negative sul processo diagnostico, sulla qualità della relazione e sul buon esito della terapia. E’ così possibile che il terapeuta faccia un uso non adeguato o addirittura difensivo della diagnosi, attui interventi o interpretazioni inappropriati o troppo precoci, fatichi a riconoscere i propri stati emotivi e quelli del paziente e agisca comportamenti inappropriati.
Al contrario, un clinico con attaccamento sicuro (tipo B), essendo in grado di integrare informazioni cognitive (logiche) con l’affettività e presentando una buona capacità riflessiva ed empatica, potrà affrontare la relazione terapeutica in modo più consapevole, manifestando capacità di mentalizzazione, di comprensione empatica, di comunicazione e di analisi razionale del problemi, collaborando col paziente e adattandosi al meglio, in modo duttile ed equilibrato, alle sue specifiche caratteristiche e necessità (indipendentemente dal suo stile di attaccamento).
Tali considerazioni, sottolinea Baldoni, si riferiscono a tendenze e rischi dei quali il clinico dovrebbe essere il più possibile consapevole, ma in realtà la formazione terapeutica è spesso in grado di compensare in buona parte le caratteristiche di attaccamento meno funzionali al buon esito della relazione col paziente.
Per quanto riguarda invece le indagini sperimentali in tale campo, a fianco di una già forte consapevolezza circa le relazioni esistenti tra attaccamento sicuro del paziente e buoni esiti nella costruzione dell’alleanza terapeutica e nel percorso di trattamento (Diener e Monroe, 2011; Smith, Msetfi e Golding, 2010), vi è oggi anche una parallela tendenza a studiare l’effetto dell’attaccamento del terapeuta su alleanza e outcome, anche attraverso ricerche empiriche.
Rubino, Barker, Roth e collaboratori (2000), ad esempio, hanno studiato, in un campione di 77 psicoterapeuti in formazione, la correlazione tra stile di attaccamento (valutato con il Relationship Scales Questionnaire, RSQ), empatia e livello di profondità dei commenti a filmati di pazienti che attraversavano una fase di rottura dell’alleanza terapeutica e dei quali era noto lo stile di attaccamento (sicuro, distanziante, invischiato o spaventato). I terapeuti con attaccamenti insicuri hanno fornito un numero di risposte empatiche significativamente inferiore rispetto a terapeuti con attaccamenti sicuri, e la differenza risultava particolarmente rilevante quando il commento riguardava i filmati di pazienti sicuri e spaventati. Questo dato è spiegabile con l’eccessivo coinvolgimento evocato dalla sofferenza o dall’ostilità del paziente, che potrebbe portare il terapeuta a rispondere in maniera angosciata o ostile, o anche con atteggiamenti iper-accudenti che lo inducono a trovare soluzioni immediate pregiudicando in tal modo l’atteggiamento di collaborazione in vista di uno scopo congiunto alla base di una buona alleanza terapeutica.
In generale, rispetto all’intero campione di psicoterapeuti, i commenti empatici più frequenti riguardavano i filmati dei pazienti con attaccamenti spaventati, erano un po’ meno frequenti con i filmati dei sicuri e degli invischiati ed erano minimi con quelli degli evitanti. Ciò è spiegabile con la particolare intensità e conflittualità delle richieste di aiuto dei pazienti spaventati, che da un lato suscita l’interesse del clinico e, dall’altro, data la forte conflittualità, lo costringe alla riflessione.
Rispetto alla profondità dei commenti, infine, questi risultavano più convenzionali e di profilo qualitativo inferiore più con i pazienti evitanti che con quelli invischiati e spaventati. Questa minore profondità delle risposte con pazienti distanzianti può essere spiegata in quanto, tali pazienti, hanno un atteggiamento che spesso minimizza da un lato l’espressione dei propri bisogni di ricevere aiuto e cura e dall’altro l’importanza della relazione con il terapeuta, provocando nel clinico una certa lontananza emotiva e quindi una maggiore difficoltà nell’empatizzare con i bisogni profondi, ma non espressi, del paziente.
La letteratura scientifica inizia così a connotarsi anche per la presenza di ricerche empiriche volte ad indagare le relazioni esistenti tra lo stile di attaccamento del terapeuta e alcuni aspetti della relazione clinica (Sauer, Lopez e Gormley, 2003; Black et al., 2005; Dinger e Strack, 2009; Bucci et al., 2015); tuttavia i risultati ottenuti non sempre sono in linea tra loro e non è semplice trarre conclusioni definitive sull’argomento.
Per quanto riguarda le revisioni della letteratura, queste si sono concentrate maggiormente sul ruolo del paziente (Daniel, 2006; Diener e Monroe, 2011; Smith et al., 2010), trascurando così la figura del terapeuta, tanto che ad oggi non esistono molte review che analizzino in modo sistematico gli studi compiuti in merito alle relazioni che intercorrono tra stile di attaccamento del clinico, alleanza e risultati della terapia.
Una recente rassegna (Degnan et al., 2014) ha però cercato di colmare tale vuoto, analizzando e comparando i risultati di 11 studi (a partire da 2258 lavori totali) volti ad indagare la relazione tra stile di attaccamento del terapeuta e alleanza terapeutica e/o outcome, compiuti tra il 1980 e il 2014, includendo nelle analisi solo quelli che si fossero avvalsi di misure validate per la valutazione dell’alleanza/outcome e dell’attaccamento. Nello specifico, l’alleanza è stata misurata principalmente attraverso il Working Alliance Inventory, WAI (in 6 degli studi considerati), mentre l’outcome è stato valutato soprattutto con la Symptom Check List-90 (SCL-90-R). Per la misura dell’attaccamento si è fatto ricorso a vari strumenti, alcuni etero-somministrati, altri ad auto-somministrazione: Adult Attachment Interview, AAI; Experiences in Close Relationship Scale, ECRS; Relationship Questionnaire, RS; Relationship Scale Questionnaire, RSQ; Attachment Styles Questionnaire, ASQ; Adult Attachment Scale, AAS.
L’utilizzo di misurazioni non omogenee, sia per quanto riguarda l’attaccamento che per quanto concerne l’alleanza terapeutica e l’outcome, costituisce però un’importante criticità dello studio, poiché non consente un corretto confronto dei risultati ottenuti.
E’ comunque possibile evidenziare qualche risultato interessante, anche se non sempre le conclusioni ottenute sono coerenti tra i diversi studi presi in esame.
Dei sette studi che hanno valutato l’impatto di un attaccamento sicuro, solo tre hanno dimostrato un’effettiva associazione positiva tra la sicurezza del terapeuta e l’alleanza terapeutica (Black et al., 2005; Bruck et al., 2006; Dunkle e Friendlander, 1996).
Dieci degli undici studi esaminati hanno misurato invece l’impatto di un terapeuta con attaccamento insicuro sull’alleanza. Tre studi (Black et al., 2005; Dinger et al., 2009; Sauer et al., 2003) suggeriscono che i clinici con uno stile di attaccamento ansioso stabiliscono alleanze di lavoro più povere con i loro clienti. Un ulteriore studio (Sauer et al., 2003) ha dimostrato che l’attaccamento ansioso del terapeuta è correlato positivamente a buoni livelli di alleanza all’inizio della terapia, ma ha un effetto negativo sulla alleanza stessa nel corso del tempo.
Su quattro studi, solo uno ha riscontrato un impatto diretto dello stile di attaccamento del terapeuta sui risultati del trattamento (Bruck et al., 2006): un attaccamento sicuro nel terapeuta porterebbe a esiti terapeutici più favorevoli rispetto a quelli ottenuti da un terapeuta con attaccamento ansioso o evitante.
Tuttavia, i risultati preliminari suggeriscono che questi rapporti potrebbero non essere così lineari e che stili di attaccamento del terapeuta e caratteristiche del paziente interagiscono tra loro nei processi di influenza dell’alleanza e degli esiti del trattamento. Altri studi hanno dimostrato che lo stile di attaccamento del terapeuta ha una maggiore influenza sull’alleanza e sull’outcome quando i pazienti presentano un quadro clinico grave. In particolare, uno studio (Schauenburg et al., 2010) ha messo in luce che lo stile di attaccamento sicuro del terapeuta ha avuto un migliore impatto su alleanza e outcome quando i pazienti presentavano una maggiore compromissione psicopatologica. Specularmente, è stato anche mostrato che l’attaccamento ansioso del terapeuta influenza negativamente la costruzione dell’alleanza con pazienti che riportano una maggiore compromissione a livello del funzionamento interpersonale.
Infine, i risultati di tre studi (Tyrell et al., 1999;Bruck et al., 2006; Petrowsi et al., 2011) suggeriscono che stili di attaccamento dissimili in paziente e terapeuta possono risultare vantaggiosi in termini di alleanza terapeutica e outcome: una mancanza di sovrapposizione tra stile di attaccamento di terapeuta e paziente renderebbe quest’ultimo più in grado di esplorare tali differenze e disconfermare così le strategie interpersonali ed emotive usualmente utilizzate, divenendo più in grado di adottare nuovi e più funzionali comportamenti, al servizio della terapia e dei suoi esiti positivi. Tuttavia, questo dato non è confermato da tutti gli studi che hanno indagato tale combinazione, tanto che un lavoro più recente (Wiseman e Tishby, 2014) ha dimostrato un impatto positivo su alleanza terapeutica e outcome qualora terapeuta e paziente presentino analoghi pattern di attaccamento (almeno in caso di attaccamento evitante a basso indice).
Nonostante l’indubbia necessità di procedere alla definizione di studi più rigorosi che valutino le associazioni tra stile di attaccamento del terapeuta e alleanza, la rassegna presa in esame mette in luce l’esistenza di alcune prove preliminari circa l’impatto positivo che un attaccamento sicuro nel terapeuta può avere sulla costruzione e sulla qualità dell’alleanza. La maggiore capacità di adattare il proprio stile interpersonale a seconda delle caratteristiche del paziente potrebbe essere un importante fattore favorente il buon esito della terapia.
Vi è inoltre qualche evidenza del fatto che un attaccamento insicuro può comportare conseguenze più rilevanti quando si lavora con pazienti complessi, maggiormente compromessi da un punto di vista clinico.
Alcune ricerche hanno poi evidenziato che lavorare con le emozioni potrebbe risultare più difficile per i terapeuti con attaccamento insicuro, in quanto gli evitanti potrebbero avvertire un certo disagio ad entrare in contatto con vissuti emotivi negativi, mentre gli ansiosi potrebbero percepire un eccessivo e disorganizzante coinvolgimento.
Poiché per ora non vi sono evidenze definitive e unanimi che emergano da ricerche empiriche circa le associazioni tra stile di attaccamento e alleanza terapeutica, è bene che i clinici prestino particolare attenzione alle proprie esperienze di attaccamento e a come queste possano entrare in gioco durante la terapia. Migliorare la conoscenza del proprio stile di attaccamento potrebbe aiutare i terapeuti a comprendere meglio alcune dinamiche interpersonali all’interno della relazione terapeutica, orientando così l’intervento e disponendo di maggiori strumenti clinici in caso sia necessario riparare alcune rotture dell’alleanza (Wallin, 2009).
Per quanto riguarda la “combinazione” tra stile di attaccamento del paziente e stile del terapeuta, al momento non è chiaro se la corrispondenza (o mismatching) sia benefica. Mallinckrodt (2010) afferma che i terapeuti dovrebbero inizialmente assecondare lo stile interpersonale del paziente per incrementarne la motivazione e l’aderenza alla terapia e successivamente, con il progredire del lavoro clinico, creare uno scarto tra il proprio stile e quello del paziente al fine di favorirne l’esplorazione e la messa in discussione, utile al cambiamento atteso.
Una via feconda per la ricerca in psicoterapia potrebbe essere costituita dall’indagare come i terapeuti dovrebbero utilizzare le maggiori conoscenze circa il proprio stile di attaccamento individuale ai fini di una migliore alleanza col paziente.
Per concludere, questa rassegna (a fianco di altri studi) evidenzia l’esistenza di alcune iniziali conferme dell’assunto secondo il quale lo stile di attaccamento del terapeuta e le interazioni tra l’attaccamento del clinico e quello del paziente impattano sull’alleanza e sui risultati della terapia. Tuttavia, alcune debolezze metodologiche e la grande eterogeneità delle caratteristiche e dei risultati degli studi considerati sottolineano la necessità di procedere nella definizione di nuovi e più rigorosi disegni di ricerca in quest’area, senza dubbio di grande interesse e rilevanza clinica. Alla luce di quanto fin qui riscontrato, è comunque bene che i terapeuti prestino particolare attenzione al proprio stile di attaccamento, a quello del paziente e alle conseguenze che questi potrebbero avere all’interno della relazione clinica: una buona conoscenza di tali aspetti, unitamente a quanto si ricava dalla Teoria dell’Attaccamento e dei Sistemi Motivazionali Interpersonali, costituisce senza dubbio un valido strumento per procedere con maggiore consapevolezza all’interno della pratica clinica.
ARTICOLO CONSIGLIATO:
La comunicazione terapeutica: gli strumenti e le strategie per renderla efficace
BIBLIOGRAFIA:
- Ackerman S. J., Hilsenroth M.J. (2001), A review of therapist characteristic and tecniques negatively impacting the therapeutic alliance. In Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Training, 38, pp. 171-185.
- Ackerman S. J., Hilsenroth M.J. (2003), A review of therapist characteristic and tecniques negatively impacting the therapeutic alliance. In Clinical Psychology Review, 23, pp. 1-33
- Ainsworth M. S., Blehar M. C., Waters E., Walls S. (1978), Patterns of attachment: a psychological study of the strange situation. Oxford, England: Winston.
- Backeland F., Lundwall L. (1975), Dropping out of treatment: a critical review. In Psychological Bulletin, 82, pp. 738-783.
- Baldoni F. (2008), L’influenza dell’attaccamento sulla relazione clinica: collaborazione, collusion e fallimento riflessivo. Maieutica, n.27-30 (giugno 2007- giugno 2008), pp. 57-72.
- Bein E., Anderson T., Strupp H. H., Henry W. P., Schaht T. E., Binder J. L., Butler S.F. (2000), The effects of training in time limited dynamic psychotherapy: changes in therapeutic outcome. In Psychotherapy Research, 10, pp. 119-131. DOWNLOAD
- Black S., Hardy G., Turpin G., Parry G. (2005), Self-reported attachment styles and therapeutic orientation of therapists and their relationship with reported general alliance quality and problems in therapy. In Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice, 78, pp. 363-377.
- Bowlby J. (1980), Attaccamento e Perdita, vol.3. Tr. it. Bollati Boringhieri, Torino 1972.
- Bowlby J. (1988), A secure base. London: Tavistock Routledge.
- Bruck E., Winston A., Aderholt S., Muran J.C. (2006), Predictive validity of patient and therapist attachment and introject styles. In Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice, 77, pp. 255-272.
- Bucci S., Seymour-Hyde A., Harris A., Berry K. (2015), Client and therapist attachment styles and working alliance. In Clinical Psychology and Psychotherapy.
- Daniel S. I. F. (2006), Adult attachment patterns and individual psychotherapy: a review. Clinical Psychology Review, 26, 968-984.
- Degnan A., Seymour-Hyde A., Harris A. Berry K. (2014), The role of therapist attachment in alliance and outcome: a systematic literature review. Clinical Psychology and Psychotherapy (2014).
- Diener M. J., Monroe J. M. (2011), The relationship between adult attachment style and therapeutic alliance in individual psychotherapy: a meta-analytic review. Psychotherapy, 48, 237-248.
- Dinger U., Strack M. (2009), Therapists’ attachment, patients’ interpersonal problems and alliance development over time in inpatient psychotherapy. In Psychotherapy Theory, Research, Practice, Training, vol.46, n.3, pp. 277-290.
- Dozier M., Cue K. L., Barnett L. (1994), Clinicians as caregivers: role of attachment organization in treatment. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 62, pp. 793-800.
- Dunkle J. H., Friedlander M. L. (1996), Contribution of therapist experience and personal characteristics to the working alliance. In Journal of Counseling Psychology, 43, pp. 456-460.
- Horvath A. O., Del Re A.C., Flückiger C., Symonds D. (2011), Alliance in individual psychotherapy. In Psychotherapy, 48, pp. 9-16.
- Kvilighan D.M., Patton M.J., Foote D. (1998), Moderating effects of client attachment of the counselor experience-working alliance relationship. In Journal of Counseling Psychology, 45, pp. 274-278.
- Liotti G., Monticelli F. (2014), Teoria e clinica dell’alleanza terapeutica. Una prospettiva cognitivo-evoluzionista. Raffaello Cortina Editore.
- Main M., Solomon J. (1986), Discovery of a disorganized/disoriented attachment pattern: procedures, findings and implications for the classification of behavior. In Brazelton T., Youngman M., Affective Development in Infancy. Ablex, Norwood, NJ.
- Mallinckrodt B. (2010), The psychotherapy relationship as attachment: evidence and implications. Journal of Social and Personal Relationships, 27, 262-270.
- Norcross J.C. (2011), Psychotherapy Relationship that Work. Evidence-Based Responsiveness. Owford University Press, New York.
- Petrowski K., Nowacki K., Pokorny D., Buchheim A. (2011), Matching the patient to the therapist: the roles of the attachment status and the helping alliance. In The Journal of Nervous and Mental Disease, 199, pp. 839-844.
- Rubino G., Barker C., Roth T., Fearon P. (2000), Therapist empathy and depth of interpretation in response to potential alliance ruptures: the role of therapist and patient attachment style. In Psychotherapy Research, 10, 4, pp. 408-420.
- Safran J.D., Muran J.C. (2000), Teoria e pratica dell’alleanza terapeutica. Tr. It. Laterza, Roma-Bari 2003.
- Sauer E.M., Lopez F.G., Gormley B. (2003), Respective contributions of therapist and client adult attachment orientations to the development of the early working alliance: a preliminary study. In Psychotherapy Research, 13, 3, pp. 371-382. DOWNLOAD
- Schauenburg H., Buchheim A., Beckh K., Nolte T., Brenkfranz K., Leichsenring F., Strack M., Dinger U. (2010), The influence of psychodynamically oriented therapists’ attachment representations on outcome and alliance in inpatient psychotherapy. In Psychotherapy Research, 20, pp. 193-202.
- Smith A. E. M., Msetfi R. M., Golding L. (2010), Client self-rated adult attachment patterns and the therapeutic alliance: a systematic review. In Clinical Psychology Review, 30, pp. 326-337.
- Tyrell C.L., Dozier M., Teague G.B., Fallot R.D. (1999), Effective treatment relationships for persons with serious psychiatric disorders: the importance of attachment states of mind. In Journal of Consulting and Clinical Psychology, 67, pp. 752-733.
- Wallin D. (2009), From the inside out: the therapist’s attachment patters as sources of insight and impasse. In M. Kerman (Ed.), Clinical Pearls of Wisdom: 21 Leading Therapists Offer Their Key Insights (pp. 245), New York: Norton W. W. & Company, Inc.
- Weiss R. (1982): Attachment in adult life. In: Parkes C.M., Stevenson Hinde J. (a cura di): The place of attachment in human behavior, Routledge, London.
- Wilkinson S.R. (2003): Coping and complaining. Attachment and the language of dis-ease. New York, Brunner-Routledge.
- Wiseman H., Tishby O. (2014), Client attachment, attachment to the therapist and client-therapist attachment match: how do they relate to change in psychodynamic psychotherapy? In Psychotherapy Research, 24, pp. 392-406.

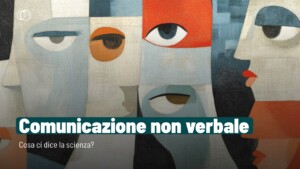
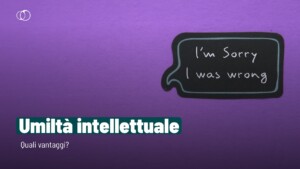

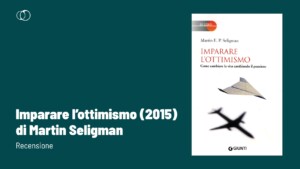














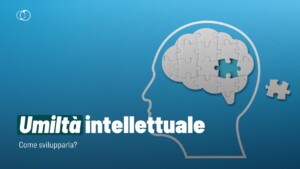




 La Mediazione Familiare, per la delicatezza dei temi che deve affrontare (aspetti sia emotivi che materiali), è una disciplina trasversale tra psicologia, sociologia e giurisprudenza e necessita la padronanza di competenze specifiche.
La Mediazione Familiare, per la delicatezza dei temi che deve affrontare (aspetti sia emotivi che materiali), è una disciplina trasversale tra psicologia, sociologia e giurisprudenza e necessita la padronanza di competenze specifiche.