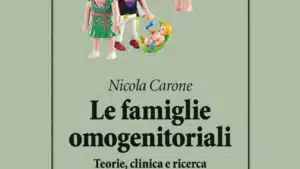Nonostante numerosi studi abbiano dimostrato l’assenza di una relazione tra il benessere dei bambini e l’orientamento sessuale dei loro genitori, le credenze negative sulla genitorialità lesbica e gay rimangono ancora molto diffuse.
Sebbene il processo di “omonormalizzazione” (Roseneil et al., 2013) abbia contribuito a mettere in discussione la nozione tradizionale di “famiglia”, a molti individui viene ancora negata la possibilità di diventare genitori a causa della non conformità al modello eteronormativo di famiglia. È il caso, ad esempio, delle coppie gay e lesbiche.
Le famiglie lesbiche e gay rappresentano un tasso di incidenza tale da non poter più essere considerate una minoranza silenziosa. Negli Stati Uniti, ad esempio, fin dai primi anni 2000, il National Survey of Family Growth (Chandra et al., 2005) ha rivelato che il 35% delle donne lesbiche e il 16% degli uomini gay avevano figli biologici o adottati.
Tuttavia, nonostante numerosi studi (ad es, Carneiro et al., 2017) abbiano dimostrato l’assenza di una relazione tra il benessere dei bambini e l’orientamento sessuale dei loro genitori, le credenze negative sulla genitorialità lesbica e gay rimangono ancora molto diffuse.
La legislazione riguardo la genitorialità gay e lesbica
Per quanto riguarda il panorama legislativo, la maggior parte dei Paesi occidentali ha ormai riconosciuto i diritti di queste coppie e dispone di normative dettagliate in materia di matrimoni o unioni civili tra persone dello stesso sesso e di genitorialità gay e lesbica.
L’Italia, fino a maggio 2016, era uno dei pochi Paesi europei in cui le coppie omosessuali non ricevevano alcun riconoscimento giuridico. L’approvazione della legge 76/2016 (Gazzetta Ufficiale, 2016) ha riconosciuto le unioni civili tra persone dello stesso sesso e ha esteso loro la maggior parte dei diritti delle coppie eterosessuali sposate. Ma prima dell’approvazione, un lungo dibattito si è focalizzato sulla sezione numero 5 del disegno di legge, che avrebbe riconosciuto il diritto di un partner di adottare i figli biologici dell’altro partner introducendo la cosiddetta step-child adoption. A causa delle profonde divisioni all’interno del governo, la sezione 5 è stata eliminata con il fine di far passare la legge, negando così a molti bambini che crescono in famiglie con genitori dello stesso sesso la stessa tutela giuridica dei loro coetanei (Lampis et al., 2017).
I dati dell’Istituto Nazionale di Statistica rivelano che nel 2012 le coppie omosessuali erano 7.513 con 529 figli (ISTAT, 2012), forse sottostimati dato che molte coppie preferiscono non dichiararsi e che il censimento si riferisce solo alle coppie conviventi (Baiamonte & Bastianoni, 2015). Nonostante la sottostima, ciò sottolinea quanto le genitorialità lesbica e gay rappresentino una realtà consolidata nel Paese. Eppure, nonostante ciò, l’eteronormatività continua a porre il veto a qualsiasi espressione di sessualità non convenzionale e a far apparire l’eterosessualità come la scelta più ovvia (Weston, 1991). Secondo l’Agenzia dell’Unione Europea per i Diritti Fondamentali (2012), la percentuale di italiani che ritiene che la genitorialità gay e lesbica danneggi i bambini è tra le più alte in Europa. Come hanno sostenuto molti autori (Baiocco et al., 2013; Bertone, 2017), questi pregiudizi persistono anche a causa di tradizioni religiose e culturali che incoraggiano opinioni e sentimenti omofobici.
Le barriere culturali, sociali e istituzionali che le persone con orientamento omosessuale si trovano ad affrontare possono giocare un ruolo cruciale nei loro desideri e nelle loro intenzioni di crescere dei figli. Per questo motivo, uno studio di Lasio e colleghi (2020) ha cercato di analizzare i desideri e le intenzioni di diventare genitori in un campione di persone gay e lesbiche italiane.
I risultati hanno rivelato che l’84,6% dei partecipanti ha dichiarato il desiderio di diventare genitore e che il 64,6% ha dichiarato l’intenzione di avere un figlio. Questo ci dimostra che, nonostante i pregiudizi prevalenti e il sistema legislativo italiano, gli individui gay e lesbiche tendono a riferire la volontà di diventare genitori.
Bisogna anche considerare che in Italia è presente una forte cultura orientata alla famiglia; il desiderio di avere figli può dipendere in gran parte dall’idea che “fare famiglia” sia un valore importante enfatizzando gli aspetti positivi del diventare genitori.
Le barriere alla genitorialità gay e lesbica
Gli autori evidenziano inoltre un divario significativo tra i desideri e le intenzioni genitoriali: il desiderio di avere un figlio non sempre si traduce nell’effettiva intenzione di averne. Ciò riflette le profonde contraddizioni del contesto culturale, sociale e politico italiano che, da un lato, enfatizza i valori della famiglia e della genitorialità ma, dall’altro, nega il riconoscimento di questi diritti ai genitori dello stesso sesso. A causa del contesto, la decisione di diventare genitori per queste persone, rispetto alle persone eterosessuali, può essere più difficile.
Per comprendere meglio questi risultati, bisogna concentrarsi sulle barriere specifiche per le persone gay e lesbiche che cercano di avere figli.
In Italia, il pregiudizio nei confronti della genitorialità lesbica e gay continua. Come dimostra la letteratura esistente (Costa et al., 2014; Whitley, 2009), il pregiudizio può avere radici nelle diverse tradizioni religiose e culturali che incoraggiano opinioni e sentimenti omofobici (Baiocco et al., 2013). Gli atteggiamenti negativi basati sulla religione potrebbero essere interiorizzati anche da individui gay, lesbiche e bisessuali, che possono persino arrivare ad avallare le argomentazioni religiose sostenendo loro stessi che non sono adatti a diventare genitori (Lasio et al., 2019).
Proprio sulla base di quanto detto, gli autori hanno preso in considerazione anche la pratica religiosa e il posizionamento politico e ideologico. Tuttavia, contrariamente ai risultati di altri studi (ad es, Petruccelli et al., 2015), il posizionamento politico, l’affiliazione e il coinvolgimento religioso non hanno mostrato alcun effetto significativo né sui desideri né sulle intenzioni genitoriali.
L’età è l’unica variabile ad aver avuto un effetto significativo sull’intenzione di diventare genitore: in età più elevata si dichiarano maggiori intenzioni di avere figli. Questi dati sono in linea con i risultati sulla popolazione LGBT, ma anche con la tendenza generale che in Italia è quella di avere figli quando si superano i 31 anni per le donne e i 35 per gli uomini (ISTAT, 2012).
Infine, i desideri e le intenzioni genitoriali potrebbero essere influenzati da una serie di variabili diverse non presenti in questo studio. I risultati ottenuti, ad esempio, potrebbero essere mediati da fattori specifici, come gli atteggiamenti personali, i valori familiari, le motivazioni verso la genitorialità e il livello di supporto sociale disponibile. Toccherà a future ricerche approfondire questi aspetti.