Innamorata persa – Centro di Igiene Mentale – CIM Nr.07 – Storie dalla Psicoterapia Pubblica
Innamorata persa
– Leggi l’introduzione –
 Spinto dal destare l’interesse del lettore, temo di aver dato una idea distorta o perlomeno parziale del lavoro del CIM. Non si deve pensare che sia un susseguirsi di emergenze di casi bizzarri e interessanti che si concludono rapidamente e più o meno positivamente.
Spinto dal destare l’interesse del lettore, temo di aver dato una idea distorta o perlomeno parziale del lavoro del CIM. Non si deve pensare che sia un susseguirsi di emergenze di casi bizzarri e interessanti che si concludono rapidamente e più o meno positivamente.
Nella grande maggioranza, superato il momento dell’acuzie segue una lunga presa in carico che prevede aspetti psicologici, farmacologici e sociali e che dura per moltissimo tempo.
Sul singolo caso si concentrano dunque quelle risorse professionali che sono necessarie, formando mini equipe che coordinano i diversi interventi, anche tenendo conto della facilità dei diversi operatori a collaborare.
Maria detta Gilda non avrebbe mai seguito un caso insieme al Dr. Giuseppe Irati e tale reciproca intolleranza lasciava ai più molti sospetti su un periodo che si collocava tra il secondo ed il terzo matrimonio di Irati ed aveva visto l’improvvisa separazione di Maria.
Al contrario, Carlo Biagioli e Luisa sarebbero andati a fare una domiciliare anche a Lucifero nell’ultimo girone dell’inferno, se avessero avuto l’opportunità di trascorrere una notte fuori insieme.
Per questo non c’è trasferta di durata superiore ad un giorno che non li veda candidati.
Ma lasciamo perdere i pettegolezzi e torniamo alla operatività normale.
Gli assistenti sociali curano la parte economica e, insieme agli infermieri, la riabilitazione e il reinserimento lavorativo che li porta ad essere costantemente impegnati in contatti istituzionali con gli amministratori locali, sindacati e organizzazioni di categoria.
Ancora, nella maggior parte dei casi la presa in carico avviene su richiesta dell’interessato o dei familiari senza alcuna emergenza.
Infine, le varie professionalità sono impegnate in diversi progetti per la promozione della salute mentale.
Il millennio appena iniziato dopo le vacanze di Natale vede gli assistenti sociali, Silvia Ciari e Giovanni Brugnoli, determinati come sempre, impegnati nella creazione di una rete di residenze per accogliere i pazienti che saranno dimessi dagli ospedali psichiatrici giudiziari entro due anni.
Le psicologhe, Filata e Ficca, stanno predisponendo degli sportelli di ascolto nelle scuole superiori per intercettare, in collaborazione con i Sert, il disagio giovanile nel delicato periodo tardo adolescenziale che vede l’esordio delle patologie psicotiche e dei disturbi alimentari.
Le infermiere Maria e Luisa hanno calendarizzate le visite domiciliari per tenere il polso delle situazione, oltre che gestire alcune attività riabilitative per migliorare la qualità della vita e favorire il reinserimento nella comunità di chi ha avuto difficoltà che lo hanno costretto ad una sosta ai box.
I medici, Irati e Mattiacci, hanno varato un corso di aggiornamento per i colleghi di medicina generale sul rischio suicidiario con la sponsorizzazione delle aziende produttrici degli antidepressivi.
Salta immediatamente agli occhi che, per fare tutto questo, gli operatori risultano pochi.
Oltre alle richieste dell’assegnazione di ulteriori risorse sostenute, senza mediazioni, dal presidente dell’associazione dei pazienti e familiari, l’indomito Vitale Eusebi, cosa fare?
Facendo di necessità virtù, Biagioli ha inventato il metodo Ayax ad imitazione del calcio totale (tutti in attacco e tutti in difesa) giocato dall’indimenticabile Olanda di Kruiff.
Ciò significava che, se la ideazione dei vari progetti era affidata alle specifiche professionalità, la realizzazione invece coinvolgeva tutti, con una feconda osmosi di competenze. Infermieri agli sportelli di ascolto nelle scuole, psicologi in domiciliare che scoprivano aspetti dell’esistenza dei loro pazienti banditi, in genere, dall’asettico ambulatorio, medici a confronto con i sindaci per ottenere benefici per i loro assistiti.
Il solo Biagioli, dedicandosi al coordinamento di tutte queste attività e, soprattutto, ai rapporti con il centro pulsante della ASL non ha specifici incarichi. Trascorre spesso le mattinate in verbose, lunghissime quanto inconcludenti riunioni con gli alti dirigenti della ASL per decisioni inerenti il management aziendale, la suddivisione delle risorse, la mediazione con i sindacati, la stipula di convenzioni ed appalti di ogni genere.
Durante tali insensati sperperi di tempo e denaro fissa ansioso il cellulare come un adolescente in attesa della conferma del primo appuntamento. Si auspica una chiamata di emergenza che gli consenta una giustificatissima fuga verso ciò che unicamente lo interessa: i pazienti, meglio se gravi.
Le riunioni cliniche in quel mese di gennaio del 2001 si concentravano su due casi provenienti entrambi dalle frazioni a sud di Monticelli che sembravano affette da una epidemia di follia: Antonella e Omero.
Il contatto con Antonella era avvenuto con la dottoressa Mattiacci, durante una consulenza nel reparto di ginecologia dell’ospedale generale di Monticelli.
Dopo la dimissione, la Mattiacci chiese di essere affiancata dalla dottoressa Maria Filata per la stima che aveva nei suoi confronti e perché riteneva utile una figura con lo spessore materno della Filata che lei, senza figli sentiva di non avere. Antonella, 33 anni, con una prevalenza di curve rispetto alle rette nel disegno del suo corpo, ha un modo infantile di relazionarsi sollecitando tenerezza e accudimento. Meglio la definisce una ambiguità di fondo per cui tratti infantili sono mischiati ad una femminilità seduttiva. Sin da piccola ha dovuto farsi carico della gestione del padre, bracciante agricolo, durante le prolungate assenze della madre ricoverata in clinica per un disturbo bipolare risoltosi solo qualche anno fa con una corda intorno ad un trave della stalla.
Nella ricostruzione della sua storia, nella psicoterapia con la Filata, emergerà dopo parecchi mesi che aveva sostituito la madre non soltanto nella gestione della casa. Forse anche lei presentava oscillazioni stagionali del tono dell’umore, ma il ricovero in ginecologia era stato motivato dalla terza gravidanza isterica nel giro di due anni.
La sessualità per Antonella era un terreno scivoloso. Il suo primo ragazzo importante lo aveva avuto a 18 anni, nello stesso anno della morte della madre. Secondo la Filata, era stato un modo per arginare le richieste del padre che, dopo la vedovanza, erano diventate più pressanti.
Quando si innamorava, Antonella mostrava una gioia incontenibile che scivolava rapidamente in una specie di eccitamento sub maniacale. Eccedeva nel trucco e le manifestazioni affettive anche verso semplici conoscenti erano talmente esagerate da diventare moleste.
Una gelosia soffocante mise in fuga il giovane partner. Antonella per sei mesi non uscì più di casa, era il padre a fare la spesa e persino ad acquistare gli assorbenti per lei. Giorno e notte con la stessa tuta da ginnastica, aveva nel cibo il suo unico piacere, prese rapidamente 15 kg e la vergogna per il suo aspetto la relegò in casa.
Poi, al carnevale di cinque anni dopo, quando il paese aveva dimenticato la sua esistenza, si presentò alla grande festa mascherata del giovedì grasso.
Alla dottoressa Filata confidò che la madre le aveva parlato, assicurandola che avrebbe trovato in quella festa l’uomo della sua vita: la luce sinistra della follia già lampeggiava nei suoi occhioni da Lolita.
Il suo fare oltremodo disponibile fece si che quella notte incontrò non uno ma ben tre uomini della sua vita che, ubriachi, ne abusarono fino all’alba. Il padre preferì mettere tutto a tacere per non precludere un futuro matrimoniale alla figlia. Antonella tornò nella sua tuta bozzolo per altri cinque anni, quando fu un vero principe a risvegliarla.
Era estate, Antonella si avvicinava ai 30 anni e ai quasi 100 Kg, il padre chiamò il vecchio medico di famiglia per una dieta ma si presentò un giovane sostituto il dottor Alfonso neolaureato alla sua prima sostituzione.
Lui si interrogò a lungo per capire se avesse avuto responsabilità nello scatenamento di un delirio erotomanico di Antonella nei suoi confronti, ma la cosa più gentile che le aveva detto era stato “lei è ancora così giovane, non deve lasciarsi andare”.
Ancora non esisteva il reato di stalking, ma Alfonso si rivolse comunque ai carabinieri di Monticelli perché intimassero ad Antonella di cessare i comportamenti persecutori nei confronti suoi e della giovane moglie incinta.
Antonella, infatti, era convinta che Alfonso fosse perdutamente innamorato di lei e impedito a realizzare la loro unione dalla macchinazione della moglie che lo tratteneva con una fattura magica che aveva anche provocato la gravidanza.
A quel tempo nessuno si era premurato di segnalare la situazione al CIM, in paese tutti dicevano che Antonella era, come del resto la madre, strana ma innocua, ed anche un po’ mignotta senza scopo di lucro, per il piacere di ragazzi e anziani. Per la cattiva fama di cui godeva nessuno si avvicinava a lei con intenzioni serie, l’ultimo uomo lo aveva incontrato a Roma, Samyr, operaio cassaintegrato con un figlio di tre anni che le aveva giurato che l’avrebbe sposata e quando, per l’ennesima volta, aveva spostato la data del presunto divorzio, le mestruazioni erano scomparse, la pancia di Antonella aveva iniziato a lievitare ed il seno ad indurirsi e farsi scuro il capezzolo.
Non si capacitava che i test comprati in farmacia fossero negativi e per questo si presentò in pronto soccorso lamentando dolori e piccole perdite insomma un rischio di aborto.
Sei mesi più tardi in occasione di un altro rinvio dell’atteso divorzio ci fu una replica.
Un anno dopo Samyr scomparve definitivamente e Antonella fu nuovamente “incinta” e decisa a portare comunque avanti la gravidanza e a chiamare quel figlio con il nome del padre.
Solo durante questo ricovero e solo perché tramortì con una ginocchiata sui testicoli il tecnico ecografista che si ostinava a non vedere il delizioso piccolo Samyr annidato nel suo utero, fu chiamato il CIM.
I neurolettici e gli stabilizzatori dell’umore prescritti dalla dottoressa Mattiacci contenevano il vissuto emotivo di tristezza e rabbia.
Sedute settimanali con la dottoressa Filata cercavano di capire perché la sessualità e la maternità fossero così centrali e pericolose nei vissuti di Antonella. A tal proposito, la crescente ostilità del padre verso qualsiasi trattamento che non fosse esclusivamente farmacologico rinsaldò l’idea che ci fosse un oscuro segreto familiare.
Un primo inserimento lavorativo predisposto da Silvia Ciari in una cooperativa che gestiva l’asilo nido di Monticelli dovette essere interrotto: la presenza di bambini piccoli era troppo stressante per Antonella.
Un altro ramo della cooperativa si occupava di assistenza agli anziani e qui la sua opera fu molto apprezzata ed il contratto rinnovato.
Frequentato un corso al centro diurno si appassionò alla pittura e, nonostante i suoi quadri avessero qualcosa di profondamente inquietante, a 37 anni fece la sua prima collettiva nei locali del comune.
Non era una vera e propria collettiva, solo un altro artista esponeva ed era proprio quell’Omero che ho messo in stand by molte righe sopra.
TORNA ALL’INDICE DELLA RUBRICA
ARGOMENTI CORRELATI:











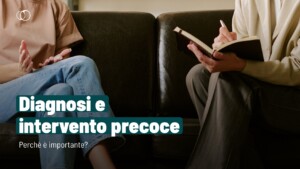


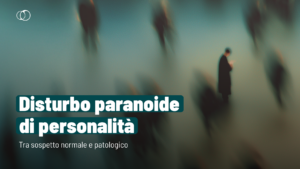




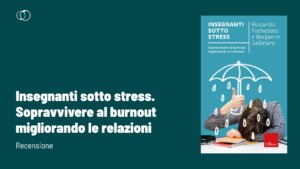


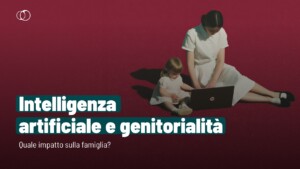


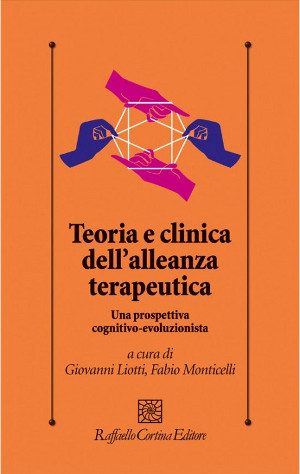 Scopo dichiarato (ed efficacemente perseguito) di questo libro è fornire al lettore una cornice teorica, una chiave di lettura clinica e un metodo di lavoro sull’alleanza terapeutica.
Scopo dichiarato (ed efficacemente perseguito) di questo libro è fornire al lettore una cornice teorica, una chiave di lettura clinica e un metodo di lavoro sull’alleanza terapeutica.
 Attualmente il concetto di salute si identifica in uno stato di benessere che coinvolge la dimensione fisica, psicologica e sociale dell’individuo.
Attualmente il concetto di salute si identifica in uno stato di benessere che coinvolge la dimensione fisica, psicologica e sociale dell’individuo. Si è dimostrato come la qualità coniugale predica uniformemente un maggiore benessere personale (ovviamente, i matrimoni più felici rendono le persone più felici ) e questo effetto è diventato molto più forte e solido nel tempo. Il divario tra i benefici derivanti da un buon matrimonio rispetto a uno mediocre, dunque, è aumentato.
Si è dimostrato come la qualità coniugale predica uniformemente un maggiore benessere personale (ovviamente, i matrimoni più felici rendono le persone più felici ) e questo effetto è diventato molto più forte e solido nel tempo. Il divario tra i benefici derivanti da un buon matrimonio rispetto a uno mediocre, dunque, è aumentato.

 Quando una persona si trova in un luogo particolarmente alto, il circuito della paura reagirebbe alla situazione inviando un rapido segnale che la spinge a porsi in una condizione di maggior sicurezza, spesso senza che ne sia del tutto consapevole, fino a quando non ragiona sul proprio comportamento valutando i segnali di percezione corporea come impulso anziché come segnale di sopravvivenza.
Quando una persona si trova in un luogo particolarmente alto, il circuito della paura reagirebbe alla situazione inviando un rapido segnale che la spinge a porsi in una condizione di maggior sicurezza, spesso senza che ne sia del tutto consapevole, fino a quando non ragiona sul proprio comportamento valutando i segnali di percezione corporea come impulso anziché come segnale di sopravvivenza.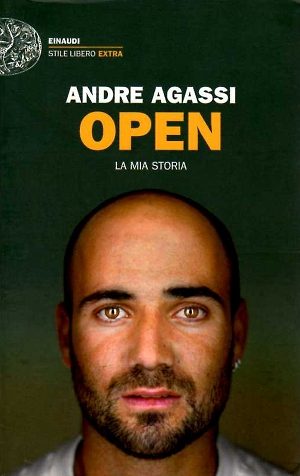
 Questo studio sottolinea l’importanza di considerare il ruolo dei Disturbi di Personalità e dell’Abuso di Alcool, e in generale di Sostanze, quando si esamina la correlazione esistente tra Gioco d’Azzardo Patologico e comorbilità psichiatrica sia per comprendere meglio i meccanismi patologici che per progettare il trattamento.
Questo studio sottolinea l’importanza di considerare il ruolo dei Disturbi di Personalità e dell’Abuso di Alcool, e in generale di Sostanze, quando si esamina la correlazione esistente tra Gioco d’Azzardo Patologico e comorbilità psichiatrica sia per comprendere meglio i meccanismi patologici che per progettare il trattamento.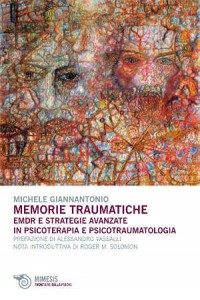
 Spinto dal destare l’interesse del lettore, temo di aver dato una idea distorta o perlomeno parziale del lavoro del CIM. Non si deve pensare che sia un susseguirsi di emergenze di casi bizzarri e interessanti che si concludono rapidamente e più o meno positivamente.
Spinto dal destare l’interesse del lettore, temo di aver dato una idea distorta o perlomeno parziale del lavoro del CIM. Non si deve pensare che sia un susseguirsi di emergenze di casi bizzarri e interessanti che si concludono rapidamente e più o meno positivamente.