L’Odissea di Omero – Centro di Igiene Mentale – CIM Nr.08 – Storie dalla Psicoterapia Pubblica
L’Odissea di Omero
– Leggi l’introduzione –

Mentre gli scienziati erano al lavoro per perfezionare la macchina, lui aveva il compito di raccogliere tutto quanto rappresentasse la nostra cultura in un luogo isolato, il suo garage, che sarebbe stata la prima capsula teletrasportata oltre i confini della galassia. Gli spionaggi extraterrestri che da secoli temevano un invasione degli umani avevano colonizzato molte menti di uomini.
L’invito ad occuparsi di Omero era giunto dal dottor Rodolfo Torre, attuale direttore del Dipartimento di salute Mentale che, ponendosi con atteggiamento rimproverante aveva immediatamente irritato Biagioli che non riusciva ad avere un rapporto sereno col suo vecchio maestro.
A sua volta Torre aveva raccolto le segnalazioni del sindaco di Monticelli che aveva sentito dire alla gente “ tanti appresso a quella sgualdrinella (intendendo Antonella) e nessuno che si occupi di quel povero ragazzo”.
Il povero ragazzo, al secolo Omero Cogliati, 45 anni portati malissimo, spalle curve, capelli scuri lisci, forforosi e già molto radi, occhi che esprimevano il più assoluto disinteresse, viveva da solo nel garage della casa della madre vedova, Assunta.
Un letto singolo, un tavolo e due sedie di formica marrone, un lavandino con poggiato uno scolapiatti di plastica rossa ed una stufetta elettrica con la parabola tutta ammaccata, la moto Guzzi 350cc del padre.
Alle pareti, una sventagliata di quadri caotica. Per usare il gabinetto saliva in casa della madre. Lì lasciava il sacchetto della roba da lavare e tornava con quella pulita. Comunque il cambio vestiti era previsto mensilmente e la doccia ogni due mesi. Nel garage aleggiava dunque quel classico odore di psicotico, un misto di fumo freddo di sigarette, cibo stantio, essere umano in macerazione e fluidi corporei evaporati.
Non cucinava e la madre gli lasciava di ritorno dalla spesa frutta, affettati, formaggi e pane sulla finestrina del garage che lui prendeva quando non visto.
La vita per Omero si era presentata subito in salita.
La madre era al secondo mese della sua gravidanza nell’agosto del 1956 quando apprese dalla radio che il marito Giovanni era tra i 136 italiani che sarebbero rimasti per sempre in terra belga nelle profondità della miniera di carbone di Marcinelle dove, per un errore umano, morirono 262 minatori.
Il padre, emigrante morto eroicamente per dare un futuro alla famiglia, restò nella mente di Omero come un mito irraggiungibile.
La famiglia, di origini molisane, non aveva parenti nè la madre, sposatasi contro la volontà della famiglia, ebbe coraggio di tornare al suo paese d’origine. Trattata come una vedova di guerra, ottenne un posto alle poste con cui riusciva ad andare avanti galleggiando sopra il livello di povertà. Quel figlio molto intelligente avrebbe rappresentato il suo riscatto.
In effetti, Omero alle elementari e poi alle medie era sempre il primo della classe e si immusoniva se non raggiungeva il dieci in tutte le materie. Tutta la sua vita era la madre, che non lasciava un istante, la scuola e i libri. Non aveva amichetti. Quando gli altri lo cercavano per giocare insieme spariva per ore e salutava a stento gli adulti che venivano a far loro visita. Sembrava una timidezza sconfinata ma era qualcosa di più, Omero tanto era interessato alle cose ed al loro funzionamento tanto era disinteressato agli esseri umani.
Torturava i piccoli animali che riusciva a catturare nel giardino di casa, mutilava i ragni zampa dopo zampa fino a che non ne rimaneva la rotonda immobile palletta del ventre, collezionava le code delle lucertole e le ali strappate alle farfalle.
A 10 anni bruciò con la benzina presa dal serbatoio del motorino delle poste il gatto siamese dei vicini.
Da quel momento le famiglie non gradirono più che i loro figli giocassero con Omero che restò sempre più solo.
Non ne provava alcun dolore e ancora di più si dedicò ai suoi amati libri di matematica.
Certi del suo talento i professori sollecitarono la madre a garantirgli le scuole superiori, possibilmente il liceo scientifico, in vista di ingegneria o matematica pura come lui diceva spesso.
Le astrazioni lo attraevano così come la concretezza e gli umani lo ripugnavano.
I soldi per prendere il pullman tutti i giorni per raggiungere il liceo scientifico di Vontano non c’erano.
La sua altissima media però consentiva una possibilità: l’accademia militare della Nunziatella di Napoli non comportava spese per le famiglie dei più meritevoli, che si assumevano l’unico impegno di non lasciare l’esercito almeno per i cinque anni successivi alla laurea.
Per i primi sei mesi giunsero all’ufficio postale, dove la mamma lavorava, rassicuranti cartoline postali con su scritto “tutto bene”, “ niente di nuovo”, “quando vieni a trovarmi”, “ cibo abbondante”.
Poi, silenzio assoluto per altri sei mesi.
Quando la madre, preoccupata, stava racimolando i soldi per andare a sincerarsi di come stessero le cose ecco arrivare un telegramma proprio per Assunta Ginestra vedova Cogliati: la si pregava di recarsi all’ospedale militare del Celio di Roma a ritirare, diceva proprio così, suo figlio Omero che era stato riformato per motivi psichiatrici.
Assunta potè vederlo per una mezz’ora, poi il colonnello medico la liquidò, sostenendo che il ragazzo poteva agitarsi. Vista la madre sprovveduta e spaventata sul da farsi la rassicurò, dicendole che sarebbe stato l’esercito a sistemare Omero in un luogo idoneo.
Dunque dai 17 ai 30 anni Omero stette al Manicomio di Santa Maria della Pietà di Roma (il più grande d’Europa) dove ricevette le migliori cure dell’epoca.
Assunta temeva quanto poi effettivamente si verificò nel 1986.
Per via della legge Basaglia i matti non erano più tali e dovevano occuparsene le famiglie.
In paese quasi non lo ricordava più nessuno, lei stessa ne aveva paura, così gli attrezzò il garage e iniziò il loro menage fatto di panni che salivano e scendevano, di affettati, formaggi e frutta sul davanzale.
Omero non usciva mai dal suo garage ed il paese presto ne dimenticò l’esistenza.
Il sindaco si avvide di lui controllando le liste elettorali, chiese notizie in paese e convocò il dottor Torre: stava al CIM riesumarlo.
In una riunione con Biagioli , il sindaco e la madre formularono le ipotesi più assurde: Biagioli avrebbe potuto presentarsi come un incaricato del comune per verificare l’abitabilità, oppure un idraulico o un talent scout per nuovi talenti della pittura, oppure la madre avrebbe potuto sbriciolare i farmaci all’interno delle pagnottelle che gli comprava o diluirli nell’acqua minerale.
Giovanni e Biagioli, che si occuperanno del caso essendo quelli delle “mission impossible” per la capacità di non scoraggiarsi e di inventare soluzioni creative ma, soprattutto, perché si divertono a lavorare insieme intendendosi al volo, scartano tutte le ipotesi che prevedano un inganno e scrivono una lettera per Omero che affidano alla madre.
“ Caro Omero, non ci conosciamo e se mi arrivasse una lettera da uno sconosciuto la getterei immediatamente, tanto più se si trattasse di uno psichiatra che vuol farsi i fatti miei. Nulla di strano, dunque, se a questo punto la strapperai in mille pezzi, ti garantisco che sei libero di farlo e non ci saranno conseguenze.
Ti scrivo perché tua madre e il sindaco sembrano preoccupati per la tua salute, insomma si chiedono se tu sia matto. Penso che vivere isolati sia una delle possibili scelte di vita e mi vengono in mente “gli stiliti” o, più vicine, le suore di clausura del convento della Consolata. Che sia una scelta libera, o una costrizione a motivo di qualche paura, tu solo lo sai. Siccome una mamma preoccupata scassa, volevo chiederti se, quando e se tu vorrai, ci darai una mano a tranquillizzarla in modo che tutti si possa campare più tranquilli.
Se ti andrà di farlo fai una chiamata allo 0578992233 e cerca di me, Carlo, o di Giovanni che lavora con me.
In verità anche io sono un po’ curioso di sapere se sei matto o un gran fico che ha capito tutto.
Per comunicare con me puoi utilizzare quello che preferisci: oltre il numero di prima ti dò anche il cellulare mio 3309874356 e la mail [email protected]. Vedi tu!”
Alla riunione generale partirono le scommesse: la chiamata di Omero era data 1 a 5, in altri termini veniva stimata con una probabilità del 20%.
La dottoressa Mattiacci era per un TSO per ripartire daccapo con un caso troppo trascurato, la dottoressa Ficca, la cui meticolosità ossessiva per le procedure e la paranoia erano peggiorate dall’inizio della convivenza con l’ingegner Riccardo, era per garantirsi da un punto di vista medico legale dopo la segnalazione, e fare una domiciliare comunque. Luisa era comunque sempre d’accordo con Biagioli, sebbene indispettita di non essere stata scelta come compagna per questa nuova avventura che si prospettava lunga, ma il crescere dei pettegolezzi su di loro e l’attivazione del marito di Luisa avevano consigliato diversamente o forse Biagioli, superato l’apice stava scivolando lungo la parabola discendente dell’innamoramento.
Gilda, poi, sosteneva di non dover intervenire in alcun modo accusando il CIM di essere strumento di normalizzazione di tutte le devianze al servizio del potere costituito. Le sue posizioni si erano ancor più radicalizzate dopo la morte del fratello, di cui sentiva colpevoli la società in generale ed il CIM in particolare.
Giuseppe Irati, impeccabile in un doppiopetto grigio che lo faceva diverso dal resto del popolo in jeans d’ordinanza, ribadiva che l’unico intervento possibile e deontologicamente corretto fosse sui portatori della richiesta, vale a dire la madre.
La saggezza della dottoressa Filata ricordò a tutti che la discussione si sarebbe potuta rimandare a un mese, dopo aver concesso ad Omero il tempo di eventualmente farsi vivo.
Non era una situazione d’urgenza, ma cronica da anni, che solo la compilazione delle liste elettorali aveva sollevato dall’oblio, dunque calma.
Un mese dopo, alla riunione successiva, si discusse a lungo se chi aveva scommesso 1 contro 5 sulla telefonata di Omero avesse o meno vinto.
Per la Ficca, che non aveva intenzione di pagare non c’erano dubbi: non c’era stata nessuna chiamata.
Al contrario la Filata, sempre attenta alla sostanza delle cose e poca incline a dispute nominalistiche che chiamava con un brutto nome, sosteneva che la presenza nella stanza accanto di Omero in compagnia di Carlo e Giovanni fosse un successo, anche se non aveva chiamato e si era presentato direttamente due giorni prima al portoncino del CIM. Addirittura, a suo avviso, i perdenti avrebbero dovuto pagare il doppio.
Per soddisfare la curiosità dei lettori debbo chiarire subito che Omero era effettivamente matto e non semplicemente un signore riservato o tutt’al più evitante o schizoide.
L’accademia militare della Nunziatella non lo aveva riformato, ma gli aveva affidato in gran segretezza una missione speciale: altro che caccia militari , razzi e astronavi, il futuro del trasporto intergalattico era il teletrasporto.
Mentre gli scienziati erano al lavoro per perfezionare la macchina, lui aveva il compito di raccogliere tutto quanto rappresentasse la nostra cultura in un luogo isolato, il suo garage, che sarebbe stata la prima capsula teletrasportata oltre i confini della galassia. Gli spionaggi extraterrestri che da secoli temevano un invasione degli umani avevano colonizzato molte menti di uomini.
Durante il periodo del ricovero al Santa Maria della Pietà (noto centro di tortura interplanetario) avevano tentato in tutti i modi violenti possibili di estorcergli il suo segreto. Ora lo facevano in modo più subdolo con onde elettromagnetiche che gli leggevano il pensiero. Le onde però non riuscivano a penetrare la saracinesca metallica del garage e, per le rare volte che usciva, si era fatto un passamontagna completamente rivestito di carta stagnola anch’essa schermante le onde.
Lui era stato scelto per la sua attitudine matematica, l’intelligenza superiore e, soprattutto, per la stupidità della madre che le impediva di accorgersi di cosa le accadesse intorno e, dunque, del vitale segreto del figlio.
Aveva accettato di incontrarli perché recentemente, tormentato dalle pressioni esterne sentiva la sua resistenza venir meno e Carlo e Giovanni avrebbero potuto essere due preziosi alleati contro lo stress, proprio a motivo della loro professione. Della selezione del materiale che testimoniasse la nostra civiltà avrebbe continuato ad occuparsene personalmente, essendo il suo compito specifico, loro sarebbero potuti essere dei personal trainer per metterlo in perfetta forma in vista della missione.
Ricevuta la loro lettera aveva chiesto ai suoi superiori il permesso di coinvolgerli e questo era giunto inequivocabile con un servizio televisivo del giorno stesso sul fitness fisico e mentale che si chiudeva con la famosa frase latina “mens sana in corpore sano”.
Nella cosmografia di Omero intorno a lui c’erano degli schermi protettivi, il metallo e la stupidità della madre, dalle spie mentali al servizio dei terribili extraterrestri che impedivano la piena liberazione della cultura terrestre. Lui, solo ma ora con l’aiuto dei suoi due trainer avrebbe liberato l’umanità dall’oppressione galattica.
Carlo, in privato, tentò una interpretazione collegata al doppio soffocamento del padre nelle viscere della terra a Marcinelle e di lui da una madre che vi aveva riversato tutte le sue attese.
Giovanni replicò che i matti erano in due e che piuttosto trovasse una buona idea per mollargli dei neurolettici altrimenti non se ne usciva.
Affascinante il fatto che dopo anni di lavoro in continua osmosi di ruoli quelli che meno credevano al potere dei farmaci fossero proprio i medici.
Si accordarono per due incontri settimanali. Il primo avveniva nel garage dove Omero mostrava loro i reperti raccolti durante la settimana e discutevano di quali sarebbe stato opportuno procurare nella settimana a venire. I tre parlavano lungamente di quali fossero le cose importanti della vita, gli obiettivi esistenziali, i pericoli e come preservarsene. Queste lunghe chiacchierate a tre costituivano una sorta di psicoterapia finalizzata a ricostruire la vicenda interiore di Omero con lo scopo di renderlo più forte di fronte alle prove che lo attendevano. Carlo lo convinse anche a prendere tutte le sere un farmaco che lo avrebbe aiutato a superare lo stress in cui la missione affidatagli lo costringeva a vivere.
Il secondo incontro della settimana era dedicato al fare concretamente per la cura del corpo. Con Giovanni, Omero iniziò a fare lunghissime passeggiate nei boschi circostanti a Monticello, così da zone meno frequentate e più rassicuranti ci si avvicinò sempre di più al centro del paese.
Omero diceva che la presenza di Giovanni lo rendeva più impermeabile e resistente alle influenze negative degli altri, modo bizzarro e delirante per segnalare la positività della relazione terapeutica.
In una di queste passeggiate raggiunsero il centro diurno.
Era il periodo in cui la Signora Cristina Forni, vedova dell’indimenticato medico condotto, meglio nota alle nostre cronache psichiatriche come catwoman, teneva un corso di pittura a tempera e ad olio per i pazienti che lo frequentavano. Omero mostrò un immediato interesse per le composizioni astratte e, a detta di Cristina, anche un notevole talento.
La settimana successiva Giovanni e Carlo bussarono alla saracinesca del garage portando un regalo inaspettato: tele di varie dimensioni, pennelli, tubietti di colore e una splendida tavolozza.
Omero poteva frequentare il corso di Cristina ed esercitarsi per proprio conto.
La sua produzione artistica era emotivamente toccante con un assoluto predominio dei colori scuri e di sprazzi luminosissimi di rosso vivo. I suoi quadri non lasciavano indifferenti e sul loro significato e l’attribuzione di possibili titoli si centravano le lunghe chiacchierate dei tre compari. I quadri figurativi venivano usati come una tavola del T.A.T. e quelli astratti come una del Roschach.
I due operatori entusiasti del loro lavoro con Omero che, pur continuando ad essere immerso nel suo delirio galattico, li aspettava con ansia e con loro usciva tranquillamente di casa, riferivano mensilmente alla riunione generale del servizio. La puntigliosa dottoressa Ficca, forse invidiosa degli innegabili successi di chi agiva senza le pastoie dell’osservanza cieca delle regole, sollevò un problema: in fondo la loro relazione con Omero non si basava su un inganno analogo a quello che avevano sdegnosamente rifiutato quando era stato proposto dalla madre? Effettivamente lui riteneva volessero davvero aiutarlo nella missione interplanetaria che non era mai stata messa in discussione.
Biagioli si produsse allora in una appassionata difesa che fu ricordata come “il diritto all’autoinganno”: Carlo sosteneva che non si dovesse nascondere nulla ai pazienti, fornendo loro tutti gli elementi di realtà possibili, ma che non si dovesse forzarli a rinunciare alle loro spiegazioni soggettive spesso a scopo antalgico.
Del resto, diceva l’autoinganno è una delle attività tipica degli uomini impegnati a rendere meno dolorosa la loro realtà. In particolare, ribadiva, si pensi ai malati terminali che nonostante mille evidenze continuano a proiettarsi nel futuro.
E’ corretto dir loro come stanno le cose, ma sarebbe crudele impedirgli la speranza.
Omero aveva ricevuto una lettera in cui si dichiarava chiaramente che erano operatori del CIM che volevano interessarsi della sua dubbia salute mentale, Carlo gli prescriveva farmaci che comprava in farmacia, con Giovanni andavano al gruppo di pittura del centro diurno psichiatrico, nessuno lo ingannava, ma perché rompere la bella favola che si raccontava? Ormai da mesi la sua vita procedeva secondo una routine decisamente ampliata e la missione di teletrasporto intergalattico sempre meno presente nella sua mente.
Oltre i due incontri settimanali, trascorreva ore a dipingere , usciva a farsi la spesa da solo, aveva imparato a prepararsi un pranzo caldo, pasta o minestre che integravano i secondi freddi.
Mancavano pochi giorni al Natale e avevano intenzione di proporgli di esporre i suoi quadri ad una collettiva dedicata ad artisti esordienti.
Omero li aspettava come sempre sulla porta del garage ma aveva una faccia lugubre.
Li fece accomodare e gli spiegò il suo dolore: la televisione la sera prima era stata chiarissima, per un incolmabile ritardo degli aspetti tecnici e per colpa dell’incompetenza della squadra degli ingegneri spaziali, il progetto era stato accantonato almeno per i prossimi cinquant’anni.
Lui, encomiato per il lavoro svolto, era comunque posto in congedo permanente e definitivo.
Anche il loro ruolo di suoi trainer non aveva più senso. Li congedò in una gelida antivigilia di Natale, dicendo che comunque avrebbe avuto piacere di rivederli ogni tanto e di continuare a discutere delle sue opere d’arte che erano state molto apprezzate alla mostra. Prendendo atto della sua richiesta le visite assunsero cadenza mensile, a titolo di follow up.
A distanza di tre anni la situazione è stabile, Omero non è certo guarito e non lo farà mai ma la sua qualità di vita è migliorata e il sindaco conta su un voto in più.
TORNA ALL’INDICE DELLA RUBRICA
ARGOMENTI CORRELATI:
 Executive function is an umbrella term, referring to those high-level processes that control and organise other mental processes, that facilitate new ways of behaving and optimise one’s approach to unfamiliar circumstances.
Executive function is an umbrella term, referring to those high-level processes that control and organise other mental processes, that facilitate new ways of behaving and optimise one’s approach to unfamiliar circumstances.


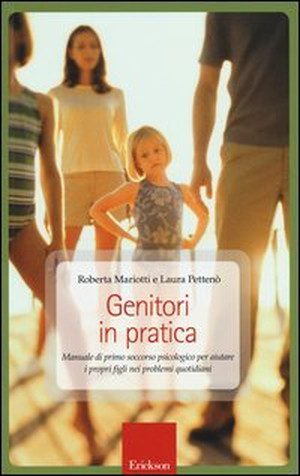 Genitori in pratica. Manuale di primo soccorso psicologico per aiutare i propri figli nei problemi quotidiani: la relazione genitore-figlio potrebbe essere paragonata, come sostengono le autrici di questo libro, a un danza in cui il genitore funge da coach nelle situazioni facili e difficili che si manifestano durante la crescita del bambino.
Genitori in pratica. Manuale di primo soccorso psicologico per aiutare i propri figli nei problemi quotidiani: la relazione genitore-figlio potrebbe essere paragonata, come sostengono le autrici di questo libro, a un danza in cui il genitore funge da coach nelle situazioni facili e difficili che si manifestano durante la crescita del bambino.
 Al CIM su ogni paziente grave si concentrano gli sforzi di molti operatori, anche se fatalmente è uno ad essere il principale care giver, colui che tiene in mente il paziente e le fila dei vari interventi per scongiurare la confusione.
Al CIM su ogni paziente grave si concentrano gli sforzi di molti operatori, anche se fatalmente è uno ad essere il principale care giver, colui che tiene in mente il paziente e le fila dei vari interventi per scongiurare la confusione. La SMT attraverso una particolare tecnica di videoregistrazione della seduta terapeutica, grazie alla quale il paziente dapprima osserva il filmato di se stesso durante un momento emotivamente significativo (ad esempio mentre rievoca un episodio) e poi ri-vede se stesso mentre osservava tale filmato, permette di “sfruttare” verso se stessi (e quindi usarli a fini terapeutici) quei meccanismi di risonanza empatica, mediati appunto dal sistema dei neuroni specchio, che normalmente usiamo per comprendere in modo intuitivo, automatico e inconscio le intenzioni e gli stati emotivi degli altri.
La SMT attraverso una particolare tecnica di videoregistrazione della seduta terapeutica, grazie alla quale il paziente dapprima osserva il filmato di se stesso durante un momento emotivamente significativo (ad esempio mentre rievoca un episodio) e poi ri-vede se stesso mentre osservava tale filmato, permette di “sfruttare” verso se stessi (e quindi usarli a fini terapeutici) quei meccanismi di risonanza empatica, mediati appunto dal sistema dei neuroni specchio, che normalmente usiamo per comprendere in modo intuitivo, automatico e inconscio le intenzioni e gli stati emotivi degli altri. Simulare e dissimulare come due facce di una realtà nascosta e unica, due processi che compromettono il nucleo significativo della relazione medico-paziente.
Simulare e dissimulare come due facce di una realtà nascosta e unica, due processi che compromettono il nucleo significativo della relazione medico-paziente.
 Con il termine deposizione o testimonianza non si designa la semplice fotografia di un evento, piuttosto una ricostruzione mnestica in cui si intercalano ritagli di realtà mai esperite o mai esistite.
Con il termine deposizione o testimonianza non si designa la semplice fotografia di un evento, piuttosto una ricostruzione mnestica in cui si intercalano ritagli di realtà mai esperite o mai esistite.

 I risultati hanno mostrato differenze di genere nella relazione tra lo stato di salute, i tratti di personalità e la conflittualità nella coppia.
I risultati hanno mostrato differenze di genere nella relazione tra lo stato di salute, i tratti di personalità e la conflittualità nella coppia.  Il film può essere molto utile a fini didattici, in quanto vengono rappresentati tutti i criteri del DSMIV per la diagnosi di disturbo di personalità antisociale. Può fornire, inoltre, una base di discussione anche con il paziente, in relazione alla consapevolezza delle conseguenze dei comportamenti e delle azioni che si compiono, spesso svantaggiose per il benessere psicosociale e sugli effetti di eventi di vita violenti vissuti.
Il film può essere molto utile a fini didattici, in quanto vengono rappresentati tutti i criteri del DSMIV per la diagnosi di disturbo di personalità antisociale. Può fornire, inoltre, una base di discussione anche con il paziente, in relazione alla consapevolezza delle conseguenze dei comportamenti e delle azioni che si compiono, spesso svantaggiose per il benessere psicosociale e sugli effetti di eventi di vita violenti vissuti.