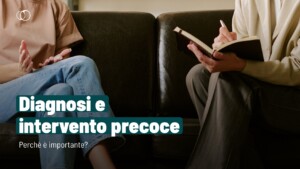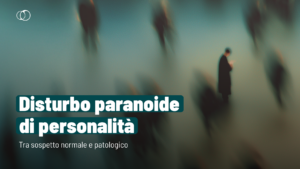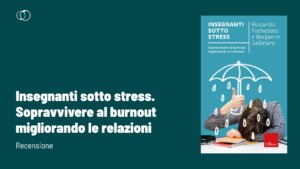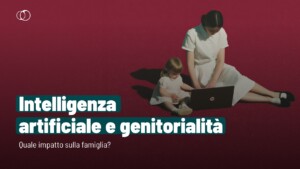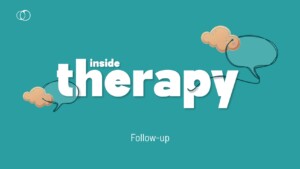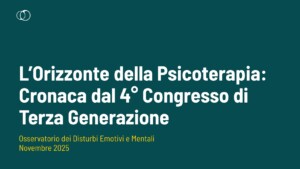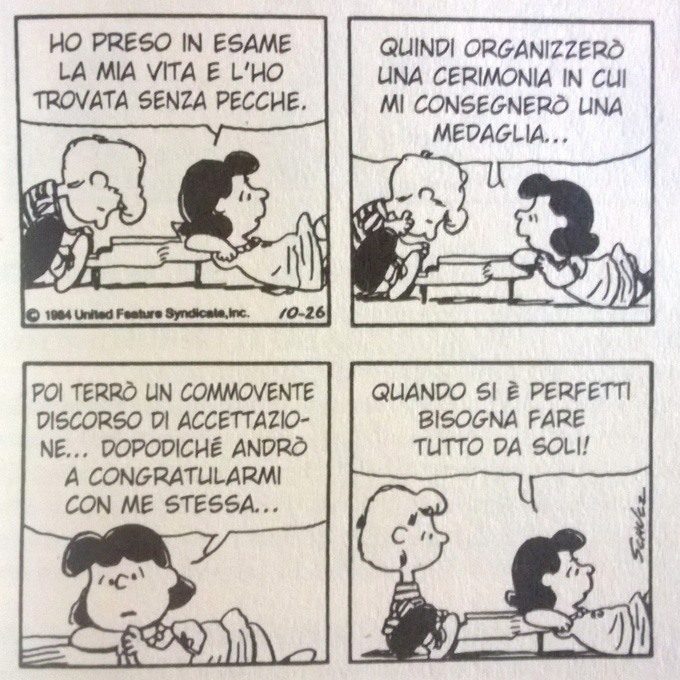La realtà virtuale in ambito clinico – Psicoterapia
Chiara Rotasperti – OPEN SCHOOL – Studi Cognitivi Milano
Gli ambienti ricreati mediante realtà virtuale rappresentano un ulteriore contesto di interazione sociale grazie al quale si rende possibile per l’utente sperimentare emozioni, azioni, mettersi in gioco con le proprie paure, le difficoltà, i comportamenti disfunzionali, facendo così emergere, nel contesto protetto di un laboratorio sperimentale, il materiale cognitivo che ne sta alla base.
Sono i primi anni ’90 quando la Realtà Virtuale inizia ad affacciarsi nel mondo della psicologia. Dopo i primi lavori base di ricerca, che per molti aspetti furono veri e propri tentativi pionieristici nella costruzione di nuove strade o poco più che stretti sentieri sconnessi, si iniziarono ad intravedere le interessanti possibilità di sviluppo di questo medium comunicativo nell’ambito della psicologia clinica.
Prese così vita una piccola comunità scientifica, caratterizzata da ricercatori di diversa origine geografica e culturale, ma tutti accomunati dalla curiosità verso ciò che man mano si rivelava sempre più uno strumento potenzialmente utile anche in campo psicologico.
Da allora sono stati fatti passi da gigante in quella e in altre direzioni: gli ambienti ricreati mediante le nuove tecnologie della realtà virtuale rappresentano un ulteriore contesto di interazione sociale grazie al quale si rende possibile per l’utente sperimentare emozioni, azioni, mettersi in gioco con le proprie paure, le difficoltà, i comportamenti disfunzionali, facendo così emergere, nel contesto protetto di un laboratorio sperimentale, il materiale cognitivo che ne sta alla base.
Cosa è virtuale?
Trasformazione da una modalità dell’essere a un’altra risponde Pierre Lévy (Lévy, 1995), cartografo della mappa del virtuale nel suo libro
Qu’est-ce que le virtuel? del 1995 e prosegue dicendo:
uno dei possibili modi di essere, contrapponibile non alla realtà ma alla attualità. Sì, perché Levy contrappone virtuale ad attuale e possibile a reale, definendole modalità dell’essere contemporaneamente presenti.
Possibile e virtuale hanno chiaramente un tratto in comune, ed è il motivo per cui spesso vengono confusi: sono entrambi latenti, non manifesti. Il reale e l’attuale invece sono entrambi presenti, manifesti.
Il virtuale quindi, visto con gli occhi di Levy, non è affatto il contrario del reale, ma:
un modo di essere fecondo e possente, che concede margine ai processi di creazione, schiude prospettive future, scava pozzi di senso al di sotto della piattezza della presenza fisica immediata.
Michel Serres (Serres, 1994), nel suo libro Atlas, descrive il tema del virtuale come fuori dal ci, fuori dall’esser-ci. Essere quindi svincolati da qualsiasi ci, per esempio:
Dove ha luogo una conversazione telefonica? Dove è una comunità virtuale? Essa vive senza un vero e proprio luogo di riferimento fisico, risiedendo ovunque si trovino i suoi membri erratici e quindi.. in nessun luogo.
Ciononostante il virtuale non può dirsi non reale. Sebbene non si sappia dove, la conversazione telefonica ha luogo, la comunità virtuale esiste, c’è. Ecco il fuori dal ci di cui parla Serres. Pensiamo ad una telefonata: il telefono separa la voce dal corpo fisico e la trasmette a distanza. Il mio corpo fisico è qui ma il mio corpo sonoro si sdoppia rendendosi presente contemporaneamente qui e altrove. Virtualizzandosi quindi il corpo si moltiplica, allo stesso modo nel quale i potenti strumenti diagnostici a disposizione della medicina (pensiamo a radiografie, risonanze magnetiche, TAC..) è come se aggiungessero strati sotto il nostro derma rendendoli visibili. Potremmo dire che hanno creato altri strati, derma nascosti, aree insospettate che emergono dal fondo dell’organismo. Ogni nuovo strumento, svelando un tipo di pelle, aggiunge un corpo visibile a quello attuale. Virtuale? Reale? Ecco perché questi due significati non sono sovrapponibili.
Non sempre la virtualizzazione è legata a uno scomparire, ma nei casi riportati finora, potremmo, al contrario parlare di una materializzazione: svincolando ciò che era solo qui e ora, essa apre nuovi spazi e altre velocità.
Come può, la realtà virtuale essere utilizzata in ambito psicoterapico? Quali sono gli aspetti che potrebbero venirci in aiuto, secondo la logica per la quale la tecnica propone e l’uomo dispone?
La realtà virtuale è uno strumento il cui apporto principale può essere cercato nell’importanza che in psicoterapia viene data all’immaginazione e alla memoria, aspetti entrambi che dipendono molto dal soggetto che ci potremmo trovare di fronte: Quanto è in grado di immaginare? Di ricordare? Quanto è disposto a farlo? E a rifarlo nella seduta dopo? E in quella dopo ancora?. Tutte domande e problematiche nelle quali la realtà virtuale ci viene in aiuto, con la sua flessibilità, con l’enorme varietà di modalità di intervento su svariati tipi di disagio psicologico, con la possibilità di strutturare stimoli controllati e contemporaneamente di monitorare le possibili risposte fisiologiche e non generate dal paziente, con l’opportunità impagabile di ricostruire scenari ad hoc creati sulle memorie del paziente stesso, sulla base dei suoi ricordi, dei suoi vissuti traumatici o no. Tutto ciò offre un considerevole aumento delle probabilità di efficacia terapeutica rispetto al solo utilizzo di procedure tradizionali.
Pensiamo ad uno scenario nel quale, all’interno del nostro studio psicoterapeutico, sia possibile sedersi col paziente, stilare con lui una lista dei suoi stimoli critici e su questa base co-costruita, stendere un programma nel quale si pianifica una desensibilizzazione progressiva dei suddetti stimoli critici, esponendo il soggetto all’esperienza di tali condizioni ricreate in virtuale. Fin qui tutto normale, potrebbe tranquillamente rientrare in una normale giornata di lavoro di uno psicoterapeuta cognitivo comportamentale.
Le differenze però iniziano subito dopo, quando, diversamente dalle esposizioni IN vivo, in ambiente virtuale le diverse componenti dell’ambiente ricostruito sono suscettibili di un ampio controllo da parte del terapeuta, il quale viene messo nelle condizioni di stabilire di volta in volta il grado di difficoltà a cui sottoporre il paziente, immaginando per lui un percorso tailor made direbbero gli americani, o su misura diremmo in Italia.
La possibilità di modulare in modo crescente le difficoltà, permette al terapeuta di creare un percorso sempre calato sullo stato attuale del paziente e al paziente di aumentare man mano la sua self-efficacy.
Bandura nel suo libro del 1977 Self-efficacy: Toward a Unifying Theory of Behavior Change annovera, fra gli aspetti che contribuiscono a generare il senso di autoefficacia, la possibilità di sperimentare performances di successo. La realtà virtuale si presta molto in questo ambito, grazie al fatto che il terapeuta, controllando gli stimoli somministrati, può fare in modo che il feedback per il paziente sia più o meno positivo rispetto alle sue performances, intervenendo in ogni istante sugli stimoli proposti e sulla loro intensità. Bandura stesso sosteneva che il senso di autoefficacia prodotto da ripetuti successi diminuisse l’impatto di eventuali fallimenti.
Gli ambienti virtuali sono quindi una via di mezzo fra la stanza del terapeuta (massima protezione) e l’ambiente esterno (altamente minaccioso), sganciati dal quel ci di cui parlava Serres, ambienti con elevato livello di flessibilità e programmabilità adatti come setting esperienziale nel quale il paziente possa approcciare gli stimoli ansiogeni senza che si senta minacciato. La potenza terapeutica di tale contesto è che situazioni, difficoltà, eventi e conseguenze possono essere sperimentate, poiché, pur sperimentando, non accade nulla al paziente, che grazie a ciò si sente libero di esplorare e di sperimentare.
La realtà virtuale entra così a far parte dell’alleanza terapeutica, del senso di fiducia verso il terapeuta e verso il processo di cura in atto, contribuendo a creare un senso di sé e della realtà altro rispetto a quanto sperimentato.
Tutto ciò non ci riporta forse alle tecniche cognitivo comportamentali per le quali l’assunzione del paziente di punti di vista alternativi ai propri è condizione sine qua non una correzione delle sue credenze disfunzionali considerate reali, date, inalterabili, non sarebbe possibile?
Per la psicologia dei costrutti personali di Kelly (Kelly, 2004) è fondamentale il concetto di validazione. Esso rappresenta la compatibilità (soggettivamente costruita) fra le previsioni che fa una persona e l’esito che essa osserva. Al contrario, l’invalidazione è l’incompatibilità (oggettivamente costruita) fra le previsioni e l’esito che ne osserva. Se in ciò facciamo rientrare anche la possibilità di creare nuovi costrutti, Kelly ritiene essenziale che tali costrutti altri siano prima presentati in contesti che non coinvolgano né il sé del paziente né persone a lui molto vicine. La creazione di un’atmosfera di sperimentazione è un’altra condizione favorevole alla formazione di nuovi costrutti, intendendo con ciò che le conseguenze delle proprie azioni sperimentali debbano essere viste come limitate e circoscritte. Tutto ciò, non riporta a scenari di realtà virtuale?
Analizziamo ora, sempre secondo Kelly, le condizioni sfavorevoli alla creazione di nuovi costrutti. Per Kelly, la condizione più sfavorevole è il senso di minaccia, cioè tutto quello che possa mettere in pericolo altri costrutti di ordine ancora superiore dai quali la persona fa dipendere la propria vita. Le conseguenze che questo quadro di minaccia/pericolo porta con sé, sono facilmente prevedibili: il paziente sarebbe inesorabilmente spinto ad aggrapparsi ancora di più ai suoi costrutti di base, esattamente come farebbe un naufrago se gli si tentasse di portare via il salvagente.
Anche l’assenza di laboratorio, per Kelly, rientra a far parte delle condizioni sfavorevoli nella formazione di nuovi costrutti, perché è improbabile riuscire a formare costrutti nuovi se manca un laboratorio nel quale metterli alla prova. Io non abbandonerei mai il salvagente che mi tiene a galla se prima non ho verificato che la cima che mi viene lanciata sarà in grado di trarmi in salvo.
Per laboratorio Kelly intende una situazione nella quale è presente una certa quantità della sostanza che una persona impiega, ridefinendola, per formare nuovi costrutti. Deve quindi essere un ambiente sicuro ma non troppo, altrimenti non riuscirei a sperimentare condizioni impegnative: sicuro che mi permetta di mettermi in gioco e non così sicuro da togliermi la possibilità di sperimentare eventuali difficoltà che potrei incontrare poi in ambiente esterno. Potremmo pensarlo come una sorta di base sicura bowlbiana nella quale il paziente può liberamente esplorare, sperimentare, vivere e rivivere sentimenti, pensieri e vissuti attuali o remoti senza sentirsi in pericolo. Il paziente è così messo nelle condizioni grazie alle quali può sperimentarsi e sperimentare il mondo esterno in modo nuovo, altro, inedito per lui.
Calando queste considerazioni in un’ottica di realtà virtuale, è facile capire quanto questo strumento possa essere d’aiuto per il paziente nel distinguere fra come sono convinto che le cose andranno e come invece potrebbero diversamente andare.
Quante sono le tecniche psicoterapeutiche che si fondano sulla manipolazione delle immagini mentali? Esse partono dal presupposto che ci sia connessione fra una rappresentazione disfunzionale ed il suo sviluppo e il mantenimento di un agire disfunzionale, causando così una compromissione più o meno marcata del funzionamento e dell’adattamento di un individuo nel mondo esterno. Se prendiamo ad esempio la terapia cognitivo comportamentale e una delle sue prospettive principali, cioè che il paziente è l’artefice principale del proprio cambiamento, è facile comprendere quanto sia importante che egli assuma un ruolo attivo nel proprio percorso di cura, in funzione del fatto che il paziente stesso è il massimo esperto delle esperienze che lo riguardano e che lui soltanto potrà fornire al terapeuta e a se stesso la chiave di accesso al suo sentire.
Le tecniche cognitive hanno dunque l’obiettivo di produrre cambiamenti a livello del pensiero, modificando quegli schemi disfunzionali causa dei comportamenti disadattivi del paziente. La tecnica espositiva, largamente utilizzata in campo cognitivo comportamentale, è un valido strumento volto a valutare l’inesattezza di determinate credenze all’origine della patologia, nonché uno straordinario strumento per sperimentare nuove modalità di interazione con l’ambiente.
Le tradizionali tecniche espositive, in immaginazione e in vivo, presentano alcuni limiti (difficoltà di immaginare, di raccontare, la reticenza ad esporsi in vivo) che la realtà virtuale può agevolmente superare, senza contare il fatto che utilizzare la tecnica espositiva facendo uso di ambienti virtuali (virtual environments) consente a paziente e terapeuta di condividere effettivamente l’esperienza: l’ambiente è infatti visibile ed accessibile ad entrambi, senza contare quanto questa modalità esperienziale aumenti in maniera esponenziale la compliance restituendo al paziente nuove prospettive per sentirsi artefice e protagonista del suo processo di cura, grazie al suo ruolo attivo (nel vero senso della parola) all’interno della terapia (pensiamo al suo muoversi all’interno di uno scenario virtuale, al fatto di poter compiere delle scelte e al fatto che sulla base di queste scelte ci siano, in presa diretta, conseguenze in tempo reale). Il paziente arriverà a percepire l’intero percorso terapeutico come parte integrante della propria vita, nella quale possiede un ruolo centrale di responsabilità e padronanza.
D’altro canto, anche per il terapeuta avviene un cambio di prospettiva. La valutazione del disagio e delle modalità attraverso cui si può manifestare avviene sulla base di una ricostruzione della realtà così come percepita dal paziente. Così facendo però il terapeuta a volte si trova in difficoltà nel delineare con chiarezza le rappresentazioni mentali e la sintomatologia che si manifesta nel momento clou del disagio, semplicemente perché non è presente, non è lì, e tutto è basato su una ricostruzione a posteriori (o a priori, nel caso sia una questione di ansia). Come può il terapeuta sapere quanto il paziente sarà efficace nel suo narrare? Quanti dettagli o informazioni importanti vanno perse basandosi su ricostruzioni?
Se però fosse possibile, attraverso un’osservazione diretta, verificare il modo in cui il nostro paziente reagisce di fronte agli stimoli patogeni, di quante informazioni in più, utili per l’intervento terapeutico, potremmo disporre? Molte. Moltissime.
La realtà virtuale ce lo permette. Ci permette di essere presenti anche quando le ansie del paziente o le sue risposte disfunzionali avvengono in situazioni non riproducibili in vivo. Sostiene Giuseppe Riva (Vincelli, Riva, Molinari, 2007) in La realtà virtuale in psicologia clinica:
Gli ambienti sono flessibili e manipolabili fino a oltrepassare i limiti della realtà esterna, creando così nuove possibilità per l’azione terapeutica
Questi nuovi strumenti ed il ritmo incalzante con cui i sistemi di realtà virtuale si sviluppano, aumentando di volta in volta il loro grado di accessibilità, portano con sé la necessità di riflettere in modo cosciente ed etico rispetto ai possibili cattivi usi che se ne possa fare alla luce del fatto che i soggetti manifestano reazioni molto intense gli ambienti simulati. Wiederhold B. e Wiederhold M. in un articolo del 2003 A New Approach: Using Virtual Realty Psychotherapy in Panic Disorder With Agoraphobia hanno approfondito il fatto che alcune categorie di pazienti possono non essere idonee alle psicoterapie condotte mediante realtà virtuale, in particolare persone affette da gravi patologie cardiache, tossicodipendenti, persone affette da epilessia e persone con problematiche riguardanti la percezione della realtà, pensiamo ad esempio a psicotici che hanno già di per sé un senso della realtà compromesso. In questo caso, introdurre la realtà virtuale sarebbe controproducente, nonché dannoso per il paziente.
Se nei primi anni novanta la realtà virtuale era ai suoi albori e alla portata di pochi, oggi un qualsiasi terapeuta può permettersi un sistema di realtà virtuale nel suo studio, ma perché, nonostante ciò, il numero di terapeuti che hanno scelto di integrare questa tecnologia nella propria pratica clinica è ancora così esiguo?
Le risposte possono essere molteplici: il timore di costi troppo elevati, la poca conoscenza delle potenzialità di questo nuovo strumento o la paura di non essere in grado di saperla usare.
Affrontiamo il problema dei costi: un sistema completo di realtà virtuale – PC, casco e sensore di posizione – costava nei primi anni ’90, non meno di 150.000 dollari e il pc che supportasse tale tecnologia, un Silicon Graphic Onyx RE2, aveva le dimensioni di un frigorifero. Oggi, gli ambienti in virtuale sono supportati dalla maggior parte dei PC in circolazione, a patto che abbiano una buona scheda grafica, con costi che si aggirano attorno ai 1000 dollari. Anche i caschi immersivi (i cosiddetti head mounted display) sono passati dai 50.000/60.000 dollari degli anni novanta, ai 600 dollari nel 2000 per un Emagin Z800 3D che rispetto ai predecessori offriva una risoluzione di gran lunga superiore ed era capace di produrre un’immagine davvero tridimensionale per approdare ad oggi, quando un head mounted display di tutto rispetto può costare circa 300 dollari. Siamo quindi passati dai 150.000 dollari degli anni novanta ai 2.000 – 5.000 dollari dei giorni nostri e la cifra, visti i progressi della tecnologia e i costi sempre più abbordabili, è destinata a scendere.
Per quanto riguarda invece le remore riguardo la poca conoscenza di questo strumento o il timore di non saperlo utilizzare, basta controllare i principali database scientifici come Medline o PsycInfo per trovare oltre 1000 articoli relativi all’uso di ambito clinico della realtà virtuale. E se il numero relativo al costo è destinato a scendere, questo invece è destinato a salire.
Occorre ricordare però che non è il terapeuta a doversi adattare alla tecnologia, ma è quest’ultima che deve offrire nuovi stimoli e strumenti in grado di aumentarne le capacità di valutazione e intervento, ed è importante segnalare che mai la realtà virtuale potrà sostituire il terapeuta, perché in virtù del fatto che è uno strumento, non avrebbe alcun senso senza una mano che lo guidi. Una penna senza uno scrittore è un oggetto inerte, inutile e così è per la realtà virtuale.
A tutela di ciò, sarebbe auspicabile la creazione di un comitato ad hoc preposto alla creazione di linee guida etiche per l’impiego dei sistemi di realtà virtuale, che si occupi inoltre di garantire un monitoraggio del loro rispetto da parte di chi intende avvalersi di questo nuovo e potente strumento.
ARTICOLO CONSIGLIATO:
Il volto delle emozioni: riconoscimento automatico dell’espressione del dolore
BIBLIOGRAFIA:
- Levy, P. (1995). Qu’est-ce que le virtuel?. Editions La Découverte. Paris.
- Serres, M. (1994). Atlas. Julliard, Paris.
- Kelly, G. A. (2004). La psicologia dei costrutti personali. Raffaello Cortina Editore. Milano.
- Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a Unifying Theory of Behavior Change. Psychological Review, 84, 191-215. DOWNLOAD
- Wiederhold, B.K., Wiederhold, M. (2003 July). A New Approach: Using Virtual Reality Psychotherapy in Panic Disorder With Agoraphobia. Psychiatric Times, 20, (7).
- Vincelli, F., Riva G., Molinari, E. (2007). La realtà virtuale in psicologia clinica. McGraw-Hill. Milano.