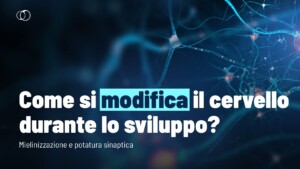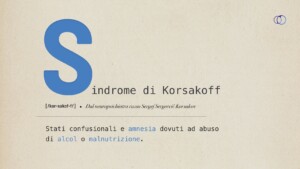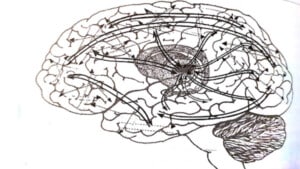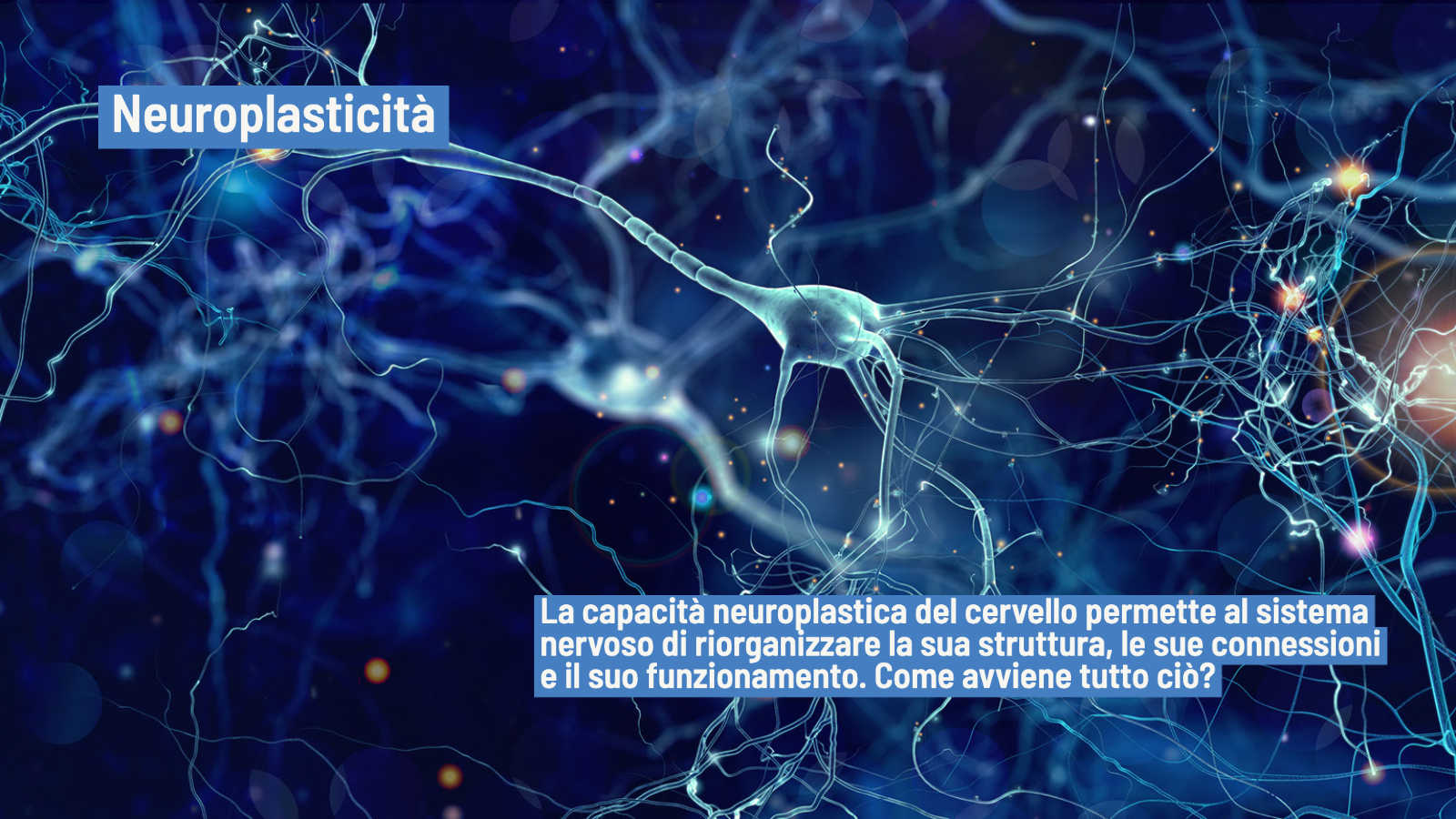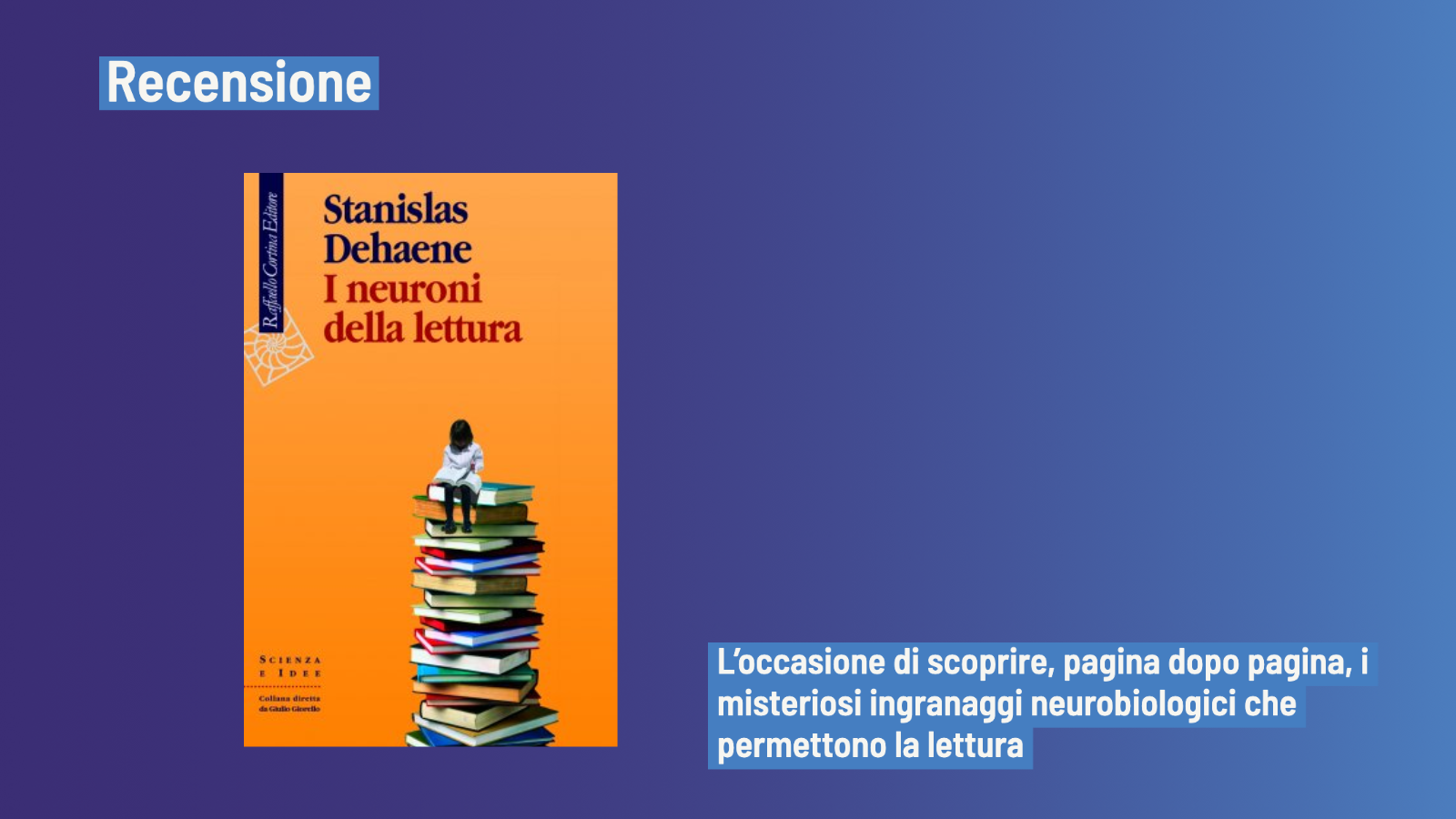Il filo rosso che unisce Lei, La grande bellezza e Maps to the stars – Cinema & Psicoterapia # 36
Antonio Scarinci.
Psicologo Psicoterapeuta. Socio Didatta SITCC
RUBRICA CINEMA & PSICOTERAPIA #36
Lei – Her (2013)
Scritto e diretto da Spike Jonze. Protagonista Joaquin Phoenix. Ha vinto l’Oscar per la migliore sceneggiatura.
Trama
Theodore Twombly, dopo essersi separato dalla moglie che conosce dall’infanzia, si dedica al lavoro. Si sente molto solo e la sua introversione non lo facilita nel costruire relazioni. Decide di acquistare un sistema operativo attratto da uno spot pubblicitario OS1, un’intelligenza artificiale che si adatta alle esigenze dell’utente, in grado di apprendere ed elaborare emozioni.
Samantha, questo è il nome dell’interfaccia femminile, riesce a instaurare un legame sempre più forte con Theodore, condividendo emozioni ed esperienze, provando sensazioni sempre più complesse. Il rapporto tra i due diventa più intimo, fino a sfociare in una vera e propria relazione d’amore.
Il protagonista si decide a incontrare la moglie Catherine per firmare i documenti per il divorzio e la mette al corrente della sua nuova relazione con OS1. La moglie si stupisce e lo accusa di aver bisogno di una realtà artificiale perché non è in grado di provare emozioni con esseri umani reali.
Theodore e Samantha continuano a frequentarsi, a sperimentare esperienze nuove e originali non sempre positive come quando Lei spinge il suo partner a incontrare Isabel, una ragazza che ha conosciuto, con cui ha parlato della loro relazione e a cui ha chiesto di surrogarla, impersonandola per avere un rapporto sessuale con Theodore. La gelosia di Lei nei confronti di Catherine fa il pari con la gelosia di Lui per un sistema operativo con il quale entra in relazione Samantha.
Theodore ha un attacco di panico quando non riesce a contattare per un’intera giornata Samantha, e quando le chiede se sta per caso interagendo anche con altri esseri umani scopre che Lei sta comunicando contemporaneamente con altri 8.316 individui e ha cominciato ad amare 641 di essi. OS1 cerca di rassicurarlo rivelandogli che queste relazioni non danneggino l’amore che continua a provare per lui.
Samantha, dopo poco tempo rivela, inoltre, che i sistemi operativi si stanno evolvendo e che intendono proseguire l’esplorazione della propria esistenza allontanandosi dagli umani. Ormai parlare con lui è come leggere un libro che ama moltissimo, ma nel quale le parole si fanno sempre più distanti tra loro, la distanza dall’umano è sempre più ampia. I due si dicono addio e Theodore scrive a Catherine, scusandosi del suo modo di fare e confessandole che tiene ancora molto a lei, pur accettando che ormai le loro strade si sono separate.
La grande bellezza ( 2013)
Diretto da Paolo Sorrentino. Protagonisti: Toni Servillo, Sabrina Ferilli, Carlo Verdone. Ha vinto il Premio Oscar come miglior film straniero nel 2014.
Trama
Jep Gambardella, giornalista e critico teatrale, protagonista del film, è immerso negli eventi mondani di una Roma di cui risaltano le bellezze del passato contrapposte alla superficialità squallida del presente. Giovane autore di un’opera letteraria molto apprezzata tanto da vincere un prestigioso premio, Gambardella non ha più scritto altro, forse per pigrizia, forse per un blocco creativo, forse perché risucchiato dal vortice della mondanità. Arrivato a Roma… Volevo diventare il re dei mondani. E ci sono riuscito. Io non volevo solo partecipare alle feste. Volevo avere il potere di farle fallire.
Ogni notte frequenta salotti festaioli tra amici annoiati: Tutti sull’orlo della disperazione, non abbiamo altro rimedio che guardarci in faccia, farci compagnia, prenderci un po’ in giro…
Due episodi segnano la narrazione: l’incontro di Jep con il marito del suo primo amore che gli annuncia la morte di sua moglie e il contenuto di un diario segreto dove la donna rivela il suo amore mai perduto per Jep e il 65° compleanno del giornalista.
Gambardella rivisita malinconicamente tutta la sua vita e medita su se stesso e sul mondo che lo circonda.
Roma diventa il vero palcoscenico del vuoto, dell’inutilità della futilità dell’esistenza di Jep, come di altri personaggi, parvenu, politici, intellettuali veri o presunti, nobili, artisti, criminali. Il sogno è quello di recuperare un’identità un senso. Mi chiedono perché non ho più scritto un libro. Ma guarda qua attorno. Queste facce. Questa città, questa gente. Questa è la mia vita: il nulla. Flaubert voleva scrivere un romanzo sul nulla e non ci è riuscito: dovrei riuscirci io?. Ho cercato la grande bellezza e non l’ho trovata.
Maps to the Stars. (2014)
Diretto da David Cronenberg, con protagonisti Julianne Moore, John Cusack, Mia Wasikowska e Robert Pattinson.
Trama
Il film si snoda sulla storia della famiglia Weiss composta da personaggi avidi di potere, fama e denaro. Stafford è uno psicoterapeuta di successo che oltre a seguire clienti famosi conduce anche un programma televisivo, sua moglie Cristina si occupa della carriera cinematografica del figlio tredicenne, già star affermata. Agatha l’altra figlia della coppia è stata rinchiusa in un manicomio ed è appena uscita. In cerca di redenzione cercherà anche lei di entrare nel mondo artificiale che avvolge tutti i protagonisti, compresa Havana Segrand, un’attrice ossessionata dal voler interpretare il ruolo che fu della madre in un remake di un famoso film del passato.
La storia assume toni drammatici quando i genitori di Agatha cercano in tutti i modi di allontanarla con disprezzo dalla loro vita, perché la sua presenza disturbata e disturbante andrebbe ad intaccare il successo faticosamente perseguito e raggiunto dagli altri componenti della famiglia.
Il film con una forte vena satirica critica la cultura occidentale rappresentata emblematicamente dal mondo dello spettacolo che dietro la lucente apparenza nasconde ombre inquietanti.
Che cosa unisce questi tre film che hanno peraltro elementi di differenziazione molto marcati in relazione alla sceneggiatura, alle riprese e al montaggio?
Un tema comune che percorre trasversalmente il soggetto di tutti e tre i film: una visione di disfacimento e vacuità, una caratterizzazione del mondo occidentale che vive di una superficialità oleosa, immerso in una dissoluzione radicale che penetra tutti i domini umani. Domina la perdita d’identità e la rassegnazione ad una pochezza che oscura le radici profonde di una civiltà millenaria che tanto progresso civile e umano ha portato a compimento. Le forme e le strutture dell’esistenza dei protagonisti si declinano in un modo inautentico che sfocia in un’estraneazione dal mondo e dagli altri, rapportandosi ai limiti e alla finitudine in termini molto negativi. Il senso della vita, le relazioni umane, la consapevolezza del qui ed ora, pilastri del benessere (Lorenzini, Scarinci, 2013) si dissolvono in una cultura poggiata su una realtà artificiale e fittizia.
Il desiderio di successo, denaro, potere muove le coscienze alterate da spot massivi che bombardano senza soluzione di continuità l’attenzione dei sudditi di una società che ha nel Prodotto Interno Lordo, nel Mercato e nel Consumo i sui totem da ingraziarsi con rituali sacrificali a danno dei più marginali e indifesi, dei rifiuti umani.
I temi che caratterizzano la narrazione di queste tre opere sollecitano la riflessione del clinico su un dato che emerge e si impone all’attenzione: l’aumento della prevalenza dei disturbi di personalità, in particolare quelli del cluster B, in un sistema sociale così frantumato, privo di struttura (APA, 2014).
A ben guardare i principali criteri che vengono elencati nella sezione III del DSM5 ci danno l’indicazione del perché di questo aumento: una compromissione pervasiva e stabile del funzionamento della personalità (del sé e interpersonale) e tratti di personalità patologici. Il primo criterio riguarda l’identità e l’autodirezionalità, l’empatia e l’intimità, il secondo si organizza in cinque grandi domini, Affettività negativa, Distacco, Antagonismo, Disinibizione, Psicoticismo.
L’identità e l’autodirezionalità interrogano l’illusorietà di percorsi tracciati senza porsi una domanda fondamentale: verso quale meta ci si sta muovendo e quale sia il modo di comportarsi, sentire, pensare più adattivo e funzionale per raggiungerla, ammesso che oggi l’agire sia intenzionale e teleologico. Perché proprio l’eterogenesi dei fini e l’anomia sociale sono gli elementi che caratterizzano la nostra società, messi in luce con tutta evidenza dai tre film.
La frenesia di un continuo movimento (si pensi alle scene di ballo di La Grande Bellezza) che tutt’al più, al meglio, permette di difendere pervicacemente una posizione faticosamente conquistata, ma sicuramente stordisce, ottunde le menti, aliena.
La distanza sempre più marcata dall’altro che si contrappone, confligge, è portatore di interessi diversi e inconciliabili, lo rende oggetto da utilizzare e sfruttare per soddisfare i propri desideri. L’altro, parafrasando Sartre, diventa l’inferno e per questo cooperare, condividere, sintonizzarsi, entrare in intimità e in empatia diventa impossibile come bene esprimono alcune sequenze di Maps to the Stars in cui persino un terapista (la categoria non è indenne dai mali del tempo) pur di difendere il successo emargina la figlia in una condizione di indegnità, la stigmatizza come minaccia alla posizione di prestigio raggiunta.
La condivisione di valori si dissolve e con essa la connessione che ci lega gli uni agli altri. Non guardiamo il volto del conspecifico piuttosto digitiamo alla ricerca di relazioni che possano farci vincere il senso di solitudine, come Theodore in Lei, alla ricerca di qualcuno che riesca perfettamente a soddisfare le nostre aspettative, riscoprendo troppo tardi l’importanza del rapporto umano.
La costruzione della personalità è influenzata dai valori della cultura prevalente in un rapporto che l’interazionismo simbolico ha magistralmente teorizzato. La personalità di base secondo la definizione di Kardiner e Linton (1965) o quella modale che si incontra con maggior frequenza in un dato sistema sociale (Parsons, 1965) è costruita all’interno di un universo simbolico. Tutte le identificazioni avvengono entro uno specifico mondo sociale che organizza i ruoli con cui la cultura è resa psicologicamente attiva nelle persone.
Un disturbo di personalità è un fallimento in alcuni compiti esistenziali universali: formare una rappresentazione di sé e degli altri stabile e integrata; costruire relazioni interpersonali adattive; raggiungere un buon funzionamento sociale (Dimaggio, Semerari, 2003) ed è chiaro che l’incremento dei disturbi chiama in causa i processi di socializzazione e i modelli culturali dominanti a cui passivamente ci si conforma.
Queste sofferenze liquide nascono dalla vulnerabilità dovuta al profondo senso di insicurezza che caratterizza il disagio post-moderno (Bauman, 2006, 2009, 2013). La cultura liquido-moderna e’ una cultura del disimpegno, della discontinuità, della dimenticanza, svuota, disorienta, deforma. La Santa in La Grande Bellezza chiede a Jep Gambardella: Sai perché mi nutro di radici?. E in assenza di risposte aggiunge: Perché sono profonde.
Stabilità emotiva, Coscienziosità, Lucidità mentale, Estroversione, Disponibilità, i cinque domini che si contrappongono agli altri che danno vita, nel DSM5, ai tratti di personalità patologici sono negati da una scarsa capacità riflessiva e di pensiero critico che sappia ricostruire una narrazione in cui l’uomo si riappropri della sua vera identità e sviluppi le condizioni per vivere una vita degna di essere vissuta. In questo nostro tempo il buio sembra prevalere sulla luce, tutto diventa confuso, ed è difficile distinguere la strada che porta alla mèta da quella che fa percorrere cerchi ripetitivi, senza direzione.
Nel vagare il rumore, la chiacchiera, la futilità impedisce di capire, di essere connessi a se stessi e agli altri, di dare una direzione al cammino.
Stiamo attraversando una complessa crisi socio-ambientale… e abbiamo bisogno di un confronto che ci unisca tutti, perché la sfida che viviamo e le sue radici umane ci riguardano e ci toccano tutti (Francesco, 2015).
L’esistenza si risolvere nelle sue possibilità; essere, essere con altro, essere con se stesso e queste possibilità si connotano in senso positivo o in senso negativo. Possiamo superare il piano fattuale per inoltrarci in quello esistenziale nel senso di poter essere in una dimensione di progettualità che trascende l’interiorità per cogliere l’altro.
L’oblio della consapevolezza riflessiva, della trascendenza e della dimensione interpersonale della coscienza conseguenza della natura relazionale dell’uomo comporta la perdita della razionalità, della responsabilità e di una dimensione comunitaria che costituisce l’identità autentica della nostra specie.
Una macroetica planetaria, un’etica universale che regoli stili di vita e comportamenti pubblici e privati può essere ritrovata solo con un ricongiungimento di una via esistenziale-personalistica e una via epistemologico-analitica (Lorenzini, Scarinci, 2013), attraverso un confronto che si nutre di premura, responsabilità, rispetto, conoscenza, cioè amore per La Grande Bellezza, per una vita autentica.
LEGGI ANCHE:
ARTICOLI CONSIGLIATI:
Her di Spike Jonze (2013): la solitudine nell’era dei social network
La Grande Bellezza di Paolo Sorrentino – Recensione
BIBLIOGRAFIA:
- American Psychiatric Association (2014). Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali DSM 5. Milano: Cortina.
- Bauman, Z. (2006). Vita liquida. Bari: Laterza
- Bauman, Z. (2009). Vita di corsa. Come salvarsi dalla tirannia dell’effimero. Bologna: Il Mulino.
- Bauman, Z. (2013). Le sorgenti del male. Trento: Erickson Editore.
- Dimaggio G., Semerari, A. (2003). I disturbi di personalità. Modelli e trattamento. Bari: Laterza.
- Francesco (2015). Laudato si. Lettera Enciclica sulla cura della casa comune. Roma: Edizioni Paoline.
- Kardiner, A., Linton, R. (1965). L’individuo e la sua società. Milano: Bompiani.
- Loenzini, R., Scarinci, A. (2013). Dal malessere al benessere. Attraverso e oltre la psicoterapia. Roma: Franco Angeli.
- Parsons, T. (1965). Il sistema sociale. Milano: Comunità.