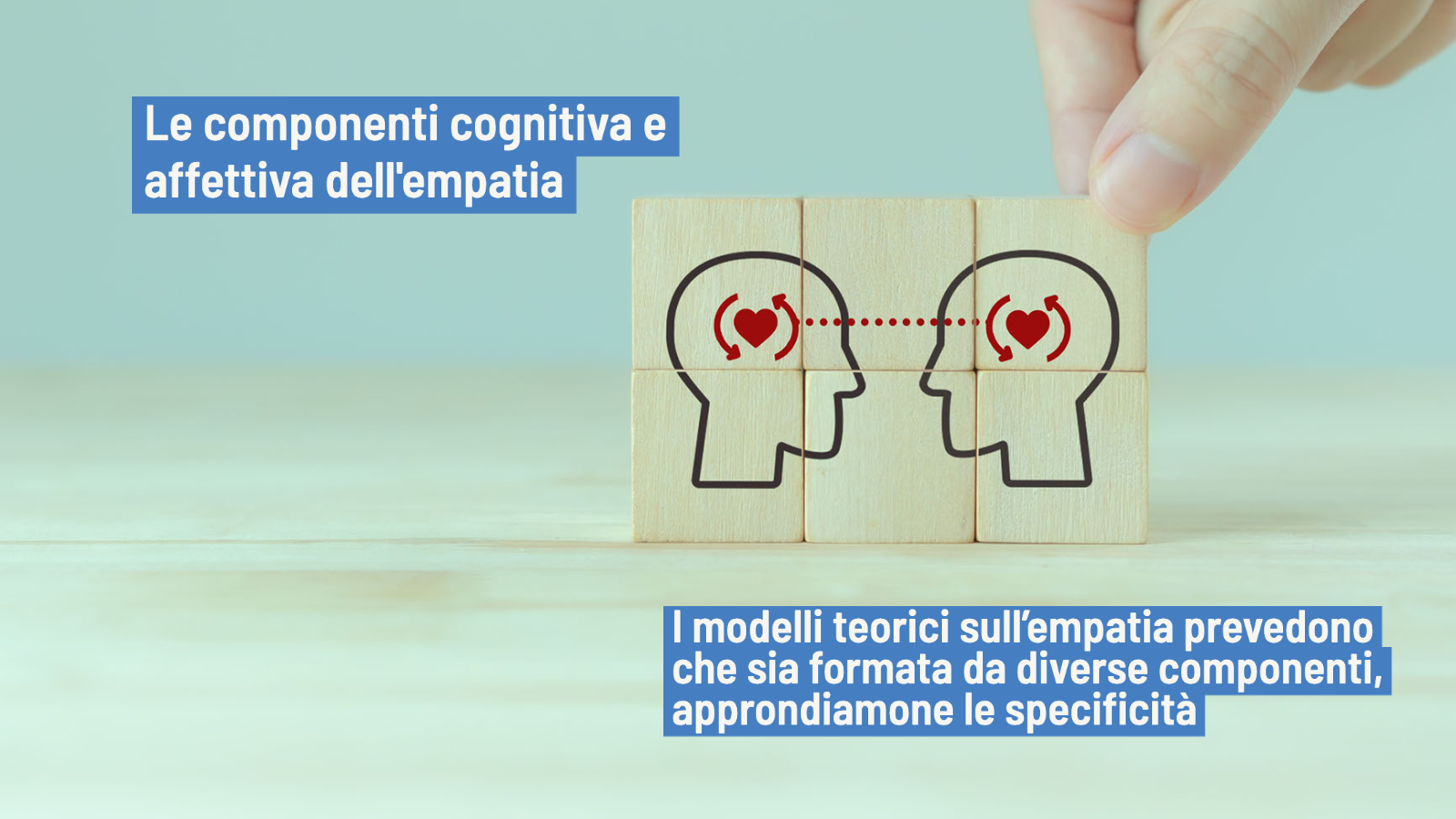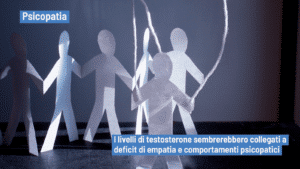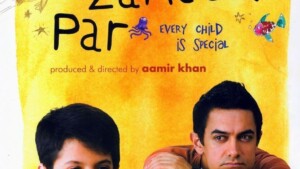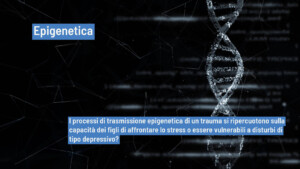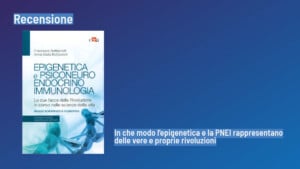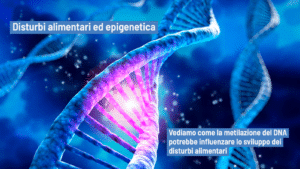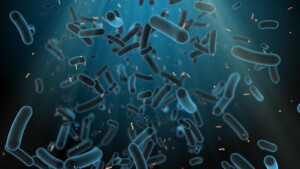Diventare genitori: le emozioni nei neopadri
Laura Bernardi – OPEN SCHOOL – Studi Cognitivi Modena
Solo recentemente la società ha cominciato a sostenere che la genitorialità è un’impresa condivisa sia dalle madri che dai padri. Uno dei segnali più rilevanti del cambiamento che ha investito la coppia e il rapporto padre‐figlio è la maggior partecipazione del padre dalla gestazione alla nascita del figlio.
Fino ad oggi la quasi totalità delle ricerche e dei libri sul tema della genitorialità si sono concentrati sulla figura della madre e sul suo ruolo nel rapporto con il bambino appena nato.
La paternità è rimasta sullo sfondo, come un dato per scontato: se quello materno è stato per secoli definito un istinto, quello paterno si è configurato come un ruolo prevalentemente economico‐disciplinare, cui ben si ottempera se si provvede adeguatamente alle necessità familiari delegando le attività domestiche e di cura alla madre (Dell’Agnese & Ruspini, 2007).
I padri hanno quindi la tendenza a interpretare le nuove responsabilità a livello esteriore, a concentrarsi per fornire alla famiglia tutto il necessario, a considerare i loro doveri dal punto di visto economico (Cabrera et al., 2000). Questa preoccupazione materiale è dovuta anche al fatto che per molto tempo non si è parlato dell’emotività del padre, argomento per secoli evitato perché in opposizione a una tacita regola secondo la quale l’uomo deve essere forte e maschio (Pellai, 2007). La cultura prevalente nella maggior parte delle società ha infatti da sempre alimentato lo stereotipo secondo il quale la mascolinità mal si concilierebbe con l’espressione dei sentimenti essendo quasi sempre le donne delegate a ciò e indicando come disdicevole per l’uomo fare riferimento al proprio mondo privato, personale (Connell, 1996; Bellassai, 2004).
Per molto tempo quindi la preoccupazione primaria per il padre dopo il parto è stata quella di provvedere alla famiglia economicamente: concentrarsi sul lavoro forniva al padre anche un ruolo chiaro, un obiettivo sicuro che serviva a ridurre la confusione e l’incertezza che caratterizzano il primo periodo dopo la nascita di un figlio (Cabrera et al., 2000; Greenberg, 2006).
L’ invisibilità del padre dovuta alla lontananza dai figli per motivi di lavoro va di pari passo con la piena assunzione del ruolo educativo della donna mettendo in crisi la funzione del padre in questo ambito (Zanfroni, 2005). Solo recentemente la società ha cominciato a sostenere che la genitorialità è un’impresa condivisa sia dalle madri che dai padri (Cabrera et al., 2000). Uno dei segnali più rilevanti del cambiamento che ha investito la coppia e il rapporto padre‐figlio è la maggior partecipazione del padre dalla gestazione alla nascita del figlio, testimoniata ulteriormente dalla sua presenza in sala parto. Oggi infatti è consuetudine che i futuri papà partecipino ad alcuni incontri dei corsi preparto, siano presenti al momento della nascita dei figli, cambino i pannolini, leggano le favole, stiano svegli la notte per cullare i neonati e indossino i marsupi. Sembra che l’espressione dell’affettività e il coinvolgimento in talune attività di cura nei confronti dei figli non vengano più percepiti come inadatti , quando non minacciosi, al ruolo paterno‐maschile (Volta et al., 2006).
Sono poche, infatti, le ricerche psicologiche che prendono in considerazione anche il padre durante il periodo perinatale e quando viene fatto è solo in maniera marginale o indiretta; ciò probabilmente è dovuto sia alle maggiori difficoltà che si riscontrano nel coinvolgere i padri (Turan, Nalbant, Bulut & Sahip, 2001) sia al fatto che gli uomini raramente si sono soffermati a riflettere sugli aspetti emozionali della paternità, avendo la tendenza ad esprimersi più in termini di fatti concreti che in termini di vissuti (Pellai, 2007).
E’ stato appurato che le difficoltà nel rapporto di coppia, la mancanza di supporto sociale e in particolare del proprio compagno, l’assenza di una persona con cui confidarsi sono considerati fattori rilevanti per problematiche nella salute mentale nella donna e per l’insorgenza della depressione postpartum (Romito et al, 1999; Nielsen Forman et al., 2000; Watt et al. 2002; Stewart et al., 2003); la depressione post-partum è un disturbo dell’umore che colpisce il 10-20% delle donne nel periodo immediatamente successivo al parto caratterizzato da crisi di pianto, cambiamenti di umore, irritabilità generale, perdita dell’appetito, insonnia o all’opposto difficoltà a rimanere svegli, assenza di interesse nelle attività quotidiane e/o verso il neonato (Gaynes, Gavin, Meltzer-Brody et al., 2005). Si può quindi ipotizzare che coinvolgere maggiormente il padre negli interventi possa produrre risultati migliori nella prevenzione di malesseri che possono insorgere nella donna e nella coppia dopo la nascita di un bambino. Altre ricerche, inoltre, dimostrano che l’interazione dei padri con i loro figli neonati può esercitare una positiva influenza nello sviluppo del bambino (Cabrera et al., 2000; Coleman et al., 2004).
Per molti uomini diventare padre è una conquista a lungo sognata, un obiettivo della vita che si realizza. Per altri, invece, è un evento a lungo rimandato, spesso evitato, non sempre cercato e voluto, anche quando si concretizza nella realtà, nonostante i diversi vissuti tutti gli uomini vivono inevitabilmente esperienze emotive profonde in prossimità dell’evento nascita del proprio figlio, ma ciò che colpisce è che pochi uomini riescono davvero a raccontare e parlare di tutto questo con qualcuno. L’esperienza emotiva dei nuovi padri rimane ancora un mistero inesplorato, un evento interiore di cui si sa pochissimo (Pellai, 2007).
Per capire meglio i sentimenti e le emozioni dei neo-papà, nel 2006 presso il punto nascita di Montecchio Emilia (AUSL Reggio Emilia), sono stati coinvolti in Metodo 118 padri alla loro prima esperienza, consecutivamente afferiti all’Ospedale di Montecchio Emilia, sono stati valutati utilizzando un questionario costruito ad hoc con scala di Likert, somministrato prima e dopo il parto. L’obiettivo fu quello di indagare come i padri vivono l’attesa del figlio e quali sentimenti ed emozioni sviluppano dopo la nascita, di valutare inoltre se la modalità del parto (spontaneo o da taglio cesareo) influisce sul loro vissuto e se la partecipazione a un corso di accompagnamento alla nascita rappresenta un elemento di facilitazione nella relazione padre-figlio. Dalle risposte ai questionari somministrati prima del parto sono emersi la consapevolezza del proprio ruolo di padre, la conoscenza delle competenze del neonato, la voglia di prendersi cura del figlio senza delegare altri, il desiderio di protagonismo al fianco della madre.
Il questionario somministrato dopo il parto rileva emozioni forti, desiderio di contatto fisico col neonato, sentimenti di protezione, felicità e tenerezza alla vista della prima poppata. Non sono emerse differenze significative tra i padri che hanno partecipato ai corsi di accompagnamento alla nascita e quelli che non vi hanno partecipato; anche la modalità del parto (spontaneo o operativo) non sembra incidere sul vissuto dei padri. La maggior parte di questi neo papà sono risultati ben consapevoli dell’importanza del loro supporto nei confronti sia della mamma che del bambino; in molti hanno esplicitato il desiderio di un contatto fisico con il figlio, verso il quale hanno espresso sentimenti di protezione e di tenerezza; i sentimenti manifestati alla vista del bambino sono risultati profondi e assai poco virili, e molti papà hanno dichiarato la volontà di prendersi cura del figlio senza delegare ad altri questo compito. E’ probabile che questi padri sopravvalutino le loro competenze e intenzioni, e che alla prova dei fatti si mostrino invece poco attivi e insicuri; dobbiamo però riconoscere che le loro percezioni sono risultate ricche e profonde.
Presso L’ASL di Varese la ricerca di Pellai e coll. del 2009 riporta che presenti e coinvolti, i nuovi padri sono ancora in difficoltà nel riconoscere, validare e condividere con altri uomini e con la propria compagna i propri stati interni associati alla propria imminente esperienza genitoriale. È fondamentale, dicono i ricercatori, aiutare gli uomini a conquistare una nuova consapevolezza emotiva, riconoscendo e dando parole alle molte emozioni che si affollano nel loro mondo intrapsichico quando si avvicinano allo status di padri.
La letteratura internazionale si è concentrata sui padri ed il loro vissuto. In uno studio del 1991, Angela D. Henderson e A. Jenise Brouse hanno condotto una ricerca che ha dimostrato come la transizione alla genitorialità sia un evento stressante, riconoscendo attraverso la letteratura che il ruolo del padre nella società nordamericana stava cambiando. Lo scopo di questo studio qualitativo era chiarire la comprensione dell’esperienza dei nuovi padri durante le prime 3 settimane dopo il parto: sono stati intervistati nelle loro case 22 padri; i risultati suggerirono che i nuovi padri passano attraverso un prevedibile processo in tre fasi durante la transizione verso la paternità.
Altri studi di Richard J. Fletcher, Stephen Matthey and Christopher G Marley (2006) hanno evidenziato come i padri possono essere involontariamente emarginati nella fase perinatale dai Servizi e della compagne. Hanno constatato che si assiste ad un crescente riconoscimento del fatto che depressione ed ansia paterne nel periodo perinatale possono avere gravi conseguenze per la nuova famiglia e sottolineato come i Servizi sanitari potrebbero meglio supportare i nuovi padri fornendo loro informazioni sulla genitorialità dalla prospettiva paterna o permettendo loro di seguire incontri specifici come parte integrante di programmi di assistenza prenatale di routine.
Chi si occupa di genitorialità sa bene che intercettare i genitori durante la gravidanza è il periodo migliore per coglierne la collaborazione propositiva all’ascolto di tematiche teoriche e pratiche che vadano a sensibilizzarne il vissuto psicologico. Genitori e partner di coppia più consapevoli delle dinamiche della neonata famiglia e del primissimo sviluppo del bambino avranno maggiori opportunità per generare circoli virtuosi di emotività equilibrata nei loro piccoli e inevitabilmente nel proprio contesto famigliare nucleare e allargato.
Attualmente non sembra essere il tempo della prevenzione sia essa psicologica, educativa o sociale bensì degli interventi, delle emergenze e forse della frustrazione di percepire raramente il successo delle azioni rivolte alla risoluzione del problema.
Lavorare con i genitori nel percorso dell’accompagnamento alla nascita potrebbe determinare davvero uno spazio privilegiato per la maturazione di percorsi di sviluppo e competenza, anche nei genitori che tanto ne abbisognano e che tanto sentono di doversi nascondere, che tanto faticano a chiedere aiuto.
Lavorare con i papà sarebbe poi un’esperienza duplice in termini di risvolti positivi: andrebbe infatti ad influenzare sensibilmente la salute psicologica e medica della mamma alle prese con cambiamenti impegnativi legati al corpo e alla mente non sempre accolti di buongrado (Pomicino L., 2006). Il rapporto di coppia sarebbe inoltre maggiormente sostenuto da un papà partner non per forza più presente –come lo stereotipo vorrebbe farci credere- ma bensì più consapevole emotivamente. Vi sono esperienza italiane presso il Consultorio di Somma Lombardo dove è previsto un modello di intervento preventivo rivolto agli uomini e definito Il cerchio dei papà. Tale progetto è stato pensato per sostenere la funzione paterna nel periodo della gravidanza e del primo semestre di vita del neonato ed è finalizzato a favorire il coinvolgimento emotivo-affettivo del padre nell’accudimento del proprio figlio, migliorando la triangolazione madre-padre-bambino e facilitando lo sviluppo di un attaccamento sicuro nel neonato (Pellai,20058). Sostiene Alberto Pellai, conduttore degli incontri coi neopadri:
Il cerchio dei papà è un primo esperimento di questo tipo e, considerato la risposta e la partecipazione che ha ottenuto da parte dei papà coinvolti, potrebbe divenire un esempio di buona pratica alla quale ispirarsi per replicare la medesima esperienza in altre realtà e contesti affinché si crei una cultura dell’evento nascita in cui mamma e papà insieme possano partecipare ai corsi di preparazione alla nascita.
Ecco un altro buon auspicio: la prevenzione psicologica con parent training (corsi per genitori). Si potrebbe intercettare la coppia in attesa già durante le visite ostetrico-ginecologiche, dove sarebbe possibile proporre la partecipazione a momenti dedicati all’approfondimento sì del travaglio/parto come già viene fatto dal personale ostetrico, ma anche di tutte quelle dinamiche psicologiche connesse al periodo dell’attesa, per poi continuare ad incontrarsi anche dopo la nascita. E’ infatti con il lieto evento che terminano i cosiddetti corsi pre parto, oggi -con un ampliamento di visuale anche terminologica e di significato -accompagnamento alla nascita, il punto di vista della prevenzione però sarebbe proprio quello di non salutarsi con la nascita ma di continuare con i genitori un percorso di conoscenza del ruolo genitoriale e dello sviluppo del bambino. Successivamente, con l’inserimento nei primi servizi educativi quali nidi e scuole d’infanzia, la prevenzione educativa potrebbe passare fisiologicamente al personale educativo competente. Questo sarebbe a mio avviso un modo per lavorare sia sulla coppia genitoriale che sul coinvolgimento dei padri ai quali si potrebbero dedicare momenti (come anche alla madri) non necessariamente di coppia , avvicinandosi all’esperienza del cerchio dei papà.
La riflessione sulle competenze di ruolo genitoriale e sulla conoscenza dello sviluppo psicologico del bambino sopraccitate è da proporsi anche ai pediatri che si trovano a convogliare nella propria onnisciente professione, la medicina certo, ma molta consulenza psicologica; per alcuni pediatri è il sapore della propria missione, per altri può essere fonte di burnout professionale.
ARTICOLO CONSIGLIATO:
Giovani padri a rischio depressione
BIBLIOGRAFIA:
- Volta, A., Bussolati, N., Capuano, C., Ferraroni, E., Novelli, D., Pisani, F. (2006). Paternità: un’indagine sulle emozioni dei nuovi padri. Quaderni acp, 13:146-9. DOWNLOAD
- Pellai, A., Dalessandro, D., Baggiani, P., et al. (2009) Nella mente dei padri: Uno studio per indagare le emozioni di un gruppo di padri partecipanti al Percorso Nascita di un Consultorio familiare. Quaderni acp, 16(3): 104-108 . DOWNLOAD
- Fletcher, R.J., Matthey, S., Marley, C.G. (2006). Addressing depression and anxiety among new fathers. Article in The Medical Journal of Australia , november 2006.
- Henderson, A. D. e Brouse, A.J.(1991).The experiences of new fathers during the first 3 weeks of life. Journal of Advanced Nursing.
- Apollonio, M., Barbiero, C., Bascucci, S., Chert, T., Nanni, R., Paviotti, E.,Montico, M., Ciotti, F. e Tamburlini, G. (2005). Supporto precoce ai neogenitori. E’ necessario? Serve? Medico e Bambino, 9, 589‐598.
- Badolato, G. (1993). Identità paterna e relazione di coppia. Trasformazione dei ruoli genitoriali. Milano : Giuffrè Editore.
- Baldassarre, I. (2006). Cʹè anche il papà : qualche consiglio per essere padri sufficientemente buoni. Gardolo, Trento: Erickson.
- Heinowitz, J. (2000). Il papà incinto. Diventare genitori insieme. Pavia: Riccardo Bonomi Editore.
- Romito, P., e Saurel‐Cubizolles, M.J. (1997). I costi della maternità nella vita delle donne. Polis, 11, 67‐88.
SITOGRAFIA: