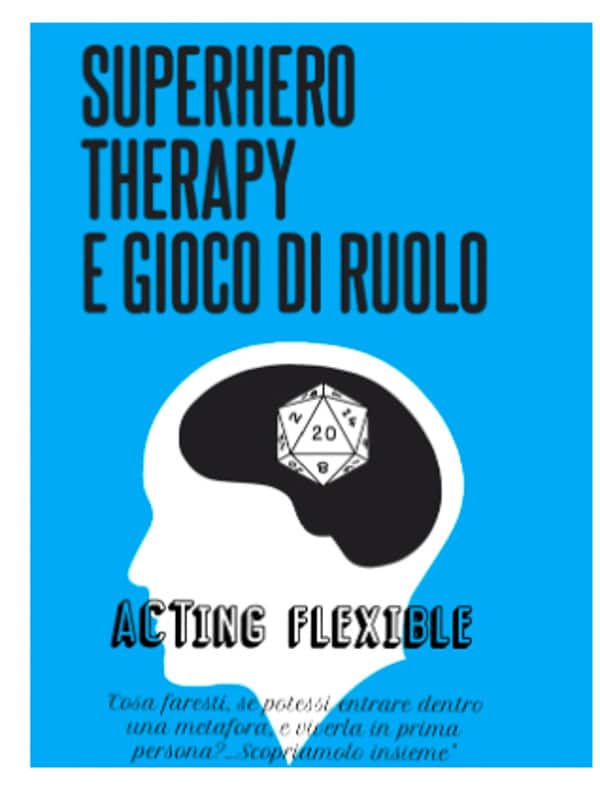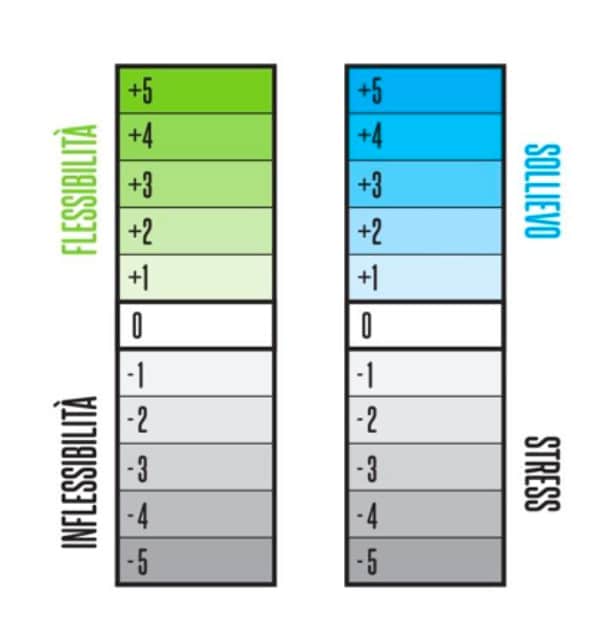Ipnosi e letteratura: considerazioni sui fenomeni ipnotici partendo da un esempio letterario
Con ipnosi ci si riferisce ad uno stato molto simile al sonno, o agli stati ad esso associati, in cui si verifica la trasmissione, da un ipnotizzatore ad un ipnotizzato, di una suggestione ovvero di un suggerimento.
Per entrare subito nel merito della questione che voglio affrontare con questo scritto riporterò un brano dal breve romanzo di Guy de Maupassant “Le Horla”:
“14 Luglio – Festa della Repubblica.
Ieri ho assistito a certi fatti che mi hanno assai turbato.
Desinavo dalla mia cugina, maritata a Sable, che comanda il 76° cacciatori a Limoges. C’erano due giovani donne, una delle quali ha sposato il dottor Parent che si interessa di malattie nervose e delle straordinarie manifestazioni che in questo periodo sono provocate dagli esperimenti sull’ipnotismo e sulla suggestione. Il dottor Parent ci parlò a lungo degli straordinari risultati che sono stati ottenuti da scienziati inglesi e dai medici della scuola di Nancy. Mi citò fatti così strani che non ci potevo proprio credere, e glielo dissi:
– Siamo in procinto di scoprire, – diceva, – uno dei più importanti segreti della natura, ossia uno dei più importanti segreti della Terra: altri ve ne sono, di diversa importanza, lassù nelle stelle. Da quando l’uomo pensa, da quando è capace di esprimere e scrivere il suo pensiero, egli sente di sfiorare un mistero che i suoi sensi grossolani e imperfetti non riescono a penetrare e cerca di supplire all’impotenza degli organi con gli sforzi dell’intelligenza. Finché l’intelligenza era ancora allo stato rudimentale, il terrore dei fenomeni invisibili assumeva forme scioccamente spaventose, da cui son nate le credenze popolari nel soprannaturale, le leggende degli spiriti vagabondi, delle fate, degli gnomi, dei fantasmi e voglio anche aggiungere la leggenda di Dio, poiché le nostre concezioni dell’operaio creatore, da qualunque religione provengano, sono le più mediocri invenzioni, e le più sciocche e inammissibili che siano uscite dal cervello spaventato delle creature. Non c’è nulla di più vero della frase di Voltaire: “Dio ha fatto l’uomo a sua immagine, ma l’uomo gli ha reso la pariglia”.
“Ora, dopo più d’un secolo, sembra di presentire l’avvento di qualcosa di nuovo. Mesmer ed alcuni altri ci hanno messo su una strada imprevedibile, e davvero siamo giunti, specialmente da quattro o cinque anni a questa parte, a risultati sorprendenti”. La mia cugina, anch’ella completamente incredula, sorrideva. Il dottor Parent le disse:
– Volete che provi ad addormentarvi, signora?
– Sì, certo.
Ella si sedette su una poltrona e il dottore cominciò a guardarla fissamente, incantandola. Ero turbato, il cuore mi batteva a precipizio e mi sentivo la gola chiusa. Vedevo gli occhi della signora Sable appesantirsi, la sua bocca torcersi, e il suo seno affannare. Dopo dieci minuti dormiva.
– Ponetevi dietro a lei, – disse il dottore.
Mi sedetti dietro a lei. Il dottore le mise in mano un biglietto da visita e le disse: – Questo è uno specchio; cosa ci vedete?
– Vedo mio cugino, – rispose ella.
– Che sta facendo?
– Si attorciglia i baffi.
– E ora?
– Si leva di tasca una fotografia.
Le due giovani donne, spaventate, dicevano: – Basta! Basta! Il dottore proseguì: – Domani vi alzerete alle otto, andrete da vostro cugino, all’albergo, e lo pregherete di prestarvi cinquemila franchi che vuole vostro marito e che vi chiederà al suo ritorno. E la svegliò. Tornando all’albergo ripensavo a quella curiosa seduta e fui preso da dubbi, non sulla buona fede, assoluta ed insospettabile, della mia cugina che conoscevo come una sorella fin dall’infanzia; ma sulla possibilità d’un trucco del dottore. Forse egli nascondeva in mano uno specchio e lo mostrava alla giovane addormentata, insieme al biglietto da visita? I prestigiatori di professione fanno cose ben più notevoli.
Me ne andai a letto. Stamani, verso le otto e mezzo, il mio cameriere è venuto a svegliarmi dicendomi:
– La signora Sable vuol parlarvi subito.
Mi vestii in fretta e la feci introdurre. Si sedette visibilmente turbata, tenendo gli occhi abbassati; e senza levarsi la veletta mi disse:
– Caro cugino, devo chiedervi un gran favore.
– Che cosa, cugina?
– Sono molto imbarazzata, eppure devo dirvelo. Ho bisogno assoluto di cinquemila franchi.
– Cosa mi dite? Voi…
– Sì, io: o meglio mio marito, che m’ha incaricato di trovarli.
Ero così stupito che nel risponderle balbettavo. Mi chiedevo se non si prendesse beffa di me, d’accordo col dottor Parent, se si trattasse d’uno scherzo ben preparato e bene eseguito. Pure, guardandola attentamente, i miei dubbi scomparvero. Quella richiesta le doveva riuscire tanto dolorosa che tremava e mi accorsi che stava sul punto di scoppiare in singhiozzi.
So che è ricchissima, perciò le dissi:
– Ma come, vostro marito non può disporre di cinquemila franchi? Suvvia, pensateci un poco… Siete sicura che vi abbia detto di venirmeli a chiedere? Restò esitante per qualche secondo, come se si sforzasse di frugare nella memoria, e mi rispose:
– Sì, sì, sono sicura.
– Vi ha scritto? Esitò ancora, riflettendo. Indovinai il lavorio tormentoso della sua mente. Non lo sapeva. Sapeva solamente di dovermi chiedere in prestito cinquemila franchi per suo marito. Decise di mentire.
– Sì, m’ha scritto.
– Quando? Ieri non mi avete detto nulla.
– Ho ricevuto una lettera stamattina.
– Potete farmela vedere?
– No… no… no… c’erano cose troppo intime, troppo personali… sicché l’ho… l’ho bruciata.
– Insomma vostro marito ha dei debiti…
Esitò di nuovo, e poi mormorò:
– Non lo so.
Le dissi bruscamente:
– Il fatto è, cara cugina, che in questo momento non posso disporre di cinquemila franchi.
Mandò un’esclamazione di dolore:
– Oh! vi prego! vi prego, trovateli!…
S’era eccitata, aveva giunto le mani, come per pregarmi. La sua voce aveva mutato tono: piangeva e balbettava, torturata, dominata dall’irresistibile ordine che aveva ricevuto.
– Vi supplico… sapeste quanto soffro… ne ho bisogno per oggi.
Ebbi compassione di lei.
– Ve li farò avere subito, ve lo giuro.
– Oh, grazie! – esclamò: – come siete buono…
– Vi ricordate, – seguitai, – cos’è successo ieri sera a casa vostra?
– Sì.
– Vi ricordate di essere stata addormentata dal dottor Parent?
– Sì.
– Lui vi ha ordinato di venire stamattina da me a chiedermi in prestito cinquemila franchi, e in questo momento voi gli state obbedendo.
Stette qualche secondo a pensare, e mi rispose:
– Ma me lo ha chiesto mio marito…
Cercai, per un’ora, di convincerla, ma non ci riuscii. Quando se ne fu andata, corsi subito dal dottore. Stava per uscire.
Sorridendo mi ascoltò, poi disse:
– Ci credete ora?
– Per forza.
– Andiamo dalla vostra cugina.
Costei stava sonnecchiando, sfinita, su una poltrona a sdraio. Il dottore la prese per il polso, la guardò per un poco, tenendole una mano davanti agli occhi, che a poco a poco, sotto quell’insostenibile influenza magnetica, si chiusero. Appena si fu addormentata le disse:
– Vostro marito non ha più bisogno dei cinquemila franchi. Perciò dimenticatevi di essere andata dal vostro cugino a supplicarlo di prestarveli; e anzi, se lui ve ne parlerà non lo capirete. Dopo la ridestò. Io trassi di tasca il portafoglio.
– Allora, mia cara cugina, eccovi quel che mi avete chiesto stamani…
Restò così sorpresa che non ebbi il coraggio d’insistere. Provai a rinfrescarle la memoria ma seguitò a negare con forza, credette che la pigliassi in giro e insomma ci mancò poco che s’offendesse. Sono tornato or ora, non m’è riuscito di mangiare nulla, tanto quell’esperimento mi ha sconvolto.”
Avrei potuto scegliere un altro esempio, tra i molti presenti in letteratura, ma ho deciso d’impiegare proprio questo brano principalmente per due motivi: in primo luogo perché Maupassant utilizza dei riferimenti storici particolarmente esatti, come ad esempio il riferimento agli esperimenti condotti a Nancy da Hyppolyte Bernheim; in secondo luogo, perché alcuni elementi della narrazione sono perfettamente congruenti con la realtà e risulta pertanto possibile fare alcune considerazioni sui reali esperimenti ipnotici della fine del diciannovesimo secolo.
Che cos’è l’iponosi?
Prima di entrare nel merito della questione cerchiamo di dare un paio di nozioni riguardo all’ipnosi: con trattamento ipnotico ci si riferisce ad uno stato molto simile al sonno, o agli stati ad esso associati, in cui si verifica la trasmissione, da un ipnotizzatore ad un ipnotizzato, di una suggestione ovvero di un suggerimento. Evidentemente ipnosi e sonno non sono perfettamente identici, lo stato ipnotico è infatti un sonno del tutto particolare. Come nel sonno, ci si trova di fronte ad un fenomeno a cavallo tra il fisiologico e lo psichico, ma l’ipnosi, a parte le sue caratteristiche superficiali come gli occhi chiusi ed il rilassamento, presenta delle peculiarità che non possiamo trascurare. Per esempio: il soggetto è, sì, addormentato, ma è al contempo vigile e capace di reagire agli stimoli esterni e a rispondere alle domande dell’ipnotizzatore. Ed è proprio il rapporto tra i due che caratterizza l’ipnosi. In effetti, la reazione agli stimoli esterni non è estesa a tutti o a tutto; il paziente dorme nei confronti del mondo intero, ma è vigile per il suo ipnotizzatore: è sotto la sua influenza. Sotto un influsso profondo l’ipnotizzato diviene docile, credulo, capace di prestazioni sorprendenti pur di soddisfare le richieste dell’ipnotizzatore. Quando l’ipnotizzatore suggerisce all’ipnotizzato di osservare una lastra specchio – come nel caso del brano di Maupassant – ciò viene eseguito immediatamente, senza opporre alcuna resistenza. In altri casi l’ipnotizzatore può indurre l’ipnotizzato ad esperire una particolare sensazione, come ad esempio l’assaporare un gusto acido, ed immediatamente sul volto di costui appare la tipica espressione contratta di chi ha bevuto l’aceto o assaggiato un limone. L’ipnotizzato sta in questo caso allucinando dei fenomeni, proprio come avviene nel sogno – dove in effetti tutto sembra perfettamente reale. La sottomissione e la credulità dell’ipnotizzato somigliano molto a quelle del bambino nei riguardi dei genitori, o quelle del cosiddetto innamorato perso nei riguardi dell’amata. Tramite questo rapporto è possibile inibire, ostacolare o influenzare una grandissima mole di fenomeni: si possono influenzare le funzioni motorie, sensitive, certi riflessi, o addirittura sentimenti, istinti, memoria ed attività. Questo naturalmente non significa che tutto è possibile, l’immagine dell’assassino per volontà dell’ipnotizzatore è una pura e semplice finzione cinematografica. Il Dottor Caligari non esiste, ci sono dei limiti a cui la soggettività dell’ipnotizzato si manterrà sempre salda, quale che sia il grado d’influenza.
Proprio come il brano di Maupassant mostra chiaramente, una volta che il paziente è sotto l’influenza della suggestione ipnotica egli porterà a zero le proprie azioni volontarie, per essere esclusivamente in balìa dei suggerimenti dell’ipnotizzatore. A differenza, però, degli esempi fatti fino ad ora, quello dell’Horla è un caso di suggestione post-ipnotica. Infatti, che la donna sia intensamente sottomessa alla volontà dell’ipnotizzatore, non ne abbiamo prova subito, ma il giorno seguente. Ed è proprio l’esecuzione di quel particolar comando a mettere il protagonista nell’angosciosa condizione di accettare la veridicità del fenomeno a cui aveva assistito. Ci terrei ora a sottolineare che non solo la donna non si ricorda della suggestione impartitale, ma – e questo è molto interessante – quando viene interrogata sulle cause del suo comportamento, si sforza con ogni mezzo di trovare delle spiegazioni, che sono false. quanto inverosimili, benché ella, bisogna sottolinearlo, si ricorda chiaramente di essere stata messa sotto ipnosi!
Ipnosi e nevrosi
Per quanto Maupassant abbia naturalmente romanzato la faccenda, tocca un punto fondamentale: così come il nevrotico non è conoscenza delle ragioni che stanno dietro al proprio comportamento patologico, anche l’ipnotizzato trova innumerevoli scuse alla sua assurda condotta. Ciò avviene perché sono entrambi sotto l’influenza di processi psichici inconsci, nel primo caso sulla base di una suggestione indiretta (o autosuggestione) e nel secondo sulla base di una suggestione diretta ovvero il comando impartitogli dall’ipnotizzatore. Possiamo pertanto affermare che la suggestione condiziona, nelle sue dinamiche dirette ed indirette, non solo la coscienza del soggetto, ma anche e soprattutto il suo inconscio.