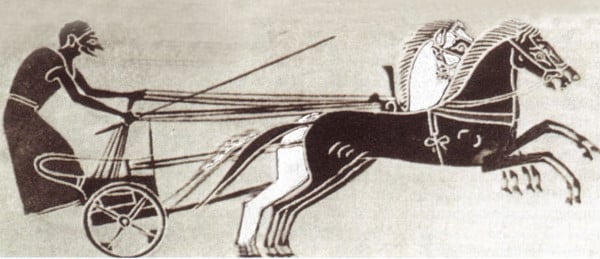Stai per commettere un terribile errore (2022) di Oliver Sibony – Recensione
Nel testo “Stai per commettere un terribile errore” l’autore si focalizza sui processi decisionali all’interno dei grandi gruppi e, nello specifico, delle organizzazioni. Nella sua analisi, percorre in maniera fluida, e allo stesso tempo dettagliata, le dinamiche inerenti ai “bias cognitivi” individuali e di gruppo.
Nello specifico, prende in considerazione quanto i
bias siano determinanti nelle “decisioni strategiche” e come, nonostante la nostra comune tendenza a “idolatrare i leader delle aziende che hanno successo attribuendo loro caratteristiche di “infallibilità” e “onnipotenza” (teoria del grande uomo al comando), anche questi leader di successo possano commettere errori nei processi decisionali. Inoltre, sempre nell’ottica delle “fallacie cognitive”, in genere abbiamo anche la tendenza ad “attribuire” il fallimento di un’azienda o di un’organizzazione a un singolo (teoria dell’uomo cattivo, come spiega l’autore). C’è quindi la tendenza a definire i buoni e i cattivi decisori sulla base dei buoni e cattivi risultati, il che, oltre ad essere tautologico e circolare, rinforza alcuni bias descritti dall’autore. In particolare, il “bias di conferma”, “l’errore di attribuzione”, “lo storytelling”, il “bias del senno del poi”.
Sibony (2022), oltre a descrivere i vari bias (nel testo chiamate “trappole”), fa una rassegna analitica e narrativa (con esempi ed evidenze sperimentali) delle tecniche utili a regolarne l’impatto. Infatti, una delle idee centrali presentate è che per quanto il nostro “bisogno di controllo” possa risultare intenso e quindi permette di “vincere i bias”, non abbiamo bisogno di ciò. Egli scrive: “Abbiamo limitazioni cognitive che potremmo non essere in grado di superare, ma ci sono organizzazioni che possono rimediare alle nostre carenze” (Sibony, 2022, p. 56). Enfatizza quindi il ruolo della “collaborazione e del processo”, di come sia più facile che i bias vengano individuati da più persone piuttosto che da “un solo decisore” e di come sia fondamentale un buon processo per agire sulle proprie intuizioni. Il gruppo, pertanto può costituire un limite nel caso in cui “i bias sociali” ricoprano un potere prevalente, e non venga dato spazio al dialogo, all’incertezza, alla divergenza e all’accoglienza, tuttavia anche una grande risorsa.
Per questioni di brevità, prenderò in considerazione soltanto alcuni dei bias esposti e delle tecniche per gestirne l’impatto sul comportamento (l’autore fornisce un’appendice abbastanza chiara e schematica di tutti i bias).
Prima è stato fatto accenno ai bias sociali. Vediamoli nel dettaglio. Uno di questi è il “pensiero di gruppo”, dinamica in cui i singoli individui mettono a tacere i propri dubbi e si conformano all’idea prevalente, invece di dissentire. In questo, Sibony (2022) enfatizza l’importanza rivestita dal gruppo, quando abbiamo bisogno di formarci opinioni su problemi complessi e con un margine non indifferente di incertezza. C’è nondimeno il ruolo giocato dall’impressionabilità di fronte a colleghi di cui rispettiamo il punto di vista, gerarchicamente superiori, fonte di un certo “timore reverenziale” e portatori di un forte grado di sicurezza di fronte all’incertezza. In genere, quindi, alla base di questa dinamica di gruppo, vi è la “paura” di possibili ritorsioni all’interno dello stesso gruppo, e, allo stesso tempo, la paura determinata dall’incertezza e da ciò che non può essere previsto. Conformarsi al gruppo, a “un grande Altro” riconosciuto nel gruppo e nell’opinione prevalente, costituisce una modalità per compensare l’angoscia derivante da questi fattori. Detto ciò, Sibony (2022) fa inoltre riferimento a un processo cognitivo automatico che, per adeguamento razionale all’opinione della maggioranza, induce il singolo individuo a cambiare idea. L’autore spiega che, una volta rivelato il consenso di gruppo, questo, insieme alla pressione sociale all’interno di esso, porta gli ingenuamente dubbiosi ad autoconvincersi di ciò che sentono.
Associati al “pensiero di gruppo”, vi sono altri bias, che si rinforzano a vicenda, innescando spesso circoli viziosi a valanga. Tra questi vorrei prenderne in considerazione alcuni, a mio avviso strettamente intercorrelati, quali, la “polarizzazione di gruppo”, la “cascata di informazioni”, il “bias di conferma”, “storytelling”, “il bias di attribuzione” e” l’escalation dell’impegno”, “avversione alla perdita”. La “polarizzazione di gruppo”, inserita da Sibony (2022), all’interno dei “bias sociali” come il pensiero di gruppo, insieme alla “cascata di informazioni”, attivano una situazione apparentemente paradossale, in cui il gruppo risulta meno informato della somma dei suoi membri. Nello specifico, la discussione all’interno del gruppo si focalizza troppo su ciò che è condiviso e ciò che sta in superficie, trascurando invece dettagli potenzialmente importanti. Ogni persona adeguerà il proprio giudizio per tenere in considerazione le opinioni espresse prima, ciò induce i gruppi a conclusioni che sono più estreme del punto di vista medio dei suoi membri e a nutrire maggiore fiducia in esse.
All’interno della polarizzazione di gruppo, vediamo associati anche il “bias di conferma e lo storytelling”.
Si è accennato al ruolo della paura nei confronti dell’incertezza. In generale –afferma Sibony (2022)– quando qualcuno ci racconta una bella storia, la tendenza automatica è di cercare elementi che la avvalorino, piuttosto che informazioni che la smentiscano. Ciò collude con un bisogno umano, ovvero un insaziabile “bisogno di storie”. Ma le storie non sono i fatti. Possiamo avere la tendenza a confermare dei fatti in una storia coerente, specie in situazioni complesse, angoscianti e di forte pressione sociale, e quindi fondere il pensiero con la realtà, arrivando pertanto a identificarci con la storia stessa. Per esempio, Russ Harris (2010), nel libro “La trappola della felicità”, parla del “meccanismo di fusione” con i pensieri in una storia coerente, del nostro prenderli come verità assolute e del nostro crederci senza riserve. Sibony afferma: “È più facile berci una storia che rafforza le nostre opinioni, piuttosto che una storia che ci disorienta e ci mette in discussione” (Sibony, 2022, p. 34). Per esempio, una persona esposta a esperienze ripetitive di rifiuto e abbandono, sarà più facile che abbia radicato internamente credenze basate su queste esperienze e sulla concomitante percezione di sé come “non abbastanza, inadeguato/a” e che abbia sviluppato stati della mente rigidi e ripetitivi che vanno a confermare proprio l’esperienza temuta, raccontandosi pertanto una storia drammatica ma, comunque, prevedibile (in questo vediamo anche il “bias dell’esperienza” in cui l’analogia con situazioni della nostra esperienza, ci porta a ricercare conferme all’esterno e potenzialmente a riproporle) .
L’autore propone anche i cosiddetti “bias dell’inerzia” che, nei processi decisionali, spingono appunto a inerzia e status quo. L’escalation dell’impegno, per esempio, spinge le aziende a salvare “a tutti i costi” azioni fallimentari. In questo, ricoprono un ruolo specifico i costi sommersi e l’avversione alla perdita. Sentiamo una potenziale perdita e fallimento, più intensamente di un guadagno della stessa entità. Di conseguenza, ci troviamo maggiormente spinti a perseverare negli stessi schemi di pensiero, emozione e comportamento e in sterili acting-out controfobici, piuttosto che riconoscere e accettare un fallimento strategico. Sibony scrive: “Molti manager sono paralizzati dalla paura del fallimento. È molto difficile condurre un vero esperimento se non si accetta la possibilità del fallimento” (Sibony, 2022). Egli infatti incoraggia il “diritto di fallire” ma non “il diritto di commettere errori”. E dal mio punto di vista, la logica che segue Sibony (2022) fa riferimento all’accettazione e, quindi, nello specifico caso aziendale, “lasciare andare” le risorse precedentemente investite ma fallimentari e trattarle come “costi irrecuperabili”. Aumentando invece la posta in un corso di azione fallimentare, rischiamo di rimanere intrappolati nel “diritto di commettere errori”, riproponendo pertanto circoli viziosi disfunzionali e alimentando “l’escalation dell’impegno”. L’errore logico dei costi sommersi e dell’escalation dell’impegno, sta quindi nell’impegnare nuove risorse soltanto in funzione di perdite irrecuperabili. Sibony (2022), invece incoraggia a porci questa domanda: “Il risultato atteso giustifica le risorse ulteriori che impegniamo oggi?”
Come accennato all’inizio, la parte finale del testo si focalizza sulle strategie per regolare l’impatto dei bias sui
processi decisionali. Viene presentato un elenco di tecniche, descritte in maniera altrettanto narrativa e fluida. In particolare, si focalizza sull’importanza della cooperazione, del dialogo, di accogliere l’incertezza, di incoraggiare i punti di “vista sfumati”, di presentare “storie alternative”. Vediamone qualcuno.
La tecnica delle “storie alternative” risulta molto utile per allentare il potere del bias di conferma, paradossalmente attraverso un altro bias che è “lo storytelling”. In particolare, fa riferimento al generare storie differenti per fatti identici. Ciò incoraggia quello che Winnicott (1979) definisce “gioco con la realtà”, e quindi la possibilità di viaggiare tra stati della mente e aprirsi pertanto a una molteplicità di prospettive. Da qui, vediamo anche la tecnica del “cambiare idea con orgoglio”, dove l’autore incoraggia la flessibilità e l’ambiguità e quindi la possibilità di andare oltre polarizzazioni del pensiero. Scrive: “È magnifico vedere un leader ammettere che una decisione è difficile e potrebbe essere necessario testarla nuovamente” (Sibony, 2022, p. 271). Viene enfatizzata l’importanza di non restare imprigionati nella propria storia e di essere pertanto aperti a narrazioni differenti. Sibony (2022), come accennato, sottolinea l’importanza del “lavoro di squadra”, ponendo però enfasi su un aspetto di fondamentale importanza per la leadership. Egli afferma che, per quanto il team sia essenziale, la decisione finale spetti comunque al leader. Deve fare appello agli altri per combattere i propri bias individuali ma, quando arriva il momento, deve prendersi la responsabilità di decidere. Quindi, è importante la connessione ma lo è altrettanto l’autonomia. In questo, Sibony (2022) suggerisce di “condividere la responsabilità” per la presa di decisioni importanti. In questo caso, viene ridotto il rischio che dominino i bias di un individuo.
Nelle conclusioni viene dedicato un interessante paragrafo alla descrizione di un possibile nuovo modello di leadership. Viene accennata l’importanza del carisma del decisore e delle concomitanti aspettative legate al suo ruolo. Tuttavia, proprio le aspettative alimentano il bias di conferma e l’ancoraggio a posizioni rigide. Sicuramente ci possono essere leader “eccessivamente fiduciosi” che incarnano lo stereotipo di un incrollabile ottimismo, ma ci può anche essere un gruppo che abbia bisogno di riporre una fede incrollabile su un “capo”. Questo però è il processo che sopprime il dissenso e scoraggia il pensiero di gruppo. Un leader che invece si prende la responsabilità della decisione finale ma, al contempo, orchestra un processo decisionale attraverso cui il team produrrà la miglior risposta possibile, abbraccia collaborazione, processo e umiltà come basi per un lavoro di gruppo. L’autore conclude con il “mito di Odisseo”, presentandolo come un possibile modello archetipico di leadership. Odisseo è abbastanza consapevole da conoscere i propri limiti e, quindi, della possibilità di non riuscire a resistere alle canzoni ammalianti delle sirene. Chiede ai suoi marinai di legarlo all’albero, riponendo quindi fiducia nel team e affidando la sua vita nelle loro mani. Dice poi ai marinai di turarsi le orecchie con la cera d’api, rinunciando a dare loro nuove istruzioni. Emerge quindi fiducia, cooperazione e consapevolezza del limite che, se accettato, diventa possibilità per la creazione di nuovi orizzonti.