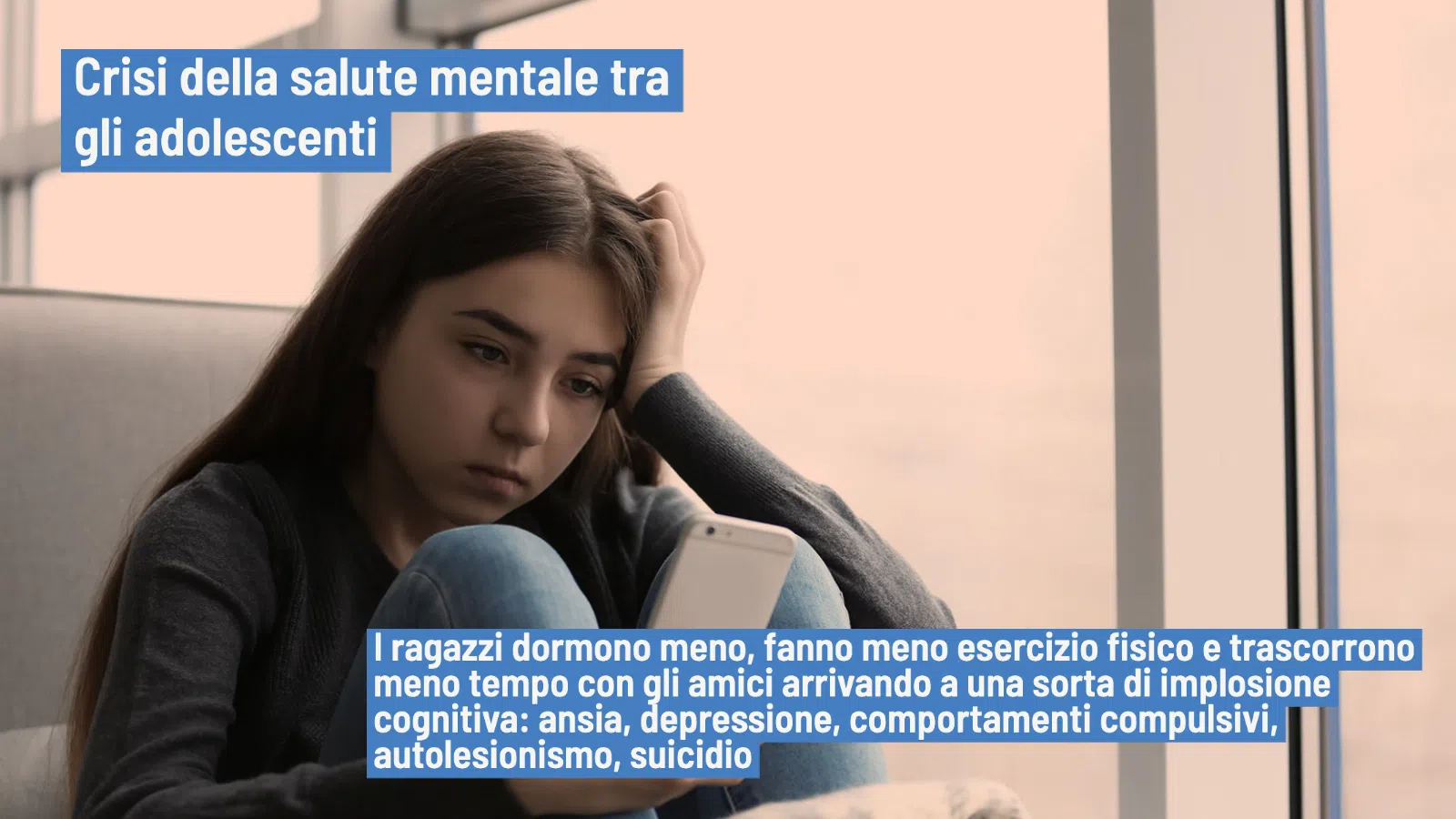Autolesionismo: che cos’è?

Secondo i criteri del DSM-IV (APA, 2000) i comportamenti autolesionistici rappresentano uno dei criteri identificativi del Disturbo Borderline di Personalità. In realtà la letteratura scientifica ha rivelato che queste modalità comportamentali non sono esclusive del disturbo borderline e, al contrario, si possono riscontrare anche in altre categorie diagnostiche, tra cui i disturbi d’ansia, la depressione, l’abuso di sostanze, i disturbi alimentari, la schizofrenia e altri disturbi di personalità.
L’autolesionismo è un disturbo che colpisce il 6% della popolazione adulta e oltre il 15% degli adolescenti e dei giovani adulti. Particolarmente diffuso nella popolazione psichiatrica, si presenta di frequente all’interno dei disturbi di personalità borderline, ma può comparire anche in pazienti affetti da disturbi d’ansia, depressione, disturbi del comportamento alimentare o disturbi di personalità diversi dal borderline. La natura della patologia, solo di recente riconosciuta come classe diagnostica a sé stante, è assai variegata: molteplici sono, infatti, le modalità con cui ci si può fare del male e molteplici sono anche le cause che spingono a condotte autolesive. Sebbene gli atti autolesionisti abbiano una natura diversa rispetto ai tentativi di suicidio, esiste un forte legame predittivo tra i primi e i secondi, che sottolinea ulteriormente la necessità di conoscere ed intervenire tempestivamente su questa forma di sofferenza.
Diagnosi di autolesionismo
In questa direzione si è mosso il DSM-V (APA; 2013), che considera l’autolesività non suicidaria come categoria diagnostica a sé stante. I criteri per la diagnosi di autolesionismo proposti nel manuale sono i seguenti:
Criterio A
Nell’ultimo anno, in cinque o più giorni, l’individuo si è intenzionalmente inflitto danni di qualche tipo alla superficie corporea in grado di indurre sanguinamento, lividi o dolore (per es. tagliandosi, bruciandosi, accoltellandosi, colpendosi, strofinandosi eccessivamente), con l’aspettativa che la ferita porti a danni fisici soltanto lievi o moderati (non c’è intenzionalità suicidaria).
Criterio B
L’individuo è coinvolto in condotte autolesive con una o più delle seguenti aspettative:
1. Ottenere sollievo da una sensazione o uno stato cognitivo negativi
2. Risolvere una difficoltà interpersonale
3. Indurre una sensazione positiva
Criterio C
L’autolesività intenzionale (le condotte autolesive)è associata ad almeno uno dei seguenti sintomi:
1. Difficoltà interpersonali o sensazioni o pensieri negativi, come depressione, ansia, tensione, rabbia, disagio generalizzato, autocritica, che si verificano nel periodo immediatamente precedente al gesto autolesivo.
2. Prima di compiere il gesto autolesivo, presenza di un periodo di preoccupazione difficilmente controllabile riguardo al gesto che l’individuo ha intenzione di commettere.
3. Pensieri di autolesività presenti frequentemente, anche quando il comportamento non viene messo in atto.
Autolesionismo: una categoria diagnostica, diverse forme di sofferenza
Nel DSM-V (APA, 2013) l’autolesionismo è stato inserito come categoria diagnostica a sé stante; ciò non significa che i comportamenti autolesivi siano riconducibili ad un’unica modalità di auto-danneggiamento. L’identificazione delle diverse forme che il disturbo può assumere risulta utile per fare chiarezza e facilita un intervento tempestivo.
Le 3 categorie di autolesionismo
Ciò che in letteratura è definito ‘deliberate self harm’ – in italiano ‘auto-danneggiamento intenzionale’- comprende un ventaglio di comportamenti patologici, riconducibili a tre categorie principali:
- le condotte di auto-danno, come l’abuso di sostanze psicoattive, la sessualità promiscua e il gioco d’azzardo,
- le condotte di auto-avvelenamento, come l’ingestione di sostanze tossiche e l’overdose di droghe,
- le condotte autolesive, come tagliarsi e bruciarsi.
Categorie delle condotte autolesive
Già negli anni Novanta le ricerche condotte da Favazza e colleghi hanno reso possibile una prima classificazione delle condotte autolesive. Favazza e Rosenthal (1993) hanno identificato diverse tipologie di autolesionismo sulla base del grado di danneggiamento dei tessuti e dei pattern comportamentali.
- L’autolesionismo maggiore consiste in atti infrequenti e isolati che provocano un danneggiamento dei tessuti grave e permanente; solitamente è associato alle psicosi o alle intossicazioni acute e include atti quali la castrazione e l’enucleazione oculare.
- L’autolesionismo stereotipico comprende comportamenti ripetuti in modo costante e ritmico, che sembrano essere privi di un significato simbolico, comunemente associati a grave ritardo mentale, all’autismo o alla sindrome di Tourette; ne sono esempi il mordersi o dare colpi con la testa.
- L’autolesionismo moderato o superficiale consiste in atti episodici o ripetuti a bassa letalità che comportano un lieve danneggiamento dei tessuti corporei (tagli, bruciature, abrasioni). Il soggetto utilizza strumenti esterni come rasoi, lamette, forbicine e compie gesti autolesivi che solitamente hanno un significato simbolico, in genere relazionale. All’interno di questa categoria, Favazza e Simeon (1995) hanno identificato tre forme principali.
Le 3 forme di autolesionismo moderato
L’autolesionismo moderato è definito compulsivo quando si declina in comportamenti quotidiani, come la tricotillomania (tirarsi i capelli) o l’onicofagia (mangiarsi le unghie); si tratta di una forma di discontrollo degli impulsi.
Episodico è invece un tentativo di riacquisire un senso di controllo e padronanza di fronte a emozioni e pensieri intollerabili, mettendo in atto comportamenti autolesivi come tagliarsi, bruciarsi o colpirsi.
Ripetitivo, infine, è una dipendenza dal comportamento autolesivo, che può diventare identitario (Es. ‘sono un cutter’).
Autolesionismo e adolescenza
L’autolesionismo è molto diffuso tra gli adolescenti e i giovani adulti. L’incidenza di tale fenomeno in queste fasce d’età oscilla tra il 15-20% (Ross et al., 2002) e l’esordio si aggira tra i 13 e i 14 anni (Herpertz, 1995; Nock et al., 2006; Withlock et al. 2006, Ross et al., 2002). Ricerche recenti suggeriscono che pensieri e comportamenti autolesivi si manifestino anche in soggetti più giovani, minori di 14 anni; inoltre hanno riscontrato che i pensieri autolesivi nelle ragazze tra i 13 e i 14 hanno una prevalenza del 22%, e fino al 15% di esse hanno tentato di farsi del male almeno una volta negli ultimi 6 mesi (Stallard et al.,2013).
L’autolesionismo in adolescenza è associato a depressione, stress, ansia, disturbi della condotta e abuso di sostanze (Nock et al., 2006) e a relazioni familiari disfunzionali, isolamento sociale e basso rendimento scolastico (Fliege et al., 2009).
“Perché ti tagli?”: le cause dell’autolesionismo
Il quadro delineato mostra chiaramente che il termine autolesionismo è un’etichetta diagnostica che racchiude comportamenti e vissuti anche piuttosto diversi tra loro. Nell’indagare le cause di tali gesti è quindi opportuno cercare di tracciare un quadro variegato, evitando semplificazioni fuorvianti.
Autolesionismo come strategia di coping
L’autolesionismo può costituire una strategia di coping e regolazione emotiva: di fronte allo stato emotivo indesiderato e vissuto come intollerabile, il soggetto si ferisce cercando di ripristinare uno stato tollerabile. Si potrebbe dire che la messa in atto di comportamenti autolesivi sia un tramutare in sofferenza fisica (quindi più reale e più facilmente gestibile) una sofferenza emozionale che non si sa come gestire: per un po’ ci si occupa solo del dolore fisico, distogliendosi temporaneamente da quello interiore (Chapman et al., 2006; Klonsky, 2007; Kamphuis et al., 2007). In questo senso l’autolesionismo sembra assumere la valenza di una strategia disadattava di coping (nozione proposta da Favazza, 1998).
Autolesionismo come punizione autoinflitta
Una seconda funzione dell’autolesionismo è la punizione autoinflitta: sembra infatti che, per alcuni soggetti, tra l’autocriticismo e i comportamenti di autodanneggiamento esista una relazione causale (Nock et al., 2008; Hooley & St Germain, 2013).
Autolesionismo come comunicazione
Infine, l’autolesionismo può costituire una forma di comunicazione del proprio disagio. Attraverso le ferite, infatti, la propria sofferenza appare evidente agli occhi degli altri (Klonsky, 2007).
Autolesionismo e suicidio
I comportamenti suicidari sono forme estreme di autolesionismo, che si collocano all’estremità del continuum delle condotte autolesive. Occorre specificare che le condotte di auto-ferimento sono più frequenti e meno gravi rispetto ai comportamenti messi in atto nel suicidio, ma soprattutto non hanno come obiettivo quello di porre fine alla propria vita: come abbiamo già avuto modo di chiarire, il gesto autolesivo può costituire una strategia di coping, una modalità di comunicazione o una auto-punizione.
Autolesionismo come fattore di rischio per il suicidio
Si noti, tuttavia, che le condotte autolesive costituiscono fattori di rischio significativi per il suicidio. Secondo una ricerca di Klonsky e collaboratori (2013) i comportamenti autolesivi sono maggiormente correlati a storie di tentati suicidi più di qualsiasi altro fattore di rischio per il suicidio (come depressione, ansia, impulsività e BPD).
Secondo Joiner (2005) il forte legame tra gesti autolesivi e tentativi di suicidio si spiegherebbe sulla base di due elementi indispensabili per cercare di togliersi la vita: il desiderio di uccidersi e la capacità di attuare comportamenti per concretizzare tale desiderio. La progressiva desensibilizzazione al dolore fisico attraverso ripetute pratiche di auto-danneggiamento potrebbe quindi favorire la messa in atto del gesto estremo del togliersi la vita.
Cura dell’autolesionismo: i trattamenti
Psicoterapia per l’autolesionismo
Il trattamento più diffuso ed efficace per intervenire sulle condotte autolesive è la Dialectical Behavioral Therapy (DBT), ideata da Marsha Linehan nel 1993 per i pazienti con disturbo borderline di personalità, poi sviluppata ed estesa ad altre tipologie di pazienti. La peculiarità del modello della Linehan consiste nell’affiancare alla componente di cambiamento e ristrutturazione cognitiva una dimensione di accettazione.
L’approccio cognitivo-comportamentale standard (CBT), infatti, lavora soprattutto nella direzione della prevenzione o della riduzione dei sintomi autolesivi nei pazienti di Asse I che presentano questi tratti, come i gravi depressi o pazienti con disturbi del comportamento alimentare. La CBT non solo pone attenzione sugli aspetti irrazionali e cognitivi dei pensieri negativi che precedono l’atto autolesivo, ma si compone anche di moduli prettamente comportamentali: le tecniche di problem solving possono essere utili nell’aiutare gli adolescenti ad affrontare gli stress che si associano all’autolesionismo, mentre le tecniche cognitive possono essere particolarmente utili nel caso in cui al tentativo di suicidio sia associata una diagnosi in Asse I (Harrington, R., Saleem, Y, 2002).
Il modello DBT, invece, è stato sviluppato a partire dalla tradizione comportamentale, ma ha affiancato alla dimensione del cambiamento un lavoro di accettazione, elemento che peraltro risulta trasversale alle cosiddette terapie cognitivo-comportamentali di terza generazione. La DBT prevede una presa in carico del paziente autolesionista a più livelli: terapia individuale, partecipazione ad un gruppo di skill training, gestione del caso in equipe e coaching telefonico per gestire le crisi sono alcuni dei tratti fondamentali dell’approccio. Il terapeuta individuale costituisce la principale figura di riferimento del paziente; nel corso delle sedute si lavora sulla motivazione al trattamento e si crea un linguaggio emotivo comune tra paziente e terapeuta, che permetta di ridurre gli effetti delle emozioni negative e aiuti a recuperare e sviluppare strategie utili per tollerare le emozioni negative che sono alla base dei comportamenti autolesionistici e degli stati di malessere generale del paziente. Lo skill training è invece un percorso di natura psicoeducativa e, in un contesto di gruppo, mira a sviluppare una serie di abilità e competenze che il paziente possa usare per gestire la propria quotidianità e le relazioni. Secondo quanto indicato da Linehan (2011) le abilità da sviluppare riguardano la mindfulness, la regolazione emotiva, l’efficacia interpersonale e la tolleranza allo stress.
Importanza delle emozioni positive
La letteratura recente (Morris, C., Simpson, J., Sampson, M., Beesley, F., 2013) evidenzia l’importanza di intervenire sulle emozioni positive, costruendo un linguaggio emotivo comune tra paziente e terapeuta che sia in grado di ridurre gli effetti delle emozioni negative e aiuti a recuperare e sviluppare strategie utili per tollerare le emozioni negative che sono alla base dei comportamenti autolesionistici e degli stati di malessere generale del paziente. Se coltivate nel tempo, le emozioni positive (Fredrickson, 2001) possono costruire una protezione che consente alle persone di affrontare meglio gli eventi avversi futuri. Guidate da emozioni positive le persone formulano un repertorio più ampio di soluzioni ai problemi. L’esperienza di emozioni positive è legata a probabilità più alte di godere di buona salute e di adattarsi a situazioni differenti, anche problematiche, sia in senso psicologico che fisico. Il lavoro sullo sviluppo delle emozioni positive è mirato a migliorare le relazioni con gli altri e a formulare strategie di pianificazione di attività di vita desiderabili che tamponino l’influenza delle emozioni negative e delle condotte disregolate da esse innescate.
Importanza della relazione terapeutica
Numerosi studi sembrano confermare l’efficacia degli approcci con un focus sulla cooperatività della relazione terapeutica, sulla motivazione e sulla spinta al trattamento (Turner et al., 2014), siano essi inscritti in un quadro DBT o parte di approcci differenti come la Dynamic Decostructive Psychotherapy, i gruppi di auto-mutuo aiuto incentrati sulla regolazione delle emozioni e alcune terapie farmacologiche che intervengono sugli inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina.
A cura di Carola Benelli e Zeno Regazzoni