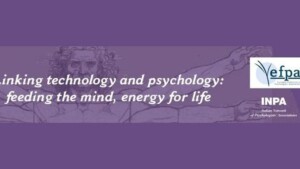Autolesionismo: un fenomeno allarmante che diventa sempre più diffuso tra gli adolescenti ed i giovani adulti, seppur venga spesso sottovalutato. L’autolesionismo comprende una categoria di comportamenti complessa ed eterogenea.
Scritto da: Maddalena Malanchini, Simona Frassica, OPEN SCHOOL DI STUDI COGNITIVI
Autolesionismo nel DSM5
Nel DSM-IV (APA, 2000) i comportamenti autolesionistici sono menzionati come uno dei criteri identificativi del Disturbo Borderline di Personalità (BPD) (criterio 5: ricorrenti minacce, gesti, comportamenti suicidari, o comportamento automutilante). Tuttavia le ricerche hanno dimostrato che tali modalità comportamentali si riscontrano anche in altre categorie diagnostiche (ad esempio nei disturbi d’ansia, depressione, abuso di sostanze, disturbi alimentari, schizofrenia e altri disturbi di personalità); e inoltre, molti degli individui che manifestano ricorrenti atti autolesionistici non soddisfano i criteri per il Disturbo Borderline di Personalità.
Autolesionismo non suicidario
Ecco perché i curatori del DSM-5 (APA, 2013) hanno deciso di inserire nell’ultima edizione del manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali le categorie diagnostiche di “Autolesionismo non suicidario” (NSSI: not suicidal self injury) e “Autolesionismo non suicidario non altrimenti specificato” (NSSI-NAS). Tali disturbi sono stati inseriti nella categoria dei disturbi diagnosticati generalmente per la prima volta nell’infanzia, fanciullezza e adolescenza.
Incidenza e distribuzione dell’autolesionismo nella popolazione
L’autolesionismo, infatti, è molto diffuso tra gli adolescenti e i giovani adulti. L’incidenza di tale fenomeno in queste fasce d’età oscilla tra il 15-20% (Ross et al., 2002) e l’esordio si aggira tra i 13 e i 14 anni (Herpertz, 1995; Nock et al., 2006; Withlock et al. 2006, Ross et al., 2002). Ricerche recenti suggeriscono che pensieri e comportamenti autolesivi si manifestano anche in soggetti più giovani, minori di 14 anni; inoltre hanno riscontrato che i pensieri autolesivi nelle ragazze tra i 13 e i 14 hanno una prevalenza del 22%, e fino al 15% di esse hanno tentato di farsi del male almeno una volta negli ultimi 6 mesi (Stallard et al.,2013). In età adulta, invece, l’incidenza risulta essere del 6% (Briere & Gil, 1998; Klonsky, 2011). Sia in adolescenza sia in età adulta l’incidenza dell’autolesionismo è più elevata tra la popolazione psichiatrica, in particolare tra i soggetti affetti da disturbi dell’umore e/o disturbi d’ansia e nelle persone caratterizzate da alti livelli di disregolazione emotiva (Klonsky, 2003; Andover et al., 2005). Inoltre l’ autolesionismo in adolescenza è associato con depressione, stress, ansia, disturbi della condotta e abuso di sostanze (Nock et al., 2006), e con relazioni familiari disfunzionali, isolamento sociale e basso rendimento scolastico (Fliege et al., 2009).
Forme di autolesionismo e classificazione
In letteratura, il termine maggiormente utilizzato per far riferimento a comportamenti autolesivi è “Deliberate Self Harm” (DSH, tradotto come “auto-danneggiamento intenzionale”), il quale comprenderebbe le condotte identificate come “Self Harm”, “Self poisoning”, “Self injury”. Nello specifico, il termine Self Harm (Auto-danno) si riferisce a condotte a rischio come l’abuso di sostanze psicoattive, la sessualità promiscua e il gioco d’azzardo; i comportamenti di Self Poisoning (Auto-avvelenamento) consistono in azioni quali l’ingestione di sostanze tossiche e l’overdose di droghe; le condotte autolesive denominate Self Injury (Auto-ferita) racchiudono fenomeni immediati e intenzionali come il tagliarsi o il bruciarsi.
Il danneggiamento del proprio corpo attraverso lesioni autoinflitte dirette ed intenzionali viene chiamato quindi Self Injury oppure self injurious behavior (autolesionismo) ovvero comportamento di auto-ferimento. Il riconoscimento dell’autolesionismo come disturbo specifico (NSSI: not suicidal self injury) nel DSM-5 ha fatto sì che l’autolesionismo venisse compreso all’interno di esso.
Una delle prime classificazioni riguardo l’ autolesionismo è stata proposta da A. Favazza e R. Rosenthal nel 1990, che distinguono i comportamenti autolesivi a seconda del grado di danneggiamento dei tessuti e del pattern comportamentale.
Gli autori sottolineano la presenza di tre principali tipologie (Favazza & Rosenthal, 1993):
A) Autolesionismo maggiore consiste in atti infrequenti e isolati che provocano un danneggiamento dei tessuti grave e permanente; solitamente è associato alle psicosi o alle intossicazioni acute e include atti quali la castrazione e l’enucleazione oculare.
B) Autolesionismo stereotipico comprende comportamenti ripetuti in modo costante e ritmico, che sembrano essere privi di un significato simbolico, comunemente associati a grave ritardo mentale, all’autismo o alla sindrome di Tourette; ne sono esempi il mordersi o dare colpi con la testa.
C) Autolesionismo moderato/superficiale consiste in atti episodici o ripetuti a bassa letalità che comportano un lieve danneggiamento dei tessuti corporei (tagli, bruciature, abrasioni); il soggetto utilizza strumenti esterni come rasoi, lamette, forbicine; i gesti assumono solitamente un significato simbolico, in genere relazionale. Si tratta della distruzione o alterazione dei tessuti corporei senza intenzione cosciente di suicidio.
Questa tipologia si suddivide ulteriormente in tre sottocategorie (Favazza & Simeon, 1995):
– Autolesionismo moderato compulsivo: include comportamenti ripetuti o ritualistici che accadono molte volte quotidianamente (ad esempio tirarsi i capelli – tricotillomania – , mangiare le unghie – onicofagia – , graffiarsi); è classificato solitamente come disturbo del controllo degli impulsi (per esempio la tricotillomania).
– Autolesionismo moderato episodico: il soggetto, attraverso il tagliarsi, bruciarsi, colpirsi, cerca di trovare sollievo da pensieri o emozioni intollerabili che è incapace di gestire, riacquistando rapidamente un senso di controllo e padronanza; si ritrova all’interno di sindromi psichiatriche quali i disturbi dell’umore, i disturbi dissociativi, i disturbi d’ansia e i disturbi di personalità.
– Autolesionismo moderato ripetitivo (o ripetuto): il soggetto si descrive come dipendente dal comportamento autolesivo, fino a farne un criterio costitutivo della propria identità (ad esempio definendosi un “cutter”).
Cause dell’autolesionismo
Autolesionismo come strategia di coping e regolazione emotiva
Nella review effettuata da Klonsky (2007) vengono esaminate le principali teorie che spiegano le ragioni per le quali le persone ricorrono all’autolesionismo. La prima, ed anche la più condivisa dai ricercatori, è quella della regolazione del distress e dell’ansia: quando le emozioni negative diventano intollerabili, entra in gioco il ferirsi come tecnica di riduzione della tensione. Un modello proposto da Chapman e collaboratori pone al centro l’idea che i gesti autolesivi vengano reiterati per cercare di estinguere “stati psicologici” indesiderati (Chapman et al., 2006). Anche Kamphuis e collaboratori hanno ipotizzato che l’autolesionismo sia una strategia disadattiva di gestione delle emozioni, in quanto gli individui frequentemente affermano di attuarlo per regolare gli stati affettivi avversi (Kamphuis et al., 2007).
Si potrebbe dire che la messa in atto di comportamenti autolesivi sia un tramutare in sofferenza fisica (quindi più reale e più facilmente gestibile) una sofferenza emozionale che non si sa come gestire: per un po’ ci si occupa solo del dolore fisico, distogliendosi temporaneamente da quello interiore. L’infliggersi dolore e la vista del proprio sangue consentono di avere un prova tangibile che la propria sofferenza è reale, che c’è qualcosa di concreto e visibile per cui provare dolore.
In questo senso, l’autolesionismo sembra assumere la valenza di una strategia disadattava di coping (nozione proposta da Favazza, 1998). Le strategie di coping sono strategie con le quali le persone affrontano le situazioni potenzialmente stressanti. In modo più sistematico, il coping viene definito come l’insieme degli sforzi cognitivi, affettivi e comportamentali di un individuo, attuati per controllare specifiche richieste interne e/o esterne che vengono valutate come eccedenti le risorse della persona (Lazarus, 1991).
Il coping è il risultato dell’interazione tra la persona, la situazione e soprattutto la percezione personale di ogni situazione problematica. Da uno studio recente riguardo le strategie di coping è emerso che tra i tre fattori identificati (coping sociale e attivo, ricerca di soluzioni esterne, coping non-produttivo), soltanto il coping sociale e attivo correla in modo significativo con assenza di comportamenti autolesionistici. Gli elementi che costituiscono tale strategia di coping (lavorare con successo e provare un senso di realizzazione, insieme a una rete di amicizie positive e a diversivi positivi come l’attività fisica) aiutano a limitare il senso di bisogno dei giovani di superare le difficoltà attraverso i tagli (Hall & Place, 2010).
Autolesionismo come punizione autoinflitta
La seconda funzione, riferita da più della metà dei soggetti intervistati, è quella che vede attuare queste condotte al fine di auto-punirsi o come forma di rabbia autodiretta (Nock et al., 2008; Hooley & St Germain, 2013), suggerendo che tra autocriticismo e autolesionismo ci sia una relazione causale.
Autolesionismo come comunicazione di un disagio
Una terza funzione, anche se meno frequente, è quella del mostrare agli altri, attraverso delle evidenze fisiche, la propria sofferenza interiore (Klonsky, 2007).
Autolesionismo nelle pratiche culturali e simboliche
Una menzione particolare meritano alcune pratiche considerate culturali: tatuaggi, piercing e alcuni riti spirituali o di altro tipo. Ad esclusione dei rituali, le altre pratiche non sottendono un significato profondo: i tatuaggi e i piercing, piuttosto diffusi attualmente nella società occidentale, secondo Favazza (1998), vengono attuati nella stragrande maggioranza dei casi per apparire attraenti, per attirare l’attenzione e per essere provocanti. Nonostante non abbia compiuto uno studio formale con un gruppo di soggetti, la sua impressione è che le persone che hanno tatuaggi elaborati e piercing (non i semplici orecchini) mostrino maggiori livelli di psicopatologia rispetto a un ipotetico gruppo di controllo. Ad ogni modo, la presenza di una psicopatologia non può certo essere inferita soltanto dal fatto che il soggetto ingaggi tali pratiche (Favazza, 1998).
Una ricerca recente effettuata su soggetti con “body modifications” (BMs – tatuaggi e piercing) ha evidenziato che il 27% dei partecipanti ha avuto episodi di autolesionismo durante l’infanzia. I dati suggeriscono che le BMs sono identificabili come comportamenti che vanno dalla semplice imitazione del gruppo dei pari fino all’essere sintomi della presenza di gravi condizioni psicopatologiche (Stirn & Hinz, 2008).
Autolesionismo vs tentato suicidio
Parlando di autolesionismo e, più in generale di condotte autolesive, non si possono tralasciare alcune considerazioni sul tentato suicidio. I comportamenti suicidari sono considerati forme di autolesionismo che si collocano ai margini estremi del continuum delle condotte autolesive, sebbene differiscano dall’autolesionismo per diverse ragioni. Infatti le condotte di auto-ferimento, oltre ad essere più frequenti, prevedono al loro interno diversi possibili comportamenti (ad esempio il tagliarsi, il bruciarsi, etc.) con conseguenze fisiche meno gravi rispetto a quelle utilizzate nei tentativi di suicidio (Muehlenkamp, 2005, 2012; Andover & Gibb, 2010). Inoltre, le persone che attuano condotte autolesive non intendono porre fine alla loro vita (Klonsky, 2007; Favazza, 1998) ed è proprio per questa ragione che nel DSM-5 si è deciso di considerare il NSSI come un disturbo a sé stante.
Gli studi effettuati su questi temi sottolineano come le condotte autolesive siano da considerare dei fattori di rischio per il suicidio. Klonsky e collaboratori (2013) hanno osservato che i comportamenti autolesivi sono maggiormente correlati a storie di tentati suicidi più di qualsiasi altro fattore di rischio per il suicidio (ad esempio depressione, ansia, impulsività e BPD). Inoltre ci sono numerosi studi longitudinali che hanno evidenziato che le condotte autolesive sono un fattore predittivo di suicidio più forte di una serie di pregressi tentati suicidi (Asarnow et al., 2011; Guan et al., 2012; Wilkinson et al., 2011).
La teorizzazione del suicidio elaborata da Joiner (2005) sembra fornire una spiegazione convincente su questa relazione. Secondo Joiner al fine di attuare un tentativo di suicidio potenzialmente letale le persone devono possedere sia il desiderio di uccidersi sia la capacità di attuare delle condotte al fine di concretizzare tale desiderio. In genere le persone hanno paura ed evitano il dolore fisico, soprattutto quello che conduce alla morte. Quindi acquisire la capacità di uccidersi implica il superare la paura del dolore connesso alle azioni concrete utilizzate per riuscirci.
Alla luce di quanto fino ad ora esaminato, i comportamenti autolesionistici possono rappresentare un fattore di rischio per il suicidio perché essendo fortemente associati con il distress emotivo e relazionale, i quali a loro volta aumentano il rischio di sviluppare un’ideazione suicidaria, con il passare del tempo desensibilizzano le persone dal dolore fisico e per questo aumentano la capacità di attuare un agito suicidario.
LEGGI ANCHE: Comportamenti autolesivi: strategie per sopravvivere
Le credenze errate sull’autolesionismo e teorie del passato
Nel corso degli ultimi dieci/quindici anni i ricercatori hanno dissipato alcune delle credenze errate rispetto all’autolesionismo e più in generale sulle condotte autolesive. Una di queste l’abbiamo enunciata all’inizio di questo lavoro ed è quella che ha condotto gli estensori dell’APA a riconoscere un’autonomia diagnostica ai comportamenti autolesivi, istituendo la categoria diagnostica dell’autolesionismo non suicidario, non considerandoli più esclusivamente come uno dei criteri diagnostici del disturbo Borderline di personalità.
Un’altra credenza errata rispetto ai comportamenti autolesivi riguarda la loro eziologia. In passato molti studiosi li consideravano il risultato o anche una riattualizzazione di pregresse esperienze di abuso sessuale in età infantile. I dati di recenti meta-analisi, invece, hanno dimostrato che tra i due fattori esistono modeste se non trascurabili associazioni (Klonsky, 2008).
Infine, un’ultima credenza errata è quella che riguarda la principale motivazione alla base delle condotte di autolesionismo. Si riteneva che questa fosse associata al desiderio di attirare l’attenzione ed elicitare delle reazioni da parte degli altri: studi condotti da diversi ricercatori, che hanno visto l’utilizzo di differenti metodologie di ricerca e l’analisi di numerosi campioni di soggetti, hanno dimostrato, invece, che i comportamenti autolesivi sono da considerarsi una strategia, prevalentemente “privata”, di rapido sollievo da intense emozioni negative (Nock, 2004; Klonsky, 2007, 2008; Chapman et al. 2006).
Autolesionismo e disregolazione emotiva
A tal proposito Andover & Morris (2014) hanno condotto una review riguardo al ruolo della disregolazione emotiva nell’ autolesionismo non suicidario, partendo da tre evidenze presenti in letteratura:
1) l’autolesionismo non suicidario è comunemente messo in atto come strategia per regolare le emozioni, poiché comporta un’attenuazione dell’esperienza emotiva negativa;
2) le persone che compiono gesti autolesivi spesso riportano alti livelli di disregolazione emotiva rispetto a coloro che non hanno una storia di comportamenti autolesivi;
3) gli interventi terapeutici che hanno dimostrato efficacia nel ridurre l’autolesionismo non suicidario si focalizzano, con training specifici, sullo sviluppo di abilità di regolazione delle emozioni.
In particolare, sembra che mettere in atto condotte autolesive riduca l’intensità dei vissuti negativi (comportando ad esempio una riduzione soggettiva della tensione, della paura, della tristezza), ma produca anche emozioni positive e che ciò sia uno dei fattori cruciali per mantenere nel tempo l’autolesionismo non suicidario (Andover & Morris, 2014).
Il modello comportamentale dell’autolesionismo
Un primo modello interessante è il modello comportamentale, empiricamente supportato, proposto da Noch e Prinstein, secondo cui la condotta autolesiva è mantenuta sia da rinforzi automatici (intrapersonali) sia da rinforzi sociali (interpersonali); i rinforzi automatici sono però maggiormente riferiti dai soggetti. Il concetto di rinforzo automatico è in linea con la funzione di regolazione emotiva, infatti l’autolesionismo non suicidario è tipicamente utilizzato per ridurre le emozioni indesiderate o per produrre emozioni desiderate (Nock & Prinstein, 2004).
Il profilo psicofiosiologico nell’autolesionismo
Anche ricerche di psicofisiologia supportano l’ipotesi secondo cui l’autolesionismo eserciti la funzione di regolare le emozioni, in quanto hanno riscontrato una diminuzione dell’arousal durante e dopo la descrizione di comportamenti autolesivi. Studi di laboratorio suggeriscono che il dolore fisico sia una caratteristica importante nella regolazione emotiva dell’autolesionismo: è stato dimostrato infatti un decremento nei vissuti emotivi negativi dopo esser stati sottoposti a uno stimolo doloroso e un aumento dei vissuti positivi. Il ruolo del dolore fisico nella regolazione emotiva può essere più accentuato per alcuni soggetti autolesionisti, come coloro che riportano nessun dolore durante tali condotte o coloro con una bassa percezione soggettiva del dolore.
Nel complesso le ricerche sulla funzione di regolazione emotiva dell’autolesionismo suggeriscono che tale comportamento sia fisiologicamente e psicologicamente mantenuto in quanto efficace, anche se maladattiva, strategia di regolazione emotiva (Andover & Morris, 2014).
Marsha Linehan: le ricerche su autolesionismo e disregolazione emotiva nel disturbo borderline
La maggior parte delle ricerche sul concetto di disregolazione emotiva e sulla sua implicazione nelle condotte autolesive non suicidarie è stata guidata dalla teoria di Marsha Linehan sulla disregolazione emotiva nel BPD, la quale ipotizza sia una vulnerabilità emotiva di base della persona sia dei deficit nelle abilità di regolazione delle emozioni (Linehan, 2011). Per vulnerabilità emotiva l’autrice intende che i soggetti affetti dal disturbo esperiscono le emozioni in modo più intenso, sono più suscettibili agli stimoli emotigeni positivi e negativi, e ritornano più lentamente a uno stato affettivo di base.
In secondo luogo, le persone con BPD hanno difficoltà nel gestire alti livelli di attivazione emotiva poiché sono carenti nelle abilità di regolazione delle emozioni; la regolazione emotiva richiede infatti due capacità: l’abilità di sentire ed etichettare le emozioni provate e l’abilità di ridurre gli stimoli emotivamente rilevanti, che potrebbero causare la riattivazione di emozioni negative/positive oppure risposte emotive secondarie. Tale modello, anche se ipotizzato per il Disturbo Borderline, è stato cruciale per la comprensione della disregolazione emotiva presente nell’autolesionismo (Andover & Morris, 2014).
Autolesionismo negli adolescenti: la funzione di regolazione cognitiva
Inoltre alcune ricerche suggeriscono che l’autolesionismo non suicidario svolga una funzione di regolazione cognitiva oltre che una funzione di regolazione emotiva, poiché hanno identificato un’associazione tra i comportamenti autolesivi come strategia di modulazione della risposta e il processo di attribuzione. (Andover & Morris, 2014). In particolare, gli adolescenti che compiono gesti autolesivi riportano che tale comportamento li distrae da pensieri non desiderati (Nock et al., 2009).
LEGGI ANCHE: AUTOLESIONISMO E ADOLESCENZA: NON POTEVO FARCI NULLA
I trattamenti per l’autolesionismo
Concludendo, gli ultimi quindici anni hanno visto un massiccio avanzamento nella comprensione dei comportamenti autolesivi (Klonsky et al., 2014). Ora sono maggiormente delineate le loro caratteristiche descrittive, i correlati psicosociali e le funzioni da essi svolte. Klonsky suggerisce che ora bisogna utilizzare tali conoscenze per sviluppare delle teorie esplicative empiriche di questi fenomeni e delineare degli interventi ad hoc, finalizzati a venire incontro alle necessità delle persone che incorrono in condotte autolesive. Ovviamente questi due obiettivi risultano fortemente interdipendenti tra loro: le teorie basate su dati empirici permettono lo sviluppo di modelli di intervento sempre più efficaci e questi, a loro volta, permettono una revisione e un potenziamento delle teorie che li hanno prodotti.
Infine nel lavoro di Turner e collaboratori (2014) viene effettuata una revisione sistematica della letteratura sui trattamenti per i comportamenti autolesivi, mostrando come spesso essi non siano davvero specifici per queste condotte, ma siano degli adattamenti di trattamenti creati per condizioni correlate come il BPD o le tendenze suicide. Diverse tipologie di intervento, tra cui la Dialectical Behavior Therapy – DBT, la terapia di gruppo sulla regolazione delle emozioni, la psicoterapia dinamica decostruttiva, l’utilizzo di psicofarmaci (Aripiprazolo, Naltrexone, SSRI associati o meno alla terapia cognitivo-comportamentale) sembrano essere efficaci nel riuscire a ridurre le condotte autolesive.
Ciononostante esistono pochi studi controllati che indagano in maniera specifica la loro efficacia nel trattamento dell’autolesionismo. Gli approcci di psicoterapia strutturati e focalizzati in maniera specifica sui comportamenti di auto-ferimento, sulla collaborazione all’interno della relazione terapeutica e sulla motivazione al cambiamento sembrano essere quelli maggiormente efficaci nella riduzione di tali condotte. I farmaci che agiscono sui sistemi dopaminergici, serotoninergici e oppioidi producono effetti positivi. In futuro studi controllati, focalizzati in maniera specifica sui comportamenti autolesivi, permetteranno di delineare dei trattamenti sempre più efficaci.