COGSCI 2013 Report dal Congresso della Cognitive Science Society. Di Bruno Bara
Dal 31 luglio al 3 agosto 2013 si è svolto a Berlino il 35esimo congresso della Cognitive Science Society, una delle principali società scientifiche della scienza cognitiva. Pubblichiamo con piacere le istruttive e divertenti mail del prof. Bruno Bara, che ha partecipato al congresso.
COGSCI 2013
Cronache dal Congresso della Cognitive Science Society
(31 luglio – 3 agosto 2013)
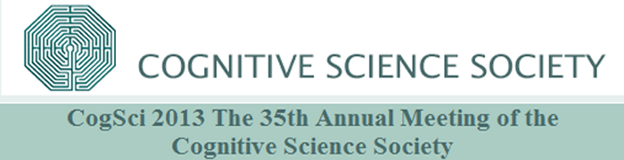
REPORTAGES DAI CONGRESSI – SCIENZE COGNITIVE
1 agosto 2013
Eccomi a Berlino per il megaconvegno di Cognitive Science, 1.300 partecipanti, battuti tutti i record precedenti. Tradizionalmente i convegni in Europa sono il meglio. Mentre negli USA ci vanno solo post-doc vestiti da surfisti californiani, qui sono presenti gli scienziati di punta, i direttori di laboratorio assieme alle promesse future. Tutti carini, gentili ed eleganti, niente braghette corte e molti vestitucci in fiore.
Inizia John Duncan, del Medical Research Council di Cambridge. Per me è un ritorno a casa: ci sono stato per mesi e mesi quando lavoravo con Johnson-Laird. Duncan ha vinto il premio Heineken 2013, il Nobel della scienza cognitiva, e ascoltandolo si capisce perché. Parla del MD, il Multiple Demand System, un sistema neurale distribuito che spiega l’intelligenza fluida, splendido nome per indicare la nostra capacità di risolvere problemi difficili o in sequenze complesse.
Quando la complessità della situazione aumenta, perdiamo le componenti cognitive più vulnerabili, oppure se la richiesta attentiva diventa troppo forte, dimentichiamo alcune porzioni di informazione. La mente chiara, la clear mind, è secondo lui quella capace di rivolgere l’attenzione alle sottoparti utili, trascurando le parti non significative, e spiega come riesce il cervello a realizzare questo.
Segue un delizioso simposio su “Evoluzione di Linguaggio e Gesti”, tutto il meglio dei primatologi sulla piazza, gente che ha passato minimo 5 anni nelle foreste pluviali: Call, Liebal, Hobaiter, Tomasello, con l’aggiunta di Susan Goldin-Meadow, la grande esperta di sordi.
Su una cosa concordano tutti: gorilla e scimpanzé sono straordinari, ma l’uomo è un’altra cosa. I video di baby chimp che per giocare svegliano la madre addormentata e di gorillone seduttive che fingendo di negarsi provocano sessualmente il maschio tonto sono irresistibili, difficile non riconoscervi figli e fidanzate. La tentazione antropomorfa colpisce senza pietà. Conclusione: non è il linguaggio la strada per l’evoluzione della comunicazione, ma la capacità di condividere, cosa che manca ai nostri competitivi cugini.
A pranzo ci sono 210 poster da guardare, e ogni giorno ce ne saranno altri 200 nuovi, vi racconto il top.
Monica Bucciarelli coi suoi collaboratori ne presenta uno innovativo sulla versione scritta del linguaggio dei segni, nessuno ci aveva pensato prima: lavoro intelligente e utile socialmente.
Amory Danek, una studiosa che nega l’esistenza dello insight nei problemi di insight, sostiene sulla base di ingegnosa evidenza sperimentale che l’esperienza di insight si riferisce solo al solutore e al suo atteggiamento mentale, mentre non sta nel problema e tantomeno nella sua soluzione. È molto incinta e la bacerei, ancora una volta tutto sta nella nostra mente e non nel mondo esterno.
Il mio favorito è Justin Matthews, che fa vedere immagini inquietanti di ponti sospesi e ti fa stimare quanto sono lunghi, immaginando di essere soli, o con qualcuno, o con un amico che ti aspetta all’altro capo del ponte. In inglese suona meglio, perché il close friend, l’amico stretto, ti fa percepire il ponte più close, più breve. Vicinanza affettiva e spaziale si mescolano, una gioia per noi terapeuti incarnati.
Berlino è esattamente come la immaginate: facile, libera, giovane, rispettosa. Tutto è concesso, basta non dare fastidio. Uso come misura le coppie gay, con figli e senza, che affollano le ordinate strade piene di locali all’aperto dove puoi mangiare, bere e fare qualunque cosa desideri.
Il ricevimento a inviti è una delusione, una sorta di aperitivo leggero per tedeschi chic, clamorosamente insoddisfacente, si salutano i colleghi e si va via. A cena con Monica debuttiamo in una grande birreria con il tradizionale maiale in ogni sua forma, ma poi lasciamo quasi tutto, troppo impegnativo se il giorno dopo tocca lavorare. Ma è un rito dovuto, da domani si cercano ristoranti migliori.
Non fa troppo caldo, il riposo è il benvenuto.
2 agosto 2013
Il secondo giorno inizia con Michael Bratman, che in plenaria parla di condivisione. Ha una posizione controcorrente, di sfida a Searle e Gilbert, sostiene che non ci sono stati mentali primitivi collettivi, ma che tutto è riducibile a stati individuali. Dopo 30 anni che seguo Searle, sia in Italia sia a Berkeley, proprio non ce la faccio a mandare tutto all’aria.
Il punto critico sono i bambini: se ha ragione Bratman, come fanno a condividere tutto ben prima che la potenza cerebrale li metta in grado di gestire stati mentali complessi? Domanda fatta, e la candida risposta è stata che non ne ha la minima idea. Vabbé che i filosofi giocano in libertà, ma proprio trascurare ogni evidenza sperimentale!
Dopo un ansiogeno coffee break, i miei valorosi dottorandi Francesca Capozzi e Tiziano Furlanetto mi accompagnano nella Room 1, dove si tiene il simposio sulle intenzioni comunicative nella mente e nel cervello.
La sequenza è Michael Tomasello su bambini e scimpanzé, Nick Chater su scelte economiche, Rosemary Varley sulle intenzioni negli afasici, e ultimo io sul circuito neurale della intenzionalità. Teniamo mezz’ora per la discussione finale, sala piena, dibattito vero, domande cattive e risposte perfide. A sorpresa ci troviamo d’accordo su una serie di punti critici tipo l’interazione fra gesti e linguaggio, e le domanda dedicate a me sono una delizia, so miracolosamente cosa rispondere. Ci divertiamo, Wayne Gray (editor di Topics) vorrebbe ne facessimo un numero speciale di Topics on Cognitive Science, a tutti piace l’idea ma nessuno si prende l’onere di proporsi come special editor, peccato.
Dovrei essere più nonchalant? E quando mi capita più di essere con cotanti scienziati, a Berlino, di fronte a qualche centinaio di miei colleghi europei?
Fra i 200 poster del giorno vi segnalo quello sull’impegno congiunto studiato attraverso le emozioni e il comportamento extralinguistico, presentato da Francesca Morganti, con fra gli autori nientemeno che Antonella Carassa e Giorgio Rezzonico!
Mi colpisce più di tutti Josh Hemmerich, che studia conoscenza e soddisfazione nei pazienti che devono prendere una decisione su come trattare il proprio cancro ai polmoni. La maggioranza vuole avere voce in capitolo, mentre il 20% più anziano preferisce affidarsi totalmente al chirurgo. Non indaga le differenze individuali, ma qualcosa che serve davvero fa piacere ascoltarlo.
Andiamo a cena nel più antico ristorante di Berlino, dove troviamo miracolosamente posto, e ci godiamo ottimi birroni e polpettone. Ancora un mojito prima di andare a dormire, e una giornata che non dimenticherò termina in gloria.
3 agosto 2013
Terza giornata di questa maratona ricca e impegnativa. La plenaria del mattino è affidata a Elizabeth Spelke, uno spettacolo di bravura e intelligenza. È famosa per i suoi studi sulla matematica e la geometria nei bambini, si è spostata sulla cognizione sociale confermando le sue doti di scienziata aperta e capace di rinnovarsi.
Mostra le meraviglie che i bambini di 3 mesi sono già in grado di fare in termini di azioni efficaci, e sostiene che a 4 mesi iniziano a comportarsi da agenti sociali, a patto che si stabilisca con loro un contatto oculare: ciò che ogni genitore sa, vale a dire che suo figlio è un genio, viene confermato sperimentalmente.
A 8 mesi si accorgono delle somiglianze sociali, amano imitare ed essere imitati (questo dura tutta la vita per molti), pian piano diventano più selettivi sulle persone con cui interagire, in quanto comprendono come le azioni abbiano effetto sulle relazioni sociali.
Si chiede cosa rende gli umani così intelligenti, e cosa permette la rivoluzione del primo anno, in concomitanza coll’insorgere del linguaggio. Secondo lei il vantaggio umano sta nelle nostre capacità cognitive sociali, perché molte altre abilità non sociali si trovano anche in altri animali.
Il dibattito se sia il linguaggio o la cognizione a determinare la svolta del primo anno attraversa il congresso. L’idea della cognizione sociale è la più convincente a mio interessato parere. E non vi venga in mente di dire che tutto importa, linguaggio, cognizione e cognizione sociale, perché fareste la figura di un cerchiobottista.
Spelke conclude che se siamo così intelligenti socialmente non si capisce come mai usiamo tanto male le nostre capacità sociali, riducendoci sull’orlo della catastrofe planetaria a ogni crisi. In effetti non è facile nemmeno capire la questione, forse riflettere seriamente sulle patologie della cognizione sociale dovrebbe diventare primario per gli scienziati.
Salto ancora una volta il pranzo, che mi dicono peraltro modesto, perché presento un poster con Rosalba Morese primo nome, Daniela Rabellino, Angela Ciaramidaro e Francesca Bosco, sulla punizione altruistica. Me lo sistema alla perfezione l’ottima Francesca Capozzi, un po’ perché i miei dottorandi sono gentili, un po’ perché non si fidano di me.
È un eccellente lavoro in risonanza magnetica sul fatto che siamo disposti a investire risorse per punire chi non si comporta correttamente, in particolare se lo scorretto è uno del nostro gruppo e tratta male uno del nostro stesso gruppo. Parecchie domande, critiche tecniche cui non so rispondere, me la cavo meglio sulle questioni teoriche.
In tema vi cito un elegantissimo poster di Giulia Andrighetto, Francesca Giardini e Rosaria Conte del CNR di Roma, tutto teorico sulla differenza fra vendetta e punizione, e uno divertente di Maryam Tabatabaeian sulla disonestà come tendenza umana automatica. I temi morali contano, cominciamo ad affrontarli finalmente.
Vado infine a un simposio sulla cooperazione, il meglio è Valentina Cardella che parla delle società animali e umane. Molto speculativa, lei punta sul linguaggio come strumento tecnico di differenziazione umana, ma in un convegno molto attento all’evoluzionismo risulta non del tutto convincente, il linguaggio cui si riferisce lei è quello evoluto di homo sapiens, come la mettiamo col paio di milioni di anni precedenti? Comunque è giovane e competente, dibatte con precisione. Ne sentiremo parlare se non la comprano all’estero come stanno facendo con tutti i dottorandi italiani di qualità.
Incontro Herbert Clark alla stessa sessione, il primo a impostare il tema della conoscenza di background nella comunicazione, gentile come sempre e come sempre capace di critiche affilate. Ci troviamo a ogni congresso, e siamo stati spesso insieme nei simposi, il nostro microcosmo è davvero micro.
Basta, neppure gli organizzatori vanno alla cerimonia finale, troppo caldo e troppi eventi. Tutti esausti, andiamo a vedere Nefertiti, per controllare se è davvero straordinaria come dicono.
Lo è, lo è, questa affascinante principessa nera merita ogni ammirazione, un prototipo di bellezza difficile, non banale, non sexy ma seducente da tremila anni. A cena ora, statemi bene e riflettete sul fatto che è stato un ebreo a donare alla città di Berlino la sua opera d’arte più famosa.
Bruno Bara.
LEGGI ANCHE:
REPORTAGES DAI CONGRESSI
SCIENZE COGNITIVE
LINGUAGGIO E COMUNICAZIONE
BAMBINI
MONDO ANIMALE
ETICA E MORALE
SITO UFFICIALE DEL CONGRESSO COGSCI 2013

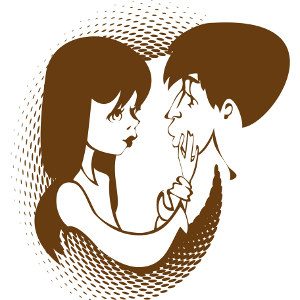






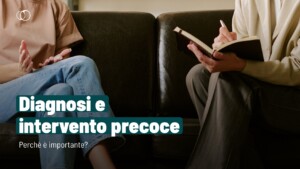


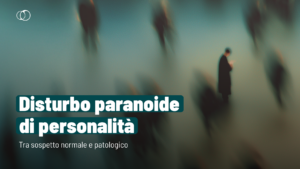




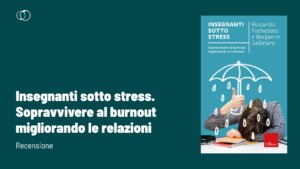


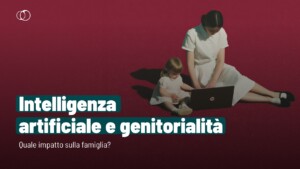



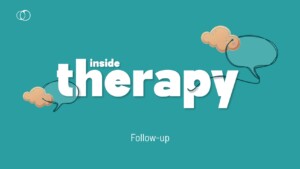



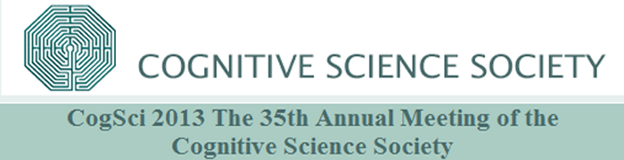
 L’adolescenza si configura come una fase della vita complessa, sfaccettata, eterogenea, caratterizzata da importanti cambiamenti e acquisizioni cognitive, affettive e socio-relazionali.
L’adolescenza si configura come una fase della vita complessa, sfaccettata, eterogenea, caratterizzata da importanti cambiamenti e acquisizioni cognitive, affettive e socio-relazionali.


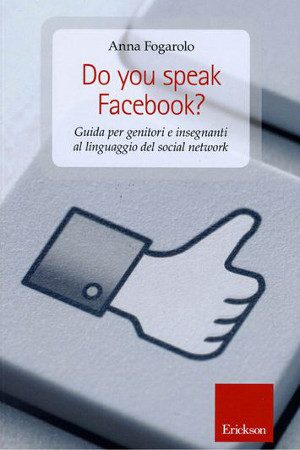 La maggior parte di noi ha dimestichezza con tutto quello che offre la Rete, sia in termini di fruizione di informazioni che in termini di “social”, macro categoria che racchiude tutti gli strumenti a disposizione del web che ci consentono di comunicare, interagire e gestire degli scambi sociali.
La maggior parte di noi ha dimestichezza con tutto quello che offre la Rete, sia in termini di fruizione di informazioni che in termini di “social”, macro categoria che racchiude tutti gli strumenti a disposizione del web che ci consentono di comunicare, interagire e gestire degli scambi sociali.
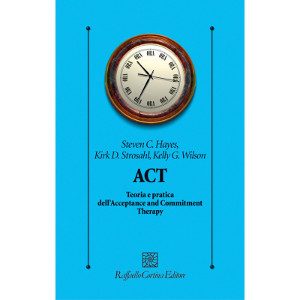
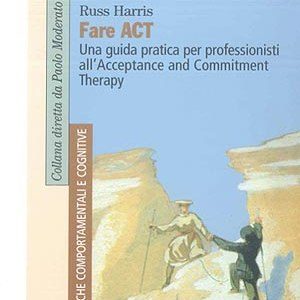

 Roger Barrett (1946-2006), soprannominato Syd dai tempi degli scout, è stato tra i fondatori della band britannica progressive rock Pink Floyd, considerata tra le principali esponenti della psichedelia. La sua militanza attiva nel gruppo è durata solo tre anni, dal 1965 al 1968, quando manifestò una grave forma di disagio psichico che lo costrinse a lasciare le scene e a trascorrere il resto della vita in modo ritirato.
Roger Barrett (1946-2006), soprannominato Syd dai tempi degli scout, è stato tra i fondatori della band britannica progressive rock Pink Floyd, considerata tra le principali esponenti della psichedelia. La sua militanza attiva nel gruppo è durata solo tre anni, dal 1965 al 1968, quando manifestò una grave forma di disagio psichico che lo costrinse a lasciare le scene e a trascorrere il resto della vita in modo ritirato.
 Praticare la mindfulness a scuola sembra ridurre i sintomi depressivi, lo stress e migliorare il benessere negli adolescenti.
Praticare la mindfulness a scuola sembra ridurre i sintomi depressivi, lo stress e migliorare il benessere negli adolescenti. 
 “Agire” per il leader vuol dire innanzitutto “prendere decisioni” e “decidere” significa: “selezionare un’alternativa fra più opportunità, allo scopo di raggiungere l’obiettivo desiderato” [Cei, 1998].
“Agire” per il leader vuol dire innanzitutto “prendere decisioni” e “decidere” significa: “selezionare un’alternativa fra più opportunità, allo scopo di raggiungere l’obiettivo desiderato” [Cei, 1998].
