Visita all’Istituto Albert Ellis di New York: primo giorno
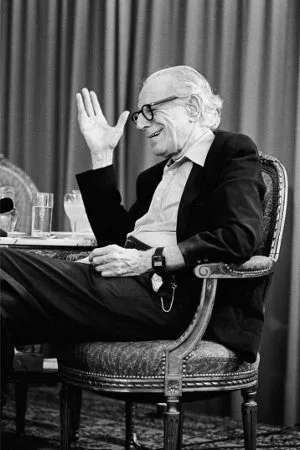
La redazione di State of Mind va in pellegrinaggio in una delle sedi storiche della nascita della terapia cognitiva: l’Istituto Albert Ellis di New York, dove ancora oggi si insegna il modello della terapia razionale emotiva comportamentale (REBT) di Albert Ellis. Cesare de Silvestri (1926-2009) importò in Italia questo modello negli anni ’60 e da allora esso rimane una delle radici storiche della pratica terapeutica cognitiva nel nostro paese. Chi si è formato sulla REBT è particolarmente attento e appassionato alla tecnica, al come si fa terapia cognitiva. Anche per questo, e per bilanciare la grande passione teoretica che ha sempre mostrato il cognitivismo italiano, alcuni di noi hanno deciso di tornare a nutrirsi alla fonte della tecnica di Ellis.
Frequentiamo perciò il “Practicum”, il corso dove si ripercorrono le basi tecniche e teoriche della REBT. Si espone il noto modello dell’ABC. Si conferma che il disputing alla Ellis è focalizzato soprattutto sulle domande “a che ti serve ragionare così?” e “quanto ti conviene davvero ragionare negativamente?”, insomma sull’aspetto pragmatico e tende sempre a sfociare nella critica della convinzione del paziente di non essere in grado di tollerare la frustrazione . Insomma, si conferma quello che sapevamo, e questo è confortante sulla qualità della trasmissione del sapere REBT che si riceve in Italia.
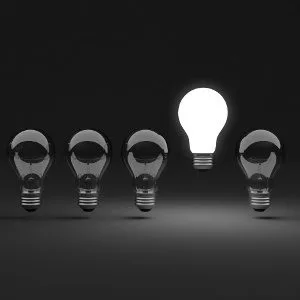
Apprendiamo però alcune sfumature che sono importanti per comprendere lo spirito della “real thing”. Per esempio la centralità di quelle che noi chiamiamo “doverizzazioni” e loro “demand” (e non più “must”; un’innovazione rispetto a Ellis? L’ho chiesto, ma la risposta è stata evasiva). Le doverizzazioni sono quelle convinzioni rigide e inflessibili di tipo valoriale per le quali, se una data situazione o evento non avvengono in una certa modalità, diventano inaccettabili e quindi catastrofiche.
Si insiste molto sulla domanda. “che cosa ha pensato che glielo rende inaccettabile?” Domanda che è più focalizzata sull’aspetto negativo rispetto alla formulazione più aperta “che cosa non ti piace in questo?” di derivazione costruttivista. Le doverizzazioni sono considerate le credenze irrazionali primarie, mentre le altre tre (terribilizzazione, intolleranza della frustrazione e auto-svalutazioni) sono definite derivate.
Si conferma definitivamente un accorgimento tecnico che non sempre è chiaro nei libri REBT: le conseguenze emotive e comportamentali “C” si accertano prima delle credenze, i “B”. Anzi, si può anche partire dal “C”, poi accertare la situazione attivante ”A” e infine arrivare al “B”. Un modello “CAB”.
Un’altra piccola sfumatura è che il B è ridotto alle 4 categorie di pensiero cosiddetto irrazionale (le elenchiamo ancora: doverizzazione, terribilizzazione, intolleranza della frustrazione e auto-svalutazione). Ogni altro pensiero diventa un “A”. Ad esempio, in un’ansia da esame anche il pensiero “ho paura di non passare l’esame” non è un B ma un A. Il B sono “devo assolutamente passarlo” (doverizzazione), “se non lo passo sarà terribile” (terribilizzazione), “se non lo passo non reggerò” (intolleranza alla frustrazione) e “se non lo passo sarò un/a miserabile” (auto-svalutazione).

Questo significa una cosa ben precisa: il terapeuta REBT fa scarsi tentativi di sdrammatizare alla Beck. Quasi per niente (anche se a precisa domanda si sono un po’ calmati e hanno ammesso che si può fare). Per loro si va sempre allo scenario peggiore, lo si “sdoverizza” e poi si apprende che si può tollerarne l’intrinseca frustrazione. La decatastrofizzazione ellisiana non è quindi una sdrammatizzazione dell’esito concreto (insomma, non stanno tanto a chiedere “perché dovrebbero bocciarti?”), ma solo delle doverizzazioni (“perché è così necessario che tu pensi che questi esame vada superato?”).
Si conferma dunque la natura stoica e pessimista della REBT, in contrasto con quella ottimista di Beck. Questo è confermato anche dal largo uso che fanno della tecnica del “worst scenario”. Qual è lo scenario peggiore? E anche se si avverasse, perché lo ritieni così tremendo? E sei sicuro di non poterlo tollerare?
Anche questo si vede poco nei libri ma diventa chiarissimo nella pratica, nelle simulate che fanno. Questa insistenza sullo scenario peggiore e sulla sua accettazione “sdoverizzata” è anche teorizzato: gli ellisiani pensano che, se ci si limitasse a sdrammatizzare alla Beck, il paziente sarà sempre dipendente dal buon o cattivo esito dei suoi desideri e passioni. Occorre invece prepararlo al peggio.
Insomma, la REBT sembra una terapia per uomini duri. Forse esagerano un po’.
Concluso il primo giorno di training, abbiamo assistito a uno dei famosi “Friday Night Live” dell’Istituto Ellis, incontri aperti al pubblico in cui volontari (spesso ex-pazienti, ho intuito) parlano davanti a tutti dei loro problemi e poi sono ristrutturati in tempo reale dal conduttore. Un tempo li conduceva Ellis in persona.
Nel prossimo articolo descriveremo il “Friday Night Live” a cui abbiamo assistito. Rimanete in linea.
BIBLIOGRAFIA:
- Ellis, A., Harper, R. A. (1961-1997). A Guide to Rational Living. New York: Melvin Powers Publisher.
- Walen, S. R., DiGiuseppe, R., Dryden, W. (1980-1992). Practitioner’s Guide to Rational-Emotive Therapy. Oxford: Oxford University Press.

