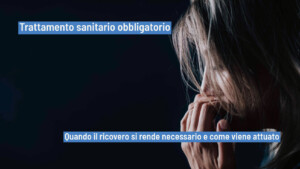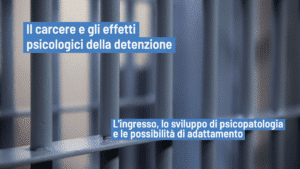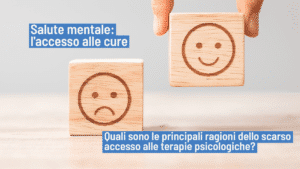L’importanza dell’emisfero destro, la regressione in terapia & la Schema Therapy – Report dal Congresso Attaccamento e trauma 2015
L’intervento di Allan Schore è stato all’insegna di una rivincita dell’impulsivo emisfero destro rispetto all’analitico emisfero sinistro, sostenuta da una dettagliata disanima dei più recenti studi nell’ambito della neurobiologia interpersonale.
LEGGI I REPORT DELLA PRIMA GIORNATA E DELLA SECONDA GIORNATA
Schore definisce l’emisfero destro come la sede di alcune tra le funzioni cognitive umane più raffinate: regolazione dello stress, intersoggettività, umorismo, empatia, compassione, moralità e creatività.
Al centro della competenza clinica e della pratica psicoterapeutica occorre pertanto collocare la capacità di potenziare l’elaborazione nell’emisfero destro, piuttosto che nel sinistro.
L’emisfero destro è sede dei processi creativi, primari, intuitivi, e analogici, che si trovano talvolta al di sotto del livello di coscienza, e considerando che i traumi relazionali precoci vengono impressi nel processo primario non verbale, è fondamentale che in terapia venga anche lasciato spazio a qualche “regressione controllata”, che permetta al materiale inconscio di esprimersi e di evocare preziosi insight.
Per regressione si intende una ripresa del contatto con gli stati precoci del corpo e del sé e con le prime forme di relazioni oggettuali; in terapia, paziente e terapeuta riattualizzano una relazione oggettuale patologica traumatica, una rappresentazione interattiva di un sé disregolato che interagisce con un oggetto non sintonizzato.
Nel paziente, la regressione a uno stato traumatico di arousal emotivo disregolante ha luogo nel cervello destro, poiché implica la riattualizzazione di una memoria implicita e procedurale dell’attaccamento precoce, e implica la comunicazione con l’originale oggetto di attaccamento.
Chiaro che la regressione in terapia deve essere adattiva e reciprocamente controllata, e non replicazione di un fallimento dei meccanismi inibitori corticali superiori, come spesso accade ad esempio ai pazienti con patologia bordeline.
A questo scopo, ci si aspetta che il cervello destro del terapeuta sia fonte di regolazione interattiva degli affetti disregolati del paziente.
A lungo termine e in ottica terapeutica, è importante sviluppare nei pazienti più fragili la capacità di regolare le proprie emozioni in maniera autonoma, implicita e automatica.
Grazie infatti agli enactment finalizzati alla riparazione e alla regolazione, il terapeuta può rafforzare il Sé integrato del paziente, il quale può poi inserire nella propria memoria autobiografica una nuova esperienza personale a cui accedere nelle situazioni pertinenti.
Il sistema di ampliamento della memoria autobiografica nel contesto terapeutico costituisce infatti il fondamento di una migliore competenza interpersonale, intesa come capacità di interagire e comunicare con gli altri, condividere il proprio punto di vista, comprendere le emozioni e opinioni altrui, collaborare con gli altri e risolvere i conflitti.
Eckhard Roediger ha presentato un modello di Schema Therapy interpersonale pensata per il trattamento delle difficoltà di coppia.
Si parte dall’assunto che la chimica degli schemi guida anche la scelta del partner, e che quindi ci ritroviamo spesso a sceglierci compagni che ci ricordano le prime persone significative di riferimento, con il rischio di riattivare nel rapporto adulto vecchi mode disadattavi.
L’intervento di schema therapy può essere effettuato sia con entrambi i partner che in sedute individuali, ma in quest’ultimo caso è comunque indispensabile ottenere l’appoggio del partner assente per il cambiamento, e occorre includerlo anche se solo tramite l’attività immaginativa.
Per la coppia è previsto anche un breve intervento di psicoeducazione su alcune tematiche rilevanti nei casi di difficoltà relazionali, ovvero gli stili di coping dominanti (resa come sottomissione, fuga come evitamento, attacco come dominanza o controllo), le quattro emozioni di base (Paura/Panico, Dolore, Disgusto/Irritazione e Rabbia) e i due sistemi sottostanti (attaccamento e assertività).
Alle coppie vengono inoltre assegnate le cosiddette “flashcards sul ciclo di mode” ossia delle griglie di automonitoraggio che ricordano un po’ gli ABC di matrice cognitivista, poiché i pazienti sono chiamati ad annotare le cause scatenanti degli episodi critici (A) la voce interiore (B) e la modalità di coping messa in atto (C) con in più un riferimento al bisogno di base trascurato e alla soluzione che metterebbe in pratica l’adulto sano.
Compatibile con l’impostazione cognitivista, anche l’assegnazione di una serie di compiti a casa, a metà strada tra la psicoterapia e il buon senso:
– Fermare gli scontri tra mode
– Compilare regolarmente le flashcards sul ciclo dei mode
– Allenare continuamente le abilità comunicative
– Dare feedback positivi al partner, almeno una volta al giorno
– Dedicare un pomeriggio alla coppia ogni settimana
– Prendere appuntamenti per attività congiunte
– Provare una riconnessione fisica
– Trascorrere periodicamente un week end libero da soli
A conclusione della mattinata Stephan Doering ha illustrato i principi fondamentali della psicoterapia focalizzata sul transfert (TFP), approccio che vede nella relazione terapeutica la fonte più ricca di informazioni sul mondo interiore del paziente, in quanto il rapporto e gli affetti che ne emergono (le componenti del transfert e controtransfert) sono immediatamente osservabili e non inquinati dall’intellettualizzazione che può subire l’eventuale materiale storico rievocato in seduta.
In sintesi, il razionale della TFP prevede che:
– Le relazioni oggettuali precoci interiorizzate e scisse si riattivano all’interno della relazione di transfert tra paziente e terapeuta
– Il terapeuta osserva, identifica e dà un nome a questi pattern relazionali
– Si effettua un’interpretazione del transfert, tecnica base della TFP
– Il paziente riconosce le parti scisse del proprio sé, ne fa esperienza affettiva e ciò porta all’integrazione e al superamento della diffusione d’identità
– L’ integrazione dell’identità che ne consegue porta ad un miglioramento del funzionamento della personalità e ad una remissione dei sintomi.
Un approccio dall’impianto quindi fortemente analitico, ma sostenuto da studi clinici randomizzati che ne hanno dimostrato l’efficacia.
ARTICOLI CONSIGLIATI:
BIBLIOGRAFIA:
- Schore A., I disturbi del sé. La disregolazione degli affetti. Astrolabio Ubaldini, 2010
- Simeone-DiFrancesco C., Roediger E., Stevens B., Healing Relationships: Schema Therapy for Couples, Oxford. Wiley-Blackwell, 2014
- Clarkin J.F., Yeomans F.E., Kernberg O.F., Psicoterapia delle personalità borderline, Raffello Cortina Editore, 2000