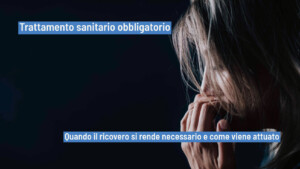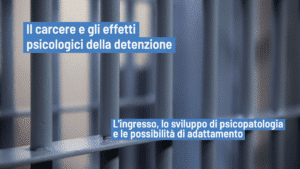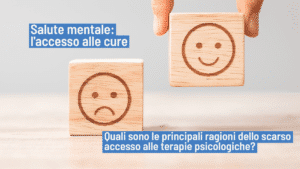La gravidanza vista dall’interno (2014) di Joan Raphael-Leff – Recensione
Valentina Messori, Cecilia Tardini, Grazia Martina – OPEN SCHOOL Studi Cognitivi Modena
L’orientamento che ogni singolo genitore porta nella cura dell’altro riflette l’ultimo capitolo della sua cumulativa storia interiore, continuamente scritta e riscritta in collaborazione con le persone che gli sono vicine.
C’era una volta….un guizzo nell’occhio interno
Al centro dell’interesse dell’autrice c’è l’esperienza del genitore, la madre o il padre come persona intera anziché come oggetto di fantasie o desideri infantili. Perciò il consueto rapporto tra figura e sfondo, presentato dalla letteratura psicoanalitica, viene spesso ribaltato: il punto di vista è quello delle madri e dei padri, che a loro volta sono figlie e figli.
Questo libro è stato scritto viaggiando per cinque continenti, fra lezioni e seminari con madri e padri in attesa e con personale sanitario; osservando dei bambini in casa, discutendo casi clinici con allievi, andando in supervisioni di psicoterapie analitiche, leggendo scritti dei maestri, scambiando ipotesi con colleghi, vivendo personali esperienze di gravidanza.
L’autrice si pone diverse domande: Che significato ha la gravidanza nel mondo interno di una donna o di un uomo?; Qual è l’esperienza emotiva del partner durante la gravidanza?; Come diventiamo quelli che siamo in relazione ai nostri figli e al nostro stesso sé infantile?; In che modo le fantasie prenatali influenzano il clima emotivo postnatale?
Nel primo capitolo, il concepimento viene presentato come l’inizio di una storia bizzarra: già prima di questo momento il bambino sconosciuto è accolto nella realtà psichica della donna in attesa, investito di illusioni e collocato in un posto preciso fra le numerose immagini di figure primarie significative che ne popolano il mondo interno. Quando due adulti iniziano una relazione emotiva, ognuno scarica sull’altro aspetti non risolti del suo patrimonio transgenerazionale di fantasie inconsce. I partner spesso si scelgono per realizzare a vicenda certe potenzialità, e il nascituro diventa parte attiva della loro rappresentazione drammatica. Il neonato incorporerà nell’immagine di sé attributi non abbandonati dai genitori.
L’arrivo del bambino suscita evocativi frammenti di memoria, fa rivivere processi latenti relativi alla prima infanzia dei genitori, che influiscono sulla qualità dell’interazione postnatale. Anche il bimbo investe gli adulti con le sue intense emozioni. I progressi tecnologici ci hanno permesso di osservare il feto vivo nell’utero, che ingerisce ed espelle, mastica, lecca , succhia, sbadiglia. La gravidanza comporta una nuova visione del proprio corpo, non ha più il possesso esclusivo del proprio corpo; la donna è letteralmente posseduta da un altro.
Secondo l’autore la gravidanza può essere divisa in tre fasi. Nella fase iniziale la donna è in gran parte impegnata a fare i conti con le nuove sensazioni corporee, i sintomi, lo squilibrio emotivo, e ad adattarsi alle conseguenze pratiche del suo stato alterato. La seconda comincia con i movimenti del feto, si presenta l’idea che un essere separato sta crescendo dentro. La fase finale inizia quando la mamma comincia a considerare il bambino un organismo vitale,capace di sopravvivere fuori di lei. Come per quello di Pandora, l’apertura del vaso materno è associata al risveglio di passioni dormienti e allo scatenarsi dell’ambivalenza interna.
Nel secondo capitolo vengono affrontati temi come il sogno in gravidanza, sogno che presenta temi fondamentali, che ricorrono in culture diverse. Lei che fù contenuta, ora è il contenitore, lei che era piccola, ora è grande e crea un piccolo essere. I dubbi sulla propria capacità di contenere, alimentare e preservare il piccolo essere, che misteriosamente dovrà trasformarsi in un bambino, si mescolano con la rabbia per il senso di assoluta solitudine; la gestante è sospesa fra un mondo interno ed esterno, a un incrocio di passato, presente e futuro, fra sé e l’altro.
E infine, la gestante intesse fantasie circa la creatura che ha in grembo, che può apparire in molte forme, umane e animali. Risonanze dal passato e figure che abitano il mondo interno sono spesso influenti, nella rappresentazione del bambino immaginario: il bambino può rappresentare un aspetto in ombra della realtà della madre, una potenzialità apprezzata o temuta. Immagini interne e fattori storici inconsci costituiscono sostanze nutritive o tossine della placenta emotiva che condiziona la gestazione psichica della gravidanza.
La gravidanza può generare dei cambiamenti anche nella relazione con il partner, in alcuni casi l’attività sessuale viene incentivata, in altri viene interrotta, in quanto si riattivano desideri infantili o si percepisce la propria privacy violata da un terzo. La diade può oscillare fra la sensazione che la gravidanza arricchisca l’intimità e un’idea d’invasione. Per quasi tutti, è stata una donna, fonte di gioia e tormento, a esercitare il potere sulla nostra infanzia. Il cordone ombelicale ha una doppia funzione: convoglia il nutrimento al bambino e rimuove i suoi prodotti di scarto; il cordone che collega la madre e il bambino può essere immaginato come un condotto, una fonte di gioia, o come minaccia persecutoria di ritorsione.
Dal canto suo il padre si trova a dover faticare per affermare il proprio contributo personale. Deve rinunciare al piacere di avvertire una vita interna e può essere geloso dell’intimità che la compagna ha col bambino. Nelle società industrializzate la formazione di sintomi offre al padre il mezzo per ripudiare la propria ostilità subendone al tempi stesso la punizione. I sintomi possono essere un mezzo per ottenere riconoscimento e cure , un modo per deviare sul proprio corpo l’attenzione, oppure una sorta di solidarietà con la compagna, o anche espressioni di invidia, manifestando un eccessivo controllo dell’alimentazione della compagna.
L’ autrice parla del padre in attesa: un uomo che oltre a provare un’insieme di emozioni verso la compagna e il feto, mette in moto in lui un riesame del proprio passato come bambino con i genitori. Il padre vive inoltre un risentimento impotente per il fatto di poter agire cosi poco su un processo di tale importanza. Anche il travaglio scatena nei padri una miriade di sentimenti differenti: può innescare risposte emotive di protezione, paura di essere una parte di ricambio nel mondo femminile, senso di colpa per aver messo la compagna in quella situazione dolorosa, senso di vergogna e di impotenza.
In che modo le fantasie prenatali influenzano il clima emotivo postnatale? E’ una delle tante domande che l’autrice propone in questo libro. La gravidanza e la nascita di un figlio, turning point nello sviluppo dell’identità femminile e nella vita di coppia, comportano una profonda crisi maturativa di rimaneggiamento e riordinamento psichico alla ricerca di nuovi equilibri. La transazione alla genitorialità delinea un processo di profonda trasformazione che riattiva rappresentazioni mentali strettamente legate alla precedente storia relazionale, dalla quale si riaffacciano le passate esperienze di attaccamento con le proprie figure genitoriali ed i vissuti di accudimento esperiti durante l’infanzia. Il tempo della gravidanza è fondamentale per i futuri genitori al fine di creare uno spazio fisico e mentale, che dovrà ospitare le rappresentazioni di sé come madre, del proprio partner come padre e del futuro bambino.
Per la donna è evidente che la realtà biologica e psichica della gravidanza comportino una trasformazione della sua immagine corporea e del sentimento d’identità che si attiva in un processo di duplice individuazione di sé, come figlia di fronte alla propria madre, come madre di fronte al proprio figlio, e nello stesso tempo di accettazione del figlio separato da sé. Tale processo di doppia individuazione avviene anche nell’uomo, che è figlio del proprio padre e nello stesso tempo diviene padre, anche se egli non vive i cambiamenti corporei e psichici e le ansie legate alla trasformazione del corpo e del parto. A lui spetta il compito non facile di sostenere il percorso della gravidanza, poi quello di favorire la relazione madre-bambino e il comportamento esplorativo successivo del bambino, attraverso il sostegno della donna, la collaborazione e l’accudimento, ma ciò è possibile solo se anche il futuro padre avvia il lavoro psichico di profondo rimaneggiamento e ritrascrizione del proprio scenario rappresentazionale.
L’adattamento a questi mutamenti può rappresentare un processo complesso, nel quale possono aprirsi scenari di fragilità psicologica, sia individuali che di coppia. Nella trasformazione psicologica che caratterizza la gravidanza, centrale è la modificazione dell’identità della donna. Muta, infatti, la rappresentazione di sé come persona, moglie, figlia, donna che lavora, amica e ora madre; il suo posto nella società, il suo status, il suo posto nella famiglia d’origine. La donna deve ricostruire il suo ruolo sociale e per fare ciò inconsciamente esplora il suo passato e il suo presente, i suoi vissuti di figlia, il rapporto con il partner. Durante i 9 mesi prima e nel periodo postnatale dopo l’identità femminile presente fino al momento del concepimento non viene abbandonata ma integrata con la nuova identità di madre; cambiano però i valori, le priorità, tutto ruota intorno al suo sentirsi madre.
Gravidanza e parto costituiscono gli eventi di quella peculiare comunicazione fondante la relazione madre-bambino, la quale contiene le premesse per l’attuarsi di relazioni e transazioni interpersonali future: l’esperienza bio-psicologica vissuta in utero trova espressione dopo la nascita, si conserva e si manifesta nel comportamento neonatale. La separazione biologica del parto costituisce poi il passaggio complesso, e a volte traumatico, dalla gravidanza-maternità sognata alla nascita-maternità reale e comporta il difficile confronto fra il bambino immaginato e reale, fra il ruolo di genitore fantastico e quello reale. La discrepanza tra le aspettative genitoriali e la realtà psicosociale dell’esperienza post-natale, la complessità delle cure neonatali, possono far riemergere questioni infantili irrisolte e rendere difficile la transizione alla genitorialità; inoltre vi è anche a volte la mancanza di sostegno psicologico alla donna in gravidanza e nel post-partum.
In questo contesto di solitudine e di difficoltà, durante la transizione biologica e psicologica alla genitorialità si possono manifestare sintomatologie ansiose depressive. Il periodo perinatale, che si estende dalla gravidanza fino al primo anno di vita del bambino, può rappresentare un momento di grande rischio per lo sviluppo o l’esacerbazione di disagi emotivi, con sofferenze in grado di compromettere l’equilibrio psicologico femminile, influenzare negativamente a livello della relazione di coppia, dell’interazione madre-bambino, ostacolando anche il normale sviluppo infantile.
In gravidanza, il benessere, lo stare e il sentirsi bene, sono elementi centrali in grado di influenzare la qualità della vita e dell’esperienza della gravidanza, il benessere e la salute del feto, e la formazione dei sistemi con cui verrà al mondo. La qualità dell’esperienza e dei vissuti nella gestazione ha ripercussioni anche sulle prime esperienze di attaccamento che indirizzeranno le future capacità relazionali e di fronteggiamento degli eventi nel bambino in una catena generazionale a lungo termine.
Ad esempio, la depressione pre-natale, ha delle importanti conseguenze già durante la gravidanza sul feto, che mostrerebbe una minore attività e disregolazioni neuroendocrine. Inoltre i neonati di madri depresse in gravidanza e alla nascita possono presentare rispetto i figli di madri non depresse, un peso più basso e una crescita minore, reazioni scarse alle espressioni facciali, difficile consolabilità, irritabilità, problemi del sonno e un maggior numero di manifestazioni di stress a partire dai primi mesi dopo la nascita. Si osserva come la madre depressa nell’interazione con il figlio sia meno responsiva e sensibile rispetto ai bisogni del figlio, esprima spesso opinioni negative nei confronti del piccolo e sia focalizzata maggiormente sulle proprie preoccupazioni, piuttosto che sul piccolo; a sua volta il neonato può esprimere difficoltà interattive, nell’addormentamento e irritabilità eccessiva. A lungo termine è stato riportato come i figli di madri depresse abbiano nel 25% dei casi difficoltà emozionali e cognitive, con conseguenze negative anche sul rendimento scolastico; una recente ricerca ha analizzato come la depressione materna post-natale possa influenzare i figli fino a 16 anni di vita, mostrando una maggiore vulnerabilità alla depressione rispetto ai figli di donne non depresse. L’isolamento materno e la variabilità delle risposte contingenti, possono compromettere la regolazione dell’attenzione e dell’affetto del neonato, con conseguenze sul suo sviluppo cognitivo e socioemotivo.
La componente ansiosa, come la depressione, potrebbero compromettere lo sviluppo di attaccamento sicuro madre-bambino e mettere a rischio lo sviluppo cognitivo, emotivo e comportamentale del bambino. Un numero crescente di ricerche documenta gli effetti a breve e a lungo termine che la precoce esposizione nel periodo gestazionale ad elevati stati ansiosi materni può indurre sullo sviluppo neonatale e infantile, nonché adolescenziale. Alla base di queste evidenze, ci sono disregolazioni ormonali che contribuiscono all’alterazione dello sviluppo del feto. In un’ottica biopsicosociale, tali elementi di vulnerabilità biologica possono essere rinforzati da specifici pattern relazionali o caratteristiche ambientali. E’ soprattutto nei primi anni di vita che si esplica l’importanza dei fattori socio-relazionali nell’influenzare le traiettorie di sviluppo infantile. I risultati dimostrano l’importante contributo della presenza di disturbi d’ansia prenatali nell’influenzare negativamente sulla transizione alla genitorialità. Minor percezione di sicurezza che le madri avvertono nel prendersi cura del bambino e la maggior instabilità comportamentale percepita nel bambino: tali elementi possono incidere sulle prime esperienze relazionali bambino-caregiver, fondamentali per la costruzione e l’organizzazione del sé infantile nei primi anni di vita. Tutto questo porta una minore regolazione comportamentale, maggiore instabilità attentiva e sviluppo motorio (Dellabatola, 2013).
L’autrice dedica un capitolo alla descrizione dei diversi approcci alla genitorialità, che iniziano già a delinearsi nelle scelte relative al parto. In particolare evidenzia tre orientamenti: Facilitazione, Regolazione e Reciprocità, determinati dell’interazione tra il bambino rievocato che si pensa di essere stato; il bambino immaginato e pensato; il bambino reale. In base a tali modelli ogni genitore ha quindi in mente che tipo di madre/padre vorrebbe essere e quali credenze sono attribuite ai bambini. Tutto ciò contribuisce a determinare nei genitori lo stato emotivo attuale e ne è a sua volta determinato. In particolare per quanto riguarda le madri, chi tra esse presenta un orientamento del tipo Facilitazione considera la maternità come un’esperienza altamente gratificante, tende a non separarsi mai dal bambino dedicandosi a lui completamente, cercando di mantenere intatta la loro bolla di esclusiva intimità.
All’estremo opposto si collocano quelle donne che si attengono all’orientamento delle Regolazione, le quali si separano volentieri dal neonato, ricercano figure di accudimento alternative al fine di ricercare una propria libertà e uno spazio per sé stesse. Nella posizione intermedia si collocano quelle madri caratterizzate dal tipo di genitorialità definito Reciprocità. Quest’ultimo orientamento tende a vedere il neonato come una persona completa con la quale può interagire, perché anch’esso socievole, disponibile e capace di relazionarsi e fare richieste. In quest’ottica sono riconosciuti come importanti sia i bisogni del bambino, che quelli di tutti gli altri componenti della famiglia, per cui si opera un adattamento continuo delle attività quotidiane tenendo conto delle necessità di ognuno.
L’ autrice passa poi anche a delineare diversi modelli che di orientamento e comportamento del futuro padre, in particolare ne descrive tre, il primo è quello del padre partecipe. Il futuro padre che ha questo orientamento desidera partecipare il più possibile alla gestazione, al parto e alla cura del neonato. Dentro di sé ha libero accesso all’ identificazione infantile con la madre gestante e nutrice, ed è capace di essere tenero e affettuoso senza nessun imbarazzo. Il secondo modello descritto è quello del rinunciatario: chi adotta questo orientamento ha anche acuta consapevolezza dello spartiacque che la gravidanza rappresenta tra maschio e femmina. Ma, in tal caso, sentendosi minacciato dal riaffiorare dell’ identificazione femminile con la madre pre-edipica, può accentuare i propri attributi mascolini e l’ identificazione con il padre e col tradizionale ruolo paterno. Gli è difficile comprendere le esperienze interiori della compagna, vede con un certo allarme i suoi sbalzi di umore e la tendenza all’ introspezione, considera i controlli in gravidanza una faccenda da donne.
Ciò nonostante, si preoccupa del benessere della compagna e del feto e, se accetta, di assistere all’ecografia, può scoprire che l’ esperienza di vedere il bambino sullo schermo dà un senso di eccitante realtà al nuovo arrivato. Infine, anche per il futuro padre viene descritta una posizione di reciprocità: costui è ben consapevole di provare sentimenti contraddittori verso la gravidanza della compagna, il parto e il bambino. La gravidanza, per quanto desiderata, è anche fonte di disagio per la donna,e al compagno dispiace lasciare a lei sola questo peso e il dolore del parto. E’ tuttavia consapevole pure delle esperienze piacevoli che la compagna sta vivendo, alle quali può prendere parte solo in maniera vicaria. Cercando di proiettarsi sul passato, riflette su come si sentiva da piccolo e su quello che può provare ora il suo bambino dentro l’ utero materno, e più avanti durante il travaglio e il parto, e una volta venuto al mondo.
Nella parte centrale del libro, l’ autrice passa poi ad esaminare i vari cambiamenti nei rapporti che avvengono quando una donna è in attesa di un bambino. In particolare la Leff si concentra sui mutamenti all’ interno della coppia in attesa, e sul rapporto della futura mamma con il proprio lavoro.
Nella transizione alla genitorialità, la gravidanza altera gli schemi relazionali esistenti, scatenando il cambiamento e offrendo occasioni di rinegoziare le aspettative emotive. Il passaggio dalla diade a triangolo riattiva angosce edipiche e vengono in primo piano problemi di possessività e rivalità. Fitte di gelosia, competitività, ansia di perdere l’ attenzione esclusiva del partner, sono comuni e inevitabili. La reciprocità della coppia risente del fatto che la gravidanza destabilizza l’ equilibrio tra i sessi e inevitabilmente accentua l’ asimmetria. Con il sopravvento delle forze inconsce il substrato della realtà biologica dell’esperienza corporea costringe uomini e donne a riesaminare la propria mascolinità o femminilità con conseguenze imprevedibili. Una donna abituata ad affermare con decisione la sua indipendenza può avere la sorpresa di desiderare le coccole del partner o le cure della madre o delle amiche. Un’ altra che è sempre stata dipendente e sottomessa, può assaporare una nuova libertà con la conquistata gravidanza. All’ inizio della gravidanza una coppia spesso si rinchiude, diventando più casalinga e tutta presa da se stessa, per fare fronte alle esigenze emotive e fisiche. Può esserci un aggiustamento dei rapporti sociali, in quanto i futuri genitori tendono a gravitare verso amici che hanno già esperienza di bambini.
Per quanto riguarda il mondo del lavoro l’ autrice riconosce che il ritorno al lavoro comporta dilemmi personali nel contemperare il desiderio di autorealizzazione con le esigenze della gravidanza e della maternità a seconda del proprio orientamento. Le donne che corrispondono al modello della Regolazione riprendono appena possibile l’ impiego a tempo pieno, mentre il tipo Facilitazione tende a rimandarlo nei primi due anni dopo il parto; le madri che adottano il modello della Reciprocità scelgono talvolta il lavoro part-time; anche se in questa dinamica entrano in gioco anche i dettami della situazione socioeconomica personale, le aspettative della società e il sistema di credenze culturali.
Nella fase iniziale della gravidanza, quando le nausee sono frequenti e la stanchezza enorme, le mansioni che richiedono sforzo fisico e i lavori ripetitivi, possono risultare logoranti. Le risposte al carico lavorativo sono varie: alcune donne cercano di ottenere congedi per malattia in modo da potersi riposare, mentre altre preferiscono essere occupate in compagnia di altri invece che stare sole. Nel secondo trimestre, la maggior parte delle donne si sente in forma e piena di energia. Alcune aumentano addirittura il livelli di attività; ad altre invece dispiace di doversi occupare del lavoro anziché concentrarsi sul feto, ora cosi vivace, e avere il tempo di godersi la gravidanza. All’ avvicinarsi del termine, alcune donne desiderano l’ arrivo del congedo di maternità lungamente atteso, altre sono piene di panico di fronte alla prospettiva di giornate senza orari al posto della rassicurante routine di lavoro.
Decidere quando smettere di lavorare per molte è un passaggio che viene complicato dal senso di fallimento nel chiedere un trattamento speciale o anche solo dall’ ammissione di stanchezza. Secondo l’autrice quello che conta per ogni singola donna è capire il proprio orientamento dopo la gravidanza: lei sola può conoscere le sue capacità e priorità emotive, o valutare i suoi limiti. Molte donne imparano in gravidanza a trovare il modo di badare a se stesse, invece di farsi guidare da modelli, interni o esterni, irrealisticamente elevati. In modo analogo, anche dopo la nascita del bambino, alcune non possono fare a meno di uno stipendio, oppure non possono permettersi di trascurare gli aggiornamenti professionali o di interrompere il progresso di carriera. Altre potrebbero prendere un congedo, ma decidono di non farlo a causa dell’ impegno professionale o dell’ interesse per il lavoro. Un compromesso possibile è la condivisione delle mansioni o l’ adozione di un orario flessibile, che permetta di godere le gioie della maternità, senza rinunciare alla parte adulta di sè e alla presenza attiva nella vita pubblica.
Negli ultimi capitoli del testo l’autrice delinea i vissuti emotivi e i cambiamenti psicologici, relazionali e sociali a cui non solo le madri, ma le intere famiglie vanno inevitabilmente incontro nel momento in cui nasce il bambino. Si viene, infatti, a determinare una situazione del tutto nuova, che richiede l’investimento di energie in un continuo adattamento.
Più in particolare viene esaminato il momento del parto, sottolineando come questo importante ed emozionante evento sia vissuto in modo del tutto diverso e personale. La priorità è la sicurezza e il benessere della donna: a questo fine è consigliabile che lei stessa effettui le scelte relative al parto in precedenza, ragionando sulle priorità e formulando il suo personale progetto con lucidità e calma, così che l’evento si concretizzi nelle modalità che rispecchiano il più possibile i suoi desideri. Questo stato affermativo aumenta la fiducia in sé stessa e, al contempo, riduce lo shock e il senso di fallimento. Il percorso risulta agevolato se la partoriente ha la possibilità di esprimere le proprie paure e sentimenti di incertezza e confusione alle persone che la assistono nel parto, ricercando in esse un sostegno emotivo, durante la gravidanza e il parto. Anche nelle delicate settimane che seguono la nascita del bambino, caratterizzate da intense e inattese reazioni psicologiche, sarebbe importante che gli operatori che hanno assistito al parto siano disponibili, al fine di rassicurare e aiutare la donna nella gestione e nel superamento di tali emozioni.
Emerge come l’esperienza delle prime settimane dopo la nascita, oltre a differire per ogni madre, sia soggetta a cambiamenti anche nell’organizzazione pratica di gestione familiare, nonché psicologica in primis delle madri, le quali possono andare incontro allo sviluppo di problemi psichici, che se non riconosciuti e trattati adeguatamente, possono sfociare in disturbi specifici. I più diffusi sono la disforia puerperale o maternity blues (o baby blues) e la depressione post-parto. Soprattutto in questi casi è necessario che una madre si senta accudita e supportata dal coniuge, ma anche da professionisti che possano fornire una psicoterapia adeguata per assistere la donna nel rintracciare risorse per aiutare sé stessa.
Gli ultimi capitoli del libro sono dedicati alla spiegazione del trattamento di tali problematiche psicologiche mediante una psicoterapia sia pre-natale che perinatale che può essere d’aiuto in questo momento delicato della vita. L’autrice sottolinea l’importanza della psicoterapia prenatale, sia individuale che di gruppo, come strumento di accompagnamento dei genitori e soprattutto delle madri lungo questo impegnativo percorso che spesso vede lo sconvolgimento e la ridefinizione di rapporti di coppia, l’elaborazione di nuovi vissuti e l’integrazione di nuove emozioni con quelle passate. Il supporto psicologico svolge un ruolo protettivo nella riduzione del rischio di complicazioni ostetriche, delle interazioni patologiche future tra madre e bambino, quali carenze emotive e maltrattamenti, e nel prevenire disturbi psichiatrici precedentemente accennati. Ulteriori risultati positivi potrebbero essere raggiunti anche dalla partecipazione ai corsi di preparazione al parto, se comprendessero anche un primo sostegno emotivo e psicologico delle gestanti, una modalità che al momento è ancora poco utilizzata, a favore di una preparazione solo pratica dei genitori rispetto alla cura del neonato in arrivo.
Nei casi in cui le problematiche si protendano anche nelle settimane successive alla nascita del bambino potrebbe essere utile una psicoterapia postnatale che aiuti ad uscire dalla confusione emozionale che la nuova situazione provoca e ad elaborare i potenti sentimenti suscitati dal contatto con il neonato. L’intervento psicologico si rende necessario soprattutto nei casi in cui la donna manifesti sintomi riconducibili ad una disforia puerperale (maternity blues) o alla depressione post-parto.
Sebbene questi ultimi capitoli relativi alla psicoterapia sembrino essere rivolti soprattutto agli operatori del settore, come studenti di psicologia, psicologi, psichiatri e psicoterapeuti, in generale la lettura del libro può essere adatta anche per le coppie in attesa e per i neo-genitori. In particolare potrebbe essere una buona lettura per le mamme che desiderano conoscere meglio gli aspetti psicologici della gravidanza e i cambiamenti affettivi, relazionali e sociali che la caratterizzano.
La gravidanza, la nascita e i primi periodi con il neonato sono generalmente ricordati dalle mamme come un’esperienza positiva, ma a volte può capitare che non tutto sia andato come ci si aspettava e in quest’ultimo caso potrebbe essere difficile per la donna adattarsi alle inaspettate difficoltà che la nuova convivenza comporta.
Il processo di adattamento ai cambiamenti fisici, emotivi e sociali, e al nuovo arrivato può richiedere giorni o anche molte settimane, un periodo in cui la neo-mamma si trova in balia di reazioni iniziali intense anche molto differenti tra loro e disforiche di diversa entità che, per difesa, possono anche essere intorpidite. I nuovi vissuti si mescolano con le esperienze passate e le aspettative future, condizionandosi a vicenda. La maternità è quindi un’esperienza allo stesso tempo esaltante e terribile, gratificante e frustrante.
È molto frequente dopo il parto la presenza di una sindrome definita disforia puerperale o baby blues, un leggero stato depressivo che si presenta nei giorni immediatamente successivi al parto, con un picco dei sintomi tra il 3-5° giorno, che si risolve nel giro di circa due settimane, senza lasciare conseguenze significative. La baby blues è caratterizzata da tristezza immotivata, irritabilità, oscillazione dell’umore, crisi di pianto e senso di inadeguatezza nei confronti dei nuovi compiti che si presenteranno. Tali sintomi sembrano essere causati principalmente dai grandi cambiamenti ormonali che seguono il parto e dalla stanchezza che ne deriva.
È anche molto diffusa nei Paesi occidentali (circa il 10/15% delle mamme) la depressione post-parto, che si sviluppa durante i 3 mesi successivi al parto, dura più a lungo ed è più disabilitante rispetto agli episodi depressivi maggiori che possono insorgere in altri periodi della vita. Dal punto di vista clinico la depressione post-parto non differisce molto dalla depressione maggiore ed è quindi caratterizzata dalla presenza di alcuni dei seguenti sintomi: tristezza, abbattimento, umore basso, perdita di interesse e di piacere verso quelle attività che prima rappresentavano fonte di piacere, senso di fallimento e di inutilità, eccessivi sensi di colpa, difficoltà di concentrazione e nel prendere decisioni, difficoltà a pensare lucidamente, a ricordare e a programmare, disturbi del sonno con insonnia o ipersonnia, cambiamenti nell’appetito, agitazione e irrequietezza o rallentamento psicomotorio, riduzione dell’energia con faticabilità e spossatezza, pensieri ricorrenti che non vale la pena di vivere o, nei casi peggiori, pensieri di morte o di suicidio. I casi più gravi di depressione post-parto devono essere differenziati dalla psicosi post-parto, un disturbo più raro e più grave nelle sue manifestazioni che colpisce circa una donna su mille. La psicosi puerperale insorge in genere entro le prime 6 settimane dal parto e le donne colpite presentano grave confusione e agitazione, gravi alterazioni dell’umore e del comportamento, deliri e allucinazioni.
A questi sintomi possono aggiungersi anche preoccupazioni eccessive per la propria salute e quella del bambino che possono sfociare in stati ansiosi o in disturbi di panico. L’ampia costellazione sintomatologica di questo disturbo ha come conseguenza immediata la difficoltà per la madre di riprendersi fisicamente in tempi rapidi e soprattutto di occuparsi della cura del neonato, con conseguente sensazione di essere una madre fallimentare. In generale le cause della depressione sono multiple e possono essere riconosciute in un intreccio di:
- fattori biologici (cambiamenti nella regolazione dei livelli dei neurotrasmettitori, nella concentrazione di alcuni ormoni e nel sistema immunitario);
- trasmissione genetica della vulnerabilità a sviluppare più facilmente questo disturbo;
- fattori psicosociali precipitanti, come eventi di vita particolarmente stressanti e significativi per la persona che possono portare all’effettiva manifestazione del disturbo. Tali eventi non sono necessariamente negativi, ma rappresentano realtà nei confronti delle quali la persona fatica ad adattarsi, come può essere appunto il divenire madre. Questi avvenimenti danno origine o aggravano lo stato depressivo determinando un peggioramento dell’adattamento nella misura in cui la persona non possiede le abilità necessarie per farvi fronte, rinuncia a reagire, si chiude in sé stessa e si lascia andare.
Più in particolare per quanto riguarda la depressione post-parto ulteriori fattori di rischio che ne aumentano la vulnerabilità possono essere rappresentati da:
- eventi specifici che riguardano la gravidanza e il rapporto con il figlio: gravidanza inattesa o indesiderata, complicanze durante la gravidanza o dopo il parto per la madre o per il bambino, nascita prematura, problemi di salute del bambino, bambino di sesso diverso da quello desiderato, separazione forzata dal figlio o l’avere a che fare con un bambino difficile per quanto riguarda il sonno, il carattere…;
- fattori legati al ruolo materno: fatica ad adattarsi al nuovo ruolo di madre e a rinunciare, seppur solo per un periodo, al proprio lavoro, personalità rigida caratterizzata da bisogno di controllo, ordine e perfezionismo, idee sulla maternità e idee di sé come madri poco rispondenti alla realtà e per questo maggiormente soggette a delusione, ambivalenza verso la gravidanza;
- eventi relativi all’ambiente familiare, sociale e culturale: precedenti episodi di depressione, infanzia infelice o difficile, carenze emotive, abuso fisico o sessuale, basso livello socio-economico, mancanza del partner o relazione di coppia insoddisfacente o problematica, mancanza di sostegno sociale e aumento della quantità di lavoro da svolgere;
- scarso sostegno sociale, problemi coniugali, disoccupazione.
Se la condizione di depressione post-parto non viene riconosciuta tempestivamente e non viene trattata in modo adeguato può determinare ripercussioni a lungo termine sulla salute mentale della donna, in termini di auto-mantenimento ed aggravamento che determinano un quadro via via sempre più invalidante. Ad aggravare ulteriormente la situazione spesso vi è un sentimento di vergogna per il fatto di provare emozioni e sentimenti negativi in risposta ad un evento che nel senso comune dovrebbe essere come il più bel momento che una donna possa vivere. Spesso la donna tenta allora di minimizzare o negare anche a sé stessa questo malessere evitando di parlarne con qualcuno per paura di non riuscire ad uscirne fuori, ritardando così il supporto psicologico necessario in questo momento delicato.
Essendo un disturbo così pervasivo la depressione post-parto inevitabilmente si ripercuote negativamente anche sugli altri componenti della famiglia: per quanto riguarda il neonato si riscontrano meno contatti con lui, meno responsività alle richieste di accudimento e scarsità di risposte a stimoli affettivi e pratici con dirette conseguenze sul bambino in termini di sviluppo cognitivo e sociale, fino ad arrivare a possibili disturbi del comportamento o dell’attaccamento. Anche la relazione con il partner risente del malessere della neomamma, la quale fatica a gestirla in modo adeguato arrivando a percepire una forte insoddisfazione, carenza di sostegno e aumento dei conflitti e della tensione. D’altra parte anche la reazione del coniuge e degli altri familiari, a volte ambivalente, alla depressione della donna, contribuisce a determinare e ad esacerbare lo stato della situazione. I familiari spesso esprimono preoccupazione e dispiacere nel constatare questo malessere, ma d’altra parte si sentono impotenti e possono esprimere sentimenti di colpa per il fatto di non sapere che tipo di aiuto dare. Possono inoltre sentirsi irritati di fronte alle continue lamentele della neomamma, al suo pessimismo e alla sua totale mancanza di forze e di motivazione.
Per quanto riguarda l’intervento terapeutico, spesso nella fase iniziale più acuta e comunque nei casi più severi, è necessario il consulto di uno psichiatra per considerare l’opportunità di impostare un trattamento di tipo farmacologico con antidepressivi, farmaci che hanno mostrato una buona efficacia nella riduzione dei sintomi. Dopo il superamento della fase acuta o nei casi di una sintomatologia lieve o moderata è buona prassi affiancare un intervento psicoterapeutico al fine non solo di avere un supporto, ma anche di imparare a riconoscere e prevenire i meccanismi che possono innescare una futura ricaduta. Da questo punto di vista le linee guida evidenziano una buona e provata efficacia della terapia cognitivo-comportamentale, il cui protocollo prevede in genere 15/20 sedute a cadenza settimanale: in una prima fase si esegue una valutazione sintomatologica, della personalità generale della persona; nella seconda fase il terapeuta presenta e insegna tecniche comportamentali e cognitive che dovranno essere applicate anche a casa tra una seduta e l’altra (compiti a casa); l’ultima fase, di 4/6 sedute a cadenza mensile prevede il monitoraggio della capacità della persona di mettere in pratica autonomamente quanto appreso. La stessa tipologia di trattamento può anche essere proposta sottoforma di terapia di gruppo. Questo protocollo è relativo al trattamento di sindromi post-parto depressive strutturate e ben definite, ma sarebbe importante anche introdurre misure preventive sfruttando i servizi medici prenatali, in modo da poter segnalare al più presto le donne che più sono in difficoltà e che rischiano quindi di sviluppare più facilmente un disturbo. Dato che questi interventi di tipo preventivo non sono ancora ben organizzati e comunque sono proposti raramente, risulta a maggior ragione importante la percezione della donna di ricevere un adeguato sostegno emotivo da parte del coniuge, dei familiari e degli amici, i quali costituiscono la più grande risorsa e la prima fonte di aiuto, oltre alla rete sociale più ampia su cui la donna ha la possibilità di contare.
La transizione alla genitorialità, i cambiamenti nel rapporto di coppia e la loro relazione con il conflitto coniugale
L’arrivo di un bambino, o anche semplicemente la sua attesa, introduce un elemento nuovo nella relazione di una coppia con l’effetto di provocare una ristrutturazione della relazione mentre l’assunzione da parte dei coniugi della funzione genitoriale comporta spesso anche un riassetto della personalità di ciascuno di essi. Questa transizione presenta alcune singolarità:
- in genere si conosce il momento del suo inizio;
- è un evento pianificato che implica una sequenza predeterminata di stadi e di esperienze attraverso i quali le persone devono passare;
- per molte coppie il fatto di avere un bambino è associato con un peggioramento della qualità del rapporto coniugale;
Come effetto della transizione la varianza della qualità del rapporto coniugale aumenta, e ciò fa pensare che mentre alcune coppie sperimentano una diminuzione del benessere coniugale, altre possono sperimentare un miglioramento. La nascita del primo bambino dà l’avvio a cambiamenti significativi nel rapporto coniugale della coppia. Dopo la nascita, i coniugi di solito passano meno tempo insieme, si impegnano in un minor numero di attività congiunte, hanno più conflitti tra di loro e riferiscono di avere una minore attività sessuale. Questi cambiamenti si aggiungono alla natura già di per sé stressante e gravosa del doversi prendere cura del bambino. Studi longitudinali (che valutano i matrimoni prima e dopo la nascita del bambino) hanno documentato un modesto, ma significativo, peggioramento della soddisfazione coniugale in molti neo-genitori e ciò è vero in particolar modo per le mogli. Il peggioramento della soddisfazione coniugale tende ad essere correlato con un incremento della conflittualità nel rapporto tra i coniugi, con un aumento della divaricazione sul modo di concepire il loro matrimonio,con una diminuzione del coinvolgimento paterno (od un aumento del coinvolgimento materno) nella cura del bambino con la violazione delle aspettative che i coniugi avevano prima del parto, con comportamenti affiliativi e di cura inadeguati nella vita matrimoniale dopo il parto, ed infine con un supporto sociale insufficiente. Il peggioramento del benessere coniugale nel periodo di transizione non è un comportamento generalizzato, anzi è un dato di fatto che alcune coppie mostrano un significativo miglioramento della soddisfazione e del buon funzionamento coniugale dopo la nascita del primo bambino. Cowan e Cowan, per esempio (citati in Simpson et al., 2002), riferiscono casi di aumento dell’attività sessuale, un aumento del grado di intimità e una migliorata capacità di problem solving, almeno per certi coniugi all’interno di certi matrimoni.
Sono stati sviluppati molti modelli per spiegare come la transizione alla genitorialità influisca sulla qualità della relazione coniugale e sul funzionamento della coppia nel tempo, due sono quelli fondamentali: i modelli ecologico/ambientali che si preoccupano di mettere a fuoco le modalità con le quali le condizioni ambientali attuali influenzano i matrimoni; e i modelli disposizionali che rivolgono la loro attenzione alle modalità con le quali le esperienze passate influenzano il funzionamento coniugale attuale. Secondo i modelli ecologico/ambientali che hanno radice nella teoria socio-cognitiva dell’apprendimento, durante il periodo di transizione alla genitorialità cambia il bilancio tra esperienze percepite come positive ed esperienze percepite come negative e ciò provoca oscillazioni e cambiamenti di lungo termine nella qualità della relazione coniugale. I giudizi di soddisfazione o di insoddisfazione coniugale dipendono dal livello cui giungono i coniugi nello sperimentare stati d’animo negativi e nel biasimarsi a vicenda. Questi modelli sono molto attenti agli eventi attuali, ambientali e di relazione, ma non prendono in considerazione il fatto che la capacità di ciascun coniuge di valutare la qualità della relazione coniugale possa essere sistematicamente filtrata e polarizzata dalle precedenti esperienze di relazione vissute nella fanciullezza o nell’adolescenza.
L’ARTICOLO CONTINUA NELLA PAGINA SEGUENTE
Levy-Shiff (1994) ha sviluppato un modello ecologico a cinque fattori nel quale si postula che i cambiamenti nella relazione coniugale che si verificano durante la transizione alla genitorialità siano dovuti a mutamenti nelle caratteristiche psicologiche dei genitori, nelle caratteristiche del bambino, nelle variabili della famiglia, nel tessuto sociale di sostegno e nelle norme culturali e sociali. Per esempio, variabili sociali come l’importanza attribuita al lavoro e alla carriera possono essere correlate con il peggioramento della capacità di adattamento nelle relazioni coniugali, in particolar modo quando i coniugi non sono d’accordo sulle responsabilità nella gestione del ménage familiare o sulla divisione dei compiti. Recentemente Levy-Shiff, Dimitrovsky, Shulman e Har-Even (1998) hanno ipotizzato che il modo in cui le persone valutano la genitorialità (in termini di entità della sfida, della minaccia, dello stress e della controllabilità), il grado in cui esse usano le diverse strategie di coping e la disponibilità del supporto sociale possano, se analizzate congiuntamente, predire i cambiamenti nel benessere familiare durante il periodo di transizione.
Altri ricercatori hanno cercato di spiegare gli effetti della transizione alla genitorialità specificando come le variabili disposizionali, modellate da esperienze di relazione precedenti, possano avere influenza sul buon funzionamento della relazione coniugale.
A differenza dei modelli ecologico/ambientali, molti modelli disposizionali cercano di delineare come e perché le esperienze avute nelle precedenti relazioni (per esempio con i genitori) possano influenzare l’interazione coniugale ed avere conseguenze che si evidenziano dopo che il bambino è stato partorito.
Cowan e Cowan (1988), ad esempio, hanno sviluppato un modello che si basa sugli effetti dovuti alla famiglia di origine. Questo modello postula che le persone che hanno sperimentato delle relazioni positive con il genitore del sesso opposto durante la fanciullezza e che avevano anche dei genitori i cui matrimoni erano felici, siano
destinate a sperimentare una maggiore soddisfazione nelle loro proprie relazioni coniugali, dopo la nascita del loro bambino. In effetti, la percezione di un conflitto intenso nelle famiglie di origine di uno o di entrambi i coniugi sembra predire davvero un peggioramento post parto della soddisfazione coniugale.
Simpson et al. (2002) fanno riferimento alla teoria dell’attaccamento di Bowlby per spiegare il comportamento dei coniugi nella transizione alla genitorialità:
- Le persone sicure sono tipicamente meno chiuse in difesa, valutano i loro partner in modo più benevolo ed usano correntemente modalità costruttive di fronteggiare gli eventi, mirate al problema ed aperte al supporto degli altri, soprattutto quando sono sotto stress. Se il loro partner offre livelli di sostegno inferiori al desiderato, formulano, a tal proposito delle attribuzioni causali costruttive. Queste loro caratteristiche di resilienza permettono alle persone sicure di rimanere ottimiste e capaci sia di ricevere che di dare supporto. Il risultato è la capacità di fronteggiare in modo efficace gli eventi stressanti e di risolvere le difficoltà emergenti con i loro partner, con un effetto che rinforza la loro relazione. Se poi le persone sicure hanno anche dei partner capaci di dare loro effettivo sostegno, le esperienze stressanti anziché provocare un peggioramento diventano l’occasione per un miglioramento della qualità della relazione coniugale e del suo modo di funzionare (Simpson e Rholes, 1994).
- Le persone evitanti, che hanno sperimentato persistenti situazioni di rifiuto nelle relazioni del passato, per sopprimere la sofferenza e la rabbia associate con il rifiuto cronico, hanno anche imparato ad essere compulsivamente autosufficienti specialmente quando sono angosciate da eventi stressanti (Bowlby, 1979).
Bartolomew e Horovitz (1991) hanno identificato due tipi di adulti evitanti,gli evitanti-impauriti (che hanno delle opinioni negative di se stessi) e gli evitanti-scostanti (che hanno di sé delle opinioni positive), ma hanno anche visto che gli adulti di entrambi i tipi nutrono dentro di sé, opinioni sugli altri negative e piene di diffidenza. Per evitare che i loro sistemi di attaccamento siano cronicamente attivati, queste persone utilizzano difese cognitive, emotive e comportamentali che li aiutino ad evitare le situazioni che potrebbero attivare i loro sistemi di attaccamento, a smorzare l’attivazione, a sminuire l’importanza dei bisogni legati all’attaccamento e a mettere in atto strategie di coping basate sul distanziamento e il ritiro. Usando queste difese le persone evitanti diminuiscono la probabilità di sperimentare ulteriori rifiuti da parte delle figure di attaccamento attuali, assicurandosi così che il loro sistema di attaccamento rimanga disattivato. Poiché nelle relazioni passate si sono abituate a ricevere un supporto scarso, queste persone non sono infastidite dal fatto di ricevere, dai loro attuali partner, un supporto di livello molto basso (specialmente nel caso di supporto emotivo). È poco probabile quindi che tali persone cerchino supporto dai loro part partner durante gli eventi stressanti.
- Le persone ambivalenti hanno ricevuto nelle relazioni passate un insieme di sostegno e di cure incoerente o imprevedibile. Come risultato, queste persone, di solito, sono piene di risentimento verso le figure di attaccamento e mettono continuamente in discussione il proprio valore. Talvolta,le persone con un alto grado di ambivalenza sviluppano opinioni negative di se stessi e positive degli altri significativi, verso i quali hanno aspettative piene di speranza (anche se accompagnate da sospetto e incertezza). Date le opinioni negative che hanno di se stessi, queste persone sono sempre vigili e attente ai segni e agli indizi di possibili abbandoni (specialmente nei confronti delle percezioni di peggioramento della disponibilità e del supporto del loro partner). Come risultato, sono combattute tra il desiderio di cercare supporto dai loro partners e quello di reagire con rabbia. Esse sono convinte di non aver ricevuto nel passato un sostegno sufficiente dalle loro figure di attaccamento nei momenti di reale bisogno e, come conseguenza, anche nelle relazioni attuali hanno spesso la percezione di ricevere un supporto insufficiente, a meno che non capiti loro di avere dei partners particolarmente capaci di offrire un supporto valido ed esplicito. Tutte queste percezioni negative hanno effetti perniciosi sulla qualità e sul funzionamento delle loro relazioni, particolarmente nel corso di evento stressanti.
Il ruolo dell’ ecografia nello sviluppo della cogenitorialità
Durante la gravidanza, nella fase di transizione alla genitorialità, un ruolo importante viene assunto dal bambino che sta per nascere; la letteratura sulle dinamiche psicologiche in gravidanza evidenzia come durante il corso della gravidanza vi sia un graduale cambiamento nella percezione che i genitori hanno del bambino che viene percepito ad un livello più immaginario all’inizio della gravidanza per poi diventare sempre più concreto con il passare del tempo e soprattutto con i primi movimenti fetali. L’ecografia ostetrica è una procedura diagnostica che, effettuata di routine durante la gravidanza, si inserisce nel processo psicologico dell’attesa, determinando un cambiamento nel processo immaginario dei genitori che si devono confrontare con un’immagine visiva del figlio.
Missonnier (1999) definisce l’ecografia come un rituale di iniziazione alla genitorialità e come una via di accesso privilegiata per accedere alla relazione precoce tra i genitori ed il figlio, infatti l’ecografia può diventare un importante momento di incontro con il bambino, permettendo ai genitori di sviluppare quel legame speciale con il figlio, che da fagiolino o chicco di caffè della prima ecografia, diventerà piano piano bambino e figlio, con un volto ed un’identità propria.
A livello psicologico l’ecografia viene percepita generalmente come un’esperienza positiva, in particolare dalle madri, che oltre ad essere rassicurate sul benessere del bambino ed avere una conferma visiva della realtà della gravidanza, possono condividere il bambino con il marito e con gli altri membri familiari Garcia; inoltre già a partire dal secondo trimestre di gravidanza, dopo avere visto l’ecografia entrambi i genitori iniziano a pensare al feto come al proprio bambino e ad immaginare se stessi come madre e padre.
Attualmente è riconosciuto che le ecografie ostetriche del secondo trimestre di gravidanza sono i principali fattori coinvolti nella formazione del legame materno-fetale (bonding); nell’ultimo trimestre di gravidanza, l’ecografia contribuisce a rinforzare la relazione con il figlio permettendo ai genitori di riconoscere aspetti più specifici del bambino: i movimenti delle braccia e delle gambe, i movimenti che il bambino fa con la bocca e soprattutto i lineamenti del volto (Campbell, 2006).
Le particolari caratteristiche fisiche e morfologiche del volto del bambino -una grande testa sproporzionata rispetto al corpo, una fronte molto ampia e sporgente rispetto al resto del volto, occhi molto grandi rispetto all’ampiezza del viso e guance paffute e sporgenti- costituiscono infattiquello che Lorenz ha definito il prototipo infantile (babyness), un elemento universale che distingue i piccoli della specie e che attrae irresistibilmente gli adulti, assolvendo la funzione di meccanismo innato per indurre i genitori ad occuparsi dei piccoli. Inoltre l’ecografia è condivisibile con il partner, permettendo anche ai padri di accedere al bambino in modo più diretto rispetto alla mediazione del corpo materno e di condividere all’interno della coppia le fantasie coscienti sul figlio. A livello psicologico, l’ecografia ostetrica può essere quindi considerata come un fattore che contribuisce alla transizione alla cogenitorialità, impegnando la coppia in una riorganizzazione delle rappresentazioni mentali del figlio, di se stessi e del partner come genitori, attraverso l’integrazione dell’immagine visiva del bambino.
ARTICOLO CONSIGLIATO:
La gravidanza vista dall’interno di Joan Raphael-Leff – Recensione
BIBLIOGRAFIA:
- Zaccagnini, C., Zavattini, G.C. (2005). Transizione alla genitorialità, conflitto coniugale e adattamento del bambino: le relazioni, i processi e le conseguenze. Psicologia clinica dello sviluppo, a. IX, vol.1.
- Ammaniti, M., Mazzoni, S., Menozzi, F. (2009). Ecografia in gravidanza e interazioni genitoriali. Relazione presentata al convegno internazionale La nascita della cogenitorialità in gravidanza. Roma, 23 Gennaio.
- Leveni, D., Morosini, P., Piacentini D. (a cura di). (2009). Mamme tristi. Vincere la depressione post parto. Trento: Erickson.
- Dellabatola, (2013). Il contributo della psicopatologia ansiosa materna prenatale sul temperamento infantile e la relazione precoce madre-bambino. Tesi di Dottorato.