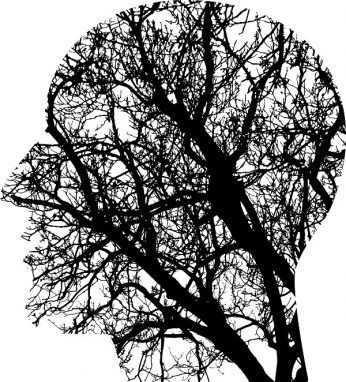Il cervello ha una mente propria (2022): una mappa (meta)teorica per le psicoterapie – Recensione
Obiettivo esplicito del volume “Il cervello ha una mente propria” non è semplicemente quello di colmare le intenzioni del padre della psicoanalisi, quanto invece, di estenderle e ristrutturarle, al passo coi nostri tempi.
Abstract
Il nuovo volume di Holmes, intitolato
“Il cervello ha una mente propria: attaccamento, neurobiologia e la nuova scienza della psicoterapia”, tenta di integrare la
psicoanalisi (e più in generale la psicoterapia) con le scoperte derivanti dalla moderna neurofisiologia, ricorrendo ad un’ottica complessa ed interdisciplinare, tale da tenere assieme la fisica quantistica, la teoria della probabilità, i modelli evoluzionistici, quelli neurocomputazionali e molto – davvero, molto – altro.
A seguire sarà proposta una sintesi critica ed approfondita del volume, densa di riflessioni contestuali in linea con gli argomenti trattati.
Introduzione: mappare una nuova scienza per la psicoterapia
A prima vista il libro di Holmes – professionista noto soprattutto per i suoi contributi alla teoria dell’attaccamento – sembrerebbe l’ennesimo tentativo di concludere lo sforzo incompiuto, che Freud iniziò ad abbozzare nel 1895 all’interno del “Progetto di una psicologia”, sperando di conferire alla nascente psicoanalisi un solido terreno neuroscientifico e metateorico; compito, questo, poi comprensibilmente sfumato – soprattutto alla luce delle conoscenze teoriche e delle metodologie di ricerca, a cui le scienze psicologiche possono attualmente fare ricorso. D’altronde, l’ambizione di strutturare una metapsicologia rappresentava per lo stesso Freud una impresa assai ardua. Non a caso, ad oggi, non si è ancora giunti ad una sua soddisfacente e comune ridefinizione (Imbasciati, 2010; Solms, 2022).
È da queste premesse che muove, per l’appunto, la digressione di Holmes, ironicamente intitolata “Il cervello ha una mente propria”, vale a dire: una logica tutta sua.
Obiettivo esplicito del volume non è semplicemente quello di colmare le intenzioni del padre della psicoanalisi, quanto invece, di estenderle e ristrutturarle, al passo coi nostri tempi.
Il volume di Holmes, infatti, tenta di integrare le scoperte derivanti dalla neurofisiologia attuale con la psicoanalisi (e più in generale con la psicoterapia), ricorrendo ad una ottica molto complessa e interdisciplinare, tale da tenere assieme la fisica quantistica, la teoria della probabilità, i modelli evoluzionistici, quelli neuro computazionali e molto – davvero, molto – altro. Il tutto, a detta di chi scrive, pare condensarsi in un interessante contributo.
Nella prefazione del volume, Alessandro Zennaro, chiarisce come l’autore non si rifaccia praticamente mai, nel corso delle pagine, a concetti di tipo pratico e, tanto meno, mai giunga a delle conclusioni definitive; l’intero volume, in tal senso, dovrebbe essere inteso non come un viaggio ma come una mappa; dalla quale potersi spostare, cambiare prospettive e camminare in direzioni nuove ed originali, su strade, in parte, già battute e segnate da Holmes – in attesa d’esser ulteriormente esplorate.
L’ARTICOLO CONTINUA DOPO L’IMMAGINE

Seppur ostico, questo libro, lo consiglierei proprio per la ricchezza dei rimandi bibliografici e degli stimoli inediti; tuttavia, a detta di chi scrive, un certo amaro potrebbe restare in bocca, dettato da quel tentativo – permettetemi – probabilmente poco coraggioso di voler salvaguardare a tutti i costi alcuni concetti psicoanalitici classici, del tutto obsoleti se rapportati sia alle neuroscienze attuali che (soprattutto) agli interessanti spunti avanzati, di pagina in pagina, dallo stesso Holmes.
Quasi un autosabotaggio – quasi! – considerando quanto scrive l’autore (p.7, Holmes, 2022):
Gabbard e Odgen, riprendendo forse inconsciamente Totem e Tabù di Freud hanno descritto il paradossale percorso dei membri del clan psicoanalitico, i quali devono contemporaneamente uccidere il padre e onorare i propri antenati. Con questo spirito la mia trattazione è al contempo un omaggio a Freud e, in parte, una ricerca di un paradigma post-psicoanalitico.
La probabilità curva le forme che usiamo per pensare: l’omeostasi nei sistemi dinamici complessi
Dettagli a parte, il concetto cardine che Holmes introduce all’interno del suo libro è quello di FEP – free energy principle: il Principio di Energia Libera (il corrispettivo di libido, in chiave 2.0), secondo cui, l’energia (in senso lato), non andrebbe intesa come uno specifico fenomeno fisico, bensì come una categoria sovraordinata, alla stregua della forza di gravità.
Gli agenti biologici (ad es. gli esseri umani), in linea con la teoria dei sistemi dinamici complessi (Seligman, 2005; Verdesca, 2018b), tenderebbero a legare – o, in termini Freudiani, ad investire – la propria energia, al fine di contrastare il disordine (l’entropia) che altrimenti ne conseguirebbe.
Secondo la teoria avanzata da Holmes, difatti, la prima funzione del cervello (a) sarebbe quella di organizzare e garantire l’omeostasi, destreggiandosi tra il bombardamento di stimoli sensoriali eterocettivi e propriocettivi. Tale omeostasi (equivalente al principio di costanza Freudiana in chiave moderna) si raggiungerebbe per mezzo di un costante processo di selezione e previsione dei dati in entrata (ossia del qui ed ora, e cioè, del presente) a partire dai dati in possesso (ossia l’esperienza già acquisita nel passato). A tal proposito Holmes scrive (p.15) che “il passato è l’unica guida per il futuro”. L’autore, in maniera più semplice, va riferendosi in tal senso al concetto di aspettative, organizzate in modelli generativi e predittivi del mondo (Neisser, 1997).
Questo processo previsionale, illustrabile facendo ricorso alla teoria della probabilità di Bayes, punterebbe a minimizzare quanto più possibile le eventuali deviazioni dallo stato implicitamente previsto – in tal senso: desiderato – dal quel soggetto, alla luce della sua biografia.
D’altronde, il modo in cui il cervello costruisce la propria realtà sarebbe basato su bias ed euristiche, tese ad approssimazioni, distorsioni, interpolazioni. Tali operazioni, secondo Holmes, costituirebbero di fatto “il sistema immunitario psichico” del soggetto – ossia, il ventaglio delle sue difese psicodinamiche (ibidem, p.96). In merito, scrive Holmes (p.49):
Se i disturbi mentali sono malattie del cervello sociale, verosimilmente l’evoluzione avrà elaborato dei meccanismi di riparazione spontanei e culturalmente mediati in grado di renderli reversibili o di mitigarli. Per evitare l’entropia, gli organismi viventi hanno strutturato alcune difese che li aiutano a contrastare il caos, a mantenere una struttura, nonché a incrementare l’adattamento e le probabilità di sopravvivenza. Negli esseri umani, le difese operano “a tutti i livelli”, da quello cellulare del sistema immunitario, attraverso le dinamiche interpersonali di attaccamento, per arrivare alle strutture che definiscono l’organizzazione di una società e che spaziano dall’assistenza sociale, alle dighe foranee, agli armamenti militari. Questi meccanismi difensivi, al pari dei sistemi che devono proteggere, sono inizialmente involontari e automatici ma, quando vengono potenziati mediante interventi diretti e intenzionali, diventano formazioni destinate a uno scopo socialmente determinato.
In altre parole: “La probabilità curva le forme che usiamo per pensare (p.13, ibidem)”. Non a caso, l’autore, ha pensato bene di definire l’equilibrio omeostatico e idiosincratico, peculiare ad ogni individuo, come equilibrio allostatico. La realtà, dunque, è plasmata, manipolata, sulla scorta dei desideri propri del soggetto, il quale tenderebbe ad assimilare gli eventi in base alle forme dei propri schemi e delle proprie categorie, di volta in volta (pre)messe in conto – una sorta di profezia che tenderebbe ad autodeterminarsi tramite prove ed errori, conferme e disconferme (Waztlawick et al, 2011; Piaget, 2017). Tuttavia “la minimizzazione dell’errore di previsione [in gergo PEM] non è mai completa o esatta. Essa straripa sempre” (Holmes, 2022, p.75).
Le mappe, insomma, raramente coinciderebbero con il territorio (Korzybski, 1958), analogamente a come le aspettative sarebbero sovrapponibili alla realtà.
In sintesi, il primo compito del sistema mentale – parafrasando Holmes – sarebbe quello di garantire una percezione di sicurezza e di controllo ambientale quanto più possibile vicina alle proprie aspettative, se volete, inconsce; non a caso, a livello cognitivo-affettivo, tale concetto, trova riscontro in quello di Internal Working Model e, più in generale, nella teoria dell’attaccamento, campo di studi molto caro ad Holmes (ad es. 1993; 1994; Verdesca, 2018; 2020; 2022).
Ridurre la discrepanza tra aspettative e realtà restituirebbe, dunque, al soggetto un senso di stabilità e coerenza, permettendogli – per mezzo di opportune operazioni difensive – il lusso di poter semplificare l’infinita complessità cui il mondo e il flusso informativo dell’ambiente circostante consiste – con gli intrinseci vantaggi e rischi evolutivi connessi a tale operazione mentale.
“La realtà di cui facciamo esperienza è per definizione virtuale, in questi termini, creata in maniera dinamica dal teatro della mente (p.90)”.
L’ARTICOLO CONTINUA DOPO L’IMMAGINE
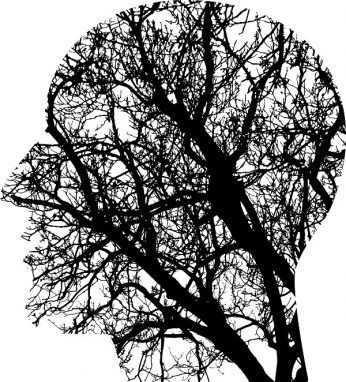
Home sweet home, ovvero, (r)esistere nell’entropia restando “a casa”
Tornando a noi, quanto detto consisterebbe nella (b) seconda funzione cui il cervello contribuirebbe: quella di resistere attivamente all’entropia. “Le cose possono andare male in molti modi differenti. In primo luogo, vi è il costante pericolo di un trauma. Nonostante le nostre migliori strategie, interferenze ambientali imprevedibili, inaspettate e deleterie possono sopraffare la PEM (p.41)”. È una questione di economia psichica, difatti “se qualcosa è del tutto improbabile, allora è sorprendente (p.13)”. In altre parole, potenzialmente, traumatica.
In linea di massima, sarebbe però possibile per il cervello garantire tale risultato – quello di tendere ad una continua riconferma delle proprie aspettative – ricorrendo a tutta una serie di inferenze attive (razionalizzazione, proiezione ecc) con il fine ultimo di condurre l’essere umano verso attrattori stabili, stati psico-somatici percepibili come familiari, situabili all’interno della propria comfort zone o, in altri termini, della propria nicchia ecologica. Insomma, sarebbe un po’ come sentirsi a casa – sia essa una splendente regia o una angusta capanna; poco importa: home sweet home, per intenderci – soprattutto quando l’ambiente da esplorare è percepito come pieno zeppo di minacce!
In sintesi, e fuor di metafora, i soggetti, creerebbero attivamente – e cioè si metterebbero nella situazione di rivivere – sempre le stesse storie; modellando in maniera allostatica l’ambiente relazionale, tale da renderlo quanto più assimilabile alle caratteristiche delle esperienze passate – tale processo è noto in psicoanalisi interpersonale come identificazione proiettiva. È per questo che un soggetto preferirebbe aggrapparsi alla propria visione del mondo, anche se considerevolmente svantaggiosa e disfunzionale, anziché compiere azioni per disconfermarla, poiché farlo potrebbe comportare molti rischi, nella misura in cui potrebbe esporre il soggetto all’incertezza dell’ignoto – ad es. a nuove attività quotidiane, conversazioni terapeutiche e propositive, ecc.
L’inconscio e la psicoterapia secondo la (meta)teoria di Holmes
Il corpus teorico, sintetizzato sin qui, corrisponde sostanzialmente al primo capitolo del volume in oggetto; nel corso dei capitoli, Holmes, tenterà di applicare le proprie digressioni al mondo della psicopatologia. L’autore espanderà il suo modello ramificandolo con temi di matrice psicoanalitica, con le neuroscienze relazionali (ad es. con le evidenze empiriche derivanti dal campo della sincronia biocomportamentale, con la mentalizzazione, la teoria polivagale e la psicologia culturale, il filone della teoria dell’attaccamento, ecc.) giungendo, infine, alle implicazioni che l’intero corpus da lui delineato avrebbe sul funzionamento stesso della psicoterapia.
Essa, la psicoterapia, equivarrebbe alla riapertura di un periodo sensibile, tale da permettere al paziente una rimodulazione affettivo-viscerale della propria esperienza vitale, consentendogli una ristrutturazione (una convalida o una disconferma) delle proprie premesse interpretative (Beck, 1984; Siegel, 2019; Verdesca, 2018a; 2020c;). Gli interventi psicoterapeutici avrebbero, dunque, il fine di disaccoppiare, decondizionare, le credenze e gli automatismi senso-motori disfunzionali, non solo rendendoli consci ma sostituendoli con nuove modalità interattive inedite, all’insegna della sicurezza interpersonale, dell’intimità e della fiducia. Il terapeuta dovrebbe, dunque, garantire la funzione di holding, divenendo una mente in prestito per il paziente (Winnicott, 1960; Holmes, 2022). L’esito di quanto detto sarebbe quello di individuare ed interrompere i pensieri veloci ed automatici disfunzionali (siano essi credenze inconsce, immagini preconsce, attivazioni sensomotorie, ecc) che la mente tenterebbe puntualmente di agire e performare in cerca di sicurezza (Beck, 1984; Kahneman, 2012;). L’obiettivo di tali interventi sarebbe quello di aprirsi al cambiamento – senza più limitarsi fisiologicamente a resistere ad esso.
L’inconscio, nell’accezione di Holmes – e come suggerito dalla scelta del titolo conferito al libro – costituirebbe un processo vasto e implicitamente (molto più cognitivo) di quanto la psicoanalisi classica in definitiva sostenesse, retto da una logica propria e ben articolata; logica, evidentemente molto complessa, ma non per questo necessariamente complicata se ben inquadrata.
In conclusione, dunque: “Il fondamento relazionale della psicoterapia aiuta i clienti a tollerare la sorpresa e a sopravvivervi e quindi a trovare modalità nuove e più sane di legare l’energia mentale (Holmes, 2022; p. 95)”, espandendo e moltiplicando le possibilità interpretative e operative della realtà.
Note a margine: verso una teoria contestuale ed integrata del cambiamento
Holmes, in chiusura del volume, esplicita la teoria del cambiamento alla base della sua proposta (meta)teorica:
Il mio entusiasmo per il FEP proviene anche dalla prospettiva dell’integrazione in psicoterapia che afferma che gli aspetti murativi di quest’ultima derivano da fattori comuni, che comprendono la relazione terapeutica stessa, una cornice teorica coerente e degli interventi che promuovono il cambiamento. La prospettiva di questo approccio è basata sui fattori comuni (Wampold, 2015). Se la salute psicologica è associata alla necessità di legare l’energia libera e minimizzare l’errore di previsione, allora tutti gli interventi che promuovono questo saranno probabilmente di grande aiuto, indipendentemente dal nome con cui vengono chiamati. Tra questi: riattivare la capacità di agency; incrementare il campionamento sensoriale attraverso gli “esperimenti” cognitivo-comportamentali o le libere associazioni psicoanalitiche; ampliare il ventaglio delle possibili ipotesi top-down mediante l’analisi e l’interpretazione dei sogni e “l’immaginazione attiva”; promuovere una tristezza che attivi il cambiamento; modificare gli a priori alla luce dell’esperienza (Holmes, 2022, pp.94-95).
Infine, è altrettanto interessante mettere in evidenza come l’autore – in chiave contestuale e costruttivista – concepisca la psicoterapia quale frattale di un processo più generale orientato al cambiamento:
(…) la psicoterapia, anziché essere un intruglio esoterico, costituisce l’esempio di una “tipologia naturale”, una forma specializzata di un fenomeno culturale più generale, sempre più necessaria in contesti che cambiano continuamente e in modo imprevedibile. Molti aspetti della vita culturale (il gioco, lo sport, la recitazione, l’iconografia) dipendono dal “disaccoppiamento” dei processi top-down e bottom-up, unito alla meta cognizione che favorisce la PEM che, a sua volta, promuove la salute. Un’opera di Shakespeare o un concerto rock liberano energie erotiche e distruttive ma, al termine dello spettacolo, nessuno ha subito danni o violenze (o almeno si spera), come dimostrano l’inchino degli artisti e l’applauso degli spettatori. L’omeostasi psicologica essenziale per una vita libera è per sua natura vulnerabile alle forze dell’entropia. Apprendere dall’esperienza, tollerare l’errore di previsione e risolverlo dipende in larga misura dalle possibilità generative delle relazioni intime. Le società che suscitano ansia, passività, disuguaglianza, isolamento e insicurezza compromettono lo sviluppo della capacità di legare questa energia libera nel bambino in via di sviluppo (ibidem, pp.94-95).