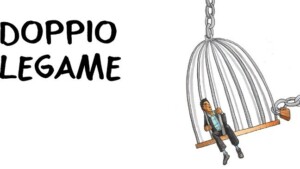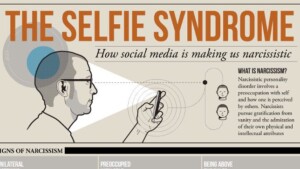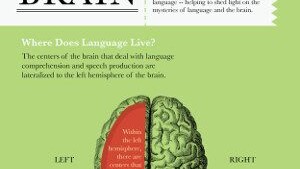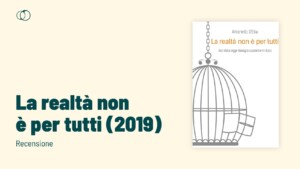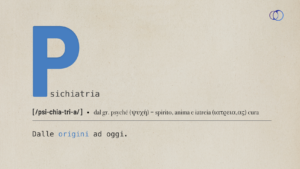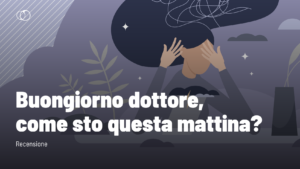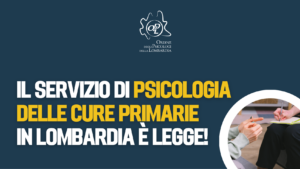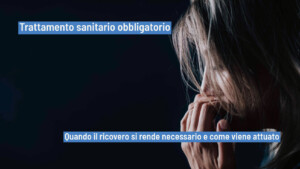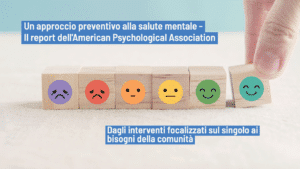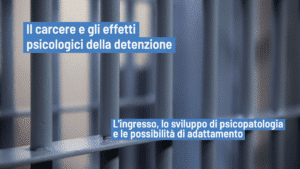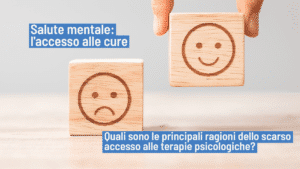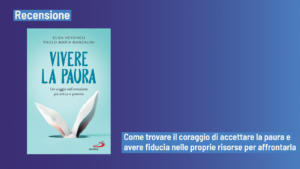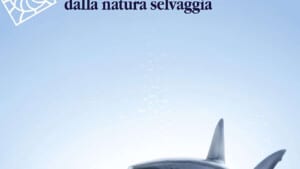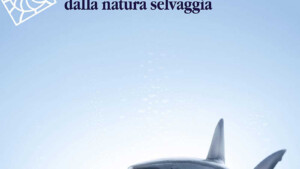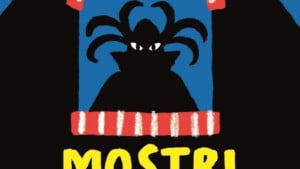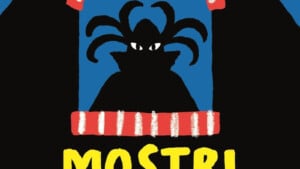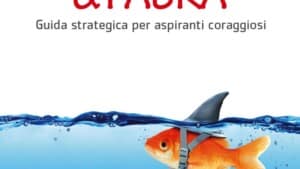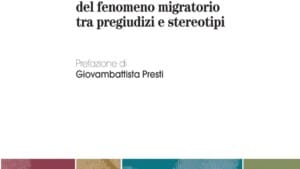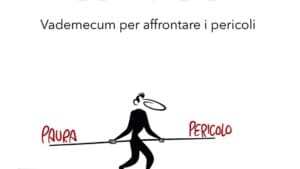Schiavo d’amore di Somerset Maugham (1915) – Psicologia & Letteratura
Giuseppe Centra
Le sue relazioni tumultuose, l’instabilità delle sue emozioni con tanto di ricorso alla scissione, le sue reazioni di rabbia, terrore e manipolazione all’abbandono e al rifiuto, la sua impulsività e i suoi acting out, la sua promiscuità e non ultimo, la sua auto ed etero-distruttività, non dimentichiamoci l’esperienza della prostituzione, sembrano orientare la donna all’interno di una dimensione borderline di personalità.
Nel romanzo “Schiavo d’amore” (1915) di Somerset Maugham va subito evidenziata la peculiarità, tutta italiana, di storpiare i titoli originali di un’opera. Infatti, il titolo italiano non coglie il richiamo a Spinoza e in particolare alla quarta parte della sua grande opera Etica intitolata appunto “Sulla schiavitù umana” (De servitute humana, o Of human bondage in ingl.) dedicata alla trattazione delle emozioni umane.
Il romanzo di formazione racconta della vita di un uomo con un difetto fisico (un piede equino) dall’infanzia, orfano, fino al raggiungimento dell’abilitazione medica che pone fine a una serie di avvenimenti altalenanti, spostamenti internazionali, incontri drammatici che segnano nell’animo il protagonista. Il libro, ovviamente, non è solo una cronaca della vita del protagonista ma scava in profondità nella mente e nel cuore dei personaggi alla ricerca del senso dell’esistenza il quale, a fine libro, sembra essere trovato al prezzo di una traccia, di una cicatrice che rimarrà indelebile per sempre nell’animo del protagonista.
Il personaggio di cui voglio parlare, però, è una giovane cameriera di nome Mildred, la quale entra in scena solamente a pagina 277 ma sarà destinata a segnare per sempre la vita di Philip, il protagonista: “…aveva i lineamenti regolari e minuti, gli occhi azzurri e la fronte larga e bassa … una gran massa di capelli con frangetta che le ricadeva sulla fronte … le labbra sottili erano pallide e la pelle delicata, di un tenue color verdolino, senza una punta di rossa nemmeno sulle guance…”.
Ciò che appare subito interessante sono le reazioni ambivalenti di Philip; infatti, la donna si mostra fredda e disinteressata al suo tentativo di attaccar bottone, suscitando in lui repulsione e disgusto (forse per lo smacco preso); eppure a partire dalla stessa notte non smette più di pensarla, autocommiserandosi per l’assurdità della situazione. Alla fine, di punto in bianco le chiede di uscire una volta insieme e lei accetta. La serata si rivela abbastanza mediocre e Philip la lascia con il terrore di averla annoiata. Tuttavia, a modo suo, lei gradisce le gentilezze di Philip, il quale si scopre innamorato. Mildred non dà mai l’impressione di accettare la sua corte ma non disprezza tutti i favori, anche economici, che lui le elargisce. Allo stesso tempo ciò fa nascere in Philip un sentimento di disprezzo che si accompagna, però, con un folle desiderio di lei.
Ecco a un certo punto la qualità del loro rapporto (p. 313): “…Non si lasciava (Philip) turbare dalla sua disattenzione, né irritare dalla sua indifferenza … Con uno sforzo diventò affabile e divertente, senza mai andare in collera, senza mai chiedere niente, senza lamenti, senza rimbrotti. Quando lei lo piantava in asso per un altro impegno, l’indomani si presentava con viso sorridente; se lei si scusava, diceva non importa. Non le lasciava mai capire che lo addolorava. Si rendeva conto che la sua sofferenza appassionata l’aveva infastidita, e badava a nascondere qualunque sentimento che potesse riuscire minimamente molesto. Era eroico…”.
Ma proprio quando si sta sciogliendo, Mildred gli rivela di aver accettato la proposta di matrimonio di un giovane che le bazzicava intorno sin da prima che incontrasse Philip. E quella che poteva essere una liberazione, per Philip si rivela una notizia angosciosa considerando la sua passione per lei (p. 333): “…Sotto l’influsso della passione si era sentito animato da un singolare vigore, e la sua mente aveva lavorato con forza inusitata. Era più vivo, c’era nel semplice esistere un’eccitazione, un ardore dell’anima, al cui confronto la vita appariva un po’ grigia. L’infelicità sofferta aveva pur avuto un compenso in quella sensazione di vitalità impetuosa e soverchiante.”. Era ancora innamorato!
Ma un pomeriggio, tornato a casa dall’ospedale trova Mildred che lo aspetta; scoppiando a piangere rivela di essere stata piantata e non avendo altre persone a cui rivolgersi pensò proprio a Philip per chiedere aiuto. Nel giro di pochi giorni la vita di Philip torna a girare intorno a lei, smette di sentirsi con amici e con la donna con cui aveva cominciato una frequentazione e non si spaventa nemmeno davanti alla rivelazione di Mildred di essere rimasta incinta. Pur facendolo con gioia, Philip stava sperperando gran parte della sua rendita per mantenerla.
In preda all’entusiasmo, Philip decide di far conoscere Mildred a un suo caro amico, Griffiths, collega del corso di medicina Purtroppo Griffiths, donnaiolo di fama, pur promettendo di non fare del male a Philip si invaghisce, ricambiato, di Mildred. Quest’ultima rivela a Philip di aver deciso di andare a vivere con Griffiths in un’altra città. Philip va su tutte le furie e minaccia di non passarle più un soldo (p. 378): “Hai dimenticato che quando eri nei guai ho fatto di tutto, per te? Ho sborsato i soldi per mantenerti fino alla nascita della bambina, ho pagato il dottore e tutto quanto, pago il mantenimento di tua figlia, i tuoi vestiti, pago ogni filo che hai addosso.”. A questo punto è Mildred a rivolgersi a lui con disprezzo (p. 378): “Non mi sei mai piaciuto, fin dal principio, ma tu ti sei attaccato per forza. Ho sempre odiato i tuoi baci. Adesso non mi lascerei toccare da te neanche se morissi di fame.”
Da questo estratto è evidente come Mildred di fronte all’ostacolo che si interpone al suo sogno ha uno sbalzo repentino: da persona grata e riconoscente nei confronti di Philip, a una svalutazione primitiva che le fa provare rabbia e disprezzo nei suoi confronti. Si può riconoscere, evidentemente, il meccanismo difensivo della scissione, processo per cui una persona considera se stesso o gli altri come tutti buoni o tutti cattivi, mostrando difficoltà a integrare gli aspetti sia positivi sia negativi in uno stesso individuo (Lingiardi e Madeddu, 2002). Tale difficoltà limita la qualità dei rapporti interpersonali dal momento che semplici gesti possono essere enfatizzati e così, alla mattina una persona può essere un salvatore e, alla sera, lo stesso diviene causa di tutti i mali.
E infatti, Mildred, dopo aver mandato a monte la relazione con l’uomo che voleva sposarla, si getta a capofitto anche nella relazione con Griffiths, il quale però vuole solo un’avventura e la abbandonerà per tornare alla sua vita di scapolo.
La drammaticità della personalità della donna emerge con tutta la sua forza proprio dopo la conclusione di questa avventura, infatti, diversi mesi dopo, mentre Philip passeggia per Piccadilly Circus, la riconosce mentre passeggia facendo la spola da un punto a un altro della piazza. Philip capisce immediatamente, anche dagli abiti indossati, che Mildred si è data alla prostituzione. L’uomo a questo punto, tra l’attrazione e il disgusto che gli suscita la vista di quella donna, si offre comunque di darle una mano e la porta a casa con sé; le offre la possibilità di lavorare per lui come colf e in cambio le offre una stanza al patto che tra di loro non si crei l’intimità di un tempo.
La personalità del protagonista può meglio essere compresa analizzando la sua storia. La difficoltà a lasciarsi dietro una donna causa di atroci sofferenze non può essere giustificata solo con l’amore, ma è un invito a interrogarci anche sul suo funzionamento mentale: Philip non ha mai conosciuto suo padre e ha perso sua madre a 9 anni, viene cresciuto da una coppia di zii che non ha avuto figli propri. Lo zio in particolare, curato di un piccolo villaggio, ha una morale rigida che contribuisce alla formazione di un massiccio Super Io in Philip, il quale si proibisce bisogni e desideri al fine di percorrere la strada per lui già tracciata. Il modello genitoriale imposto dagli zii, basato su una ridotta espressività ed elevato controllo nel quale tutto è affrontato razionalmente mentre è represso ogni tentativo di vivere le proprie emozioni e i propri sentimenti potrebbero aver fatto maturare, in Philp, dei tratti dipendenti. Il protagonista, nella sua infanzia, non ha soddisfatto quel naturale bisogno di sana dipendenza affettiva da un caregiver e quando si scopre innamorato è incapace di gestire le giuste distanze nel rapporto. A conferma di ciò, vi sarebbero le reazioni di sottomissione e adesività che caratterizzano le personalità dipendenti (Gabbard, 2007) e di cui Philip fa ampiamente esperienza durante tutto il romanzo.
Tutta la difficoltà di una personalità dipendente a staccarsi dall’oggetto spicca quando Philip decide di aiutare Mildred togliendola dalla strada. Riflette che ormai qualcosa si è rotto, che tutte le lacrime versate, le sofferenze patite e le umiliazioni subite lo hanno logorato dentro e non riesce più a guardare Mildred con gli occhi di prima. Eppure decide di accoglierla in casa! E il tornare a vivere con lei non può non farci pensare a qualcosa di perverso nel suo funzionamento mentale.
L’acme del romanzo si raggiunge una notte quando Mildred decide di aspettare sveglia Philip, il quale aveva dedicato una serata ai vecchi amici. Al suo rientro, Mildred si mostra amorevole e premurosa, d’altronde le due esperienze di abbandono vissute l’avevano spinta a riflettere che accasarsi con Philip, sempre pronto a tutto per lei, era l’unica soluzione per garantire un futuro a lei e a sua figlia. Decide di giocarsi la sua carta migliore o forse la sua grande debolezza: la libido, la sua voluttuosità che drammaticamente l’aveva spinta a inseguire e a bruciare le sue precedenti relazioni.
Prova a sedurlo, ad accarezzarlo e baciarlo ma i sentimenti di Philip nei suoi confronti sono oramai consumati e vuoti e così la scansa, scatenando l’accanita reazione della donna (p. 490): “…Di te non mi è mai importato niente, nemmeno per un momento, ti prendevo in giro, sempre, mi annoiavi … e ti odiavo, non ti avrei mai permesso di toccarmi se non era per i soldi, e mi veniva la nausea quando dovevo lasciare che mi baciassi. Ridevamo di te, io e Griffiths, ridevamo di com’eri babbeo. Babbeo! Babbeo! … Storpio!”. L’indomani, come di consueto, Philip va in ospedale ma al suo ritorno trova la casa devastata, ogni cosa è distrutta e nulla è risparmiato, in compenso Mildred scompare.
Un’ultima riflessione va fatta sul personaggio di Mildred. Le sue relazioni tumultuose, l’instabilità delle sue emozioni con tanto di ricorso alla scissione, le sue reazioni di rabbia, terrore e manipolazione all’abbandono e al rifiuto, la sua impulsività e i suoi acting out, la sua promiscuità e non ultimo, la sua auto ed etero-distruttività, non dimentichiamoci l’esperienza della prostituzione, sembrano orientare la donna all’interno di una dimensione borderline di personalità.
Il disturbo borderline di personalità, infatti, si caratterizza per una marcata volubilità nel campo delle relazioni interpersonali, dell’immagine di sé e degli affetti, oltre a intensi vissuti abbandonici e spiccata impulsività (Lingiardi e Gazzillo, 2014). Come dice Kernberg (1984), sono persone che soffrono e che fanno soffrire: ne sa qualcosa il protagonista di Schiavo d’amore!
ARTICOLO CONSIGLIATO:
Amore e tradimento di Rubin Dunbar (2013) – Recensione – Letteratura
BIBLIOGRAFIA:
- Maugham S. W., (1915). Schiavo d’amore. Adelphi: Milano 2013.
- Gabbard G. O., (2005). Psichiatria psicodinamica. Raffaello Cortina: Milano 2007.
- Kernberg O. F., (1984). Disturbi gravi della personalità. Bollati Boringhieri: Torino 1987.
- Lingiardi, V. et Gazzillo, F., (2014). La personalità e i suoi disturbi. Raffaello Cortina: Milano.
- Lingiardi V. et Madeddu F., (2002). I meccanismi di difesa. Raffaello Cortina: Milano.
- Spinoza B., (1677). Etica. Armando Editore: Roma 2008.





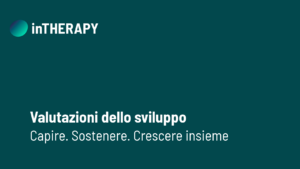


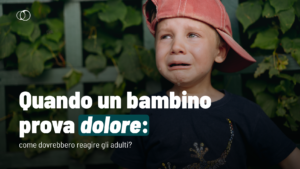









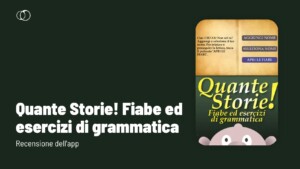









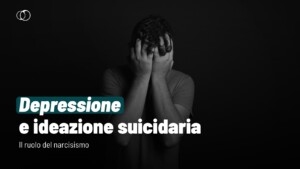
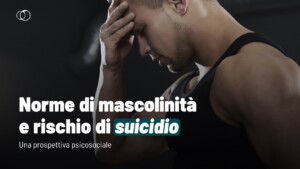
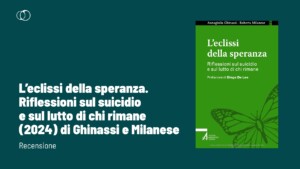


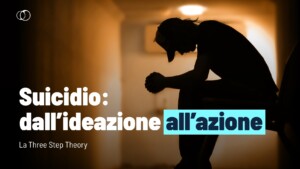
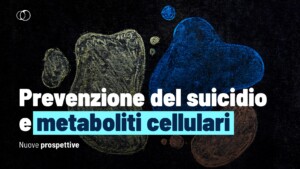


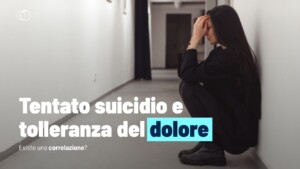
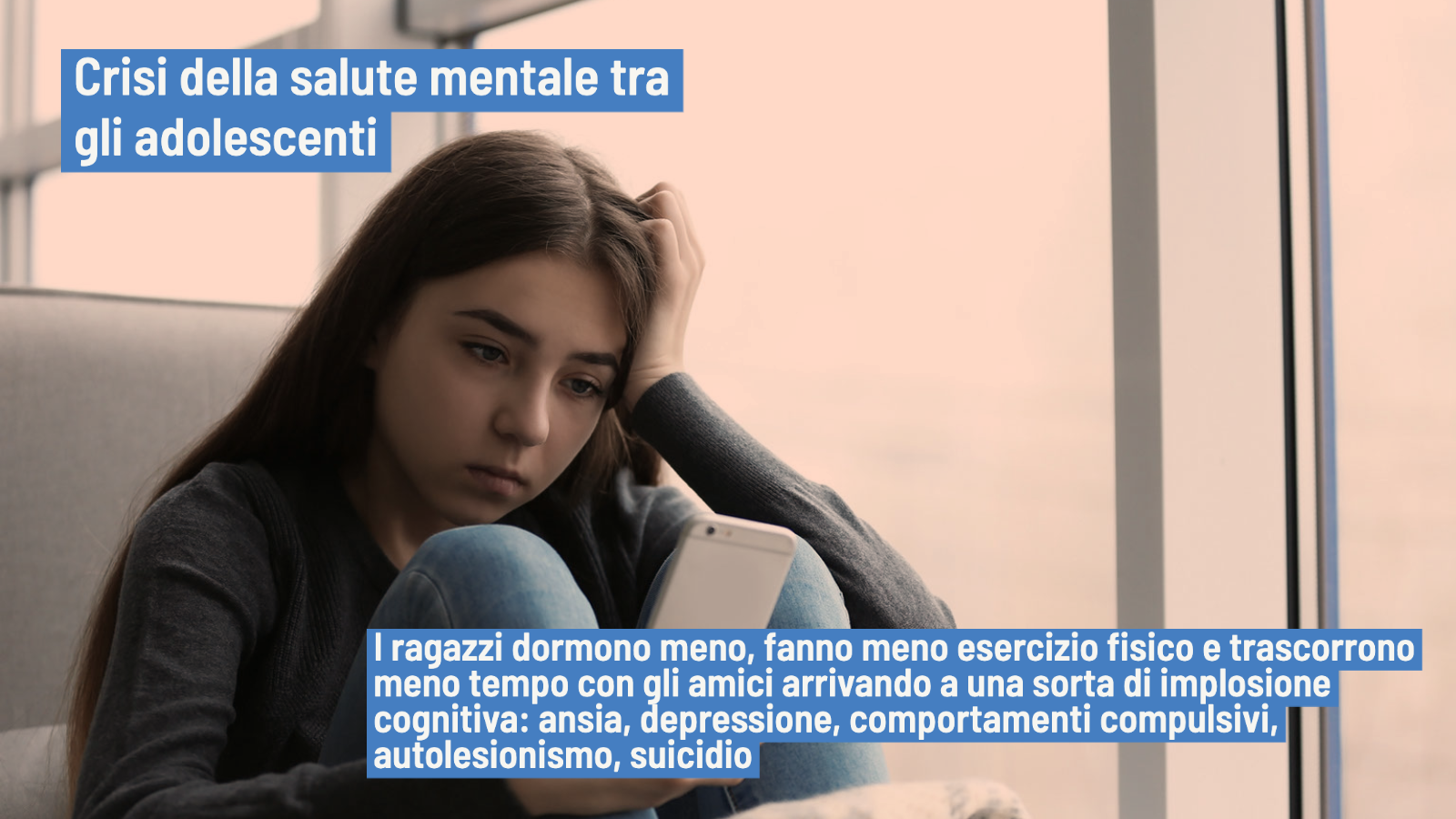
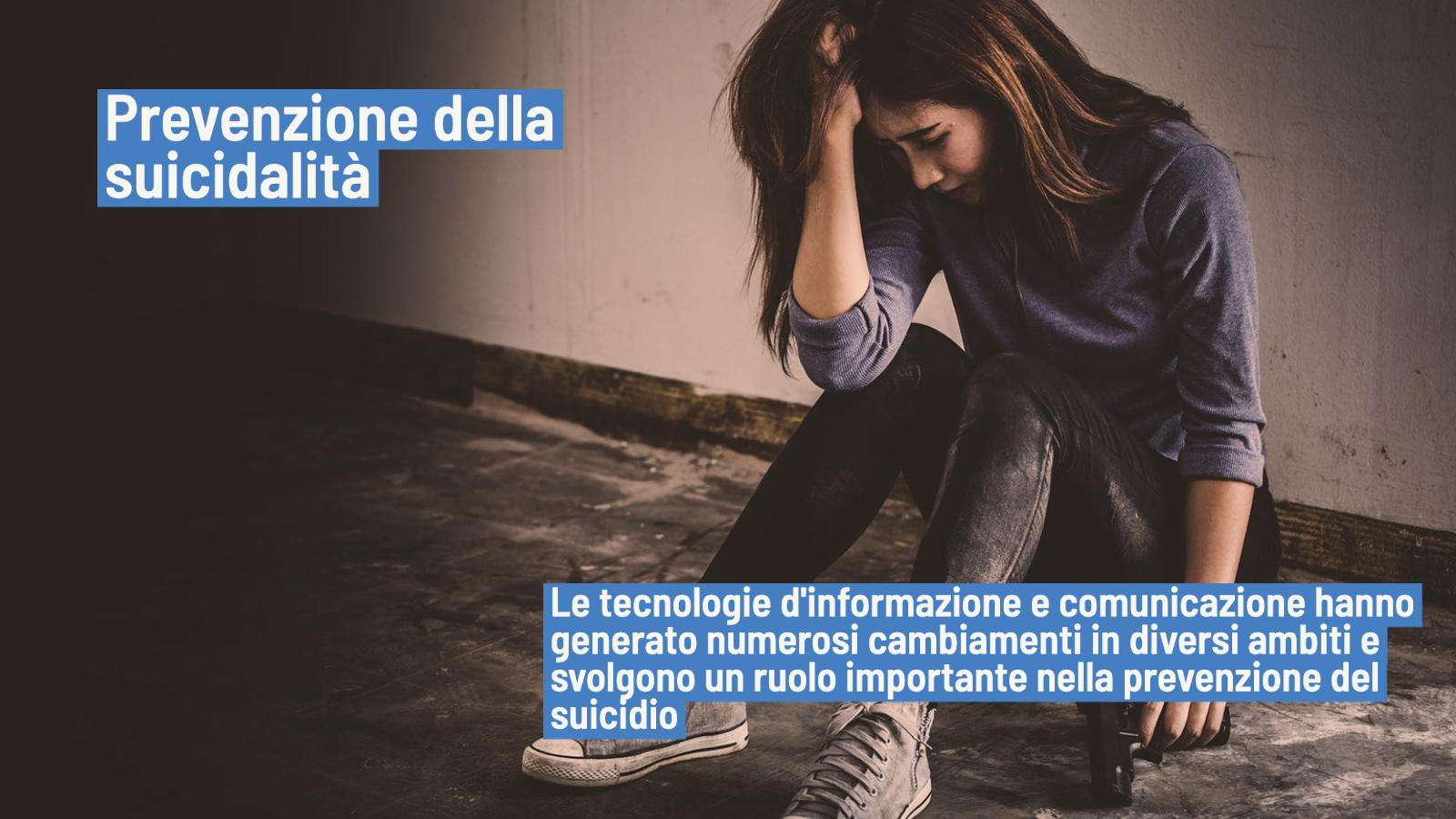
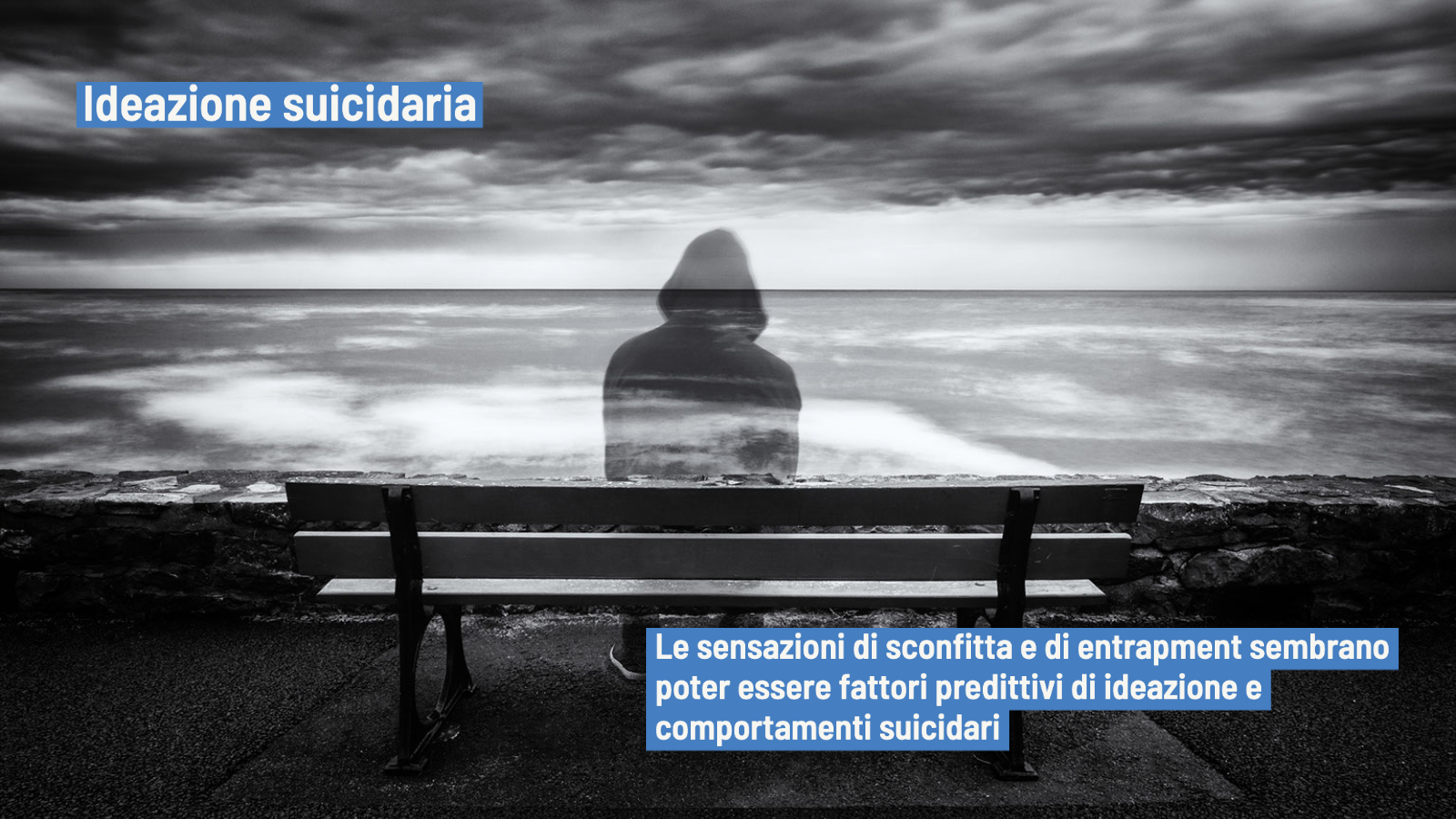


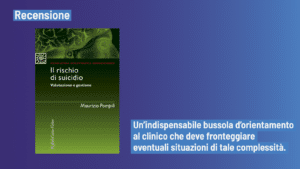

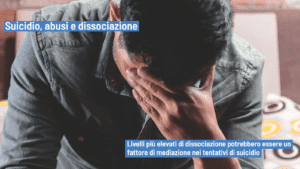

.jpg.aspx)