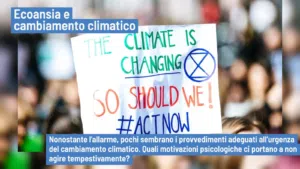Gli effetti del cambiamento climatico
Gli effetti del cambiamento climatico sulla salute mentale stanno sempre più interessando la comunità scientifica. Svariate review e recenti studi su larga scala fanno il punto sullo stato dell’arte di questa tematica. Ne emerge un quadro coerente secondo cui l’esposizione a disastri ambientali ed eventi climatici meteorologici estremi ha un impatto significativo sul benessere psicologico e sulla salute mentale delle persone.
È importante sottolineare che secondo diverse review tematiche (Charlson et al., 2021; Cianconi et al., 2020) e secondo le principali associazioni legate al mondo della salute mentale, come ad esempio l’American Psychological Association, il cambiamento climatico è riconosciuto come un fenomeno contemporaneo che può impattare sulla salute mentale delle persone e delle comunità di cui fanno parte, con effetti sia a breve che a medio-lungo termine. Gli impatti negativi del cambiamento climatico sulla salute e sul benessere degli individui, delle comunità e dei paesi sono sempre più gravi e frequenti.
Cambiamento climatico e salute mentale
I disastri naturali e gli eventi climatici estremi esacerbati dal cambiamento climatico possono avere effetti diretti e indiretti sul benessere psicofisico e sulla salute mentale degli individui.
Anzitutto, poiché si configurano come eventi traumatici. I dati raccolti da svariate fonti scientifiche ci restituiscono un quadro coerente secondo cui vi sarebbero effetti traumatici di media-intensa gravità di carattere acuto e post traumatico in persone esposte a disastri naturali quali inondazioni, condizioni metereologiche estreme, ondate di calore e incendi. Gli effetti traumatici diretti occorrono attraverso l’effettivo ferimento personale, o attraverso il ferimento o morte di persone care, danni e perdite di proprietà personali, distruzione o perdita della propria abitazione. Terrore, rabbia, reazioni di shock, e molte altre reazioni emotive intense possono emergere come iniziale risposta all’evento di un disastro naturale estremo (Raphael, 2007).
Il disturbo da stress post-traumatico (PTSD) è uno tra i possibili esiti in termini di salute mentale che possono insorgere a seguito di un disastro naturale o evento climatico estremo. Studi su popolazioni esposte a gravi uragani, come ad esempio l’Uragano Katrina del 2005 in Mississippi e Louisiana, hanno evidenziato che una persona su sei ha soddisfatto i criteri diagnostici del PTSD (Kessler et al., 2008; Lowe et al., 2013). Le inondazioni sono altri eventi climatici estremi che possono fungere da trigger per l’esordio di PTSD, con percentuali piuttosto elevate: alcuni studi riportano percentuali di PTSD dal 26 al 43% nelle popolazioni vittime delle inondazioni in Gran Bretagna (Munro et al., 2017). Similmente, percentuali elevate di PTSD si riscontrano nelle persone che si trovano a fare esperienza di incendi a macchia d’olio (Psarros et al., 2017).
Oltre al PTSD, ma anche in comorbilità con esso, si riscontrano ulteriori disturbi psicopatologici che possono essere conseguenti a eventi climatici estremi, tra cui sintomi depressivi, disturbi d’ansia, abuso di sostanze (Cianconi et al., 2020; Charlson et al., 2021). Generalmente, le difficoltà psicologiche post-disastro ambientale possono prolungarsi per mesi, tipicamente per circa 5-7 mesi, ma diversi studi evidenziano effetti a lungo termine anche oltre l’anno dall’evento. Le vittime di inondazioni, secondo alcuni studi, riportano distress psicologico per diversi anni a venire (Crabtree, 2012; Alderman et al., 2012).
I disastri naturali possono inoltre avere un impatto sulle infrastrutture sociali, compromettendo la funzionalità di sistemi educativi, sanitari, economici e di trasporto (Clayton, 2020). La distruzione di queste infrastrutture può essere un motivo sufficiente per incentivare la migrazione dei popoli. Il fenomeno della migrazione a seguito di un disastro naturale è un evento molto stressante, in quanto gli individui sono costretti a lasciare la propria abitazione e a trovare un nuovo luogo dove stabilirsi, con tutte le difficoltà che si possono riscontrare.
Che cos’è l’ecoansia
Anche per gli individui che non vivono in prima persona gli impatti diretti di disastri naturali o eventi climatici estremi, la consapevolezza del problema in materia di cambiamento climatico può essere accompagnata da emozioni negative, tra cui paure, rabbia, sensazioni di impotenza e sfinimento (Moser, 2007). Queste emozioni negative possono non riferirsi a quadri psicopatologici definiti; semplicemente prendere contatto con il lento e inesorabile andamento del cambiamento climatico può portare con sé preoccupazioni, stress e sofferenza riguardo il futuro per sé stessi e per le generazioni future.
Secondo l’APA per eco-ansia si intende “una paura cronica per il destino dell’ambiente e del pianeta”. Si tratta di forme di disagio e inquietudine, che si esprimono in modo variabile a livello clinico e subclinico, in considerazione dell’impatto del cambiamento climatico sul nostro pianeta.
L’ecoansia viene quindi definita come paura cronica di catastrofi ambientali, che comporta un’accentuata sofferenza emotiva, mentale o somatica in risposta ai pericolosi cambiamenti del clima (APA, 2017).
Alcune evidenze suggeriscono che l’ecoansia (o “climate anxiety”) è maggiormente prevalente tra i giovani adulti, mentre le generazioni più anziane ne sarebbero meno impattate (Chen et al., 2020). Una survey nazionale svolta nel 2019 negli Stati Uniti ha evidenziato che il 57% degli adolescenti intervistati riportavano preoccupazioni riguardo il cambiamento climatico (Kaplan & Guskin, 2019). Secondo ulteriori studi l’ecoansia emerge in maniera decisamente più significativa tra le persone che hanno esperito gli effetti diretti del cambiamento climatico.
Va precisato che l’ecoansia non assume necessariamente tratti patologici; vissuti di preoccupazione e di paura rappresentano segnali che ci mettono in allerta rispetto a pericoli e minacce che potremmo dover affrontare, in modo da direzionare in parte l’attenzione e gli sforzi per farvi fronte.
Nonostante tali emozioni possano avere una funzione adattiva, aiutando l’individuo a rimanere vigile verso possibili minacce, l’ansia può diventare una fonte di disagio nel momento in cui interferisce con la quotidianità di un individuo, divenendo difficile da controllare e causando complicazioni in diversi ambiti di vita, come il sonno o la socialità (Clayton, 2020).