La formazione in psicoterapia. Quale scuola scegliere dopo la laurea? – Recensione
 La formazione in psicoterapia: “Quale scuola scegliere dopo la laurea?”. E’ questo il quesito su cui noi psicologi ci interroghiamo dopo aver conseguito il diploma di laurea in vista di un futuro da psicoterapeuta.
La formazione in psicoterapia: “Quale scuola scegliere dopo la laurea?”. E’ questo il quesito su cui noi psicologi ci interroghiamo dopo aver conseguito il diploma di laurea in vista di un futuro da psicoterapeuta.
Quale sarà l’orientamento e, quindi, la scuola che ci permetterà di diventare dei terapeuti? Il manuale La formazione in psicoterapia – Quale scuola scegliere dopo la laurea?, a cura di Alberto Zucconi ed edito da Alpes, offre un valido strumento per orientarsi nella scelta della scuola di specializzazione all’interno di un panorama costellato da approcci psicoterapeutici differenti per origine, base teorica, tecniche psicoterapeutiche.
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale
Il testo comprende 10 capitoli relativi alla storia della psicoterapia internazionale, agli aspetti qualitativi della formazione e alla figura dello psicoterapeuta, più una parte conclusiva che raccoglie un elenco di tutte le Scuole di specializzazione presenti in Italia. La parte iniziale propone una classificazione storica e descrittiva delle psicoterapie e delle varie correnti psicologiche, dalla psicoanalisi al movimento cognitivo-comportamentale fino agli approcci più recenti, tra cui l’approccio umanistico che, intorno alla metà degli anni ’50, si propone come “terza via” rispetto alla psicoanalisi e al movimento comportamentale, con l’obiettivo di assumere una prospettiva sociale nell’ambito del pensiero psicologico.
Tale classificazione ha lo scopo di esplorare sinteticamente le diversità dei paradigmi e come questi si sono sviluppati nel corso degli anni. Punto focale del manuale, su cui si concentra buona parte della riflessione dell’autore, riguarda i processi che assicurano la qualità interna ed esterna dei corsi di studio terziari (universitari e post secondari) di fondamentale importanza all’interno del processo di qualificazione delle Scuole. In Italia questo aspetto è garantito dal Coordinamento Nazionale Scuole private di Psicoterapia (CNSP), un’associazione fondata nel 1989 senza fini di lucro che “opera per promuovere la qualità e la trasparenza nella formazione e difendere i legittimi diritti delle scuole afferenti a tutti i vari approcci psicoterapeutici”.
Insieme alla Federazione Italiana delle Associazioni di Psicoterapia (FIAP), questa Istituzione dà voce ai maggiori rappresentanti della psicoterapia in Italia. Una prima parte del libro, quindi, è incentrata soprattutto sulle Istituzioni e sui processi che hanno lo scopo di garantire la qualità nella formazione post-lauream. Nel corso degli ultimi anni l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha stimato che nel mondo circa 450 milioni di persone soffre di disturbi mentali e che la richiesta di trattamento di queste malattie attualmente eccede l’offerta di accesso della popolazione.
Questo allarme porta con sé la necessità di garantire sia la qualità delle cure psicologiche offerte che quella della formazione psicoterapeutica. L’autore sottolinea l’esigenza di migliorare l’efficacia dei corsi di formazione in psicoterapia e dei servizi erogati dai diversi approcci attraverso la promozione sistematica della ricerca all’interno di ogni scuola, in vista di un miglioramento nella pratica clinica.
Successivamente il testo si focalizza sulla figura dello psicoterapeuta e sulla definizione delle competenze professionali implicate in questa professione. Chi è lo psicoterapeuta e quali capacità mette a disposizione in ambito clinico? La definizione di queste competenze delinea l’identità di questo specialista ed è utile per definire ulteriormente i percorsi formativi in questo settore, per chiarire l’identità della professione, il suo operato e il processo di costruzione della figura dello psicoterapeuta.
L’ultima parte del libro raccoglie informazioni descrittive di tutti gli Istituti di Psicoterapia abilitati in Italia e delle Scuole di specializzazione in ambito psicoterapeutico. Per ogni Scuola di formazione si presenta il modello teorico di riferimento, i fondatori, la storia, indirizzi e contatti utili, docenti, affiliazioni con organismi scientifici nazionali ed internazionali, pubblicazioni, attività culturali svolte, orari e costi del corso. 200 pagine di informazioni utili presentate in modo chiaro e dettagliato, da offrire agli studenti come strumento per muoversi più abilmente nella ricerca della scuola.
Questa raccolta, infatti, chiarisce approfonditamente il panorama attuale delle Scuole di psicoterapia in Italia, in un formato comodo e facilmente accessibile allo studente.
Questo testo rappresenta uno scritto utile e ben strutturato ed offre un quadro esaustivo dell’attuale situazione della psicoterapia nel nostro Paese, dello sviluppo storico dei paradigmi, dei processi che garantiscono la qualità della formazione e soprattutto un elenco completo degli Istituti di Psicoterapia abilitati e delle Scuole di Psicoterapia nel nostro Paese, da sfogliare e consultare nel momento in cui ci si affaccia al mondo della formazione post-universitaria.
Scopri le Scuole di Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale in Italia del network Studi Cognitivi



 Blue Jasmine: il bel film di Woody Allen racconta la fine dell’epoca garrula e chiacchierona, ricca e cinica dell’America precrisi. E la racconta con una storia emblematica.
Blue Jasmine: il bel film di Woody Allen racconta la fine dell’epoca garrula e chiacchierona, ricca e cinica dell’America precrisi. E la racconta con una storia emblematica.
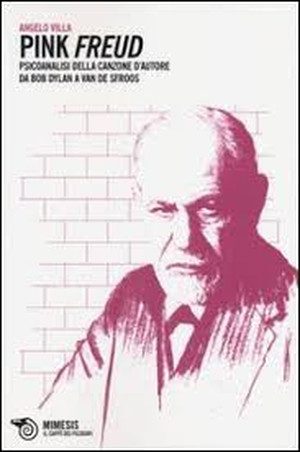
 Sono dislessico e collaboratore editoriale. Binomio impossibile? Assolutamente no. Le case editrici si sono presto accorte che un collaboratore dislessico è un’opportunità. Perché quello che va bene per un dislessico va benissimo per tutti i lettori.
Sono dislessico e collaboratore editoriale. Binomio impossibile? Assolutamente no. Le case editrici si sono presto accorte che un collaboratore dislessico è un’opportunità. Perché quello che va bene per un dislessico va benissimo per tutti i lettori.












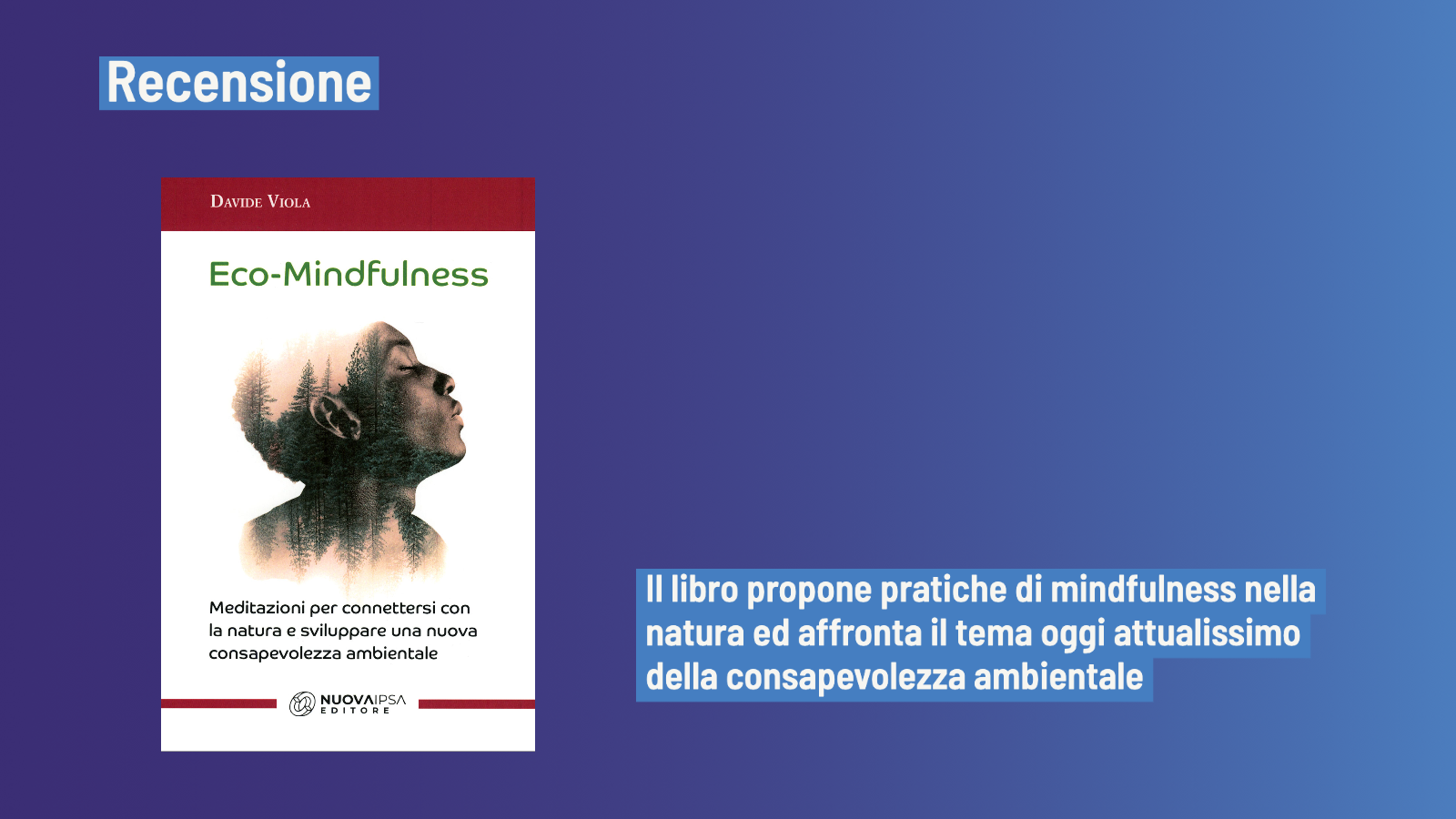







 L’ultimo libro di Christopher Bollas, il cui titolo originale è “China on the Mind”, si presenta come un’ampia ricognizione di natura letteraria e filosofica sulla forma mentis orientale, ricca anche di digressioni di carattere autobiografico; è in corso la sua traduzione in cinese presso l’Università di Pechino.
L’ultimo libro di Christopher Bollas, il cui titolo originale è “China on the Mind”, si presenta come un’ampia ricognizione di natura letteraria e filosofica sulla forma mentis orientale, ricca anche di digressioni di carattere autobiografico; è in corso la sua traduzione in cinese presso l’Università di Pechino.



 I risultati delle ricerche effettuate utilizzando la Leadership Scale for Sports hanno permesso di dimostrare l’esistenza di diverse relazioni tra variabili che possono influenzare le preferenze degli atleti.
I risultati delle ricerche effettuate utilizzando la Leadership Scale for Sports hanno permesso di dimostrare l’esistenza di diverse relazioni tra variabili che possono influenzare le preferenze degli atleti. Gli amori briciola – Concedono all’altro poco di loro stessi, ecco perché sono dei briciola, sia emotivamente sia a livello comportamentale; si legano, ma mai fino in fondo.
Gli amori briciola – Concedono all’altro poco di loro stessi, ecco perché sono dei briciola, sia emotivamente sia a livello comportamentale; si legano, ma mai fino in fondo.