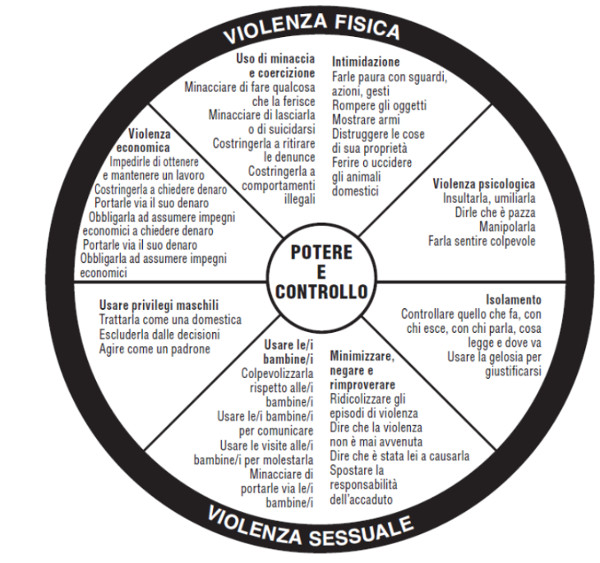Stress da università
Gli studenti universitari sollevano varie questioni: costi, difficoltà a trovare alloggi, carenza di studentati, sollecitazione a performance elevate e visione negativa di un eventuale ritardo nel conseguimento della laurea.
Premessa
Negli ultimi mesi diversi quotidiani (Il sole 24 ore, La Repubblica, Il Corriere della Sera, Open online, Il Mattino, solo per citarne alcuni), hanno parlato delle forti pressioni a cui si sentono sottoposti gli studenti e che in casi estremi hanno drammaticamente condotto al suicidio.
Gli articoli individuano alcuni punti critici che meriterebbero di essere approfonditi e a partire dai quali, in questo articolo, si cercherà di formulare alcune riflessioni.
Il contesto universitario
All’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università di Ferrara la presidente del consiglio degli studenti nell’ambito del suo intervento ha detto: “Non siamo più disposti ad accettare senso di inadeguatezza, depressione o persino suicidi a causa delle condizioni imposte da un sistema malato che baratta la persona con la performance” (Tuttoscuola, aprile 2023).
La studentessa ha inoltre contestato il sistema di borse di studio e studentati che darebbero solo l’illusione di garantire pari opportunità perché nella realtà è difficile accedervi e richiedono risultati eccellenti da conseguire entro periodi di tempo determinati.
Le preoccupazioni connesse ai costi, in particolare per i fuori sede, sono tra le questioni sollevate dagli studenti e che potrebbero contribuire ad aumentare le pressioni da parte delle famiglie a procedere velocemente e bene. È recente la protesta messa in atto dagli studenti in diverse università contro il caro affitti degli appartamenti e delle stanze.
Evidentemente i punti da considerare sono molteplici: inflazione, lavoro precario, stipendi bassi, costi eccessivi delle case, solo per citare alcune questioni che di frequente sono oggetto di dibattito. Certamente ci sono problematiche sociali di rilievo e tuttavia, da una parte taluni argomenti sollevati non sembrano in grado da soli di giustificare lo stress che riferiscono gli studenti, dall’altra alcuni temi sollevati dagli universitari stessi sembrano connessi maggiormente allo studio e ad aspetti emotivi. Il presente articolo proverà ad affrontare proprio queste ultime componenti.
Gli standard prestazionali
Un ulteriore aspetto evidenziato dagli studenti, in termini negativi, è la percezione che all’Università si faccia riferimento a un modello di prestazione che fa sentire molto a disagio chi è fuori corso. A tale proposito Open online in un articolo riporta proprio le difficoltà incontrate da alcune studentesse fuori corso.
Una ragazza racconta come dopo essere sempre stata una studentessa modello, a causa di problemi personali, ha rallentato gli studi e in seguito, a causa delle difficoltà a recuperare, prima si è isolata e successivamente è caduta in uno stato depressivo.
Sono invece le ambizioni che i genitori proiettano sui figli motivo di pressione per una ragazza che racconta che finché era una studentessa modello si sentiva motivo di orgoglio, ma quando ha iniziato a rendere meno si è sentita motivo di vergogna.
Altre storie parlano dei sensi di colpa verso la famiglia, del dispiacere di avere deluso le aspettative, ma anche di non sentirsi compresi per l’impegno dedicato. Come se i familiari talvolta dessero importanza ai risultati e non considerassero adeguatamente la dedizione mostrata nei confronti dello studio.
Gli studenti intervistati convergono sul fatto che i suicidi provocati dagli insuccessi universitari non li sorprendono: “Quando la mente diventa il tuo nemico, è molto difficile uscirne, entri in una dimensione molto buia, molto solitaria, molto autocritica. La comparazione con gli altri diventa una costante”. Ritengono inoltre che un elemento spesso presente nelle situazioni più estreme è il ricorrere alle bugie (Open on line, 2023).
Da un’inchiesta condotta da Skuola.net emerge che gli studenti sentono sempre di più la pressione sociale, le aspettative familiari e la paura del fallimento.
Circa un universitario su tre ammette di avere mentito almeno una volta in famiglia sul suo rendimento e per molti la bugia è sistematica.
I dati raccolti da Skuola.net inoltre confermano come le aspettative contribuiscono a creare malessere; in questi casi le domande sull’università vengono percepite come una pressione sociale che fa sentire in difficoltà particolarmente chi non si sente in regola (Skuola.net).
Componenti emotive, aspettative e bugie
Volendo provare a fare una sintesi a partire dalle testimonianze degli studenti (riportate da alcuni articoli), sembrano emergere dei temi trasversali: la paura del fallimento, il senso di inadeguatezza e il confronto con gli altri, utilizzato come una sorta di ‘misura’ del proprio valore, le aspettative, come la paura di deludere l’altro e presumibilmente anche se stessi in quanto non adeguati all’idea che si vorrebbe avere di sé.
Le aspettative degli altri possono creare sofferenza, in particolare laddove gli studenti non riescono a tenere ritmi adeguati nel sostenere gli esami. Le aspettative, inoltre, possono essere alla base di alcune bugie dette in famiglia; in altri casi i ragazzi potrebbero mentire per tranquillizzare i genitori oppure perché si sentono inadeguati e avvertono un senso di vergogna per il loro andamento universitario. Parlando di bugie, un altro aspetto da considerare è che nel momento in cui si cominciano a raccontare, se questa modalità diviene sistematica e non occasionale, è la situazione che si viene a creare a diventare fonte di uno stress importante. Dire le bugie può sembrare una buona strategia nell’immediato ma con il passare del tempo finisce per diventare un problema sempre più difficile da gestire.
Sembra, infatti, che se già c’era una difficoltà a condividere l’andamento degli esami, il rischio è che diventerà ancora più difficile comunicare la situazione effettiva una volta che si saranno accumulate informazioni non vere e magari si è fatto credere alla famiglia di essere in regola o prossimi alla laurea.
Tornando invece al tema delle aspettative, questo meriterebbe di essere focalizzato meglio, individuando, per esempio, come queste vengono avvertite. I ragazzi come si spiegano le difficoltà che incontrano nel sostenere gli esami che, in un secondo momento, possono creare il problema delle aspettative deluse? Certamente la questione è complessa e coinvolge più fattori.
Sono inoltre da considerare gli aspetti relazionali che sembrano diventare una componente importante nei casi più complessi. Andrebbero valutati, per esempio, i motivi che rendono difficile informare la famiglia delle difficoltà che si incontrano negli studi. Il problema primario è rappresentato dalla difficoltà ad aprirsi in famiglia (e con gli amici), oppure dai problemi negli studi? Potrebbe accadere, per esempio, che un malessere creato dal disagio di non riuscire a corrispondere alle attese degli altri determini una deflessione dell’umore e, di conseguenza, un senso di sfiducia nella possibilità di riuscire a far fronte alle difficoltà incontrate, creando, quindi, una sorta di circolo vizioso.
E ancora, cosa fa sì che i ragazzi ritengano che dire la verità comporterebbe gravi conseguenze e sentano di non poterle affrontare? Tra le motivazioni potrebbe esserci la paura della reazione dei genitori? Paura di deludere? Difficoltà ad accettare i propri presunti limiti intellettuali (non sempre c’è una corrispondenza tra capacità e rendimento)? Vergogna?
Un altro disagio emerso è il confronto. Anche in questo caso andrebbe focalizzato cosa porta a fare dei confronti e come fanno sentire, sia nel caso fosse a proprio favore (cioè quando si ha un rendimento migliore degli altri), o al contrario se ci si sente inadeguati. Per lo studente che reagisce male ai successi dei colleghi, perché magari lo fanno sentire incapace, potrebbe essere utile lavorare sull’insicurezza; sentendosi più sicuro di sé dovrebbe riuscire ad affrontare meglio il confronto con il rendimento degli altri, cioè senza sentirsi necessariamente messo in discussione.
Altro tema è il timore del fallimento. Spesso descrive il modo in cui si sente la persona se non riesce in qualcosa, ma sembra prima di tutto esprimere un vissuto emotivo. Quando si incontrano difficoltà negli studi ne andrebbe compresa la natura e non vanno lette prevalentemente come espressione di una propria incapacità. Come vedremo di seguito, spesso delle flessioni nel rendimento possono accadere e sono legate ai passaggi di studi e a difficoltà che presenta il nuovo contesto. In altri casi, può darsi che vadano valutati i criteri di scelta della Facoltà per vedere quanto in effetti corrispondono alle attitudini ed aspirazioni di ciascuno studente.
Purtroppo, come sappiamo, sono tutti meccanismi per i quali se non si interviene possono cronicizzarsi creando uno stato emotivo all’interno del quale diventa difficile distinguere la causa dall’effetto.
È inoltre importante che i ragazzi sentano di poter chiedere aiuto quando attraversano dei momenti di disagio, senza vivere questa esigenza come una debolezza. Il sostegno può venire dalla famiglia, dagli amici o colleghi, quando questo non è possibile o non è sufficiente, è bene rivolgersi a un professionista. Avere la disponibilità di centri di ascolto adeguati presso tutte le Università è una delle richieste degli studenti. La questione, tuttavia, appare delicata perché evidentemente non basta che ci sia l’offerta di professionisti ma è necessario che la persona capisca di avere bisogno di aiuto. Come sappiamo se il problema è sentito come ‘esterno’, legato al contesto, più difficilmente ci sarà una richiesta di consulenza psicologica pur in presenza di una sofferenza.
Università: un percorso complesso
L’argomento è complesso e andrebbe esaminato considerando i diversi aspetti coinvolti nell’esperienza universitaria. Mettere l’attenzione prevalentemente sulle richieste dell’Università o della società rischia di non intercettare adeguatamente altri problemi più profondi. In condizioni analoghe non tutti gli studenti reagiscono allo stesso modo; andrebbe compreso meglio quali elementi possono produrre nei ragazzi reazioni di sofferenza anche estrema, e perché è percepita senza via di uscita.
Come abbiamo visto, gli studenti sollevano varie questioni: costi, difficoltà a trovare alloggi, carenza di studentati, sollecitazione a performance elevate, visione negativa di un eventuale ritardo nel conseguimento della laurea e da qui tutti i problemi riferiti dai fuori corso, solo per citare alcuni punti.
Tra i diversi ambiti c’è l’incertezza per il futuro lavorativo (sia nel trovare lavoro che per l’aspetto della precarietà). Certamente la percezione di una mancanza di prospettiva futura può influire sulla motivazione e creare stati di ansia e preoccupazione. Da valutare anche la fiducia o meno che gli studenti ripongono nelle prospettive fornite dagli studi universitari.
Il presidente della Conferenza dei Rettori, Salvatore Cuzzocrea, a commento dei fatti di attualità, dice: “Credo che il merito sia una buona cosa e non dovrebbe essere percepito come un danno, anzi, aiuta a creare una linea di partenza equa per tutti. È normale commettere errori, bisogna imparare a cadere e rialzarsi. Tuttavia, se sbaglio un rigore, non posso incolpare l’allenatore. I giovani oggi devono comprendere che un insuccesso non li rende dei falliti. Ritengo che anche la società contemporanea, che valorizza maggiormente il successo facile da tiktoker piuttosto che l’istruzione e il lavoro, abbia una parte di responsabilità” (La Redazione, 2023).
In una Società che si sta trasformando occorre anche valutare la reale motivazione e interesse che hanno i ragazzi a intraprendere gli studi universitari. Il livello di convinzione, infatti, può influire sul rendimento.
Crescere comporta anche riuscire ad affrontare una certa quota di incertezza, comprendere come far fronte alle caratteristiche della società in cui si sta vivendo così da individuare i modi per provare a realizzare al meglio le proprie aspirazioni e progetti. Percorsi spesso tortuosi e non facili nei quali bisogna da una parte capire come orientarsi a livello pratico, scegliendo iter formativi utili a realizzare le proprie attitudini e interessi lavorativi, e dall’altra riuscire a comprendere ed affrontare le risposte emotive connesse all’esperienza degli studi e più in generale alla fase della vita che si attraversa. I due aspetti si intrecciano inevitabilmente perché, per esempio, uno studente con un’adeguata sicurezza nelle proprie capacità riuscirà ad affrontare eventuali difficoltà con una serenità maggiore di chi parte già con un senso di scarsa fiducia nella sua possibilità di riuscita.
La risposta alle difficoltà che si incontrano nel corso degli studi universitari appare pertanto complessa e articolata perché coinvolge più fattori. Considerare le pressioni che arrivano dall’Università o dalla Società quale fattore prevalente può essere fuorviante, perché pone l’attenzione sul contesto esterno e non sullo sviluppo di capacità di risposta di tipo individuale.
I fattori esterni sono in gran parte fuori dal controllo dell’individuo, spostare la riflessione sui fattori interni può favorire la scoperta di un modo più efficace per affrontare il disagio che può impattare sull’esperienza universitaria nel suo complesso e in tutti i suoi aspetti.
Tornando più specificamente agli studi universitari, poiché c’è un’interazione fra stato emotivo e rendimento negli studi, è anche attraverso una messa a fuoco maggiore della componente emotiva che potrebbe risultare più facile capire la modalità con cui ciascuno studente risponderà agli ostacoli che incontra.
Per riflettere sull’interazione fra componente psicologica e atteggiamento verso lo studio possono essere utili alcune osservazioni condotte da Dweck.
Mindset e apprendimento
Carol Dweck, docente presso la Stanford University, dagli inizi della sua carriera ha cercato di capire come le persone affrontano i fallimenti.
La studiosa si è interessata in particolare di apprendimento, e ha osservato come di fronte ai problemi che si possono verificare nel corso degli studi alcuni studenti riescono a mantenere l’impegno, mentre altri, pur avendo capacità analoghe, si scoraggiano e vivono male le difficoltà che incontrano.
Il lavoro della studiosa si fonda sull’idea che le persone fin da piccole sviluppano convinzioni su di sé (mindset) in base alle quali daranno significato alle loro esperienze. Quindi persone diverse potranno reagire in modo diverso a un’esperienza analoga. Gli individui possono essere più o meno consapevoli delle proprie credenze, ma comunque queste influenzeranno fortemente ciò che desiderano e il modo in cui si impegneranno per ottenerlo (Dweck, 2017).
A spiegazione dei diversi atteggiamenti che i ragazzi attuano nei confronti dell’apprendimento la Dweck individua il mindset statico e dinamico. Coloro che hanno sviluppato prevalentemente un mindset statico ritengono che l’intelligenza e le capacità costituiscano entità date, tratti fissi che non è possibile migliorare; pertanto sono più preoccupati di apparire brillanti e temono le difficoltà perché li potrebbero esporre a dei possibili insuccessi che in questo caso verrebbero vissuti male, in quanto percepiti come espressione di incapacità.
Gli studenti che hanno sviluppato un mindset di tipo dinamico, invece, ritengono che le capacità possano essere potenziate attraverso l’impegno e l’apprendimento. In questo caso gli studenti si sentiranno meno preoccupati di mostrarsi bravi perché eventuali insuccessi incidono meno sull’autostima; piuttosto sono interessati a impegnarsi per accrescere le loro capacità e superare le difficoltà incontrate nello studio.
L’insuccesso può motivare o demotivare
Non sembra esserci necessariamente una correlazione tra capacità e rendimento nello studio. Questo non vuol dire che chiunque possa riuscire in tutti i campi e settori e a tutti i livelli, ma semplicemente che ci sono delle potenzialità che vengono utilizzate in modo differente in relazione al mindset. La Dweck, infatti, osserva come studenti capaci possono andare in crisi quando incontrano delle difficoltà, mentre studenti anche meno preparati sono stimolati dalle difficoltà perché rappresentano un’occasione per mettersi alla prova.
E ancora la Dweck riporta come studenti che sembrano molto dotati, ma che hanno sviluppato un mindset statico, dubitano più facilmente di sé stessi e sminuiscono la propria intelligenza quando sbagliano un compito, oppure non superano un esame; mentre gli studenti con mindset dinamico presentano preoccupazioni di questo tipo in misura minore.
Dagli studi effettuati dalla Dweck e collaboratori, gli studenti con i due mindset non differiscono nelle loro risposte quando tutto va bene, ma quando incontrano delle difficoltà, in questo caso, nel percorso di studi. Come se gli studenti con mindset statico per mantenere fiducia nelle proprie capacità avessero un maggiore bisogno di conferme e andassero in crisi quando queste, per qualche ragione, vengono a mancare, mentre gli studenti con mindset dinamico sono meno dipendenti dai successi e mantengono una maggiore costanza anche quando non riescono a superare una prova.
“Si potrebbe pensare alla vulnerabilità come una forma di consapevolezza delle proprie capacità. In realtà non è così. La vulnerabilità non riguarda l’effettiva competenza che gli studenti mettono in un compito” (Dweck, 2000).
L’apprendimento non è un processo lineare
Alla luce dei mindset individuati dalla Dweck è possibile provare a fare alcune riflessioni sull’apprendimento, senza che queste abbiano alcuna pretesa di esaustività. Pur non essendoci una correlazione diretta fra abilità e rendimento, alcuni studenti tendono a vivere i risultati delle prove come indicatori delle proprie capacità e si scoraggiano più facilmente in presenza, per esempio, di un rendimento ritenuto poco soddisfacente.
Può essere utile ricordare ai ragazzi che incontrare delle difficoltà è assolutamente normale. Non basta un insuccesso per formulare una valutazione negativa. Un calo di rendimento, per esempio, si può verificare nei passaggi dalla scuola primaria a quella secondaria di primo grado e poi nel passaggio alla scuola secondaria di secondo grado e ancora arrivati all’Università. In queste variazioni di contesto formativo i ragazzi spesso cambiano compagni e devono ambientarsi con il nuovo gruppo, hanno nuovi docenti e si devono adattare a nuovi stili di insegnamento; andando avanti nel percorso di studi gli studenti vengono sottoposti a richieste progressivamente crescenti, e questo può richiedere una fase di assestamento. Sempre in questi cambi di livello di istruzione possono verificarsi cali del rendimento che vanno compresi e non vissuti come prova di scarse capacità. Un altro passaggio che può essere critico è l’ingresso all’Università, che rappresenta un contesto molto diverso rispetto a quello scolastico e dove spesso, anche in relazione alla Facoltà, agli studenti viene richiesta una maggiore autonomia nella preparazione degli esami e nella organizzazione degli stessi. Inoltre, la relazione con i docenti è tipicamente più impersonale.
Mindset e reazioni di tipo depressivo
La Dweck e collaboratori hanno condotto un’osservazione nei campus universitari nel periodo di febbraio e marzo, quando gli studenti sono più sotto pressione per le prove d’esame, in modo da poter verificare se fosse emerso un rapporto tra mindset e risposte riconducibili a una deflessione dell’umore (per esempio tristezza, insoddisfazione).
Hanno quindi individuato i mindset di un gruppo di studenti e poi hanno chiesto loro di tenere un diario dove dovevano rispondere a domande sull’umore, le loro attività e il modo in cui affrontavano i problemi.
Gli studenti con mindset statico tendevano a rimuginare sui loro insuccessi, tormentandosi con l’idea che questi fossero indicativi della loro incompetenza e inadeguatezza. Anche in questo caso, le situazioni percepite come fallimento sembravano definire l’identità personale degli studenti e lasciavano poco spazio alla speranza di un miglioramento. I ricercatori notarono, inoltre, che gli studenti con mindset statico, quando si sentivano depressi, si scoraggiavano e lasciavano andare le cose, non avevano fiducia nella possibilità di risolvere i problemi di studio.
Anche molti studenti con forma mentis dinamica erano piuttosto abbattuti, ma comunque si impegnavano per risolvere i loro problemi e per restare al passo con il lavoro da svolgere.
La Dweck spiega questo diverso comportamento facendo ricorso appunto ai diversi mindset. Se le persone credono che le capacità siano immutabili tenderanno a percepire un insuccesso, una difficoltà, come qualcosa che le definisce in maniera permanente lasciando meno spazio alla possibilità di un recupero. Per gli individui che invece credono che le loro qualità possano essere sviluppate, eventuali insuccessi possono comunque abbattere e scoraggiare, ma non saranno in grado di definire l’identità e il senso di sicurezza, in modo stabile; pertanto crescita e cambiamento rimangono possibili e più facilmente viene avvertita la possibilità di recuperare.
Conclusioni
Per comprendere ulteriormente quali fattori portano a sviluppare un mindset piuttosto che un altro, può essere utile fare riferimento a una teoria dello sviluppo, come la teoria dell’attaccamento di Bowlby e i successivi ampliamenti che sono stati fatti.
Alcune parole di Bowlby mettono in evidenza un aspetto interessante per l’argomento trattato: “Abbiamo ampie prove del fatto che gli esseri umani di ogni età sono più sereni e in grado di affinare il proprio ingegno per trarne un maggior profitto se possono confidare nel fatto che al loro fianco ci sono persone fidate che verranno in loro aiuto in caso di difficoltà” (Bowlby, 1989).
Anche la Dweck tra i fattori che contribuiscono allo sviluppo dei mindset fa riferimento al ruolo della famiglia. Sono importanti i messaggi che i genitori mandano ai figli a commento delle esperienze di apprendimento; viene messa l’attenzione sui risultati, sul talento? O sull’impegno? Discorso analogo anche per le lodi. A parere della Dweck le lodi rivolte alla persona possono anche contribuire a rendere insicuri. I bambini e i ragazzi che vengono lodati per i loro successi possono sviluppare uno stato di preoccupazione quando temono di non riuscire. Infatti, se nel momento in cui ottengono buoni risultati vengono lodati, cosa accadrà quando invece non riusciranno a superare una prova, quando si verifica un insuccesso? Dimostrano di essere incapaci? Potremmo dire che un certo uso delle lodi e dei giudizi negativi potrebbero contribuire a creare una sorta di ansia da prestazione.
Sappiamo che anche la scuola e le istituzioni formative ed educative in generale possono rivestire un ruolo importante, così come altre figure di riferimento. Pertanto, i messaggi che vengono trasmessi, in modo esplicito o implicito, anche da questi contesti, tra cui l’Università, dovrebbero essere volti a favorire la crescita e lo sviluppo armonico dei giovani senza sollecitare pressioni eccessive.
La teoria dell’attaccamento –che non affronteremo in questo articolo– può essere utile a cogliere come un senso di sicurezza adeguato dovrebbe favorire la capacità di affrontare eventuali ostacoli e insuccessi senza che questi impattino in modo significativo sull’autostima, sul senso di sé e quindi sul proprio senso di valore. Leggere il lavoro della Dweck alla luce della teoria dell’attaccamento può aiutare a comprendere meglio i diversi atteggiamenti verso l’apprendimento che adottano gli studenti e quali esperienze nelle fasi dello sviluppo possono rafforzare un mindset piuttosto che l’altro (Mannino, 2019).
L’obiettivo, pertanto, non è far sparire gli intoppi, gli impedimenti, ma che ciascuno trovi una strategia per farvi fronte in modo proattivo. Tutti gli studenti, tutti gli individui in generale, possono andare incontro a momenti di difficoltà, magari dovuti a disagi incontrati nella vita personale. Mettere l’attenzione principalmente sulle richieste e pressioni esercitate dall’Università rischia di non dare un’adeguata centralità alle risorse personali (emotive, cognitive, relazionali, ecc) di ciascun individuo, ostacolando un’adeguata comprensione delle difficoltà incontrate, necessaria per individuare percorsi efficaci per superarle.
La riflessione, per essere adeguatamente proficua, come già detto, dovrebbe coinvolgere almeno quattro livelli: quello individuale, quello familiare, quello Universitario e quello più ampio della Società.