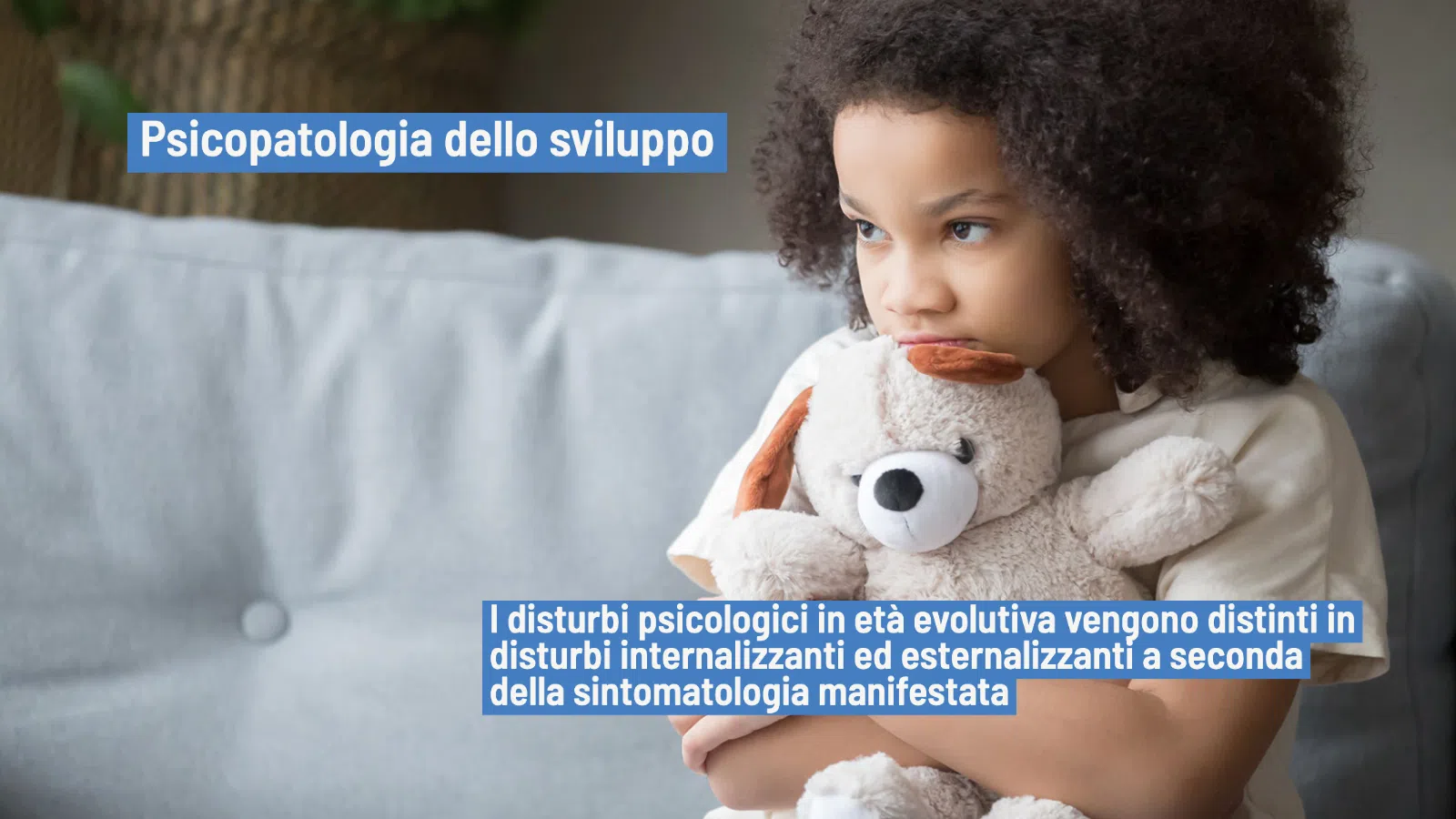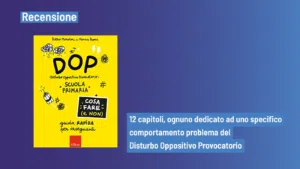Che cos’è il disturbo oppositivo provocatorio?
Il disturbo oppositivo provocatorio è un disturbo del comportamento che si manifesta generalmente a partire dall’età prescolare e può persistere sino all’età adulta. È caratterizzato da frequente umore collerico o irritabile e da un modello di comportamento vendicativo, polemico, provocatorio e non collaborativo verso coetanei, genitori, insegnanti e altre figure autoritarie.
Quali sono i sintomi del disturbo oppositivo provocatorio?
Secondo il Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali (APA, 2013), il disturbo oppositivo provocatorio viene diagnosticato quando un individuo manifesta per minimo 6 mesi almeno quattro sintomi in qualsiasi categoria, frequentemente e nelle interazioni con persone diverse dai fratelli. Le categorie e i sintomi associati sono:
Umore collerico/irritabile
- andare spesso in collera
- mostrarsi spesso permaloso/a o facilmente contrariato/a
- essere spesso adirato o risentito
Comportamento polemico/provocatorio
- litigare regolarmente con figure autorevoli, come insegnanti e datori di lavoro
- sfida o rifiuto di richieste o regole
- infastidire e irritare deliberatamente gli altri
- incolpare gli altri per il proprio cattivo comportamento e i propri errori
Vendicatività
- comportamento dispettoso o vendicativo 2 o più volte in 6 mesi.
La sintomatologia deve manifestarsi tutti i giorni per almeno sei mesi per bambini al di sotto dei 5 anni e almeno una volta a settimana nei casi di esordio oltre i 5 anni (APA, 2013). Questa modalità di comportamento genera disagio all’individuo e a chi lo circonda, compromette significativamente il funzionamento sia a casa che a scuola e interferisce nel rapporto con figure come insegnanti e genitori, nonché nella relazione con i coetanei. Spesso i sintomi del disturbo sono parte integrante di un più ampio modello di interazioni problematiche con gli altri. L’individuo che ne è affetto, infatti, non si riconosce come frequentemente in collera, sfidante e ostile, ma tende a giustificare il proprio comportamento come reazione a richieste esterne e situazioni irragionevoli (ibidem).
I sintomi possono anche essere manifestati solo ed esclusivamente a casa e con i familiari. Il numero di contesti in cui si verificano i sintomi (ad esempio, casa, scuola, lavoro ecc.) determina la gravità del disturbo: lieve, se i sintomi sono circoscritti a un unico contesto, moderata se i sintomi sono presenti in almeno due ambienti, grave se si estendono a tre o più contesti.
La diagnosi può avvenire da parte di uno psicologo o neuropsichiatra infantile sulla base di un’osservazione diretta dell’individuo e di informazioni anamnestiche raccolte dai familiari.
Comportamento difficile o disturbo? Quando cercare aiuto
I sintomi del disturbo oppositivo provocatorio possono manifestarsi anche in assenza di un vero e proprio disturbo, e nei bambini possono essere associati a fattori quali l’età, il genere, lo stato di salute generale, il temperamento e la cultura d’appartenenza. Tuttavia, un comportamento “difficile” in un bambino può essere considerato un disturbo se riflette criteri come costanza, ovvero la presenza per almeno gli ultimi 6 mesi precedenti la valutazione, frequenza, persistenza e compromissione del funzionamento nelle principali attività di vita del bambino, quali scuola, famiglia e relazioni sociali (Barkley & Benton, 2016). Generalmente, gli scoppi di rabbia aumentano in modo significativo durante il primo anno di vita e fino alla prima infanzia, mentre i genitori rispondono conseguentemente con un maggiore controllo, ad esempio stabilendo delle regole e, a loro volta, suscitando ancora più rabbia nei bambini. I livelli medi di rabbia diminuiscono dopo la prima infanzia e nella fanciullezza media, presumibilmente man mano che i bambini migliorano nel regolare le proprie emozioni e nel comunicare e negoziare obiettivi con genitori e coetanei (Liu et al., 2018).
Consideriamo l’esempio di un bambino in età prescolare. I suoi accessi di collera potrebbero essere considerati un sintomo di disturbo oppositivo provocatorio solo qualora si fossero verificati quasi tutti i giorni negli ultimi 6 mesi, in concomitanza con almeno tre degli altri sintomi del disturbo e di una compromissione significativa delle aree di vita del bambino, come famiglia, scuola d’infanzia ecc. (APA, 2013).
Diffusione, sviluppo e decorso del disturbo oppositivo provocatorio
La prevalenza del disturbo oppositivo provocatorio può variare tra l’1 e l’11%. Prima dell’adolescenza, si verifica maggiormente nei maschi (APA, 2013).
Solitamente, i primi sintomi compaiono verso l’età prescolare e non oltre la prima adolescenza.
Rispetto alla prognosi, se sviluppato durante l’infanzia, il disturbo oppositivo provocatorio frequentemente esita, nella media età adolescenziale e prima età adulta, in un disturbo della condotta, soprattutto se i sintomi predominanti sono quelli relativi alla provocatorietà e alla vendicatività. Tuttavia, non tutti i bambini con diagnosi di disturbo oppositivo provocatorio sviluppano successivamente un disturbo della condotta.
Al contrario, per i soggetti caratterizzati da una predominanza dei sintomi legati alla collera e all’irritabilità, può essere più probabile l’emergere di un disturbo internalizzante, come ansia e depressione.
In generale, i bambini con disturbo oppositivo provocatorio sono maggiormente esposti, da adulti, al rischio di sviluppare problemi nel controllo degli impulsi, abuso di sostanze, ansia e depressione; inoltre tendono ad avere un più basso livello di istruzione (solo per i maschi), a ricoprire ruoli professionali meno prestigiosi, redditi più bassi, maggior rischio di contrarre debiti (solo per le femmine) e maggiore instabilità lavorativa sia per gli uomini che per le donne (Leadbeater et al., 2023). Le percentuali di diagnosi di disturbo oppositivo provocatorio sono più elevate tra i bambini, gli adolescenti e gli adulti con disturbo da deficit di attenzione e iperattività (APA, 2013).
Cause del disturbo oppositivo provocatorio
Sono state avanzate diverse ipotesi per spiegare l’eziologia del disturbo oppositivo provocatorio; alcune di esse fanno riferimento a fattori di rischio di tipo genetico e di tipo temperamentale, come un’elevata reattività emozionale e una scarsa tolleranza alla frustrazione (APA, 2013).
Altre ipotesi attribuiscono invece una rilevanza maggiore ad aspetti di natura ambientale, tra cui (Aggarwal & Marwaha, 2025):
- fumo in gravidanza
- comportamenti disadattivi dei genitori, come devianza, uso di sostanze e alcol
- pratiche educative rigide o incoerenti
- instabilità familiare dovuta a lutti, separazioni, nuovi matrimoni e affidamento
- trascuratezza o abusi
- influenza dei pari
- depressione materna perinatale.
In particolare, alcuni studi suggeriscono che uno stile genitoriale eccessivamente rigido e autoritario possa favorire l’instaurarsi di un circolo vizioso in cui si pone maggiore attenzione sugli aspetti comportamentali problematici del bambino. In questo modo, il bambino fa propria l’immagine del bambino “cattivo”, con una più elevata probabilità di reiterare i comportamenti indesiderati. Inoltre, il mancato rinforzo dei comportamenti positivi rischia di farli passare in secondo piano, così che il bambino potrebbe sentirsi meno incoraggiato a metterli in atto (Farruggia et al, 2008).
Trattamento del disturbo oppositivo provocatorio
Attualmente esistono diverse tipologie di trattamento del disturbo oppositivo provocatorio, che coinvolgono sia il bambino che la coppia genitoriale. Inoltre, nei casi di maggiore gravità, può essere valutato il ricorso anche a una terapia farmacologica.
La tipologia di trattamento si differenzia sulla base della fascia di età dei soggetti coinvolti. Per i bambini in età prescolare, l’intervento spesso si concentra solo su una psico-educazione rivolta ai genitori; per l’età scolare invece risulta maggiormente efficace un lavoro che coinvolga la scuola, oltre che un intervento di psico-educazione genitoriale e una terapia individuale (skills trainig) con il bambino. Infine, per gli adolescenti, la modalità più efficace di trattamento risulta quella della terapia individuale associata ad un parent training (AACAP, 2009).
Parent-management training
Il parent-management training insegna ai genitori in modo pratico a fronteggiare i comportamenti del proprio figlio in modo positivo e prevede tecniche educative e una supervisione adatta all’età del bambino. Questa modalità di trattamento (ACCAP, 2009) intende migliorare le capacità genitoriali attraverso una supervisione supportiva, favorendo l’instaurarsi di una disciplina autorevole e diminuendo le pratiche parentali inefficaci (come l’uso di punizioni coercitive o la focalizzazione sui comportamenti negativi).
Lo scopo del trattamento è quello di ridurre i comportamenti problematici attraverso l’insegnamento di nuove modalità di rinforzo positivo che il genitore potrà attuare con il figlio, così da aumentare il senso di efficacia di quest’ultimo.
Skills Training
Il cognitive problem-solving skills training è uno dei training dedicati al trattamento del disturbo oppositivo provocatorio. Esso si inserisce nell’ambito dell’approccio cognitivo – comportamentale e ha lo scopo di ridurre i comportamenti inappropriati e dirompenti attraverso l’insegnamento diretto al bambino di nuovi metodi per far fronte a situazioni fortemente stressanti.
Il presupposto teorico alla base consiste nel ritenere che le persone con disturbo oppositivo provocatorio presentino delle distorsioni nei processi cognitivi e, per tale motivo, vengono offerte alcune alternative cognitive che possano, di conseguenza, generare soluzioni alternative ai problemi interpersonali. Nello skills training, bambini e ragazzi si esercitano a soffermarsi sulle conseguenze delle proprie azioni, identificando il significato dei propri e altrui gesti e allenando l’empatia (Kazdin, 1997). L’approccio cognitivo pone l’attenzione sul modo in cui l’individuo percepisce, decodifica e fa esperienza del mondo. L’aggressività non è di per sé dettata dagli eventi, ma piuttosto dal modo in cui vengono percepiti e processati, attribuendo ostilità intenzionale negli altri (Crick & Dodge, 1994).
Un ulteriore intervento per il disturbo oppositivo provocatorio è quello incentrato sul potenziamento delle competenze sociali (Social Skills Training), che insegna al bambino a interagire in una modalità maggiormente positiva e adeguata con i pari.
Questa tipologia di intervento può essere anche condotta in un contesto di vita abituale del bambino, come la scuola o il gruppo di coetanei di riferimento, al fine di ottenere una maggiore generalizzazione degli apprendimenti (AACAP, 2009).
Trattamento farmacologico per il disturbo oppositivo provocatorio
Va sottolineato come ad oggi non esistano specifici farmaci per il trattamento del disturbo oppositivo provocatorio e il solo utilizzo del farmaco non è stato dimostrato efficace come modalità di intervento per questo disturbo (AACAP, 2009).
I farmaci vengono adottati come parte di un trattamento più ampio ed integrato, soprattutto nei casi in cui sono presenti altri disturbi in comorbilità (Schur et al., 2003, Steiner et al., 2003) come il disturbo da deficit di attenzione ed iperattività (ADHD), disturbi d’ansia o disturbi dell’umore.
I farmaci maggiormente utilizzati sono gli psicostimolanti, gli stabilizzatori dell’umore e gli antidepressivi. I primi, in particolare il Ritalin, vengono utilizzati nei casi di comorbilità tra disturbo oppositivo provocatorio e ADHD e si sono dimostrati efficaci nel ridurre la sintomatologia comportamentale (Newcorn et al., 2005).
- AACAP, (2009). Oppositional Defiant Disorder: A Guide for Families. AACAP Practice Parameter.
- Aggarwal, A., & Marwaha, R. (2024). Oppositional Defiant Disorder. In StatPearls. StatPearls Publishing.
- American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.).
- Barkley, R.A & Benton, C.M. (2016). Mio figlio è impossibile. Edizioni Centro Studi Erickson S.p.A., Trento
- Crick, N. R. & Dodge, K.A. (1994). A review and reformulation of social information processing mechanisms in children social adjustment. Psychological Bullettin, 115, 70-101.
- Eyberg, S.M., Schumann, E.M., & Rey, J. (1998). Child and adolescent psychology research: Developmental issues. Journal of Abnormal Child Psychology, 26, 71–82.
- Farruggia, R., Romani, M., & Bartolomeo, S. (2008). Disturbi della Condotta/Disturbi della Personalità: riflessioni teorico-cliniche per una presa in carico precoce. Psichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza, 75: 3-4, 503-513.
- Kazdin, A. E. (1997). Practitioner Review: Psychosocial Treatments for Conduct Disorder in Children Alan, Journal of Child Psychology and Psychiatry, vol. 38, no.2. 161-178
- Leadbeater BJ, Merrin GJ, Contreras A, Ames ME. (2023). Trajectories of oppositional defiant disorder severity from adolescence to young adulthood and substance use, mental health, and behavioral problems. J Can Acad Child Adolesc Psychiatry. 2023 Nov;32(4):224-235.
- Liu C, Moore GA, Beekman C, Pérez-Edgar KE, Leve LD, Shaw DS, Ganiban JM, Natsuaki MN, Reiss D, Neiderhiser JM. (2018). Developmental patterns of anger from infancy to middle childhood predict problem behaviors at age 8. Dev Psychol. 2018 Nov;54(11):2090-2100.
- Newcorn, JH, Spencer, TJ, Biederman, J, Milton, DR, and Michelson, D. (2005). Atomoxetine treatment in children and adolescents with attention-deficit/hyperactivity disorder and comorbid oppositional defiant disorder.J Am Acad Child Adolesc Psychiatry.;44:40–248.
- Schur, S, Sikich, L, Findling, R, Malone, R, Crismon, M, Derivan, A, MacIntyre, J, Pappadopulos, E, Greenhill, L, Schooler, N, Van Orden, K, and Jensen, P. (2003). Treatment recommendations for the use of antipsychotics for aggressive youth (TRAAY): I. A review.J Am Acad Child Adolesc Psychiatry.;42:132–144.
- Smith, M. L., (1996). A study of social skills training and oppositional defiant disorder with a kindergarten student. ETD Collection for AUC Robert W. Woodruff Library. Paper 2021.
- Steiner, H, Petersen, M, Saxena, K, Ford, S, and Matthews, Z. (2003). A randomized clinical trial of divalproex sodium in conduct disorders.J Clin Psychiatry.;64:1183–1191.