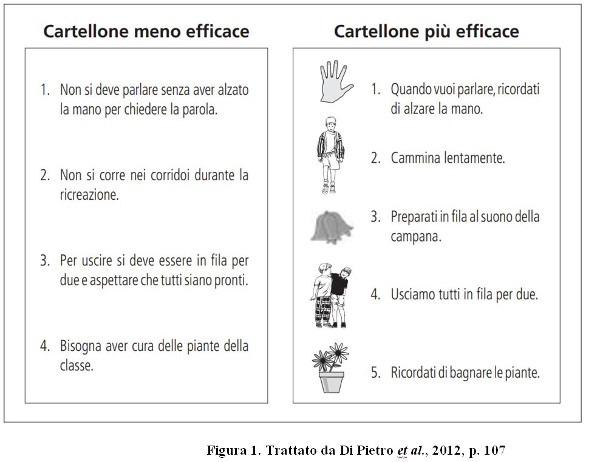Salute mentale nelle università: il caso della Yale University
In un mondo accademico che si concentra sull’eccellenza e sulle prestazioni, le difficoltà legate alla salute mentale possono passare inosservate o non ricevere l’attenzione necessaria. La salute mentale degli studenti merita attenzione, comprensione e azioni concrete per garantire un ambiente di apprendimento sano e sicuro.
Introduzione
La salute mentale degli studenti universitari è diventata un tema di crescente preoccupazione nelle istituzioni accademiche di tutto il mondo. Un recente articolo del Washington Post ha messo in luce la controversia riguardante i servizi di salute mentale presso la Yale University (Wan, 2022), una delle università più prestigiose degli Stati Uniti e di tutto il mondo. Secondo l’articolo, alcuni studenti che affrontavano problemi di salute mentale sarebbero stati costretti a ritirarsi e seguire una procedura di riammissione, attraverso un processo lungo e complicato. Questo ha scatenato un dibattito tra gli amministratori universitari, che difendono i servizi di salute mentale di Yale, e i critici che sostengono che le politiche per la tutela della salute mentale dell’università sono inadeguate.
La situazione a Yale
Secondo il Washington Post (Wan, 2022), più di 25 studenti ed ex-studenti di Yale hanno lamentato politiche e servizi inadeguati rivolti agli studenti in difficoltà rispetto alla propria salute mentale. Alcuni studenti hanno dichiarato di non aver ricevuto risposte dopo aver cercato assistenza per problemi di salute mentale, mentre altri hanno avuto accesso a sessioni di consulenza limitate. Inoltre, parecchi studenti hanno nascosto le loro difficoltà mentali per evitare le procedure di ritiro dall’università, che sembrerebbero esercitare pressioni sugli studenti a lasciare il campus in tempi brevi.
Una ormai nota e triste testimonianza di una giovane studentessa di Yale morta per suicidio, mette in luce una parte delle procedure attuate dall’Università in casi di problemi di salute mentale:
Al momento della dimissione dall’ospedale… il mio documento di identità di Yale fu confiscato, così come la chiave della mia stanza. Mi fu data una sera per impacchettare tutta la mia vita (trad. it. Giambrone, 2015).
L’articolo pubblicato sul The Atlantic (2015) sostiene che le procedure di ritiro rendono particolarmente difficile per gli studenti con problemi di salute mentale lasciare il campus, anche quando la pausa da scuola potrebbe migliorare il loro benessere, anche in vista delle complicate procedure di riammissione. Secondo diversi studenti di Yale, nel campus c’è il timore che l’amministrazione costringa gli studenti con problemi mentali ad andarsene; c’è anche il timore che agli studenti malati non sia permesso di tornare. Di conseguenza, gli studenti che soffrono di ansia, depressione e altri disturbi potrebbero non ricevere le cure di cui hanno bisogno. E per molti di quelli che scelgono di richiedere cure, la domanda diventa presto: “Quanto dovrei aprirmi?”.
Il racconto di una studentessa riguardo alla sua esperienza personale (Williams, 2014) con problemi di salute mentale e la risposta ricevuta dall’Università di Yale aiuta a comprendere il meccanismo delle procedure di riammissione al Campus e alla frequenza dei corsi universitari. La studentessa descrive un incontro con un valutatore che la interroga sul suo problema (autolesionismo) e le suggerisce che sarebbe più sicuro per il suo benessere lasciare Yale, nonostante i suoi sforzi nel cercare aiuto e nell’assicurare il suo impegno nella terapia, il valutatore insinua che Yale non può averla nel campus. Secondo le conversazioni dell’autrice con il personale dell’ospedale e con i compagni di corso, sembra che agli studenti che sono stati ricoverati in ospedale sia raramente permesso di rimanere a Yale. La studentessa, autrice dell’articolo, suggerirebbe che Yale dia priorità alla propria immagine e vorrebbe che chi non è “a posto” se ne vada, aspettativa pesante e deleteria per gli studenti.
In sostanza, se uno studente di Yale sente di avere problemi di salute mentale e decide di chiedere aiuto, scelta che in alcuni casi potrebbe richiedere l’assenza dal Campus o l’ospedalizzazione, deve presentare richiesta di ritiro dall’università e dopo il suo periodo di cura è sottoposto ad una valutazione non clinica del suo stato di benessere, che sembra disincentivare al reinserimento.
In risposta all’articolo del Washington Post del 2022 scritto da Wan, gli amministratori di Yale hanno pubblicato lettere difensive, sottolineando il loro impegno per la salute e il benessere degli studenti. Il Decano e il Direttore della Salute Mentale e del Counselling dell’Università di Yale hanno scritto una lettera in cui sostenevano che l’articolo ignorasse gli sforzi complessi e articolati di Yale per affrontare la salute mentale degli studenti. Il Presidente dell’Università di Yale ha anche pubblicato una lettera in cui difendeva gli sforzi di Yale nel promuovere il benessere degli studenti.
Punti di vista alternativi
Nonostante la difesa degli amministratori di Yale, i critici sostengono che ci siano ancora molti problemi da affrontare nei servizi di salute mentale dell’università. Rishi Mirchandani, un rappresentante del gruppo di advocacy per la salute mentale “Elis for Rachael”, ha scritto che la risposta degli amministratori universitari è stata basata su argomentazioni fuorvianti. Ha affermato che il problema non riguarda la necessità di rimanere iscritti continuativamente, ma piuttosto la mancanza di alternative al ritiro a tempo indeterminato senza assicurazione sanitaria, alloggio e supporto istituzionale.
Alicia Floyd, ex studentessa di Yale che ha tentato il suicidio nel 2000, ha criticato gli amministratori per non aver affrontato direttamente l’argomento principale dell’articolo del Washington Post: la pressione esercitata sugli studenti in crisi a lasciare immediatamente il campus. I leader di “Elis for Rachael”, hanno sottolineato che le politiche di Yale possono mettere gli studenti in una situazione ancora più precaria.
L’organizzazione “Elis for Rachael” è nata in memoria di una studentessa di Yale morta per suicidio nel 2021.
Migliorare il sostegno agli studenti
L’associazione “Elis for Rachael” propone una serie di cambiamenti per migliorare il supporto e la tutela degli studenti che devono affrontare ritiri medici. Primo tra tutti, suggeriscono che l’Università offra un piano di assicurazione sanitaria accessibile agli studenti sia iscritti che in ritiro medico, per consentire loro di consultare professionisti esterni e affrontare la necessità crescente di assistenza psicologica. Suggeriscono di implementare un corso di formazione annuale sul primo soccorso per la salute mentale per studenti, docenti, personale e amministratori. Ancora, richiedono di eliminare gli ostacoli non medici costosi per il reintegro degli studenti dopo un ritiro medico, come requisiti di trasferimento di crediti accademici o interviste non cliniche (come quella descritta nell’articolo di Williams, 2014). Inoltre, ritengono sia necessario fornire una motivazione dettagliata e concreta per il rifiuto delle domande di reintegro e di pubblicare criteri obiettivi per il processo di reintegro.
Importanza dei servizi di salute mentale nelle università
Il caso di Yale solleva una questione più ampia circa l’importanza dei servizi di salute mentale all’interno delle università, a disposizione degli studenti. Gli studenti universitari affrontano spesso pressioni significative, tra cui l’adattamento a un nuovo contesto lontano da casa, l’equilibrio tra studio-lavoro-vita sociale e il confronto con aspettative elevate. Questi fattori possono sfidare la salute mentale degli studenti e contribuire ad incrementare lo stress percepito, in una fase della vita già stressante per definizione.
Investire in servizi di salute mentale adeguati nelle università è essenziale per garantire che gli studenti abbiano accesso a risorse e supporto coerenti con il loro bisogni in caso di momenti di difficoltà e sofferenza mentale. I servizi di salute mentale dovrebbero essere accessibili, inclusivi e sensibili alle sfide specifiche che gli studenti affrontano durante il loro percorso accademico. Non solo aiutano gli studenti a superare le difficoltà, ma contribuiscono anche a creare un ambiente di apprendimento sano e supportivo.
Conclusioni e prospettive future
Il caso di Yale University evidenzia l’importanza di migliorare i servizi di salute mentale nelle università. Gli studenti universitari dovrebbero poter contare su servizi efficaci e accessibili per affrontare le sfide della salute mentale durante il loro percorso accademico. Le istituzioni accademiche devono impegnarsi a migliorare e modernizzare i propri servizi, assicurando che gli studenti abbiano risorse adeguate in caso di crisi. Inoltre, è fondamentale promuovere una cultura che incoraggi la ricerca di aiuto e la consapevolezza della salute mentale tra gli studenti.
Investire nella salute mentale degli studenti è un investimento nel loro benessere e successo accademico. Le università dovrebbero lavorare a stretto contatto con gli studenti, i rappresentanti degli studenti e gli esperti di salute mentale per sviluppare politiche e servizi che rispondano alle esigenze degli studenti universitari. Solo attraverso uno sforzo collettivo sarà possibile creare un ambiente universitario che sostenga appieno il benessere mentale degli studenti e li aiuti a raggiungere il loro pieno potenziale accademico e personale.