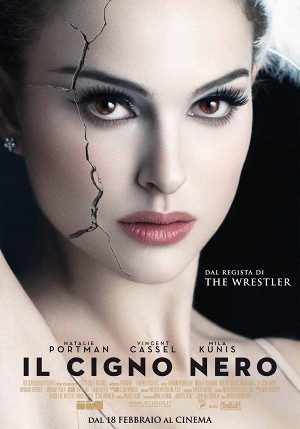Abusati e abusanti – Report dal Congresso Nazionale EMDR
Report dal Congresso Nazionale EMDR
Labirinti traumatici: il filo dell’EMDR
8-10 Novembre 2013, Milano
 Il lavoro con gli abusanti è di fondamentale importanza per la prevenzione di recidive e rappresenta un passo indispensabile per la piena tutela delle vittime.
Il lavoro con gli abusanti è di fondamentale importanza per la prevenzione di recidive e rappresenta un passo indispensabile per la piena tutela delle vittime.
All’interno del congresso nazionale EMDR, svoltosi negli scorsi giorni a Milano, organizzato dall’Associazione per l’EMDR in Italia, molto spazio è stato dedicato all’abuso e alla violenza, ma affrontando questi delicati temi da una prospettiva nuova e interessante, ovvero prendendo in considerazione tutti gli attori dell’esperienza traumatica: sopravvissuti e abusanti.
Apre i lavori Julie Stowasser, coordinatrice del settore Violenza Domestica dell’American Psychological Association, con un workshop su questo fenomeno di allarmante attualità che ha visto un forte incremento nel nostro Paese negli ultimi anni, in controtendenza rispetto a quanto si sta verificando negli USA.
I dati parlano chiaro: In Italia il 50% delle donne uccise lo sono per mano del convivente, il 30% da fidanzati o ex-partner e nella maggior parte dei casi c’è stato un precedente stalking per cui non sono state prese le misure necessarie a causa di un sistema penale lento e ancora inadeguato su questo fronte.
Julie Stowasser sottolinea con molta forza l’idea che gli effetti della violenza domestica non sono solo una questione privata, ma riguardano tutti noi e hanno profonde ricadute sulle generazioni successive.
Le definizioni giuridiche, sociologiche e culturali variano da una paese all’altro, e ad oggi non esiste un profilo coerente di aggressore e vittima. Soprattutto rispetto agli abusanti abbiamo pochi dati: la maggior parte di loro sono uomini, ma non ne conosciamo la percentuale.
Nell’ambito degli interventi terapeutici la violenza domestica può essere definita come un pattern di comportamenti verbali e non verbali messi in atto intenzionalmente e volti ad ottenere dominio e controllo all’interno di una relazione, attraverso umiliazione, minacce, intimidazione, coercizione fino alla violenza vera e propria.
E’ un comportamento intenzionale perché non c’è una totale perdita di controllo: questi abusanti sono in grado di mantenere un comportamento perfettamente calmo e controllato di fronte ai vicini di casa o alle forze dell’ordine che intervengono per poi rientrare in casa e dare sfogo alla violenza verso la partner.
Tipicamente questo pattern di comportamenti ha un andamento ciclico: da una fase di escalation la tensione si trasforma in scatto esplosivo per poi decrescere fino alla fase delle scuse e dei tentativi di riappacificazione. Questo “ciclo della violenza” col tempo aumenta di frequenza e di intensità, a volte con molta lentezza, altre volte, invece, si assiste ad una rapida escalation, con conseguenze anche letali.
L’intervento di Julie Stowasser non mira a fornire al terapeuta specifici strumenti per il trattamento, ma una chiave di lettura utile alla comprensione e alla presa di consapevolezza di una situazione con cui ci si può trovare a fare i conti in terapia.
E’ importante imparare a riconoscere e ad agire innanzi tutto per garantire la sicurezza della vittima e in secondo luogo per farsi carico dell’abusante.
Molto spesso, infatti, gli aggressori mostrano nella loro storia di vita la presenza di un Disturbo da Stress Post-Traumatico o traumi irrisolti, esposizione alla violenza durante la loro infanzia o un ambiente di crescita in cui hanno imparato che la violenza è la risposta ad ogni problema. Il ciclo della violenza si ripete e coinvolge le generazioni successive.
Proprio in virtù di queste considerazioni l’EMDR, integrato con altri strumenti di intervento, sembra essere un trattamento molto promettente per i perpetratori di violenza domestica.
L’attenzione è focalizzata su alcuni target specifici, come la vergogna e i sensi di colpa, prepotenze subite, perdite, abusi e altri eventuali traumi. Solitamente è possibile rintracciare una storia critica con qualche figura maschile di riferimento, più frequentemente il padre. Orgoglio ferito, machismo e odio generale verso le donne sono altri target molto importanti del lavoro con l’EMDR.
Anche l’intervento di
Ronald Ricci responsabile del Sexuality Responsability Program presso il Devereux Kanner Center di West Chester,
si focalizza sul trattamento degli abusanti, in questo caso gli autori di reati sessuali.
Il lavoro con questa tipologia di abusanti è di fondamentale importanza per la prevenzione di recidive e rappresenta un passo indispensabile per la piena tutela delle vittime. Questo tipo di abusanti, infatti, presenta un alto tasso di recidive e un trattamento mirato può contribuire in maniera significativa a diminuirle. Purtroppo in Italia non esiste un piano di trattamento condiviso a livello nazionale per questo tipo di offender e l’iniziativa viene lasciata alle singole amministrazioni.
Nel suo lavoro Ronald Ricci propone, in linea con quanto evidenziato dalle teorie emergenti in questo campo, un modello di trattamento dei sex offenders focalizzato sul trauma.
Il modello di trattamento classico era basato prevalentemente sull’evitamento delle situazioni che potessero innescare il comportamento deviante e sull’assunzione di responsabilità. Gli eventuali abusi subìti da parte del perpetratore venivano concepiti come scuse per giustificare il comportamento deviante e per questa ragione non gli era permesso parlarne. Questo tipo di trattamento non motivava sufficientemente gli offenders a cambiare e non permetteva di ridurre significativamente le recidive. Non teneva inoltre in considerazione il fatto che una precedente storia di abuso fosse un fattore eziologico contribuente allo sviluppo del comportamento deviante.
Molti offenders, infatti, come effetto del trauma, ricordano in maniera distorta i fatti collegati alla loro vittimizzazione, negando il danno subìto o credendo di essere stati loro i responsabili dell’abuso. Generalizzando queste credenze, non percepiscono il danno che causano alle loro vittime e le ritengono in qualche modo responsabili o corresponsabili dell’abuso.
La letteratura ha messo in evidenza alcuni fattori di vulnerabilità presenti in questo tipo di offenders: deficit d’intimità e di abilità sociali, script sessuali distorti, disregolazione emotiva, credenze a sostegno del reato, oltre alla presenza di script devianti sessuali spesso derivanti dalla vittimizzazione sessuale nell’infanzia.
Gli attuali modelli di trattamento per sex offenders si focalizzano proprio su questi aspetti e includono al loro interno uno spazio dedicato all’elaborazione di esperienze traumatiche, anche attraverso l’uso dell’EMDR.
Il modello proposto da Ronald Ricci integra il trattamento EMDR con il modello “Good Lives”: il reato sessuale viene concepito come un modo maladattivo per ottenere un bene primario e il lavoro consiste nell’offrire al paziente la possibilità di soddisfare i suoi bisogni in modi più adattivi e nel rispetto dei bisogni altrui.
Il trattamento inizia durante la detenzione e continua in libertà vigilata e comprende gruppi di sostegno, trattamento terapeutico generale e trattamento EMDR focalizzato sui traumi.
Alcune testimonianze video di un gruppo di pazienti sottoposti a questo tipo di trattamento mostrano chiaramente l’efficacia di questo strumento nel permettere a queste persone di elaborare le esperienze di abuso subìto e di entrare in contatto con i propri sentimenti, ponte indispensabile per una vera comprensione dei vissuti delle loro vittime e delle conseguenze dei loro comportamenti devianti. Il trattamento EMDR sembra avere una grande efficacia nel ridurre uno dei fattori maggiormente predittivi delle recidive: l’eccitazione sessuale deviante verso la tipologia di vittime del reato commesso.
Un altro interessante intervento sul tema dell’abuso, questa volta incentrato sulle vittime, è stato quello di Derek Farrell, professore ordinario dell’Università di Worcester, relativo al trattamento EMDR con sopravvissuti ad abusi subìti da parte di membri del clero.
Fenomeno purtroppo diffuso che coinvolge tutte le fedi e tutte le chiese, affonda le sue radici molto indietro nel tempo e se ne trovano testimonianze in documenti molto antichi.
Fulcro del lavoro presentato da Farrell è l’idea che questo tipo di abuso non sia peggiore di altri, ma che presenti delle differenze di cui è necessario tener conto per offrire un trattamento adeguato ai sopravvissuti.
Queste differenze riguardano innanzi tutto la figura degli abusanti: per quanto il loro ruolo sia profondamente cambiato nel corso degli ultimi decenni, tipicamente essi ricoprono una posizione di grande importanza all’interno della comunità. Questo fa sì che spesso le vittime vengano obbligate alla segretezza ed al silenzio e, nel caso riferiscano l’abuso subìto, non vengano credute né sostenute dalla comunità, andando incontro ad una ri-traumatizzazione.
Altra caratteristica frequente in questo tipo trauma è la credenza che Dio abbia contribuito all’abuso, attraverso le strategie di obbligo al silenzio utilizzate dai preti abusanti o per aver permesso che accadesse.
Spesso questa esperienza conduce ad un allontanamento dalla fede, che si configura come un ulteriore trauma, un profondo senso di perdita.
Un ulteriore dato importante è che nel trattamento EMDR di questi pazienti il futuro è un target di grande rilevanza. Futuro che va oltre la sola dimensione terrena, come raccontano le parole di una vittima: “Se il mio abusante si dovesse pentire Dio lo perdonerebbe e lo accoglierebbe in paradiso, e ciò renderebbe il paradiso un posto non sicuro”.
Il messaggio che emerge dai diversi interventi è chiaro: farsi carico dei “carnefici” non è solamente utile, ma necessario per interrompere il ciclo della violenza e offrire un reale aiuto alle vittime passate, presenti e potenziali.
Gli ostacoli che una simile prospettiva deve affrontare sono diversi: innanzi tutto far accettare alle istituzioni e all’opinione pubblica interventi volti ad aiutare chi si rende responsabile di crimini che spesso suscitano reazioni profonde e feroci; in secondo luogo coinvolgere il personale curante in percorsi emotivamente molto faticosi che comportano lo stare a contatto con sentimenti e comportamenti che mettono a dura prova le capacità empatiche; un ulteriore difficoltà è quella di coinvolgere e motivare gli abusanti stessi in un percorso di messa in discussione di sé e dei propri pattern comportamentali.
Nonostante queste difficoltà quello che i relatori sottolineano è l’imprescindibilità di questo tipo di lavoro, con l’obiettivo primario di proteggere innanzi tutto le vittime e le generazioni future dagli effetti traumatici dell’abuso.
LEGGI:



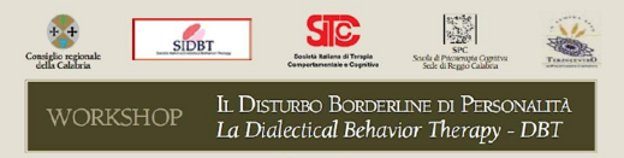






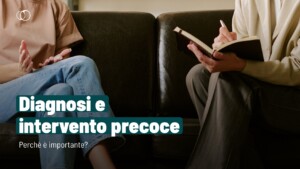


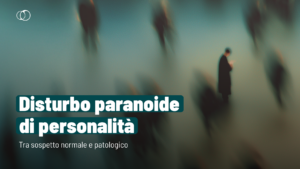




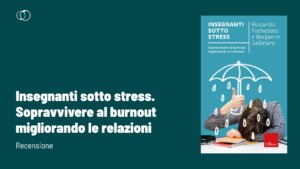


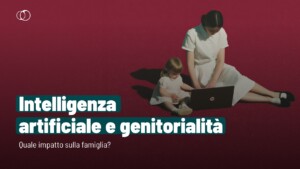



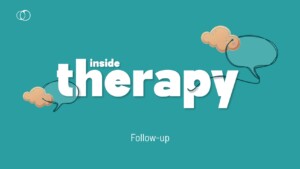
 Che fumare non faccia bene è ormai noto ed assodato; che fumare in gravidanza possa aumentare il rischio per il feto e il futuro bambino di sviluppare molteplici problematiche tra cui ad esempio una riduzione del peso alla nascita e difficoltà attentive nel corso dello sviluppo è stato ampiamente dimostrato. Ciò che c’è di nuovo è che il fumo in gravidanza aumenta il rischio per il futuro bambino, una volta adulto, di sviluppare un Disturbo Bipolare.
Che fumare non faccia bene è ormai noto ed assodato; che fumare in gravidanza possa aumentare il rischio per il feto e il futuro bambino di sviluppare molteplici problematiche tra cui ad esempio una riduzione del peso alla nascita e difficoltà attentive nel corso dello sviluppo è stato ampiamente dimostrato. Ciò che c’è di nuovo è che il fumo in gravidanza aumenta il rischio per il futuro bambino, una volta adulto, di sviluppare un Disturbo Bipolare.
 Il badantismo è cresciuto in concomitanza al cambiamento della famiglia tradizionale italiana, sicuramente meno coesa di un tempo e in continua evoluzione (Fruggeri, 1997).
Il badantismo è cresciuto in concomitanza al cambiamento della famiglia tradizionale italiana, sicuramente meno coesa di un tempo e in continua evoluzione (Fruggeri, 1997).
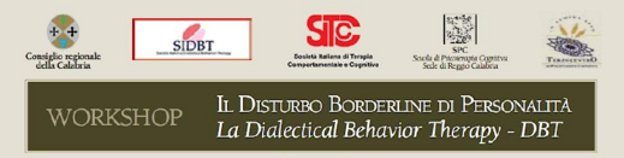




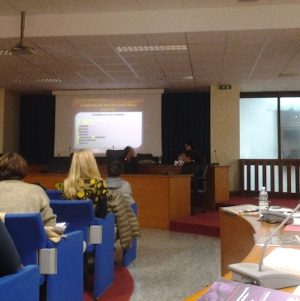

 Il lavoro con gli abusanti è di fondamentale importanza per la prevenzione di recidive e rappresenta un passo indispensabile per la piena tutela delle vittime.
Il lavoro con gli abusanti è di fondamentale importanza per la prevenzione di recidive e rappresenta un passo indispensabile per la piena tutela delle vittime. Il conflitto: componenti e processi comportamentali.
Il conflitto: componenti e processi comportamentali. Fare sesso occasionale fa star bene! Falsa credenza o dura realtà?
Fare sesso occasionale fa star bene! Falsa credenza o dura realtà?