Errori – Centro di Igiene Mentale – CIM Nr.03 – Storie dalla Psicoterapia Pubblica
Errori
– Leggi l’introduzione –
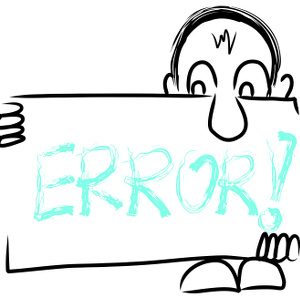 Se un CIM segue con cura i pazienti è infrequente che ci siano emergenze di pazienti noti. Dunque, quando arriva una chiamata d’urgenza, si tratta spesso di situazioni nuove in acuzie che agitano l’animo degli operatori chiamati a partire verso l’ignoto e scarsamente desiderosi di avere un encomio alla memoria e magari una stanza intitolata a loro nome.
Se un CIM segue con cura i pazienti è infrequente che ci siano emergenze di pazienti noti. Dunque, quando arriva una chiamata d’urgenza, si tratta spesso di situazioni nuove in acuzie che agitano l’animo degli operatori chiamati a partire verso l’ignoto e scarsamente desiderosi di avere un encomio alla memoria e magari una stanza intitolata a loro nome.
Insomma, un po’ di timore non dichiarato serpeggia soprattutto se, come in quella mattina gelida, piovosa e scura del 2 dicembre, sono i carabinieri stessi a chiamare, avvertendo che sono in attesa sul posto con due gazzelle e hanno già chiamato il 118 per ‘ambulanza.
Con una macchina del servizio e con quella privata di Biagioli partono lui stesso con Giò, che non lo lascia mai nelle situazioni difficili, Silvia Ciari, la dottoressa Mattiacci che per fare eventualmente il TSO servono i certificati di due medici e Gilda che non si perde mai un’occasione adrenalinica.
In un quarto d’ora sono nella frazione del Poggio.
I fatti stanno avvenendo in una casa isolata che si identifica per le auto dei carabinieri con le muffole accese ed una folla di curiosi smaniosi di spiegare come sono andate le cose e perchè ce lo si doveva aspettare. Nella casetta abitano Salvatore Misano, quarantenne contadino con tre ettari di proprietà nella zona del torrente e sua moglie Teresa, che gestisce un negozio di verdura sulla piazzetta della frazione dove vende i prodotti coltivati dal marito.
Non avendo figli vivono in ristrettezze ma con decoro.
Dagli astanti gli operatori apprendono subito la versione popolare della vicenda: Salvatore è impazzito e minaccia di uccidere la moglie, in preda ad un delirio di gelosia che lo tormenta da tempo. Del resto, la madre di Salvatore da trent’anni vive a Villa Serena per un delirio mistico e da tre anni è stata raggiunta dalla figlia 45enne Marisa che accusava i vicini di spiare le sue nudità attraverso gli apparecchi televisivi. Villa Serena è il posto giusto per tutta la famiglia…
Salvatore viene descritto come un uomo semplice, rozzo, brutto e poco curato che quando non sgobba nei campi è molestamente ubriaco e più di una volta è stato malmenato da uomini per vendicare le loro mogli, figlie, sorelle cui aveva prestato attenzioni non richieste.
Quando al negozio c’è anche lui le donne preferiscono non andarci, ma per fortuna non c’è quasi mai.
Teresa somiglia ad Anna Magnani con una folta chioma nera, occhi azzurri da perdercisi, fisico asciutto ma robusto da lavoratrice.
Sottraendolo alla folla, i carabinieri riassumono a Biagioli i fatti: Salvatore si è coricato con Teresa, la stringe per il collo e minaccia di strangolarla se non confessa di fronte a tutti il suo misfatto.
La poveretta è terrorizzata, piange e chiede aiuto. Secondo Salvatore, quando è rientrato inaspettamente presto dai campi per il maltempo, ha trovato i due fedifraghi. La porta della casupola dà direttamente nell’unico locale che fa da cucina e soggiorno. Entrato all’improvviso, ha sorpreso Teresa china sul tavolo con Liborio alle sue spalle che vibrava possenti colpi. Quest’ultimo, era riuscito a fuggire terrorizzato nonostante i pantaloni a mezz’asta intralciassero la corsa.
Teresa, trascinata nel letto matrimoniale, era prima stata posseduta per sfregio ed ora era in attesa di essere strangolata. Nessuno si era preoccupato di rintracciare Liborio, vicedirettore della Cassa di Risparmio e presidente della Pro loco, perchè i precedenti familiari di Salvatore, il suo alcolismo, l’essere un violento ed aver sofferto di deliri di gelosia non lasciavano adito a dubbi.
Nella stanza da letto entrarono Giò e la dottoressa Lina, gli altri a calmare la folla. Salvatore con le mani al collo della moglie dettava ai due i movimenti consentiti e quelli proibiti. Ad ogni disobbedienza aumentava la stretta al collo. Teresa passava da un pallore cadaverico che lasciava immaginare come sarebbe potuta diventare di lì a poco ad un viola congestionato per via dell’ostacolo al deflusso delle giugulari che la stretta provocava.
Giovanni si mise a raccontare delle sue personali tristi vicende con le donne con ammiccanti segni di intesa per Salvatore sulla innata puttanaggine del sesso femminile. Gli ricordò come a pagare fossero sempre gli uomini che, per aver difeso il loro onore finivano per anni in carcere, come un suo zio di Milano (completamente inventato) mentre le troie, libere da ogni controllo, se la spassavano alle loro spalle. Lavoro, galera e corna, quello era il destino degli uomini onesti a meno che non riuscissero a provare effettivamente il tradimento e avere pubblica soddisfazione, come suo cugino Alberto (anch’esso inventato) che aveva costretto per la vergogna la moglie a confinarsi in un convento di suore.
Giovanni parlava con tono cantilenante che aveva un effetto ipnotico e nel frattempo si avvicinava lentamente.
Vedendo la difficoltà di Salvatore a rispondergli per la secchezza della bocca, aveva strillato per un’ora, si offrì di portargli un bicchiere d’acqua. Salvatore impose che prima ne bevesse metà lui per sincerarsi che non ci fossero farmaci o veleni. Mentre Giò beveva, d’improvviso gli gettò con forza l’acqua in faccia e, approfittando del momentaneo disorientamento di Salvatore, in un attimo gli fu sopra. Incravattandogli il collo gli fece mollare la presa su Teresa che in un istante fu in cucina nuda completamente e tremante per la paura.
Un carabiniere la coprì con la giacca dell’uniforme che lei, con un vezzo di femminilità, si abbottonò tutta con cura.
Un giornalista di una testata locale scattò col telefonino alcune foto.
La dottoressa Mattaccini, con l’aiuto di Gilda prontamente accorsa a dar man forte a Giò nell’immobilizzazione, cercava di praticare un’ iniezione al povero Salvatore, orientandosi tra gli arti aggrovigliati dei tre.
Mezz’ora dopo l’ambulanza partiva con a bordo Teresa per accertamenti e in stato di shock e Salvatore con l’auto del CIM con Giovanni e Silvia verso Villa Armonia per una terapia meno d’assalto.
Lasciati i paesani a commentare sui guasti della legge Basaglia e i carabinieri a predisporre il verbale sul famigerato tavolo della cucina raccogliendo le voci sulla pericolosità del Salvatore, la specchiata onestà di Teresa e ancor più dell’incolpevole Liborio, gli operatori del CIM tornarono in sede con l’auto del capo.
Ora che l’emergenza era superata bisognava capirci qualcosa e predisporre un progetto.
Certamente sarebbe stata necessaria una terapia farmacologica ma, dato il contesto relazionale in cui la crisi delirante allucinatoria si era manifestata, sembrò opportuno proporre una psicoterapia di coppia di cui si sarebbe dovuto far carico il dottor Irati che, nel suo studio, trattava tutti i pruriti affettivo-sessuali delle coppie abbienti del paese.
Questa volta lo avrebbe fatto, con non minor passione e competenza, gratis per un contadino ubriacone e la sua povera moglie.
Salvatore fu dimesso una settimana più tardi, con una terapia di 20 gocce per tre volte al dì di Serenase.
Più sedato e tranquillo si scusava per il disturbo che aveva provocato e voleva riprendere al più presto la sua vita normale. Disposto a perdonare la moglie, che ribadiva invece non avesse nulla da farsi perdonare, mostrava estrema collaborazione ma ribadiva con fermezza che la scena che gli era apparsa entrando in casa non era stata un’ allucinazione.
Si rendeva conto della sua esagerata gelosia e insieme ne ricostruirono la storia.
La sua famiglia d’origine aveva visto continue liti tra un padre alcolista ed una madre chiacchierata al punto che ricordava le prese in giro già dei compagnucci delle medie che gli facevano notare come la sorella più grande fosse il ritratto del medico condotto. Lui, piccolo ma muscoloso, difendeva l’onorabilità della famiglia a furia di cazzotti. A 13 anni in una rissa perse un testicolo per una ginocchiata. Smise di battersi quando, tornato prima da scuola per una sospensione, aveva trovato la madre a letto con il medico. Lì doveva aver iniziato a pensare che delle donne non ci si può fidare.
Il dr. Irati gioiva per le acute considerazioni che non si aspettava dal contadino.
Quando aveva vent’anni la madre era finita a Villa Serena dopo una crisi mistica in cui aveva smesso di mangiare e riteneva di essere Santa Caterina da Siena. Il padre era morto dopo poco di cirrosi e la sorella rimasta incinta senza essere fidanzata si convinse di essere la vergine Maria e raggiunse la madre. Di temi sessuali e di tradimenti era intessuta la sua esistenza, si può dire che avesse scelto Teresa non tanto per la sua bellezza ma per l’onestà di tutta la sua famiglia, imparentata con il vescovo di Vontano. Gli accertamenti, dopo i primi anni di matrimonio senza figli, stabilirono che Salvatore, anche a motivo del testicolo unico, era sterile. In paese la differenza tra sterile e finocchio sfuggiva ai più e Salvatore divenne oggetto di pesanti prese in giro che gli ricordarono le umiliazioni infantili così iniziò a bere, ripercorrendo la strada del padre. Come spesso accade l’alcolismo provoca impotenza e questa, a sua volta, gelosia. Salvatore si rendeva conto di tutto ciò, ma al termine di ogni seduta ci teneva a ribadire che lui quel giorno aveva visto lucidamente il coito della moglie con il signor Liborio.
Di settimana in settimana la terapia farmacologica, ancora inefficace veniva aumentata. Gli effetti secondari extrapiramidali erano solo una modesta rigidità che rendeva l’incedere un po’ robotico ma nulla più. Finalmente giunti al dosaggio di 70 gocce per tre volte al dì Salvatore iniziò ad ammettere la possibilità di essersi confuso: forse aveva scambiato la sua immaginazione per realtà. In quei giorni era ossessionato dalla gelosia e infuriato per il rifiuto da parte della cassa di risparmio dove lavorava Liborio di un piccolo prestito indispensabile per l’acquisto delle sementi.
Si era certamente sbagliato e anche di questo chiedeva scusa. Stabilizzatosi il pensiero critico al vissuto allucinatorio e delirante, la farmacoterapia iniziò ad essere gradatamente ridotta e la psicoterapia si incentrò sul futuro della coppia.
Alla venticinquesima seduta, mentre si parava del vissuto di Teresa circa la mancata maternità, questa scoppiò improvvisamente a piangere. Confusamente, tra i singhiozzi, disse che invece era tutto vero e che la relazione con Liborio durava da tre anni. Salvatore non si meravigliò, ne era sempre stato convinto. Aveva ritrattato la sua versione negando persino la certezza percettiva dei suoi occhi perchè temeva che il progressivo aumento della terapia farmacologica lo avrebbe ammazzato. Salvatore e Teresa non si separarono e il loro matrimonio divenne per lei un ergastolo: lui era punitivo e violento e lei si vendicava dandosi apertamente con grande generosità a giovani e vecchi.
Molti sembrano gli errori commessi dai curanti ma la storia e, forse, gli errori non si fermano qui.
Dieci anni dopo Salvatore fu accusato di molestie sessuali nella scuola elementare dove faceva da bidello ma ne uscì completamente scagionato. Dopo tre mesi restò illeso in un incidente dove morì il bambino di otto anni che si era offerto di portare a casa, essendo i genitori in ritardo all’uscita di scuola.
Qualche tempo dopo, il medico legale che fece l’autopsia sul corpo di Salvatore, trovato malamente seppellito nel suo orto, dichiarò che il colpo con la doppietta era stato sparato dopo che la canna di quest’ultima era stata infilata per oltre trenta centimetri nell’orifizio anale di Salvatore e forse lo sfondamento intestinale era stata la causa della morte.
Teresa, anziana e senza più un reddito, liberatasi dal suo carceriere, trasformò in attività a fini di lucro la sua vocazione.
ARGOMENTI CORRELATI:
TORNA ALL’INDICE DELLA RUBRICA



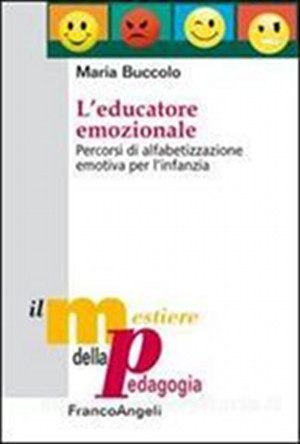

 Per ciò che riguarda la salute occorre distinguere tra chi gioca in modo adeguato (tipicamente per un periodo di tempo breve, con perdite accettabili e in un certo senso calcolate), e coloro che manifestano nel gioco perdita di controllo sulla condotta, disagio emotivo, compulsività e dipendenza.
Per ciò che riguarda la salute occorre distinguere tra chi gioca in modo adeguato (tipicamente per un periodo di tempo breve, con perdite accettabili e in un certo senso calcolate), e coloro che manifestano nel gioco perdita di controllo sulla condotta, disagio emotivo, compulsività e dipendenza.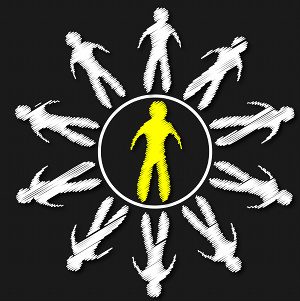 Il leader non è colui che sa comportarsi in un modo ma colui che sa comportarsi nel modo giusto al momento giusto per poter migliorare sia il livello di produttività che quello di soddisfazione dei membri della squadra.
Il leader non è colui che sa comportarsi in un modo ma colui che sa comportarsi nel modo giusto al momento giusto per poter migliorare sia il livello di produttività che quello di soddisfazione dei membri della squadra.
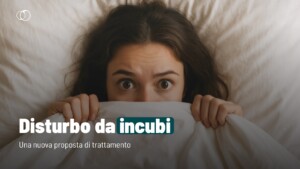

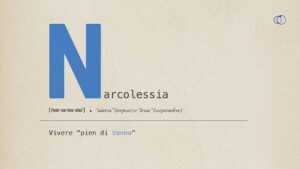
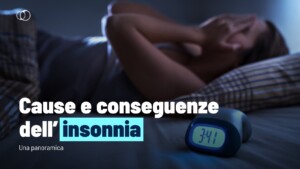

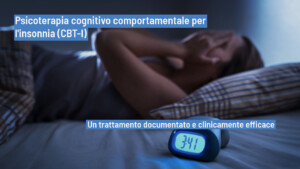
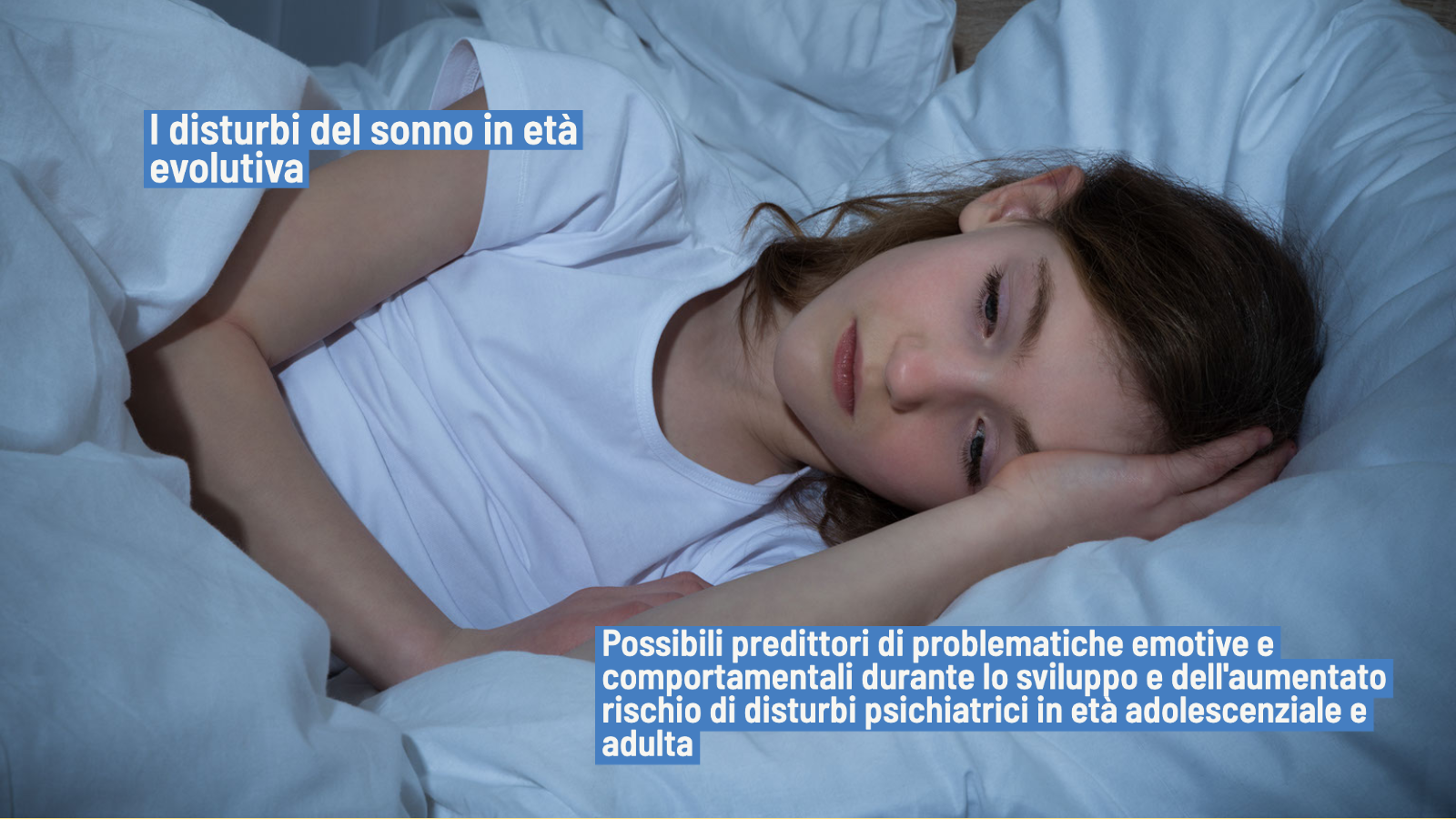

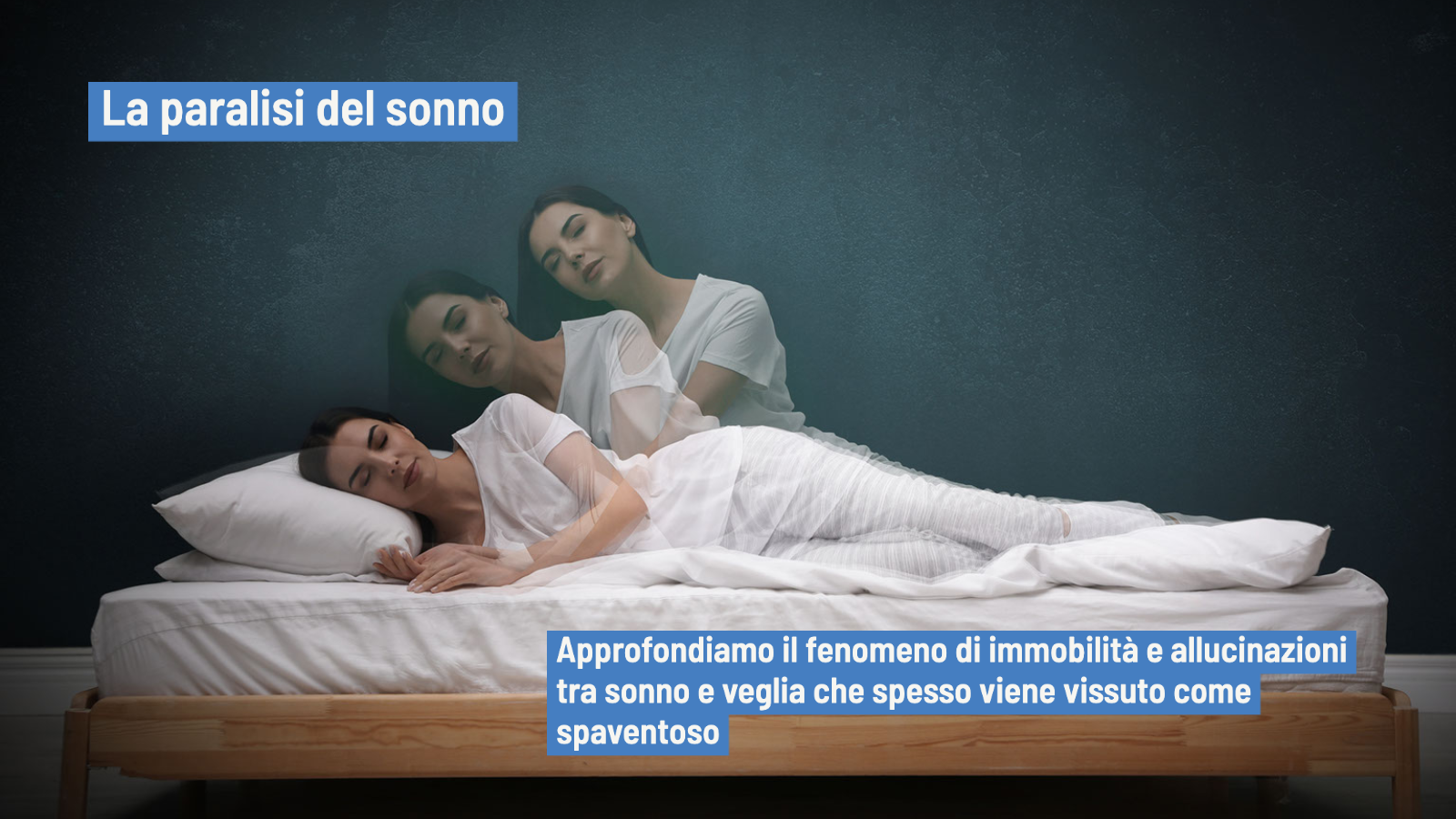
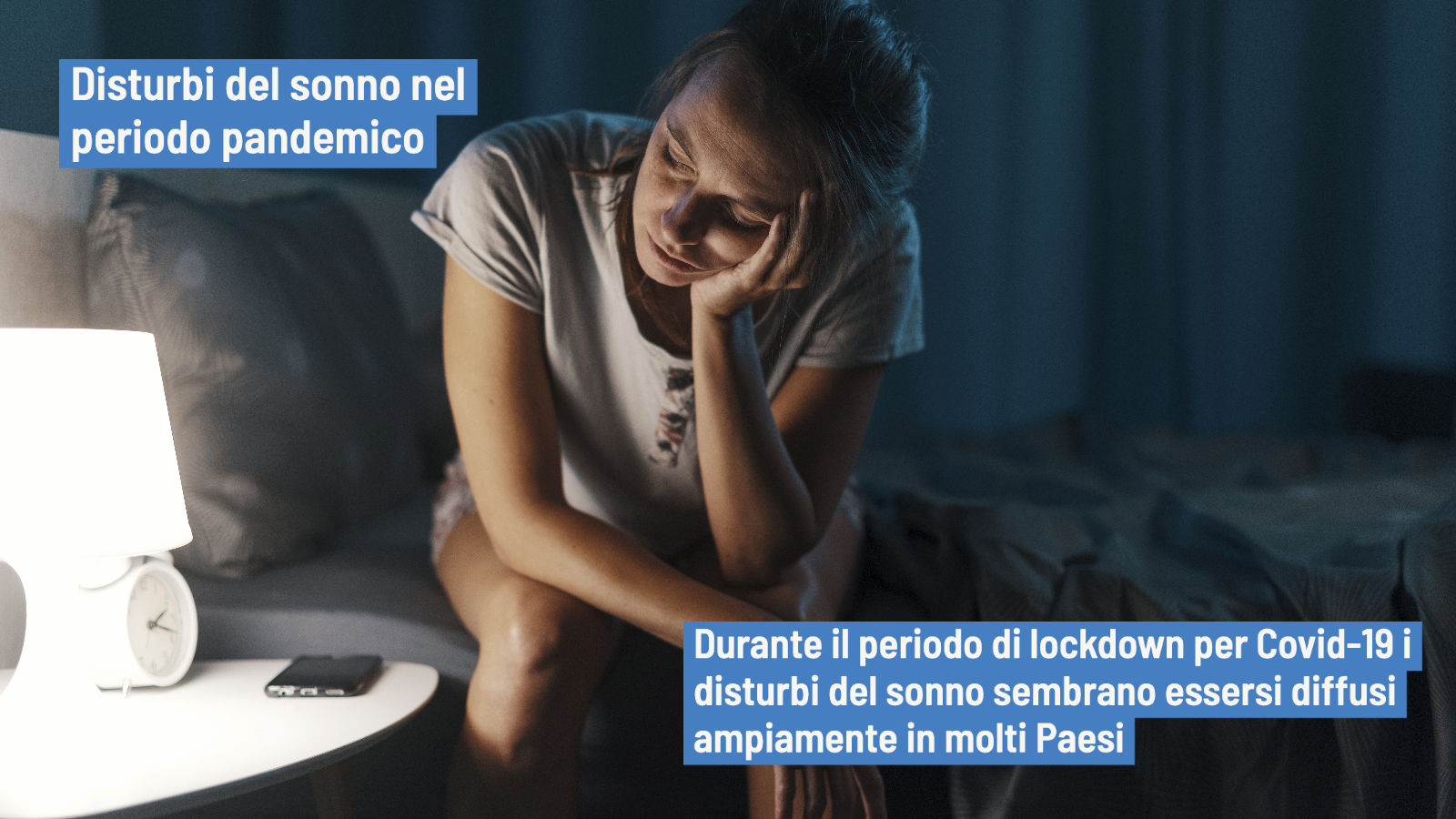










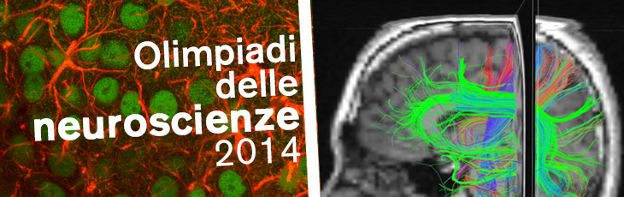






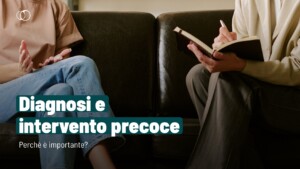


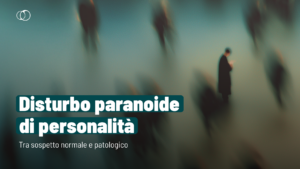




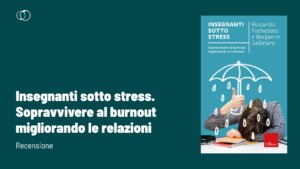


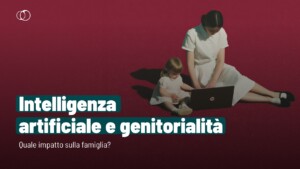


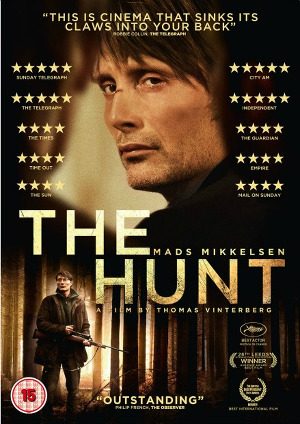 The Hunt: se chiedessimo alle persone di definire in una parola il tema principale del film di Thomas Vinterberg (lo stesso regista di Festen), sicuramente qualcuno risponderebbe che tratta di “pedofilia”. Tuttavia l’argomento è un altro, ovvero cosa accadrebbe nella “possibilità” che un abuso del genere fosse avvenuto?
The Hunt: se chiedessimo alle persone di definire in una parola il tema principale del film di Thomas Vinterberg (lo stesso regista di Festen), sicuramente qualcuno risponderebbe che tratta di “pedofilia”. Tuttavia l’argomento è un altro, ovvero cosa accadrebbe nella “possibilità” che un abuso del genere fosse avvenuto? Amare qualcuno vuol dire riconoscerlo nella propria individualità, ma soprattutto significa essere liberi. Contrariamente a quello che si pensa unione non significa fusione, niente di più sbagliato, ma rispetto della libertà altrui.
Amare qualcuno vuol dire riconoscerlo nella propria individualità, ma soprattutto significa essere liberi. Contrariamente a quello che si pensa unione non significa fusione, niente di più sbagliato, ma rispetto della libertà altrui. Editoriale
Editoriale Senza sogni saremmo lucertole. Questo beneficio del sogno è particolarmente curioso perché non richiede che il sogno venga realizzato. Si tratta di un moto dinamico dell’essere umano che prescinde dal risultato, quello che conta è viaggiare verso un desiderio e non raggiungerlo.
Senza sogni saremmo lucertole. Questo beneficio del sogno è particolarmente curioso perché non richiede che il sogno venga realizzato. Si tratta di un moto dinamico dell’essere umano che prescinde dal risultato, quello che conta è viaggiare verso un desiderio e non raggiungerlo. Lo scopo principale del presente studio è stato quello di indagare la relazione tra i temi della costellazione materna (Stern, 1995), principalmente la relazionalità primaria, e l’attaccamento materno-fetale. Ha partecipato al nostro studio un campione di 257 donne suddivise, in base al periodo di gravidanza, in quattro gruppi (<7 mesi, 7mesi, 8 mesi, 9 mesi).
Lo scopo principale del presente studio è stato quello di indagare la relazione tra i temi della costellazione materna (Stern, 1995), principalmente la relazionalità primaria, e l’attaccamento materno-fetale. Ha partecipato al nostro studio un campione di 257 donne suddivise, in base al periodo di gravidanza, in quattro gruppi (<7 mesi, 7mesi, 8 mesi, 9 mesi).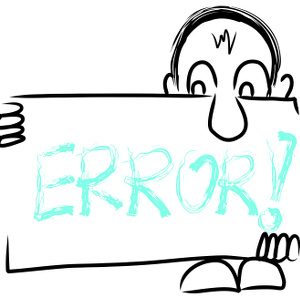 Se un CIM segue con cura i pazienti è infrequente che ci siano emergenze di pazienti noti. Dunque, quando arriva una chiamata d’urgenza, si tratta spesso di situazioni nuove in acuzie che agitano l’animo degli operatori chiamati a partire verso l’ignoto e scarsamente desiderosi di avere un encomio alla memoria e magari una stanza intitolata a loro nome.
Se un CIM segue con cura i pazienti è infrequente che ci siano emergenze di pazienti noti. Dunque, quando arriva una chiamata d’urgenza, si tratta spesso di situazioni nuove in acuzie che agitano l’animo degli operatori chiamati a partire verso l’ignoto e scarsamente desiderosi di avere un encomio alla memoria e magari una stanza intitolata a loro nome.