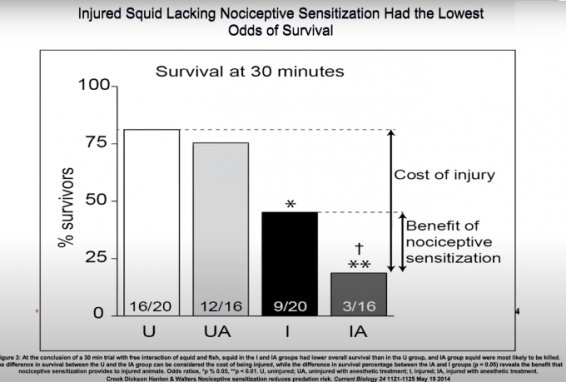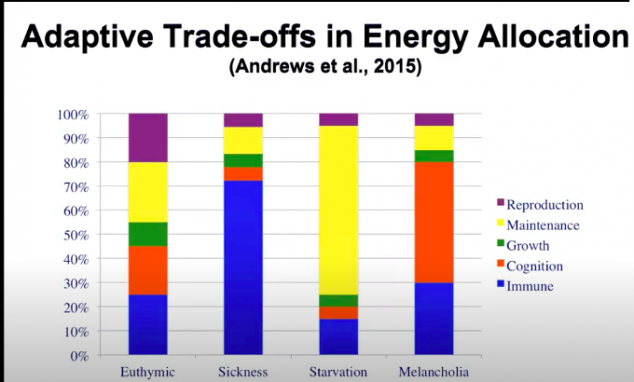Nella mente degli astronauti. I fattori di rischio psicologico dei viaggi nello Spazio
L’obiettivo del presente articolo è quello di approfondire la letteratura scientifica riguardo all’impatto delle missioni spaziali sulla salute psicologica degli equipaggi.
Dal punto di vista fisiopatologico sono già state effettuate diverse ricerche che dimostrano quanto la presenza di particelle radioattive e della microgravità nello Spazio provochino importanti compromissioni a livello cardio-vascolare e vestibolo-cocleare. Dal punto di vista psicologico, invece, sono ancora da approfondire i rischi e gli effetti del volo spaziale. Sono noti fenomeni come le illusioni, la gestione delle emozioni, la fame sensoriale e l’“effetto panoramica”, ma in questo elaborato vengono anche analizzati gli effetti che la permanenza nell’ambiente extra-terrestre può indurre sulla cognizione, sulle emozioni e su processi come la memoria, la percezione e l’attenzione. Microgravità, radiazioni ionizzanti, assenza di ritmo circadiano, accelerazione, rumore, stress e isolamento sono solo alcune delle sfide a cui vengono sottoposti gli astronauti. Questi fattori richiedono un notevole sforzo di adattamento particolarmente complesso a causa del fatto che l’ambiente spaziale si contrappone alle tre principali costanti che hanno plasmato l’organismo umano: l’attrazione gravitazionale, l’alternanza del giorno e della notte e importanti relazioni interpersonali.
Questo articolo vuole richiamare l’attenzione sulla necessità di costruire una nuova branca della psicologia volta allo studio delle specifiche problematiche in vista del costante aumento dei voli nello Spazio e in previsione di un futuro turismo spaziale. Ogni argomento è stato approfondito attraverso articoli scientifici pubblicati su riviste specialistiche internazionali, anche grazie alle indicazioni da parte della NASA e dell’ESA, che si sono rese disponibili inviando materiale scientifico e consigliando riviste indicizzate che trattano l’argomento.
Radiazioni ionizzanti, microgravità e risvolti neuropsicologici
Numerose aree cerebrali risultano compromesse e alterate durante i voli nello Spazio (Oluwafemi, Abdelbaki, Lai, Mora-Almanza & Afolayan, 2021, pp. 27-29). I dati della NASA hanno dimostrato quali siano gli effetti negativi dell’esposizione neurocellulare alle radiazioni, evidenziando gravi danni a carico del sistema immunitario, nello specifico alle cellule Natural Killer (NK), un sottotipo di globuli bianchi in grado di riconoscere e distruggere le cellule tumorali (Jandial, Hoshide, Waters & Limoli, 2018, pp. 7-8).
A questi già gravi effetti si sommano anche criticità nelle prestazioni cognitive e sensomotorie degli astronauti provocate dalla microgravità (Clark, Newman, Oman, Merfeld & Young, 2015, pp. 6-8), condizione denominata anche weightlessness, ovvero assenza di peso o gravità zero (G0). In un contesto di microgravità, il carico che le forze di attrazione esercitano su un individuo e la percezione stessa di gravità sono assenti, pertanto il corpo è come se galleggiasse nell’ambiente (Grimm, 2019, pp. 2-4). Una conseguenza fisiopatologica diretta esercitata dalla microgravità è l’aumento della pressione intracranica (ICP, Intracranial Pressure), causa primaria dei cambiamenti strutturali dell’encefalo (Michael, 2018, pp. 76). I rischi a lungo termine dell’ICP consistono in forti mal di testa e alterazioni della vista, ma anche tinnito pulsante, atassia, disturbi della memoria e disfunzione cognitiva (McGeeney & Friedman, 2014, pp. 446-447). Infatti, è stata riscontrata una condizione descritta come VIIP (Vision Impairment and Intracranial Pressure, disturbi della vista e della pressione intracranica): si tratta di una sindrome dovuta allo spostamento del liquido cefalo-rachidiano causato dal prolungato aumento dell’ICP, che viene evidenziata nei due terzi degli astronauti, la cui maggioranza ha dichiarato un calo del visus al ritorno sulla Terra, persistente anche dopo diversi anni (J. A. David et al., 2012, pp. 66).
La NASA ha fatto diversi investimenti sullo studio dei rischi acuti e cronici (post-missione) relativi all’insorgenza dei deficit del SNC. Dalle ricerche è stato confermato l’effetto negativo della permanenza nello Spazio, capace di indurre fenomeni di erosione della struttura neuronale e dell’integrità sinaptica in specifiche regioni del cervello (Parihar et al., 2016, pp. 10-13). I neuroni ippocampali e corticali mostrano significative riduzioni della complessità dendritica (Mogilever et al., 2018, pp. 17) mentre una minore densità dendritica si trova nel midollo spinale e in altre regioni del cervello. Inoltre, negli astronauti che hanno partecipato a voli di lunga durata si è verificato un restringimento significativo del solco centrale, uno spostamento verso l’alto del cervello all’interno della scatola cranica, un restringimento degli spazi subaracnoidei in cui scorre il liquido cerebrospinale e una riduzione significativa di materia grigia, comprese le ampie aree cerebrali corrispondenti ai poli temporali e frontali (Dwain et al., 2016, pp. 55).
L’apparato cardio-circolatorio e il sistema vestibolo-cocleare
In assenza di gravità il cuore degli astronauti cambia forma assumendo un aspetto più sferico del 9,4%. Nelle missioni della durata di circa 6 mesi la forma sferica sembra essere temporanea in quanto, poco dopo il ritorno sulla Terra, il cuore riprende la sua forma originale allungata grazie alla forza di gravità (Otsuka et al., 2019, pp. 6-7). Gli eventuali disturbi cardio-circolatori legati a questa nuova condizione necessitano di ulteriori approfondimenti.
Per quanto riguarda il sistema vestibolo-cocleare, in caso di microgravità, viene a mancare la verticalità come fonte di riferimento e il sistema percettivo deve riadattarsi. Se le forze gravitazionali cambiano, l’adattamento alla nuova condizione richiede accomodamenti della postura e del sistema motorio con aggiustamenti da parte dell’apparato vestibolare determinando disturbi quali: nausea, conati di vomito, diarrea, inappetenza, cefalea e malessere diffuso, che si ripresentano una volta ritornati sulla Terra. Si parla infatti della “sindrome da adattamento allo Spazio” (Robert, Kennedy, Julie & Daniel, 1999, pp. 23-25), (SAS, “sindrome da adattamento spaziale” o “mal di Spazio”). La SAS può manifestarsi anche al rientro a Terra, in tal caso è definita “Sindrome da sbarco” (ESA, 2019, pp. 1-2). Queste informazioni, giunte nell’encefalo, vengono elaborate e integrate con quelle fornite dal cervelletto e dalla corteccia cerebrale (centro del pensiero e della memoria), (Sarkar et al., 2006, pp. 549-550). Ma se gli input sensoriali ricevuti sono in conflitto tra loro, si può determinare la cosiddetta “cinetosi” (o “malattia del movimento”) che include una serie di disturbi che si manifestano quando ci si trova su un mezzo di trasporto (Zhang et al., 2019, pp. 2). Questa problematica deriva dall’invio al cervello di messaggi contrastanti da parte degli organi dell’equilibrio: orecchio interno, occhi, muscoli e articolazioni. Circa il 70% degli astronauti soffre di cinetosi spaziale (SMS), (Koch et al., 2018, pp. 687-688). Conseguentemente gli astronauti tendono a privilegiare gli indicatori corporei rispetto a quelli visivi per indicare le coordinate di uno stimolo, si parla infatti di “orientamento retinico”, ovvero una tipologia di orientamento che dipende dal parallelismo e dalla verticalità tra la retina dell’osservatore e la posizione di un oggetto complesso (Doorn, Gardoni & Murphy, 2019, pp.125). La percezione, l’orientamento di se stessi e del mondo, è fondamentale non solo per l’equilibrio (Manckoundia, Mourey, Pfitzenmeyer, van Hoecke & Pérennou, 2017, pp. 786-789) ma anche per molte altre sfere della percezione, compresi il riconoscimento dei volti e degli oggetti. L’assenza di gravità influisce sull’informazione vestibolare, e il sistema nervoso centrale deve adattarsi per riorganizzare il controllo delle funzioni come la postura, la coordinazione occhio-mano, l’orientamento spaziale e la navigazione (Cebolla et al., 2016, pp. 8-9). Gli effetti comportamentali che scaturiscono da questa nuova condizione consistono in disturbi d’ansia, attacchi di panico, agorafobia, calo dell’attenzione selettiva e disturbi di memoria (J. A. David et al., 2012, pp. 78- 79).
Le illusioni spaziali e la confusione mentale
Lo Spazio cosmico è fonte di frequenti e bizzarre illusioni. Come avviene durante i lanci nello spazio, l’assenza di peso è preceduta da un’accelerazione, forza potentissima che incolla il cosmonauta allo schienale del sedile. Ma l’organismo si oppone a questa forza: i muscoli reagiscono tendendosi per staccare il corpo dal sedile. Quando l’assenza di peso si manifesta improvvisamente, i muscoli restano tesi per inerzia ed è in quel momento che il cosmonauta prova la sensazione, inevitabile ma erronea, di volare sulla schiena o di trovarsi in posizione supina. Se invece i muscoli della schiena si decontraggono gradualmente, il passaggio all’assenza di peso non genera simili illusioni. Tuttavia, quando il sistema nervoso è incapace di inibire l’informazione alterata proveniente dall’apparato otolitico, le rappresentazioni erronee possono persistere abbastanza a lungo (Koppelmans et al., 2013, pp. 203-204). La natura delle illusioni spaziali è determinata dal ruolo e dal contributo secondario ai vari tipi di input sensoriali dovuti all’orientamento spaziale. È possibile dunque che, in condizioni di microgravità, emergano errori percettivi e illusioni che poi si risolveranno al ritorno sulla Terra. Dalle risposte fornite a una serie di questionari somministrati a 104 astronauti, uno studio di Kornilova (1997) ha rilevato come nel 98% dei casi venisse riferita una qualche forma di illusione circa la propria posizione, il proprio movimento e il movimento degli oggetti circostanti (Kornilova, 1977, pp. 433-435). In particolare, può cambiare la percezione dell’orientamento del proprio corpo: se sulla Terra la verticale soggettiva è legata alla posizione della testa e del corpo, in orbita anche i piedi possono essere percepiti come parte superiore del corpo. Questo fenomeno viene chiamato “illusione dell’inversione” (inversion illusion) ed è dovuto alla distribuzione dei fluidi che lasciano le estremità inferiori per dirigersi verso il cervello (Mammarella, 2020, pp. 78-79). È emerso, inoltre, che anche la percezione della profondità è alterata, parlando in questo caso di “percezione illusoria” (Moore et al., 2019, pp. 13-14). Inoltre, in alcuni individui viene riferita anche un’alterazione dello schema corporeo, vale a dire della rappresentazione della sua forma e delle sue dimensioni, della grandezza assoluta e relativa delle diverse parti dell’organismo e dei movimenti degli arti (Young & Zabini, 2017, pp. 67-68). Questa reazione psichica ricorda la “Sindrome della fine del mondo”, dovuta alla sensazione di sentirsi leggeri come una piuma e di galleggiare nell’aria (Gagarin & Lebedev, 2016, pp. 196-197).
La sfera emotiva degli astronauti
L’adattamento allo Spazio pone vincoli dirompenti per la salute fisica e mentale degli astronauti in termini di isolamento e confinamento. Può accadere che le emozioni mobilitino le risposte psichiche, permettendo di portare a termine imprese a prima vista irrealizzabili. Ma esse possono anche produrre l’effetto contrario, paralizzando la volontà e facendo perdere ogni capacità a coloro che ne sono preda, rendendoli irresoluti e incapaci di agire (Gorbunov et al., 2017, pp. 255-257). Si tratta infatti di una situazione che esige uno sforzo di volontà teso a dominare la crescente inquietudine e a permettere una giusta valutazione di ciò che sta accadendo (Mulcahy, Blue, Vardiman, Castleberry & Vanderploeg, 2016, pp. 883-884). Queste reazioni si possono manifestare in modo diverso da un individuo all’altro. Alcuni ai quali il pericolo causa un vero e proprio shock emozionale rischiano di perdere la lucidità mentale; altri accusano un deterioramento generale dell’attività pratica, sebbene nell’insieme il comportamento resti razionale; altri ancora conservano una perfetta padronanza di se stessi, dando prova di presenza di spirito e di prontezza (vengono definiti: “amanti delle sensazioni forti”). La loro reazione in presenza di un pericolo costituisce “l’eccitazione da combattimento”, uno stato capace di provocare l’intensificazione dell’attività psichica nell’uomo che, dopo aver superato le difficoltà e la paura, prova una soddisfazione del tutto particolare (Ferrand, Ruffault, Tytelman, Flahault & Négovanska, 2015, pp. 723-724).
Un resoconto dettagliato della NASA sugli effetti dell’isolamento e del confinamento distingue tra una condizione comportamentale negativa non patologica e un eventuale disturbo di natura psichiatrica. La prima si riferisce ai cambiamenti a carico dell’umore, della cognizione e delle relazioni interpersonali, mentre il secondo riguarda disturbi diagnosticati secondo i criteri del DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders). Tra i sintomi e i disturbi psichiatrici manifestati più frequentemente ci sono i deliri, il disturbo di adattamento (spesso chiamato anche “depressione situazionale”) e condizioni di nevrastenia caratterizzate da stanchezza, irritabilità, difficoltà di concentrazione, problemi di appetito e di sonno.
La fame sensoriale
In condizioni normali l’uomo non ha quasi mai occasione di trovarsi in mancanza di stimoli. I diversi fenomeni provenienti dall’ambiente circostante vengono percepiti dagli organi di senso e gli impulsi nervosi trasmettono fedelmente al cervello l’informazione corrispondente. L’uomo è ben lontano dall’essere cosciente di tutti gli stimoli che agiscono sui suoi sensi, ma essi sono indispensabili per il normale funzionamento del cervello. Migliaia di immagini diverse passano costantemente davanti ai suoi occhi, in ogni momento. Una quantità di rumori di ogni tipo si succede senza interruzione creando una base sonora ininterrotta. La pelle percepisce i cambiamenti della temperatura e gli spostamenti d’aria, ma durante i voli spaziali l’assenza di stimoli permanenti può originare seri problemi funzionali (NASA, 2021, pp. 3). In questo caso esiste la situazione di “fame sensoriale”, provocata dall’insufficienza degli stimoli ambientali ricevuti dal cervello. Analizzando i risultati degli esperimenti effettuati in una camera di silenzio, si è riscontrato che questa “fame” mette a dura prova i processi psichici dell’uomo.
Si è visto come la musica sia un eccellente antidoto contro la fame sensoriale esercitando un potente effetto emotivo, generando il buon umore e aumentando le capacità lavorative. È emerso che ascoltare la musica trovandosi in orbita consente di registrare variazioni dell’attività fisiologica negli astronauti, permettendo di valutarne lo stato emozionale (Jurij Gagarin, Vladimir V. Lebedev, 2021, pp. 78-83).
Viaggiare nello Spazio presenta molti aspetti positivi e in alcuni casi può favorire la crescita personale. Molti viaggiatori spaziali sono tornati a casa con una visione più positiva di loro stessi e del loro ruolo sul pianeta. Dal cosmo la Terra può essere vista come bellissima e unica, senza confini politici evidenti o conflitti internazionali. Alcuni astronauti nello Spazio hanno riferito esperienze trascendentali, intuizioni religiose e un migliore senso dell’unità del genere umano. A volte il fascino e l’incanto dello Spazio hanno causato gravissimi problemi durante le missioni spaziali. Ad esempio, un cosmonauta rimase così estasiato dalla vista dello Spazio che iniziò a fluttuare fuori dalla navicella dimenticandosi di mettersi in sicurezza attraverso un cavo e un altro alterò il sistema giroscopico della navicella lasciando la sua postazione di lavoro per avere una migliore visuale della Terra. Ma la maggior parte delle esperienze nello Spazio sono state positive e non così strazianti (Tarnas & Tranquilli, 2012, pp. 56-60).
Sulla soglia dell’astronave: l’effetto panoramica
L’effetto panoramica, chiamato anche “effetto della veduta d’insieme” (in inglese Overview Effect) riferito da alcuni astronauti durante il volo spaziale, è un cambiamento cognitivo della consapevolezza causato dall’osservazione della Terra dall’orbita o dalla superficie lunare (Lineweaver & Chopra, 2019, pp. 112). Questo effetto si riferisce all’esperienza di vedere in prima persona la realtà della Terra dallo Spazio, percepita come una piccola, fragile sfera della vita, “appesa nel vuoto”, avvolta da una sottile atmosfera che la protegge dall’ambiente esterno (Appleyard, 2017, pp. 118).
Dallo Spazio gli astronauti sostengono che i confini nazionali svaniscono, i conflitti diventano irrilevanti mentre appare evidente e imperativa la necessità di creare una società planetaria volta a proteggere questo “pallido punto azzurro nello Spazio” (Yaden et al., 2016, pp. 6-7). Risulta particolarmente interessante evidenziare come la reazione degli astronauti deriverebbe soprattutto dal guardare la Terra in tutta la sua bellezza e in tutta la sua fragilità (Voski, 2020, pp. 109-110). Semplificando, dallo Spazio il nostro pianeta appare come piccolo, fragile e indifeso: un posto dove tutti i conflitti umani appaiono secondari e futili rispetto all’enormità dell’Universo (Weibel, 2020, pp. 418).
In relazione all’auto-trascendenza, gli autori affermano che nel caso di questo effetto si prova un senso di unione con il pianeta Terra e tutti i suoi abitanti derivante da uno stimolo visivo particolarmente sorprendente. Sempre secondo Yaden, dallo Spazio gli astronauti percepiscono la Terra come non l’hanno mai vista prima, inducendoli a fantasticare con l’immagine stessa e, di conseguenza, modificando il loro modo di guardare le cose e il mondo (David B. Yaden & Andrew B. Newberg, 2020, pp. 106-110). È stato ipotizzato però anche il rovescio della medaglia, una potenziale condizione psicologica chiamata Earth-out-of-view ovvero il fenomeno del non poter vedere più la Terra, che si potrebbe manifestare nel corso di un futuro viaggio verso Marte. Non vedendo più la Terra, l’equipaggio perderebbe il suo punto di riferimento e potrebbero manifestarsi disturbi dell’umore, depressione, ansia e allucinazioni (Mammarella, 2020, pp. 80-81).
Dall’analisi di queste nozioni si ipotizza che negli astronauti, una volta tornati dai viaggi spaziali, possano comparire dei disturbi che superano la soglia della sofferenza lieve. Si potrebbe, a nostro parere, parlare di “Sindrome di Gulliver”, una sindrome dovuta alla necessità di riadattarsi alla vita sulla Terra. Il nome che proponiamo deriva dalla letteratura americana: “I viaggi di Gulliver” di Jonathan Swift, in cui nella quarta e ultima parte del romanzo, l’autore descrive dell’abbandono del protagonista nella terra dei “cavalli razionali”. La figura del cavallo rappresenta nel romanzo metaforicamente la bellezza, la razionalità, la perfezione della natura e l’intelligenza per cui Gulliver inizia a comprenderne l’immensa superiorità rispetto alla sua razza. Una volta esiliato anche da queste terre Gulliver si ingegna per tornare a casa, in Inghilterra. Tuttavia, quando giunge a casa, non riesce più a tollerare la stupidità, l’arretratezza e il declino in confronto con quella terra ammirata in cui tutto era razionale e perfetto. Questo racconto evoca metaforicamente quello che può accadere agli astronauti nello spazio (come l’effetto panoramica di quando si è in orbita) e ciò che può comportare il loro rientro sulla Terra: disturbi d’ansia, attacchi di panico, agorafobia ecc.
Riflessioni conclusive: la necessità di una nuova disciplina, la Psicologia dello Spazio
L’interesse nell’approfondire la letteratura riguardante le variabili psicologiche implicate in una missione spaziale deriva dalla ragione principale che nei prossimi anni la Psicologia dello Spazio rivestirà un ruolo cruciale in molti progetti. Tra questi emerge quello della NASA (National Aeronautics and Space Administration) HRP (Human Research Program), con lo scopo di studiare i rischi che una missione spaziale può presentare per la salute dell’uomo, integrando i risultati di varie discipline applicate allo studio dello Spazio e avere così una visione d’insieme delle capacità umane di adattamento nello Spazio. Successivamente anche l’Agenzia Spaziale Europea (ESA, European Space Agency) ha lanciato dei programmi simili per affrontare una serie di problemi chiave relativi ai fattori umani nelle missioni spaziali a lungo termine. Questi progetti testimoniano l’esigenza di riportare al centro delle ricerche astronomiche l’uomo con le sue potenzialità e debolezze.
Inoltre, con l’attuale presenza di una sonda su Marte e la previsione di un futuro lancio, è essenziale approfondire maggiormente la potenzialità dell’impatto psicologico e fisico delle missioni spaziali sull’uomo. Infatti, durante i precedenti voli spaziali, si sono verificate situazioni di importante stress psicologico che ha influito negativamente sulle prestazioni dei membri dell’equipaggio e sulle loro capacità di relazionarsi con il personale nel controllo della missione. Si sente sempre di più la necessità di affrontare i temi relativi all’adattamento psicologico e neurosensoriale nello Spazio, come pure gli effetti dell’isolamento e del confinamento. Ma nonostante il vaglio accurato della letteratura scientifica, questo campo di ricerca risulta carente di studi in ambito psicologico. Per questo motivo ci appare chiara la necessità di approfondire la Psicologia dello Spazio, con una nuova branca della psicologia dedicata esclusivamente all’analisi delle problematiche psicofisiche dell’uomo nello Spazio.
Per esempio, gli psicologi esperti di Psicologia dello Spazio possono svolgere un ruolo importante nell’analisi e nell’esplorazione dei voli spaziali. Infatti, il contributo psicologico potrebbe rivelarsi fondamentale nella selezione e formazione, nella gestione dei conflitti, dello stress e della convivenza forzata in uno spazio molto ridotto per lunghi periodi di tempo. Durante il reclutamento, gli psicologi possono fornire linee guida sugli stili di coping appropriati per reagire a fattori di stress legati alla missione; durante l’addestramento, possono aiutare gli astronauti a pianificare e affrontare i problemi sviluppando strategie di coping adatte. Il coping orientato al compito è correlato al controllo e all’efficienza, permettendo così una riduzione dei livelli di stress e ansia nelle situazioni di emergenza. Pertanto, dovrebbero essere prese in considerazione le indagini sulle dinamiche di gruppo, lo stress fisico e psicologico causato da un tale ambiente e l’impossibilità di mettere in atto azioni semplici per affrontare e risolvere questi problemi. Tuttavia, è evidente che l’impatto del volo spaziale su un individuo non si esaurisce al momento del rientro fisico. È importante ricordare che l’astronauta dovrà anche fare un “rientro” psicologico, post-volo, alla vita sulla Terra. Infatti, nell’attuale momento storico pesantemente segnato dal conflitto tra Russia e Ucraina, gli astronauti russi attualmente in orbita si sono mostrati indifferenti e totalmente estranei alle decisioni politiche del loro Paese, come confermato dall’effetto panoramica (Thompson, 2022, pp.1-3). Questa sensazione di arretratezza dichiarata dagli astronauti una volta tornati sulla Terra rappresenta il focus di una delle problematiche psicologiche a cui gli astronauti vanno incontro, il riadattamento alla vita sulla Terra.