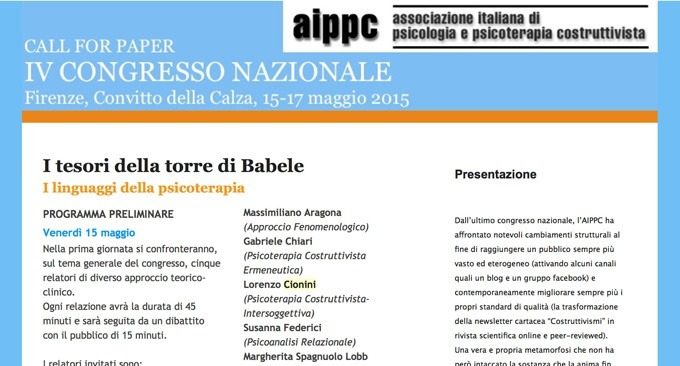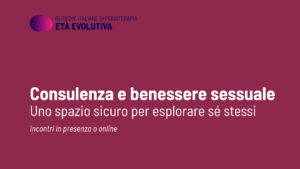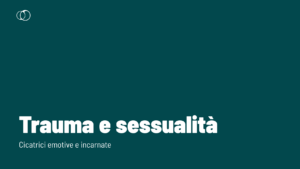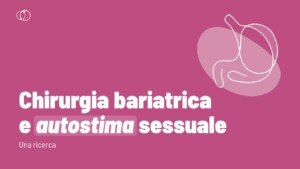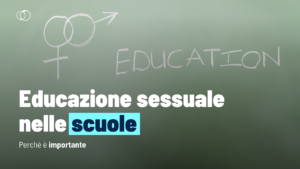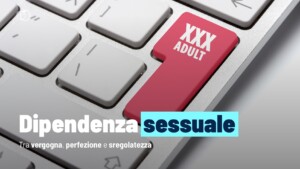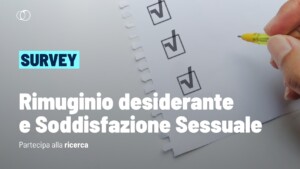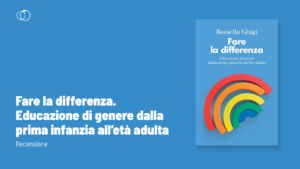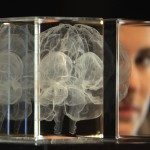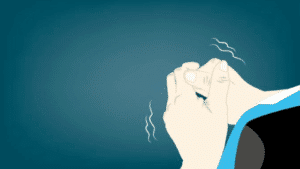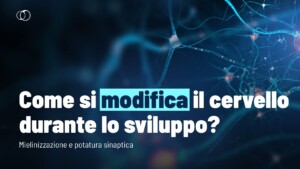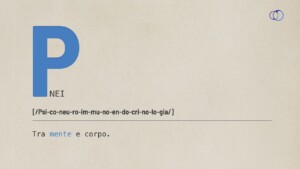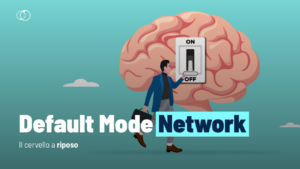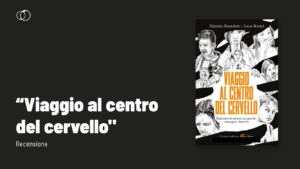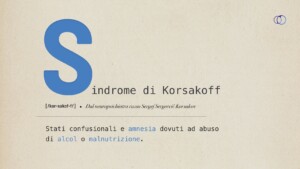I vissuti psicologici e psicopatologici della maternità
OPEN SCHOOL STUDI COGNITIVI MILANO
La gravidanza e la maternità costituiscono un periodo di grandi cambiamenti per la donna e per la coppia e molteplici risultano le emozioni e i vissuti psicologici associati all’evento della nascita di un bambino.
– “Sto per diventare madre, che gioia ma che fatica!”
– “Sarò una buona madre?”
– “Potrò riprendere il mio lavoro e la mia vita anche quando nascerà mio figlio?”
La gravidanza e la maternità costituiscono un periodo di grandi cambiamenti per la donna e per la coppia e molteplici risultano le emozioni e i vissuti psicologici associati all’evento della nascita di un bambino. La Benedek ha definito la gravidanza come un evento psicosomatico che genera modificazioni sia fisiologiche che psicologiche. La Bibring, invece, utilizza l’espressione di “crisi maturativa” e concepisce la gravidanza come un processo in cui si riattivano conflitti legati al periodo infantile e si riattualizzano processi di identificazione inconsci con la figura materna. I conflitti infantili trovano una risoluzione in questo periodo di svolta, che comporta una rielaborazione delle proprie esperienze e il raggiungimento di un maggiore livello di integrazione. Secondo la Pines (1982), le neo-mamme in questa fase del ciclo vitale ridefiniscono la propria identità femminile, rivivono il processo di separazione-individuazione dalla propria madre e sperimentano una duplice identificazione con la madre e il feto: sono allo stesso tempo figlie delle loro madri e madri dei loro figli.
La gravidanza, tuttavia, non viene vissuta da tutte le donne nello stesso modo: infatti, essa può arrivare nel momento giusto, troppo presto o troppo tardi, dopo tanti tentativi, può essere desiderata o non programmata, può avvenire senza che si abbia un partner stabile o si potrebbe essere in un Paese straniero o in difficoltà economiche. Questi fattori influenzano il proprio modo di vivere la gravidanza e le emozioni conseguenti: ad es. la donna potrebbe essere in ansia o esperire un umore deflesso se la gravidanza arriva troppo presto o se non si ha un partner stabile supportivo o se si versa in difficoltà economiche, ecc. Dunque,
a seconda del proprio vissuto, possono emergere soprattutto emozioni positive di gioia e speranza o emozioni negative durature e intense di ansia o tristezza. Tuttavia, anche nelle situazioni in cui la gravidanza è desiderata ed è rappresentata positivamente nella propria mente, possono alternarsi emozioni positive e negative, gioie e ansie, speranze e delusioni.
Diverse ricerche (Raphael-Leff, 2014) hanno dimostrato che le donne durante la gravidanza sviluppano uno stile materno che influenza le aspettative, fantasie e rappresentazioni della donna gravida e la relazione tra madre e bambino. Raphael-Leff ha definito 3 stili materni: la madre “facilitante” e la madre “regolatrice”, mentre nel mezzo si colloca lo stile della “reciprocità”. La madre “facilitante” vive la maternità come un’esperienza positiva che le consente di rivivere l’unione vissuta con la madre durante l’infanzia; la donna si costruisce la propria identità di madre, accetta la gravidanza e si prepara adeguatamente al parto; dopo la nascita del bambino tende a ricercare la vicinanza del piccolo e a rimandare la ripresa dell’attività lavorativa.
Talvolta però la madre “facilitante” può idealizzare eccessivamente il bambino, negando qualsiasi forma di imperfezione; la madre “facilitante” in genere non coglie nessun difetto o problematica nella gravidanza, la vive come un’esperienza meravigliosa e a volte rischia di sacrificare completamente se stessa e la sua realizzazione personale e professionale per il bambino. La madre “regolatrice”, invece, non tollera le trasformazioni corporee, considera il feto un intruso, la gravidanza le riattiva conflitti infantili e il parto è concepito come un’esperienza negativa; tende a tornare velocemente allo svolgimento delle sue attività quotidiane e a delegare la cura del bambino ad altre figure significative. In una posizione intermedia, invece, si colloca lo stile della reciprocità: la donna è felice di aspettare un bambino, ma presenta anche rimpianti rispetto ai cambiamenti inevitabili che subiranno la sua vita professionale, personale e di coppia.
Riporto una citazione del testo “La gravidanza vista dall’interno” di Raphael-Leff emblematica per comprendere lo stile della reciprocità:
“Quanto alla gravidanza quello che ho dentro è un essere benvenuto e sono felice che ci sia. Sono io che l’ho invitato, sento che ha preso il controllo in maniera creativa, non invasiva. Il bambino non mi fa richieste irragionevoli, è una sensazione benevola. Sono sempre più legata a questa creatura che si muove dentro di me, e osservo anche come risponde alle cose. Ma non voglio fantasticare troppo, a rischio di rimanere delusa: questo bambino è una persona con le sue risposte e con una personalità, che sono sinceramente curiosa di conoscere. Non voglio introdurre le mie aspettative personali, è meglio aspettare e stare a guardare e vedere come si sviluppano queste qualità nel corso del tempo.”
I cambiamenti che caratterizzano questa fase delicata della vita di una donna e della coppia sono molteplici. Innanzitutto, il primo cambiamento riguarda la propria immagine corporea e per alcune donne può essere difficile accettare l’aumento di peso, il pancione e le relative difficoltà fisiche nello svolgere le attività quotidiane che possono insorgere soprattutto negli ultimi mesi.
Dopo il parto, invece, è necessario rinunciare allo stato di gravidanza e separarsi dal bambino interno, per instaurare un rapporto affettivo con un bambino reale e non più ideale. Oltre ai cambiamenti fisici, la maternità comporta anche delle conseguenze a livello sociale e psicologico in quanto la neo-mamma si assume le responsabilità insite nel ruolo genitoriale e talvolta può essere costretta a lasciare il suo lavoro, generando delle difficoltà finanziarie nella famiglia; mentre in altri casi può temere di perdere la sua libertà e la propria identità ed è necessario riorganizzare le giornate in base alle esigenze del bambino (Schaffer, 2005). Nonostante la maternità generi questi cambiamenti, l’arrivo di un figlio può comportare anche un aumento della sicurezza personale, una maggiore realizzazione di sé e un miglioramento nelle relazioni con la propria famiglia d’origine (Schaffer, 2005).
La gravidanza comporta anche una ridefinizione del rapporto di coppia, in quanto sia a livello reale che immaginario, è necessario includere il terzo e questo tende a turbare l’equilibrio familiare (Bastianoni, Taurino, 2009). Anche il partner si trova ad affrontare un processo di adattamento che dipende dalla sua storia infantile e dal processo di identificazione con il padre. È stato dimostrato che nel corso della transizione alla genitorialità, generalmente, il grado di soddisfazione e di benessere percepito dalla coppia si riduce sebbene questo declino non interessi tutte le coppie (Belsky, Rovine, 1990).
Entrambi i genitori, in genere, si chiedono quali comportamenti e modalità relazionali che hanno appreso dalla famiglia d’origine intendono riproporre al loro figlio. La nascita di un bambino genera anche una ridefinizione del rapporto con i propri genitori in quanto l’assunzione del ruolo genitoriale porta a instaurare con la famiglia d’origine una relazione paritaria e adulta (Bramanti, 1999).
La nascita di un figlio porta entrambi i genitori a chiedersi se saranno competenti e adeguati nell’adempiere ai compiti impliciti nel ruolo genitoriale. Il costrutto di “self-efficacy” si riferisce a quanto i genitori si percepiscano capaci di rapportarsi e di comportarsi in modo adeguato col piccolo svolgendo con successo i compiti connessi al ruolo genitoriale. Se il livello di efficacia nei genitori è alto ciò li rende meno vulnerabili allo stress connesso alla genitorialità e li porta ad affrontare con più serenità anche le piccole difficoltà quotidiane. Nel complesso un alto livello di “self-efficacy” sia nella madre che nel padre è associato ad una globale soddisfazione della vita familiare (Bramanti, 1999).
Ogni futuro genitore durante l’attesa del bambino fantastica sul nascituro, su come sarà, il nome, il genere, ecc. e in questo modo entrambi i genitori cominciano a fargli spazio, non solo nell’esterno, ma anche nella propria mente e ci si prepara psicologicamente a quello che avverrà dopo il parto. Si parla in questo caso di “bambino ideale” fantasticato e atteso durante la gravidanza. Il genitore proietta tutte le sue aspettative sul bambino e lo concepisce come la realizzazione di un progetto personale e di coppia. Tuttavia, crearsi delle aspettative troppo alte rispetto al piccolo potrebbe far incorrere in future delusioni nel momento in cui questo non risponde alle proprie esigenze elevate: più alte sono le aspettative, più alta potrebbe essere la delusione e questo potrebbe generare delle difficoltà relazionali col bambino che non risponde alle proprie aspettative e un senso di fallimento personale. Anche per quanto concerne la rappresentazione del genitore si distinguono quella del “genitore ideale” e del “genitore reale”: l’idea del genitore ideale viene definita in base alle proprie esperienze, alla propria personalità e alla famiglia d’origine.
La letteratura ha evidenziato che soprattutto le primipare appaiono molto vulnerabili nel post-partum e necessitano di un adeguato supporto emotivo da parte del partner, della madre, di altri parenti e di esperti per l’accudimento del piccolo, l’allattamento e il riconoscimento dei segnali di benessere e di malessere del bambino. Il rientro a casa, l’allattamento, l’adattamento ai ritmi biologici del bambino sono i principali vissuti del puerperio. La neo-mamma può temere di fallire nel suo ruolo e questo le procura ansia e talvolta uno stato depressivo (Della Vedova e al., 2008). Per questo, è possibile che insorgano disturbi psicopatologici ai quali si presta sempre maggiore attenzione nell’ambito della prevenzione e del trattamento (Bellantuono e al., 2007).
La letteratura classifica questi disturbi in 3 categorie principali: Maternity Blues, depressione post-partum e psicosi puerperale.
Il Maternity Blues rappresenta il disturbo emotivo più comune e, allo stesso tempo, più lieve e transitorio, che ricorre molto spesso nella prima settimana dopo il parto. È stata rilevata una prevalenza variabile dal 50 all’85% e questa non sembra differire tra le culture. Questo disturbo è caratterizzato dal seguente quadro sintomatologico: tendenza al pianto, irritabilità, labilità dell’umore, disturbi del sonno, tristezza. Sebbene questo disturbo sia considerato una conseguenza fisiologica del parto, nel 20% dei casi evolve in un Episodio Depressivo Maggiore nel giro di un anno (Caroti e Al., 2007).
La depressione post-partum richiede una diagnosi differenziale rispetto al Maternity Blues. L’insorgenza può avvenire anche in gravidanza: nel sesto mese, la depressione colpisce approssimativamente il 10% delle donne di età compresa tra i 25 e i 44 anni (Cooper, Murray, 1998). I sintomi più frequenti sono: tristezza, sentimenti di colpa o di autosvalutazione eccessivi o inappropriati, difficoltà di concentrazione, alterazioni del sonno e dell’appetito, astenia. In molti casi, i sintomi d’ansia possono associarsi per comorbidità a sintomi depressivi. L’esordio della depressione è previsto entro i primi 3 mesi dal parto e la durata media è di alcuni mesi. Le cause sono molteplici; i sintomi si possono ricondurre a fattori di tipo ormonale o di natura emotiva: il cambiamento fisico e della concezione di sé, la sensazione di perdita della libertà e della propria identità. Ad essi si aggiungono fattori pratici, tra cui l’alterazione del ritmo sonno-veglia a causa dell’allattamento e variabili psicosociali, quali una relazione insoddisfacente con il partner, la mancanza di supporto sociale, difficoltà economiche, ecc. Ad essi si aggiungono anche alcuni fattori neonatali del bambino tra cui il temperamento e fattori ostetrici e perinatali.
La psicosi puerperale è il disturbo psichiatrico più grave e raro. I sintomi caratteristici sono: deliri, allucinazioni, brusche oscillazioni dell’umore, disturbi del comportamento. La madre manifesta un rifiuto totale del piccolo e per la maggior parte del giorno appare triste ed apatica, tanto da non dedicarsi neanche alla cura del sé. Spesso compaiono idee paranoidi di persecuzione e si rileva un alto rischio di suicidio e di infanticidio.
Questi disturbi hanno delle conseguenze sia a breve che a lungo termine anche sul bambino e sulla relazione di attaccamento tra madre e bambino. Da questo, si comprende, quanto sia fondamentale una precoce individuazione dei sintomi per evitare che il disturbo si aggravi e per poter intervenire tempestivamente.
ARTICOLO CONSIGLIATO:
Naturalmente infertile: storie di strade e di sogni – Recensione
BIBLIOGRAFIA:
- Benedek, T.F. (1956). Toward the biology of the depressive constellation. Journal of the American Psychoanalytic Association, 4 , 389-427.
- Bibring, G.L. (1959). Some considerations of the psychological processes in pregnancy. The psychoanalytic study of the child, 14, 113-121.
- Pines, D. (1982). The relevance of early psychic development in pregnancy and abortion. International Journal of Psychoanalysis, 63, 311-320.
- Raphael-Leff, J. (2014). La gravidanza vista dall’interno. Astrolabio: Roma.
- Schaffer, H.R. (2005). Psicologia dello sviluppo. Raffaello Cortina: Milano.
- Bastianoni, P., Taurino, A. (2009). Famiglie e genitorialità oggi: nuovi significati e prospettive. Unicopli: Milano.
- Belsky, J., Rovine, M. (1990). Patterns of marital change across the transition to parenthood: pregnancy to three years postpartum. Journal of Marriage and the Family, 52, 5-19.
- Bramanti, D. (1999). Coniugalità e genitorialità: i legami familiari nella società complessa: Atti del Primo Seminario Internazionale del Redif. Milano: Vita e pensiero.
- Della Vedova, A.M., Cabrassi, F., Ducceschi, B., Cena, L., Lojacono, A., Vitali, E., De Franceschi, L., Guana, M., Bianchi, U.A., Imbasciati, A. (2008). Parto e puerperio: i vissuti delle donne in un’ottica di ricerca multidisciplinare. Syrio online. Retrieved August, 2008
- Bellantuono, C., Migliarese, G., Maggioni, F., Imperatore, G. (2007). L’impiego dei farmaci antidepressivi nel puerperio. Recenti progressi in medicina, 98 (1), 29-42. DOWNLOAD
- Caroti, E., Fonzi, L., Bersani, G. (2007). Modelli neurobiologici nei disturbi dell’umore post-partum. Rivista di psichiatria, 42 (6), 366-376. DOWNLOAD
- Cooper, P.J., Murray, L. (1998). Postnatal depression. Clinical Review, 316, 1884-1886.