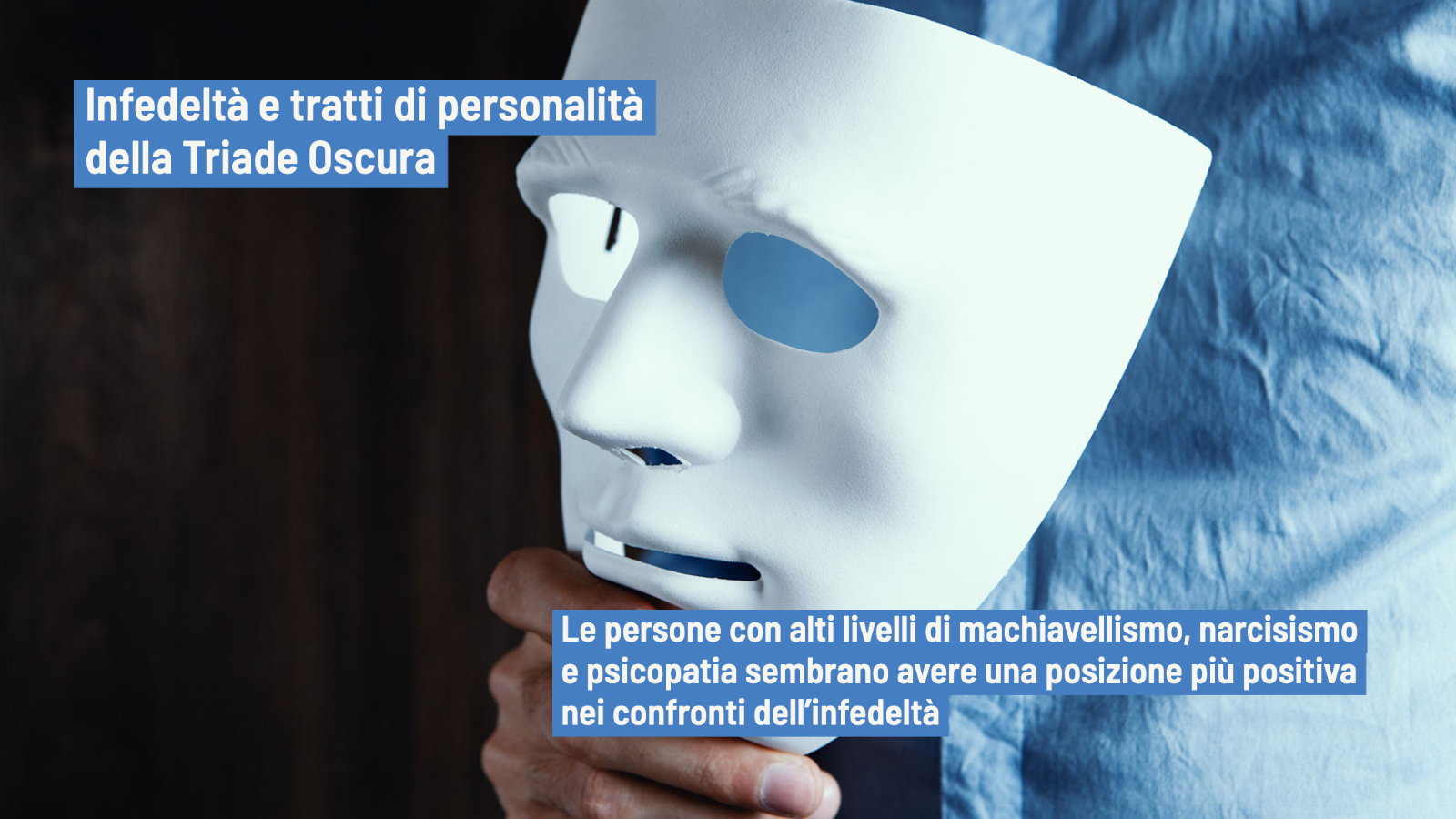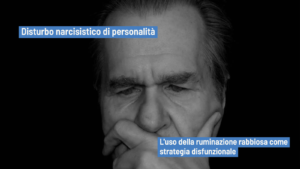La creatività secondo la teoria sistemica di Csikszentmihalyi: il ruolo del dominio e dell’area di specialità
Il modello sistemico di Csikszentmihalyi vede la creatività come un evento culturale, sociale e psicologico nello stesso tempo. Essendo convinto, all’inizio del suo percorso scientifico, che la creatività sia un processo esclusivamente intrapsichico, Csikszentmihalyi si rende conto, in seguito alle sue ricerche e a quelle di altri studiosi come Morris Stein e Dean Simonton, dell’importanza delle variabili esterne nello studio della creatività.
Le variabili esterne, che costituiscono l’ambiente, si costituiscono in due aspetti principali: uno simbolico o culturale, chiamato dominio, e uno sociale, chiamato area di specialità. La creatività è un fenomeno che risulta dall’interazione tra la persona, il dominio e l’area di specialità.
Il ruolo del dominio
Il dominio consiste in un set di regole simboliche e procedure (Csikszentmihalyi ,2005, 247) specifiche, che conserva e trasmette il patrimonio di conoscenze. Il dominio è una categoria importante per la creatività, in quanto la novità che essa porta può aver senso soltanto in riferimento a qualcosa che già esiste, l’originalità dovendosi rapportare al tradizionale. Un dominio, come per esempio la matematica, la pittura, la musica, trasmette in continuazione informazioni alla persona, mentre la persona che manifesta creatività provoca un cambiamento in un particolare dominio o lo trasforma in uno nuovo che rimarrà nel tempo.
Alcune persone hanno più opportunità delle altre di produrre dei cambiamenti nei dominii, sia per le qualità personali, sia perché si trovano in una posizione favorevole rispetto a certi dominii, posizione che può essere data da un maggiore accesso o da una posizione sociale che permette di impiegare più tempo di sperimentazione. Per esempio, molte delle scoperte scientifiche di una volta sono state fatte da persone che avevano sia i mezzi, che il tempo necessari, così come alcuni preti (Copernico), precettori (Lavoisier), medici (Galvani). Al contrario, una persona non può essere creativa in un dominio a cui non è esposta: per quanto un bambino possa avere delle doti in matematica, egli non potrà contribuire con qualcosa di nuovo alla matematica senza sapere le sue regole (Csikszentmihalyi ,2005, 250).
L’insieme dei dominii fanno parte di ciò che noi chiamiamo cultura, ovvero il sapere di una società o dell’intera umanità. Tra i primi dominii possiamo nominare quelli del linguaggio, dell’arte, della musica, della religione.
L’interazione tra il dominio e le persone nell’ambito della creatività consiste nel fatto che le persone creative introducono sempre un cambiamento nel dominio, e il cambiamento influisce sui modi di pensare, agire o essere dei membri di quella cultura.
Il cambiamento che non influisce sui pensieri, sentimenti e i modi di agire non è un cambiamento creativo. Dawkins (cit. in Csikszentmihalyi, 2005, 250) fa un’analogia tra l’evoluzione biologica e la creatività, ossia tra il modo di trasmissione del materiale genetico tramite il gene e quello del patrimonio culturale, tramite quello che lui chiama meme. A differenza del gene, che trasmette le informazioni geneticamente, i memi di un dominio sono trasmessi intenzionalmente e imparati. Il meme (tipi di conoscenza, stili dell’arte, sistemi di credenze, ecc.) è un’ unità di informazione culturale di una comunità i cui membri hanno generalmente lo stesso modo di pensare, fare ed essere, imparati gli uni dagli altri e riprodotti senza modificarli.
Quando si produce un cambiamento invece abbiamo a che fare con la creatività. I memi si sono modificati molto lentamente durante la storia. Per esempio, per modificare l’utensile di pietra apparso nell’epoca di pietra ci è voluto un milione di anni. Alcuni aspetti della cultura possono influire sulla modificazione e l’apparizione di nuovi memi: il modo immagazzinare le informazioni, l’accessibilità alle informazioni, il grado di differenziazione dei dominii, il grado di integrazione della cultura, l’apertura.
Se le informazioni sono immagazzinate in un modo rigoroso e durevole, le persone sono facilitate nell’assimilazione del sapere e, di conseguenza, si possono trovare in una situazione favorevole rispetto all’innovazione. L’accessibilità all’informazione invece determina la cerchia delle persone che possono partecipare ai processi creativi: nel Medioevo, per esempio, il clero ha limitato l’accesso delle masse alle conoscenze religiose, così come la richiesta di conoscere il latino e il greco hanno limitato l’accesso del popolo all’educazione superiore. Per quanto riguarda il grado di differenziazione dei dominii, possiamo dire che la specializzazione delle informazioni porta chiarezza e i progressi possono essere più probabili. L’integrazione della cultura invece comporta la difficoltà dell’accettazione di una novità di un certo dominio, in quanto implicherebbe la modificazione dell’intera cultura. Ma una volta accettata, questa novità porta cambiamento in tutta la cultura.
Infine, l’apertura di una cultura alle informazioni di un’altra fa crescere la possibilità di innovazione. Infatti, i nuovi memi appaiono più frequentemente nelle culture che sono esposte a idee e credenze diverse, spesso per la fortuna di una posizione geografica strategica o per ragioni economiche. E’ quello che è successo con i commercianti greci che hanno raccolto informazioni dall’Egitto, dall’Oriente, dal nord dell’Africa, Persia e Scandinavia, per poi elaborarle nelle loro città stato. E’ anche l’esempio di Firenze e Venezia, che nel periodo del Rinascimento erano centri di produzione e commercio.
Spostando l’attenzione dalla cultura al dominio, possiamo valutare anche l’influenza di alcune caratteristiche del dominio sulla creatività, come per esempio il sistema di codificazione, l’integrazione delle informazioni del dominio, l’importanza del dominio per la cultura, l’accessibilità del dominio, il grado di autonomia del dominio rispetto alla cultura. Di solito, un dominio sviluppa i propri memi e i propri sistemi di codifica, che, per quanto sono chiari, per tanto sono assimilabili e quindi possono costituirsi base e strumenti per la creatività.
Rispetto al grado di organizzazione delle informazioni, un dominio con un sistema simbolico debole e diffuso si troverà nell’impossibilità di stabilire se una novità porta o meno dei miglioramenti, così come è capitato nel dominio della chimica prima dell’adozione della tabella di Mendeleev. Al contrario, un sistema può essere talmente organizzato che diventa rigido e rende impossibile ogni innovazione, come nel caso della fisica pre-quantistica. L’importanza di un dominio per una cultura varia nel tempo, in funzione di alcuni fattori, come per esempio le opportunità di realizzazione professionale ed economica, le prospettive per il futuro, ecc. Il dominio soprastante attrae gran parte dell’interesse dell’elite, aumentando così le possibilità di manifestazione della creatività. Come esempio possiamo portare il dominio dell’arte nel periodo del rinascimento, la fisica quantistica all’inizio del ventesimo secolo.
Anche l’accessibilità delle informazioni di un dominio può stimolare la creatività, essendo conferma in questo senso gli effetti che ha avuto l’introduzione della stampa o dell’internet, in tempi più recenti. Un’ altra caratteristica del dominio che influisce sulla creatività è la sua autonomia rispetto ad altri. Quando essa viene a mancare, il dominio più importante di quel momento li può bloccare o limitare l’estensione e la possibilità di sviluppo, come è successo per il dominio dell’astronomia nei casi di Galilei e Giordano Bruno, quando il dominio imperante era la religione che voleva proteggere le sue verità. Un altro esempio in questo senso può essere il dominio politico marxista nell’Unione Sovietica, che respingeva l’emergere di idee di altri dominii che entravano in conflitto con le proprie (Csikszentmihalyi, 2005, 254-255).
LEGGI ANCHE GLI ARTICOLI SU: CREATIVITA’
Il ruolo dell’area di specialità
L’area di specialità è composta da specialisti di un certo dominio che hanno il compito di selezionare e valutare le performance delle persone, in vista dell’inclusione o meno delle loro creazioni in uno specifico dominio. L’area di specialità si riferisce all’organizzazione sociale di un certo dominio, come per esempio i professori, i critici d’arte, i custodi dei musei, ecc. Così come un dominio è necessario perché una persona possa portare novità, un’area di specialità è necessaria per deliberare quale di queste novità merita di essere introdotta nei dominii, quindi nella cultura. Tra i memi esiste una concorrenza simile a quella che esiste tra i geni. Per sopravvivere, le culture devono eliminare gran parte delle nuove idee che i suoi membri producono, non potendo assimilare tutte le novità senza dissolversi nel caos. L’individuo, per il limite di attenzione, non può seguire tutte le novità, ma solo una parte di loro. Nello stesso tempo, la cultura non può sopravvivere a lungo se non quando gran parte dei suoi membri presta attenzione ad almeno alcune stesse cose. Da qua l’esigenza di selezione e l’importanza delle diverse aree di specialità che agiscono da filtri, aiutandoci a scegliere quelle nuovi memi che meritano la nostra attenzione.
La società come insieme di aree di specialità
Nella prospettiva sistemica, l’insieme delle aree di specialità legate tra di loro, e quindi degli individui che hanno il potere di modificare i dominii, costituiscono la società. Esistono diverse condizioni della società che sono rilevanti per la creatività, in termini di stimolazione o inibizione: la ricchezza della società, l’interesse per le nuove idee, l’organizzazione sociale ed economica, la mobilità e le situazioni conflittuali, la complessità della società.
Di solito, le società sviluppate hanno più possibilità di incoraggiare la creatività, in quanto possono aumentare l’accessibilità alle informazioni, possono offrire alle persone una formazione più specializzata, hanno i mezzi per costruire università e laboratori e per ricompensare gli sforzi creativi, nonché per mettere in pratica le nuove idee. Nelle società in cui invece l’intera energia fisica ed intellettuale viene investita in attività legate alla sopravvivenza, esistono meno probabilità perché le innovazioni siano stimolate, prese in considerazione e riconosciute. Nonostante ciò, sembra che esista una distanza tra la ricchezza e l’attuazione della creatività, dovuta al fatto che prima di tutto la ricchezza viene investita in opere sociali e di infrastruttura (trasporto, industria, ecc.) e solo dopo nello sviluppo dei dominii di altro tipo (telefonia, servizi), come testimonia la situazione degli Stati Uniti del diciannovesimo secolo.
Un altro modo in cui la società influisce sulla creatività è legato al suo essere proattiva o reattiva alle novità. A differenza di una società proattiva, quella reattiva non sollecita e non stimola la creatività, come è successo nell’Egitto, quando, in seguito a realizzazioni spettacolari raggiunte nell’arte, architettura, religione e tecnologia, si è deciso di non cambiare più niente, venendo riconosciuta soltanto la precisione dell’esecuzione, ma non l’originalità.
Anche il tipo di organizzazione della società ha un ruolo importante per la creatività, in termini di apertura o meno al cambiamento.
Le società strutturate in maniera stabile, le società ugualitarie e quelle in cui l’autorità centrale tende all’assolutismo hanno pochi interessi per il cambiamento, per il fatto che la novità viene vista come minaccia per lo stato attuale delle cose. Le aristocrazie e le oligarchie possono favorire la creatività più che le democrazie o i regimi socialisti, per il motivo che, quando il potere e la ricchezza sono concentrate nelle mani di pochi, è più facile destinare parte di essi per sperimenti rischiosi o non necessari.
La mobilità, le minacce esterne e i conflitti interni di una società influenzano in modo positivo la creatività. La mobilità permette l’accesso e l’uso di diverse idee delle diverse culture, motivo per il quale tante opere d’arte o scoperte scientifiche sono nate in città che erano grandi centri commerciali, come per esempio Firenze, Napoli, Venezia, durante il Rinascimento. Anche la disintegrazione interna sembra avere come effetto un incoraggiamento della creatività, probabilmente per il fatto che gli interessi delle classe di solito separate arrivano a sostenersi reciprocamente. Le minacce esterne invece le consideriamo in termini di concorenza tra diverse società in diversi dominii, quando ognuna vuole superare le altre.
La complessità di una società si misura anche in funzione del grado di assimilazione della novità, che a sua volta dipende dalla specializzazione e dall’uniformità. Le condizioni ideali della creatività sono legate alla forte differenziazione dei dominii, insieme però ad una unità organica.
L’area di specialità
Le aree di specialità possono variare come grandezza in funzione del tipo di dominio e del suo grado di specializzazione. Esistono aree di specialità composte da poche persone, come è il caso del dominio delle lingue e letterature assire, oppure del dominio della biologia molecolare. Al contrario, possono esistere aree di specialità formate da mille specialisti, come nel dominio dell’ingegneria elettronica, altre che si confondono con la società, come può essere quello della musica leggera. Le aree de specialità hanno un ruolo decisivo nel selezionare e introdurre nei dominii i prodotti creativi. Ci sono diversi aspetti che contribuiscono alla probabilità di accettazione o rifiuto delle novità da parte dell’area di specialità: il rapporto con le risorse, il rapporto con le altre aree di specialità, la flessibilità.
Un’area di specialità, per attirare persone verso il proprio dominio, deve essere in grado di ottenere risorse dalla società, in modo da poter offrire ricompense economiche o legate alla posizione sociale. Infatti, non a caso, durante la storia, la creatività nell’arte e nelle scienze si è sviluppata in società che avevano fondi da investire in quei dominii: le opere di Firenze sono state fatte con il contributo dei banchieri di tutta l’Europa, così come Leonardo da Vinci si è spostato in diverse parti del mondo in funzione del cambiamento del mercato. Alcune aree di specialità attirano nuovi talenti per la posizione importante dei suoi valori nella società, come succede nei giorni d’oggi con l’ecologia o l’informatica.
Quando un’area di specialità è dipendente da considerazioni politiche, religiose o economiche, i criteri di scelta dei memi vengono alterati da esse, e si corre il rischio di escludere dai rispettivi dominii opere di grande valore. La storia non manca di casi in cui opere artistiche sono state rifiutate perché non soddisfacevano canoni religiosi, oppure situazioni in cui opere letterarie e scientifiche sono state annullate per non essere state in concordanza con le ideologie politiche. All’altro estremo, la totale indipendenza di un area di specialità dal resto della società riduce la sua efficienza (Roco, 2004, 27).
La flessibilità dell’area di specialità è un altro fattore importante nella scelta dei prodotti creativi. Le strategie estreme di conservatorismo totale o accettazione della qualsiasi sono dannose, la prima perché fa mancare al dominio la novità, diventando statico, la seconda perché troppe novità sono difficile da metabolizzare e il dominio si destabilizza.
FINE PRIMA PARTE – LEGGI LA SECONDA PARTE
ARTICOLO CONSIGLIATO:
Il rapporto tra Creatività ed Emozioni
BIBLIOGRAFIA:
- Csikszentmihalyi, M. (1996). Creativity. Flow and the psychology of discovery and Invention. HarperCollins: NY
- Csikszentmihalyi, M.(2005). Implicatiile unei perspective sistemice in studierea creativitatii, in Sternberg, R. (Ed.) (2005). Manual de creativitate. Polirom: Iasi, pp. 247-273.
- Roco, M.(2004). Creativitate si inteligenta emotionala. Polirom: Iasi.
EXTRA: Mihaly Csikszentmihalyi: Il segreto della felicità (VIDEO Sottotitoli in Italiano)