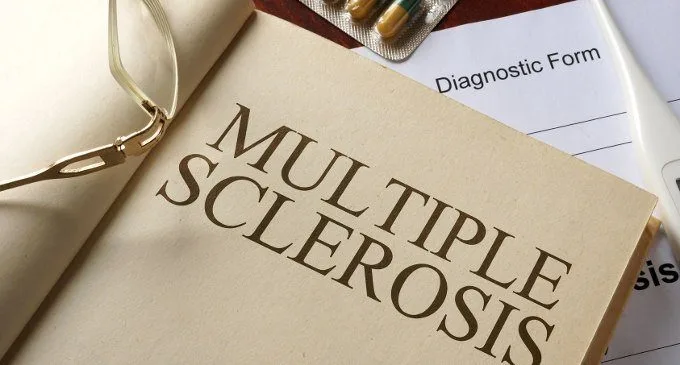Il profilo neuropsicologico caratteristico della sclerosi multipla presenta deficit a carico di diversi domini, quali attenzione, velocità di elaborazione delle informazioni, funzioni esecutive e memoria a lungo termine.
Anna Maria Mirto – OPEN SCHOOL, Studi Cognitivi Modena
Che cos’è la Sclerosi Multipla?
La sclerosi multipla (SM), anche detta sclerosi a placche, è una patologia cronica autoimmune, infiammatoria e demielinizzante, progressivamente invalidante, a eziopatogenesi non definita, che colpisce il sistema nervoso centrale (SNC) (Cambier Jean M.M., 2005).
Essa rappresenta la più frequente malattia neurologica tra i giovani adulti (Grossi P., 2008) il cui esordio si manifesta nel 70% dei casi tra i 20 e 40 anni (Vella L., 1985; Grossi P., 2008), con un’età media d’insorgenza di 28 anni (Lanzillo R. et al., 2016). Negli ultimi anni, si è inoltre osservato un incremento dal 3% al 5% di casi di sclerosi multipla ad esordio precoce, ossia precedente ai 18 anni (Lanzillo R. et al., 2016).
Sintomatologia
L’effetto fisiopatologico del processo di dissociazione assomielinica consiste nella riduzione della velocità di conduzione degli impulsi, la quale si manifesta attraverso un eterogeneo spettro sintomatologico. Infatti, dipendentemente della sede del focolaio di demielinizzazione che va in contro a perdita della propria funzionalità, è possibile osservare l’insorgenza di diversi sintomi (Cambier Jean M.M., 2005):
- Motori: dovuti ad un interessamento della via piramidale, possono manifestarmi mono- o bilateralmente, distribuendosi in maniera emiparetica (l’emiparesi è la perdita parziale della forza muscolare e della motilità volontaria di un lato del corpo, dx o sx) o, più spesso, paraparetica (la paraparesi è la perdita parziale della forza muscolare e della motilità a entrambi gli arti superiori o inferiori. ). Tra i deficit motori più frequenti rientrano l’alterazione della marcia che assume carattere di spasticità, il segno di Babinski, abolizione dei riflessi addominali superficiali del riflesso velo palatino;
- Sensitivi: interessano uno o più arti, il tronco e il volto, e possono manifestarsi mono- o bilateralmente. Consistono in parestesie tattile, termica e algica, e segno di Lhermitte (quest’ultimo consiste in una sensazione di scarica elettrica);
- Cerebellari: si manifestano in disturbi dell’equilibrio e della coordinazione motoria, come l’atassia della marcia, perdita di equilibrio ed insorgenza di vertigini, astenia degli arti, disartria (ovvero disturbo motorio del linguaggio dovuto a disordine fonoarticolatorio caratterizzato da debolezza e mancanza di coordinazione della lingua e della muscolatura orale e facciale.) associata a scarsa fluidità nell’eloquio, lentezza e alterazione della prosodia, disfagia;
- Deficit dei nervi cranici: i sintomi variano in funzione del nervo soggetto a demielinizzazione. I più frequenti sono vertigine, disequilibrio e nistagmo, ovvero movimenti oscillatori, ritmici e involontari dei globi oculari (vie vestibolari), ipoacusia (nervo cocleare), miochimie (disturbi del movimento che consistono in contrazioni muscolari involontarie ampie) facciali, paralisi facciale periferica, emispasmo facciale (contrazione unilaterale, involontari ed intermittente dei muscoli della faccia, nervo facciale in particolare), diplopia (nervi oculomotori), neurite ottica retro bulbare (NORB, nervo ottico: essa può essere definita come uno dei sintomi caratteristici della sclerosi multipla in quanto, nel corso dell’evoluzione della malattia, presto o tardi che sia, si manifesta attraverso l’abbassamento dell’acuità visiva);
- Disfunzioni vegetative: osservabili nella percezione di fatica, nei disturbi intestinali (stipsi o dissenteria), sessuali (perdita sensibilità genitale, diminuzione della libido, disfunzione erettile e perdita della capacità orgasmica), delle vie urinarie (incontinenza);
- Sintomi parossistici: rappresentano sintomi a insorgenza improvvisa e risoluzione rapida, nella sclerosi multipla ne è un esempio l’epilessia.
L’esame di questi sintomi, e quindi dell’efficienza dei diversi sistemi neurologici funzionali, permette di misurare lo stato di invalidità delle persone affette da sclerosi multipla e di monitorare la progressione della malattia.
Uno degli strumenti utilizzati a tal fine e che nella pratica clinica viene specificatamente impiegato per la valutazione delle strategie terapeutiche è l’Expandend Disability Status Scale (EDSS) (Kurtzke J.F., 1983) [v. Fig. 1].
Fig. 1 – Expandend Disability Status Scale (EDSS)
Questa scala, tuttavia, si mostra inadeguata nel fornire una valutazione globale della sintomatologia caratteristica della Sclerosi Multipla in quanto non prevede l’indagine funzionale dello status degli arti superiori e del quadro cognitivo. A tal proposito, lo strumento per eccellenza raccomandato inoltre dalla Task Force on Clinical Outcomes Assessment of National Multiple Sclerosis Society è il Mulpiple Sclerosis Funcional Composite (MSFC), il quale consente un’indagine multidimensionale dei sintomi clinici della sclerosi multipla (Fischer J.S. et al., 2013).
Funzionamento Cognitivo
Come riportato pocanzi, tra i sintomi clinici della sclerosi multipla rientra anche la compromissione degli aspetti cognitivi. Infatti, tra la popolazione affetta da questa patologia si stima un range di prevalenza di alterazione del funzionamento cognitivo che va dal 43% al 70% (Chiaravallotti N.D. e DeLuca J., 2008). Tale ampia variabilità dei dati può essere ricondotta ai differenti criteri clinici di selezione del campione adottati dai diversi studi (es: tipo di decorso, grado di disabilità e durata della malattia) (Planche V. et al., 2015).
Il profilo neuropsicologico caratteristico della sclerosi multipla presenta deficit a carico di diversi domini, quali attenzione (sostenuta, selettiva, divisa e alternata), velocità di elaborazione delle informazioni, funzioni esecutive (concettualizzazione astratta, problem solving, pianificazione, multitasking, fluenza verbale) e memoria a lungo termine (Chiaravallotti N.D. e DeLuca J., 2008). I domini solitamente risparmiati sono, invece, il linguaggio e l’intelligenza generale (Q.I.) (Planche V. et al., 2015).
Alcuni studi hanno osservato differenti quadri di funzionamento cognitivo in correlazione al tipo di variante di sclerosi multipla. In particolare, in una recente ricerca condotta da un gruppo francese (Planche V. et al., 2015), si è tentato di fare chiarezza circa le somiglianze e le differenze cognitive tra le varianti Recidivante-Remittente (RR), Progressiva Secondaria (PS) e Progressiva Primaria (PP).
I domini indagati nel presente studio erano: velocità di elaborazione, working memory, memoria verbale episodica, funzioni esecutive, fluenza verbale, denominazione e prassia costruttiva. Tra questi, la velocità di elaborazione delle informazioni è emersa come la funzione cognitiva più frequentemente danneggiata, seguita poi da memoria verbale episodica, funzioni esecutive, abilità costruttive visuo-spaziali. Relativamente alla correlazione tra tipologia di variante della sclerosi multipla e grado di severità dell’alterazione cognitiva, è emerso che, tra i 101 soggetti inclusi nello studio, il 77% mostrava un declino cognitivo caratterizzato da almeno 1 dominio danneggiato, il 63%, invece, presentava una alterazione severa (almeno 2 domini danneggiati). Tra i partecipanti alla ricerca rientranti in quest’ultima condizione, si è osservata una maggioranza di pazienti con forma progressiva, di cui quelli con variante PS sono risultati essere più frequentemente interessati.
Infine, dalle analisi dei dati sociodemografici e dell’EDSS si sono riscontrate una correlazione positiva tra alterazione cognitiva e disabilità fisica e una correlazione negativa tra declino cognitivo e scolarizzazione. Pertanto, dallo studio di Planche e collaboratori (2015) si evince come le forme progressive, ed in particolare la variante PS, e un grado di disabilità medio (EDSS > 4) rappresentino due predittori del declino cognitivo.
Relativamente ai cambiamenti del funzionamento cognitivo nel corso della progressione della malattia, ad oggi si contano pochi studi longitudinali in letteratura che hanno analizzato questo aspetto. In particolare in un follow-up di 10 anni condotto da Amato e collaboratori (2001) si è stimato un incremento della popolazione con declino cognitivo pari al 30%; in un altro studio, poi, hanno osservato una progressione del declino con estensione verso molti domini cognitivi precedentemente integri (Kujala P. et al., 1996)
Depressione e Declino Cognitivo
La presenza di disabilità fisica, unitamente alla percezione di una bassa qualità della vita, hanno, nel malato affetto da sclerosi multipla, un forte impatto sulla sfera psicoemotiva, influenzando le capacità di coping e lo stato dell’umore (Lynch S.G. et al., 2001; Lanzillo R. et al., 2015; Johansson, S. et al., 2016). In particolare, il sintomo psichiatrico maggiormente diffuso in questa patologia, già noto ai tempi di Charcot (1879), scopritore della sclerosi multipla, è la depressione.
Data l’alta frequenza con cui questo disordine dell’umore si presenta nella sclerosi multipla, diverse ricerche hanno analizzato la possibile relazione tra questo sintomo e il funzionamento cognitivo. I risultati ad oggi presenti in letteratura, sembrano suggerire una ricaduta negativa della depressione sulla performance cognitiva solo entro i livelli moderato-severo del sintomo psichiatrico e in maniera circoscritta ai domini cognitivi di velocità di elaborazione, working memory e funzioni esecutive (Siegert, R.J. e Abernethy, D.A., 2005).
Conclusione
La sclerosi multipla si configura come la prima patologia neurologica a comportare invalidità fisica tra la popolazione giovane. A causa del processo di demielinizzazione caratteristico della malattia e che interessa molteplici siti cerebrali e del midollo spinale, la vita del malato di sclerosi multipla si ritrova costellata da una eterogenea sintomatologia, indicativa della compromissione di diversi domini funzionali, fisico-motori e cognitivi. I deficit che insorgono hanno poi un impatto sull’autonomia dell’individuo, incidendo negativamente, spesso, sulla percezione della qualità di vita e sulla sfera emotiva.
Risulta, pertanto, fondamentale intervenire quanto più precocemente possibile, non solo farmacologicamente per evitare e ritardare la disabilità fisica, ma anche con un supporto psicologico al fine di aiutare il paziente ad affrontare e accettare i cambiamenti dovuti dalla malattia.