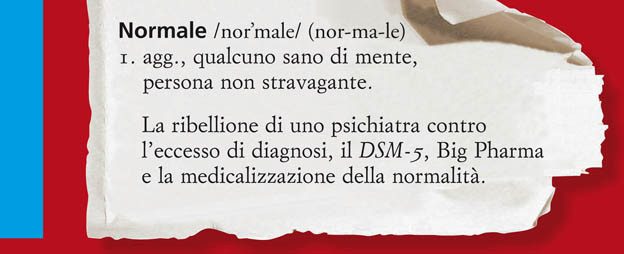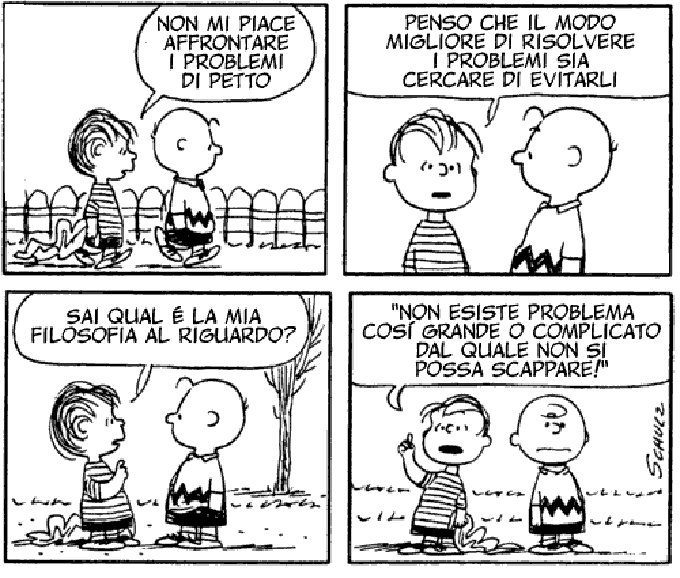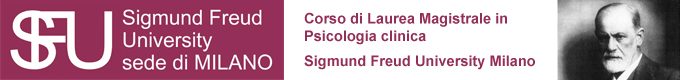Un’analisi critica dei modelli biomedici per i disturbi psicologici
In questo appassionante articolo del 2013 (pubblicato nella Clinical Psychology Review), Brett J. Deacon spiega, partendo da una attenta analisi critica del vigente modello biomedico, perché le cause di molti disturbi psichici non sono unicamente ascrivibili a fattori di ordine biomedico.
Da parecchi decenni molti scienziati sostengono che le cause della psicopatologia dipendono da disregolazioni neurotrasmettitoriali, da anomalie genetiche e da deficit nel funzionamento e nella struttura cerebrale. Tuttavia, ad oggi, nessuno ha identificato una sola causa biologica, né un solo biomarker, responsabile di uno specifico disturbo psichico. Mentre si sostiene che i farmaci psicotropi abbiano un ruolo nel correggere lo sbilanciamento chimico, causa della psicopatologia, in realtà gli psicofarmaci non hanno dimostrato avere nessuna effettiva influenza curativa superiore a quanto già rilevato oltre mezzo secolo fa.
In compenso, invece, la patologia mentale è divenuta più cronica e più grave rispetto al passato, coinvolgendo un numero sempre crescente di individui. In parallelo è spaventosamente aumentata la stigmatizzazione verso chi soffre di tali disturbi.
In sostanza, il modello biomedico (approccio predominante negli Stati Uniti e nelle culture occidentalizzate) assume che disturbi come la schizofrenia, il disturbo depressivo maggiore, il disturbo di attenzione e di iperattività (ADHD) e l’abuso di sostanze siano condizioni causate da deficit del cervello. Questo significa che 1) i disordini mentali sono causati da anomalie biologiche che hanno la loro sede nel cervello, 2) non esiste una netta e chiara distinzione tra disturbi fisici e mentali e 3) che il trattamento biologico rappresenta l’unica cura possibile. L’obiettivo principale della ricerca biomedica è studiare le cause biologiche dei disturbi psichici, nel tentativo di scoprire la pillola magica per ciascun disturbo psichico, negando completamente l’influenza di altri possibili fattori eziologici, quali i fattori sociali, psicologici e comportamentali.
La stessa Associazione Psichiatrica Americana (APA), nel 2003, ha affermato che le cause di qualsiasi disordine mentale sono esclusivamente riconducibili ai fattori biologici.
Nella storia della cura della psicopatologia, le prime tecniche utilizzate negli anni ’30 (i.e., la terapia elettroconvulsiva, la lobotomia e la terapia di insulina) hanno incoraggiato la credenza che i disturbi psichici si potessero curare con le sole terapie biologiche. In seguito, la rivoluzione “biochimica” degli anni ’50 ha permesso di scoprire che alcune componenti chimiche erano in grado di limitare la gravità di alcune manifestazioni cliniche (anche in conseguenza a patologie organiche, come la neuro sifilide), riducendo sintomi psicotici, depressivi, maniacali, ansiosi e legati all’iperattività. Man mano, con l’avvento della psicoanalisi, sono state mosse forti critiche alla teoria dello squilibrio chimico, sia da parte della stessa psichiatria che dai freudiani, che rifiutavano con convinzione questo approccio come unica cura della patologia mentale. Nel 1980, l’uscita del DSM III rappresentò un influente traguardo scientifico che favoriva la comunicazione tra clinici di diversi paesi. Tuttavia, nonostante tutte le incertezze e le controversie in corso, il DSM si era nettamente schierato a favore del modello biomedico. Da quello stesso anno, guarda caso, le case farmaceutiche ricevettero l’autorizzazione di sponsorizzare gli interventi scientifici alle conferenze annuali dell’APA. Nel giro di un paio di anni la collaborazione tra case farmaceutiche e APA si intensificò notevolmente ed ebbe inizio una vera e propria collaborazione, che si estendeva anche alla formazione e all’aggiornamento medico.
In parallelo, il National Institute of Mental Health (NIMH) ed altre organizzazioni, iniziarono a devolvere fondi di ricerca ad enti e università che indagavano le basi scientifiche dei modelli biomedici applicati alla psichiatria, con il dichiarato benestare della National Alliance on Mental Illness (NAMI). I modelli biomedici si erano proposti anche la funzione di ridurre lo stigma verso la patologia mentale, basata, secondo loro, non su fattori socio-ambientali, ma unicamente su disfunzioni organiche.
Ad esempio, la terapia del Disturbo Ossessivo Compulsivo (DOC) promossa dal NIMH nel 2009 si basava unicamente sulla farmacoterapia. I “consumatori” che soffrivano di DOC sono stati incoraggiati a farsi prescrivere antidepressivi, ansiolitici o beta-bloccanti, dai loro medici di base (anche senza una accurata valutazione psicodiagnostica), poiché le numerose evidenze scientifiche a favore della terapia basata sull’esposizione e prevenzione della risposta (ERP) erano state completamente trascurate dal NIMH. È importante ricordare che negli USA, così come in Nuova Zelanda, le case farmaceutiche possono pubblicizzare direttamente ai consumatori i propri farmaci. Questo significa che gran parte degli investimenti economici sono orientati in questa direzione e all’educazione dei pazienti sui loro disturbi, sulle loro presunte cause biologiche e quindi sulla loro cura, a carattere unicamente biochimico.
In uno studio del 2005, Kravitz e collaboratori hanno rilevato che il 50% dei pazienti che si erano rivolti al medico per problemi di depressione, assieme alla richiesta di aiuto, e indipendentemente dalla correttezza della diagnosi, indicava già il nome esatto del farmaco per cui desiderava la prescrizione! Nonostante questo dato tristemente noto negli USA, la Food & Drug Administration (FDA), non è intervenuta ed è rimasta in silenzio! Ricordiamo che, oggi, gli antidepressivi rappresentano la terza categoria di farmaci più prescritta negli USA ed è la prima tra gli adulti tra 18 e 44 anni. Diversi clinici rilevano che circa la metà dei farmaci psicotropi viene prescritta ad individui che non hanno una diagnosi psichiatrica certa e si teme che, con il DSM5, e l’aumento delle etichette diagnostiche, questo dato possa ulteriormente aumentare.
In seguito alla “rivoluzione” biomedica, negli ultimi decenni, sono stati investiti miliardi di dollari nella ricerca nell’ambito delle neuroscienze e della genetica; ma se si fossero ottenuti dei risultati significativi, questi dati non si sarebbero già dovuti trovare all’interno dell’ultimissimo DSM5? Al contrario, i neuroscienziati, ancora, non hanno nemmeno ben compreso come definire propriamente un “circuito cerebrale”, né come tradurre l’attività o le immagini mentali (derivate dalle metodiche di neuroimmagini) nei termini di “cosa effettivamente accade nel cervello”. Una semplice “cartografia” cerebrale, che eventualmente spiega “dove” certi processi mentali hanno luogo, non è sufficiente per “spiegare” i processi che sottendono al funzionamento psichico (Castelfranchi, 2015).
Infine, altro problema irrisolto, quello della stigmatizzazione. Il tentativo di eguagliare la condizione psichiatrica a un problema organico, in modo da ridurre le discriminazioni ed evitare colpevolizzazioni, nella realtà, ha potenziato l’interpretazione di tipo biomedico e ha accresciuto i comportamenti di isolamento e rifiuto verso chi soffre di patologie mentali. Il problema della stigmatizzazione è complesso e coinvolge più aspetti, mentre il riduzionismo organicista, invece, contribuisce all’aumento della cronicità e all’irreversibilità dei problemi psichici. Di fatti, gli USA hanno una delle più alte prevalenze di malattie psichiatriche, che si sono ulteriormente cronicizzate e intensificate nelle ultime decadi. Ad esempio, la depressione maggiore è sempre più cronica e resistente al trattamento, sebbene, dalla fine degli anni ’80, la somministrazione dei nuovi farmaci antidepressivi sia aumentata del 400%! Si teme, persino, che l’uso prolungato di questi farmaci aumenti il deterioramento mentale, anziché contenerlo. La stessa cosa è accaduta per altre tipologie di psicofarmaci. Se in ambito infantile, ad esempio, il numero di problemi non-psichiatrici si è drasticamente ridotto (come per il cancro o la Sindrome di Down), i disturbi mentali, oggi, rappresentano la prima causa di disabilità in età evolutiva. Vista la scarsa efficacia dei dati relativi a questo approccio sarebbe imperativo chiedersi: “Quanto, ancora, dobbiamo aspettare per mettere definitivamente a nudo i suoi limiti e le sue inconcludenze?”.
All’interno del panorama psichiatrico, all’ombra del modello biomedico, si è sviluppata la psicologia clinica, con le sue teorie e le sue modalità di intervento e di cura. I trial clinici randomizzati (RCT) rappresentano il metodo di ricerca utilizzato per valutare l’efficacia degli interventi psicoterapici e farmacologici. Per essere riconosciuti “efficaci” dal NIMH, gli RCT devono provare l’efficacia di un certo trattamento standardizzato e manualizzato, assegnando in modo casuale i pazienti ad un trattamento o ad una condizione di controllo e basando la selezione dei partecipanti sui rigidi criteri diagnostici del DSM.
Nell’ambito dell’intervento psicoterapico, gli RCT hanno dimostrato ampiamente l’efficacia, anche considerando i costi, di molti disturbi psichici (i.e., depressione, disturbi alimentari, disturbi d’ansia, ADHD, disturbo borderline di personalità, etc.). Alcuni limiti nel testare l’efficacia degli interventi psicoterapeutici riguardano l’estendibilità dei dati osservati al mondo reale, l’utilizzo di manuali standardizzati e un numero definito di sedute. Ovviamente, questo rigore taglia fuori dalla ricerca una serie di psicopatologie più articolate e, cosa osservata di frequente, coloro i quali soffrono di disturbi sub-clinici che, pur essendo fonte di sofferenza, non soddisfano completamente i criteri del DSM. Nella maggior parte dei casi gli RCT hanno indagato l’efficacia di trattamenti specifici, come, ad esempio, gli effetti dell’esposizione in vivo a stimoli fobici, dell’esposizione tramite immaginazione ad episodi traumatici e di interventi per i pensieri ossessivi.
Molte di queste tecniche derivano da approcci terapeutici più complessi che non sono facilmente operazionalizzabili all’interno di un trial clinico rigorosamente controllato. Nella pratica clinica, inoltre, è abbastanza frequente incontrare pazienti che presentano più di un singolo disturbo psichico. Spesso è possibile osservare delle comorbilità e una sovrapposizione sintomatologica condivisa con più disturbi.
Ad esempio, il disturbo da attacchi di panico, la fobia specifica, il disturbo post-traumatico da stress, il disturbo d’ansia generalizzato e il DOC sono tutti accomunati dalla presenza di convinzioni patogene, da distorsioni nell’elaborazione di informazioni e da comportamenti “di sicurezza” che mantengono la patologia. In tutti questi casi, l’esposizione e prevenzione della risposta rappresenta l’intervento elettivo (ma non l’unico) nel trattamento. Il clinico che utilizza l’approccio del “singolo-disturbo” per diagnosticare e curare i suoi pazienti rischia di vedere l’albero, ma non la foresta.
Il modello biomedico applicato alla psicopatologia rischia di aumentare ulteriormente il gap tra la pratica Reale e la psicologia sperimentale, quando, invece, sarebbe fondamentale che la psicologia clinica conquistasse individualmente il suo spazio, alla luce, soprattutto, dei costi ridotti e degli outcome efficaci, ad oggi emersi.
Conclusioni
Il paradigma biomedico è stato spinto e sostenuto da interessi economici, politici e ideologici, senza però portare ad un effettivo miglioramento nella diagnosi o nel trattamento della psicopatologia. Ad oggi, considerando i fattori genetici, la disregolazione neurotrasmettitoriale, le esperienze traumatiche o le credenze irrazionali, non è stata identificata neanche una sola causa biologica per uno specifico disturbo.
Per quale motivo allora continuare ad insistere su un solo modello, se, ad oggi, dopo i numerosi investimenti, non si sono ottenuti i risultati sperati?
È ovvio che tutti i fenomeni psicologici abbiano un corrispettivo biologico. Affermare che un disturbo del comportamento alimentare o un disturbo d’ansia abbia una base biologica ha senso, senza che, però, questo implichi che quest’ultima sia la causa della patologia stessa. Le correlazioni cervello->mente e mente->cervello esistono, è evidente, ma non spiegano la loro reciproca relazione. Sino ad oggi, infatti, non sembra che la ricerca sulla psicopatologia abbia aiutato molto a comprendere questa connessione. Un disturbo psichico può essere spiegato, e studiato, a diversi livelli di organizzazione (i.e., molecolare, ambientale, cognitivo, neuronale, etc.) e nessuno di questi è sovraordinato rispetto agli altri, poiché appartengono tutti allo stesso fenomeno.
Al contrario, ciascun livello dovrebbe contribuire alla spiegazione del disturbo in sé e può essere oggetto di studio per diversi motivi. Ad oggi, il modello biomedico non ha considerato né i diversi livelli, né ha contribuito a creare un dibattito costruttivo e aperto con chi si occupa delle altri componenti coinvolte. Negli ultimi decenni i sostenitori del modello biomedico si sono cocciutamente opposti e chiusi a qualsiasi forma di confronto con altri professionisti, ad esempio con chi proponeva un nuovo modello medico, basato sull’approccio bio-psico-sociale di Engel (1977).
Per citarne alcuni. Nel 2003, il gruppo di attivisti MindFreedom è stato screditato e ignorato pubblicamente dall’APA quando era intervenuto per richiedere evidenze scientifiche a favore del modello biomedico. Nel 2005, l’intervento televisivo a Today Show di Tom Cruise, il quale aveva pubblicamente dichiarato che non esistono prove a favore della teoria dello sbilanciamento chimico. E, ancora, nel 2010, dopo la pubblicazione del libro “Anatomy of an Epidemic” di Robert Whitaker il quale, dopo essere stato invitato come speaker a diverse conferenze internazionali, dove aveva sollevato parecchi dubbi relativi all’infondatezza e alle incoerenze del modello biomedico, è stato duramente ripreso e screditato apertamente, senza che poi gli venisse data la possibilità di difendere o di discutere i suoi interventi. Sarebbe auspicabile, invece, utilizzare un approccio multi-disciplinare, in modo da favorire uno scambio e un dialogo collaborativo tra le numerose professionalità interessate alla diagnosi e alla cura dei disordini mentali.
Le domande che restano indiscutibilmente aperte, sottolinea Deacon, sono:
1) Com’è possibile considerare i disturbi mentali su base unicamente organica, se i ricercatori non sono stati ancora in grado di identificare almeno un marker biologico (ammesso che riuscirci abbia un ruolo, poi, nel trattamento) utile per la diagnosi o per distinguere un individuo con psicopatologia da uno sano?
2) Come si può considerare la teoria dello squilibrio chimico la causa dei disturbi psichici se gli scienziati non hanno identificato una baseline di come il cervello umano funzioni in condizioni di normalità?
3) Perché psichiatri, medici, biologi e organizzazioni come l’APA, il NIHM o il NAMI hanno continuato a promuovere il modello biomedico della patologia mentale, se ancora non esistono prove chiare a suo sostegno? E qual è il ruolo delle case farmaceutiche?
4) Perché vengono ancora investiti milioni di dollari nella promozione della ricerca biomedica se, ad oggi, dopo diverse decadi, non sono stati identificati farmaci, test biologici o trattamenti efficaci?
5) Se è vero che gli psicofarmaci hanno migliorato il malfunzionamento psicologico e sono ormai ampiamente diffusi, come mai i disturbi psichici sono aumentati? Non ci si dovrebbe, invece, aspettare una riduzione della psicopatologia, vista l’enorme diffusione di terapie su base biochimica?
6) L’attribuzione della patologia mentale a cause mediche non ha ridotto la stigmatizzazione ma, anzi, questa è drasticamente aumentata, contribuendo ad un sempre maggiore isolamento e rifiuto, da parte della popolazione sana, dei pazienti affetti da malattia mentale.
Considerando tutti questi interrogativi, un dibattito leale e aperto sarebbe chiaramente necessario. Fortunatamente, ultimamente il confronto è stato avviato, sia in alcune conferenze internazionali (i.e., International Society for Ethical Pshychology and Psychiatry) che sul sito www.madinamerica.com. Per la prima volta nella sua storia, conseguentemente a queste obiezioni, il DSM5 rischia di essere screditato da parecchie comunità di salute mentale che non possono ignorare quanto proposto, spesso con la forza e evitando confronti e dibattiti, dai sostenitori del modello biomedico. Il dialogo dovrebbe portare alla ricerca di una reale comprensione ed integrazione, basata su tutti i livelli di analisi possibili (dal micro al macro e viceversa), dei disturbi psichici, senza, però, scadere in un compromesso politico, invece di una reale soluzione scientifica. Quest’ultima si dovrebbe basare sulla risoluzione di alcuni punti chiave, tra i quali, il rapporto mente/cervello (per un recente approfondimento, vedi Castelfrachi, 2015) e la comprensione chiara della distinzione tra psicopatologia e neuropatologia (che coinvolge i disturbi della motilità, della sensibilità, dell’equilibrio e del linguaggio).
ARTICOLO CONSIGLIATO:
Aspetti neuropsicologici nell’anoressia nervosa e correlazioni con fattori ansiosi
BIBLIOGRAFIA:
- Castelfranchi C. (2015). Modelli psicologici: conflitti e prospettive. Scienza & Mente, 21/22, Maggio 2015, 43-55.
- Deacon B. J. (2013). The biomedical model of mental disorder: A critical analysis of its validity, utility, and effects on psychotherapy research. Clinical Psychology Review, 33, 846–861
- Engel, G. L. (1977). The need for a new medical model: a challenge for biomedicine. Science, 196, 129–136. DOWNLOAD
- Kravitz, R. L., Epstein, R. M., Feldman, M. D., Franz, C. E., Azari, R.,Wilkes, M. S., et al. (2005). Influence of patients’ requests for direct-to-consumer advertised antidepressants: A randomized controlled trial. Journal of the American Medical Association, 293,1995–2002.