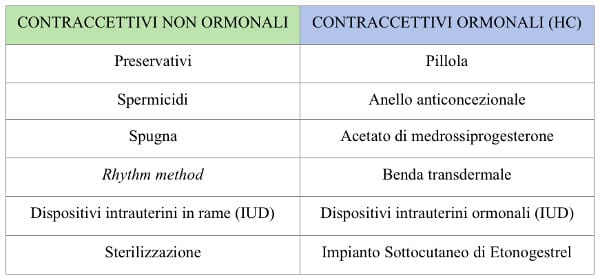Il disturbo della balbuzie come “conflitto” della parola
Descrivendo la balbuzie, Fenichel (1945) la definisce un fenomeno isterico pregenitale a mezzo del quale il bambino gestisce un conflitto avente ad oggetto l’impulso ad esprimersi, derivante dall’Es, e l’ostacolo di una censura impeditiva, dettata dall’istanza superegoica, in questa fase già particolarmente dominante.
La balbuzie
La
balbuzie è un
disturbo del linguaggio caratterizzato dall’emissione di una fluenza verbale stentata e disarmonica, in associazione ad una mimica spasmodica di natura neurologico-muscolare, finalizzata a ripristinare il ritmo verbale a seguito di un blocco espressivo. La difficoltà di pronuncia può manifestarsi all’inizio del discorso attraverso interruzioni seguite da lunghi silenzi: in questo caso si parla di
balbuzie tonica. Al contrario, se l’inceppo si focalizza sulle sillabe di una parola o di un gruppo di fonemi che vengono coattivamente ripetuti si parla di
balbuzie clonica.
Per quanto un fattore di familiarità risulti parzialmente influente nell’insorgenza della balbuzie, sembra possibile ipotizzarne l’origine non prettamente organica. L’impossibilità di esprimersi con fluenza verbale normotipica sembra dunque attribuibile a fattori di natura soggettiva e ambientale che, tradotti in bagaglio esperienziale, possono rivelarsi una fonte agevolatrice del disturbo (Fenichel, 1945; Horner, 1993). Rispetto ai casi in cui non sono presenti difetti relativi all’apparato fonatorio, né altre disfunzionalità clinicamente riscontrabili, l’ipotesi dell’eziologia non organica viene avvalorata dalla tendenza –tipica del disturbo– ad amplificarsi nei contesti ad elevato impatto emotivo e stressogeno (Gaddini, 1980).
L’eziologia del disturbo e il modello psicodinamico
Il modello psicodinamico interpreta la balbuzie come l’esito di un processo evolutivo disfunzionale, in cui la normale acquisizione dello strumento verbale, legata allo sviluppo di competenze biologiche innate, viene ostacolata da vissuti psichici di disagio, intercorsi in un’età precoce, tipicamente, prima dei 3 anni (Horner, 1993).
Descrivendo la balbuzie, Fenichel (1945) la definisce un fenomeno isterico pregenitale a mezzo del quale il bambino gestisce un conflitto avente ad oggetto l’impulso ad esprimersi, derivante dall’Es, e l’ostacolo di una censura impeditiva, dettata dall’istanza superegoica, in questa fase già particolarmente dominante. Quello che si verifica nella balbuzie –come in ogni altro caso di conversione isterica– è un conflitto tra pulsioni, la cui gestione viene affidata alla creazione di un sintomo somatico compiacente, una manifestazione patologica che limita la funzione senza nessun coinvolgimento organico: in questo caso la parola è dunque presente, ma in una forma stentata e disarmonica, perché ostacolata da meccanismi inconsci censuranti (Freud, 1892-1895) .
E se questo appare il vantaggio primario del disturbo, un possibile vantaggio secondario potrebbe essere identificato nel ricevere maggiore attenzione che, proprio grazie alle sue difficoltà espressive, il balbuziente riesce ad ottenere. L’inceppo, quindi, potrebbe risultare un inconscio attivatore ambientale, grazie al quale egli riesce a rendersi visibile, manifestando una presenza che altrimenti passerebbe inosservata (Crocetti, 2022).
Se per i soggetti normotipici la dimestichezza con lo strumento verbale viene automatizzata e vissuta in una condizione emotiva neutrale, il balbuziente effettua un iperinvestimento nel linguaggio, rendendolo un elemento saliente della propria identità, oltre che un mezzo di auto conferma (Fenichel, 1945). Egli medita continuamente sulla parola più giusta da dire, in un rimuginio quasi ossessivo con cui cerca di reperire, all’interno del suo repertorio semantico, il termine foneticamente più “vantaggioso”, perché in grado di evitare l’interruzione della fluenza. Ma, al di là del vantaggio fonetico, una così intensa ricerca semantica potrebbe celare l’intento di scegliere la parola contenutisticamente più appropriata e meno criticabile da parte degli interlocutori. Il balbuziente nutre infatti una profonda convinzione di inadeguatezza che lo spinge a reputarsi inferiore agli altri, o comunque mai all’altezza delle aspettative.
Questa componente perfezionistica della personalità –di cui la ricerca ossessiva della parola costituisce l’esito disfunzionale– deriva da un’istanza superegoica particolarmente censurante, a sua volta generata da un ambiente evolutivo ipercritico e intransigente, in cui l’istanza genitoriale risulta contaminata da intenzionalità punitive più che educative e supportive.
Il bambino balbuziente viene reso oggetto di critiche e squalifiche costanti, che alimentano in lui un’autopercezione di inadeguatezza e manchevolezza (Bonnard, 1963). Non si tratta di gestire un vissuto traumatico: ciò che il balbuziente deve fronteggiare è piuttosto lo stato ansiogeno dato da un continuo attacco identitario, che lo costringe a rivalutare in senso limitativo tutte le sue pulsioni, le sue capacità, le sue potenzialità (Fenichel, 1932).
L’ambiente familiare e lo stile educativo: possibili fattori predisponenti
L’ambiente familiare del balbuziente disegna un contesto in cui la parola costituisce uno strumento di valutazione intransigente, privo di una valenza emotiva ed educativa, il cui unico messaggio risiede nella irrimediabilità dell’errore.
Il bambino teme il giudizio, ed è consapevole di non poter sbagliare. Per questo si pone al perenne servizio di un perfezionismo che, dalla sfera espressiva, si trasferisce a quella esistenziale, coinvolgendone ogni aspetto. Il rimprovero o la critica del genitore diventano per lui un mezzo valutativo censurante che, una volta interiorizzato, si trasforma in un legislatore interno altrettanto severo che dà vita a una condizione collusiva ansiogena dagli effetti profondamente austosvalutanti.
Nel contesto familiare del balbuziente la valenza emotiva verbale è fortemente deficitaria. L’espressività genitoriale non si focalizza sull’analisi degli stati mentali del bambino, né dei propri. L’aspetto comunicativo è limitato alla trasmissione di messaggi concreti la cui attenzione è tutta rivolta all’aspetto formale delle parole, piuttosto che al significato emotivo e meta-emotivo delle stesse. L’IO desiderante viene depauperato da questa presenza genitoriale normotica, concreta e affettivamente refrattaria, che spinge a vergognarsi di sé e del Sé, in un circolo vizioso costruito sulle basi dell’impotenza, del perfezionismo, della mortificazione silenziosa e inesprimibile (Bollas, 1989).
Il disagio che ne consegue è visibile anche sul lungo termine. Non sono pochi i bambini che, in comorbilità con il disturbo dell’espressione, manifestano disturbi internalizzanti –legati a patologie dell’ansia o dell’umore– e la più tipica lalofobia, inerente fobia specifica dell’espressione verbale. Molti sono ostaggio di un vissuto autoisolante e depressivo, favorito da un’incapacità di costruire relazioni amicali delle quali non si sentono all’altezza. In ambito scolastico il loro difetto di pronuncia tende ad essere accolto con scarsa empatia, soprattutto da parte dei pari, che tendono a mortificarli, talvolta anche crudelmente, consolidando il percetto di inadeguatezza ed impotenza già instauratosi nel contesto familiare (Tomaiuoli, 2015).
La personalità del balbuziente
Il mondo del balbuziente è caratterizzato da una difficoltà adattiva che, al di là dell’espressione verbale, coinvolge trasversalmente ogni dimensione esistenziale, caratterizzandola patologicamente: egli può presentare:
- tratti di personalità narcisistica ipervigile, sviluppati a causa delle mortificazioni subite in ambito affettivo e sociale;
- tratti di perfezionismo, posto come strumento difensivo alla mortificazione del Sé;
- vissuto evitante e inconsciamente ostile verso un ambiente percepito come rifiutante;
- tratti depressivi, generati dalla scarsa fiducia nel sé e nel mondo affettivo oggettuale che lo circonda.
Essendo rimasti fissi ad una fase anale conflittuale, molto spesso si tratta di soggetti testardi, caratterizzati da aggressività passiva, spiccato senso del dovere, ostinazione e intensa componente superegoica, cui soggiace una latente pulsione oppositiva volta a compensare le umiliazioni di un Sé percepito al contempo fragile e onnipotente. Malgrado la presenza di mortificazioni affettive reiterate, il sano narcisismo del balbuziente non ha infatti subìto una totale amputazione. Si trova piuttosto in una condizione emotiva conflittuale, che vede la contrapposizione tra una visione del Sé desiderosa di riconoscimento e una umile e impotente che ambisce soltanto a nascondersi (Sigurtà, 1955; 1970).
Questa tendenza alla dicotomia determina la formazione di una struttura psichica in cui l’espressione emotiva non ha trovato regolazione né canalizzazione simbolica, e ha dato vita ad uno stile espressivo egualmente conflittuale, disorganizzato, disregolato.
La parola ha perduto, nel balbuziente, una potenzialità creativa e relazionale, divenendo piuttosto il condensato simbolico di lotte conflittuali tra pulsioni polarizzate e tuttavia compresenti, quali libertà e dipendenza, volontà di apparire e di nascondersi, pulsione relazionale e di isolamento, ma soprattutto volontà di compiacere il proprio narcisismo o quello dei genitori, per usufruire della loro presenza affettiva e sentirsi apprezzato.
Non è un caso se la balbuzie si manifesta nel periodo anale, quello in cui il bambino avverte la necessità di raggiungere gratificazioni autonomiche, pur beneficiando della presenza di un supporto genitoriale costante e attendibile. È esattamente in questa fase evolutiva che il linguaggio può divenire un mezzo di espressione e di conferma del Sé, tramite il quale l’infans manifesta i propri vissuti emotivi, ancorché connotati di oppositività verso la volontà del genitore.
Nasce il linguaggio contrastivo, il fascino irresistibile del “NO”, che, al di là di una negazione, rappresenta un mezzo di costruzione, riconoscimento e conferma dell’identità. Il bambino ha necessità di contrapporsi al genitore, e il genitore è chiamato ad accogliere questo contrasto come un segnale evolutivo da potenziare, anziché da inibire tramite condotte inibitorie e punitive. Eventualità, quest’ultima, in cui la parola non assumerà la preziosa funzione di incontro e relazione che le è propria, ma diverrà un contesto saturato di significati eteroimposti, un terreno di scontro inibito, di critica, di aggressività passiva, verso i quali il bambino dovrà mostrare una dolorosa ma inevitabile compiacenza (Freud, 1963). Si crea così il terreno fertile per un disturbo espressivo che, nei casi normotipici, si risolve con l’esaurirsi della fase anale.
La balbuzie come angoscia del reale
L’Io del balbuziente teme le proprie pulsioni non per una decisione maturata autonomamente, ma a causa di una educazione proibitiva che gliene ha impedito il soddisfacimento, connotandole di un vissuto superegoico iperinvestito (Freud, 1936). La sua potrebbe essere definita un’angoscia del reale, perché legata al timore di esprimere tutte quelle pulsioni che, per quanto innate e naturali, sono state oggetto di una pressante censura educativa.
Persino attività come mangiare, dormire, masticare, risultano circondate da un’aura di non praticabilità, quasi di vergogna, che ha indotto il bambino ad associare alle stesse un insopprimibile senso di colpa.
Il genitore ha instaurato in lui un un senso imperante di vergogna, spingendolo a nascondere, a trattenere, a celare con pudore mortificante la propria espressività, verbale così come somatica. Sotto quest’ottica, l’inceppo verbale non è che una parte del blocco supergoico da cui il balbuziente si sente invaso, e la paura di parlare non è che il riflesso metaforico di una ben più profonda paura di apparire, di esternalizzare il proprio mondo interiore, risultare visibile e giudicabile dagli altri, nella convinzione che questo comporterebbe l’ennesima mortificazione.
Il balbuziente non ha paura di parlare, ma di dire. Dire ciò che ha internalizzato e che percepisce come pericoloso, ostile, minaccioso. La balbuzie diventa un limite insuperabile, un difetto imperdonabile nel quale il soggetto si riconosce e da cui si lascia dominare, riflettendovi la sua intera identità. Invalidato da un sintomo da cui non riesce a separarsi, in una collusione difensiva inscindibile, egli condensa nella parola il proprio vissuto di frustrazione pulsionale, di impotenza e incapacità, rendendola lo specchio di un fallimento esistenziale per certi aspetti ineludibile (Klein, 1923).
Ma solo fino a che la parola viene attribuita al Sé: uno scostamento tra la produzione verbale e l’identità del parlante determina un cambiamento, talvolta notevole, della capacità espressiva, limitandone la disfunzionalità. A testimonianza di ciò si veda come le prestazioni verbali, solitamente scadenti in questi soggetti, subiscano un subitaneo miglioramento nei contesti in cui l’espressione verbale viene svincolata dal Sè: ad esempio interpretazioni teatrali, in cui viene vestito il ruolo di qualcun altro, o prestazioni verbali di gruppo, in cui l’identità risulta diluita con quella di altri individui, dando luogo ad una desoggettivizzazione in grado di sbloccare l’impasse isterica e liquidare il senso di colpa insito nell’espressività verbale (Tomaiuoli, 2015).
Proprio questo aspetto è servito alla strutturazione di programmi terapeutici aventi ad oggetto una rieducazione alla parola, nei quali il balbuziente può riacquistare il piacere dello strumento verbale grazie a un’autorivalutazione più indulgente e gratificante e a un più adeguato investimento relazionale.
In conclusione, la balbuzie è un sintomo che si origina quando capacità innate, come quella inerente lo sviluppo del linguaggio, vengono rese oggetto di esperienze evolutive limitanti che vanno a ledere la dimensione dell’identità e dell’autostima (Hartmann, 1939). Proprio questo aspetto ha contribuito a consolidare l’ipotesi di una natura non organica del disturbo, attualmente identificato con l’esito di un disagio che affonda le radici in un contesto evolutivo affettivamente povero, inadeguato e caratterizzato da elevate componenti stressogeno-conflittuali.