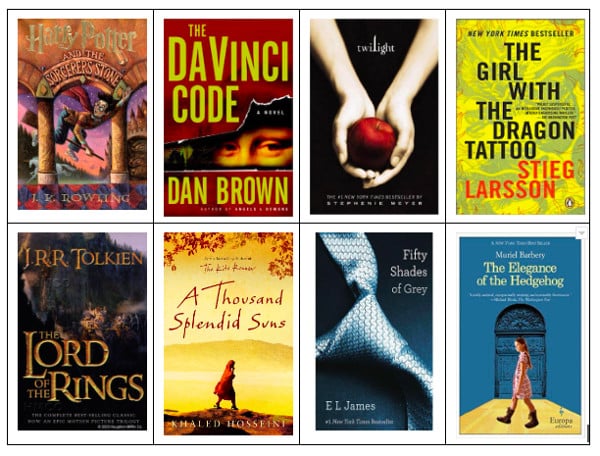Psicologia dell’esperienza immersiva nei copioni narrativi: best sellers, serie tv e serie cinematografiche
Questo articolo esplora in quali modi il best seller, il prodotto narrativo più diffuso di questi anni, contribuisce a plasmare il nostro immaginario psicologico, il nostro inconscio collettivo, i nostri ruoli sociali e i nostri valori.
“Se le persone non trovano quel che desiderano, si accontentano di desiderare quello che trovano” (Guy Debord)
Consideriamo solo i primi due dei cinque assiomi della comunicazione secondo Paul Watzlawick.
- 1° assioma – È impossibile non comunicare. (“L’attività o l’inattività, le parole o il silenzio hanno tutti valore di messaggio: influenzano gli altri e gli altri, a loro volta, non possono non rispondere a queste comunicazioni e in tal modo comunicano anche loro”)
- 2° assioma – In ogni comunicazione si ha una metacomunicazione che regolamenta i rapporti tra chi sta comunicando. (“Ogni comunicazione ha un aspetto di contenuto e un aspetto di relazione, di modo che il secondo classifica il primo ed è quindi metacomunicazione”)
Nel voler ricercare chi siano, cosa vogliano comunicare e metacomunicare gli autori dei best sellers attraverso le storie che ci raccontano e i personaggi che le animano, dovremmo a mio parere tematizzare, dal vertice di una psicologia sociale e politica, ed anche piuttosto radicalmente, questi primi due assiomi della comunicazione.
Non v’è dubbio che “comunicare” è interesse precipuo di ogni autore di romanzi e storie, ma nel caso degli autori che vendono molti milioni di copie, come le star dell’editoria, la comunicazione attraversa innumerevoli passaggi intermedi, tutti i passaggi che riguardano il confezionamento del prodotto nella filiera che va dalla scrittura sulla scrivania dell’autore fino al comodino o alla mensola di casa nostra, passando dal contratto editoriale, la revisione e l’editing dei contenuti nel solco della politica editoriale della major editrice, le scelte di marketing e di promozione multimediale dell’opera nei canali adeguati, comprese, in certi casi, le leggende costruite ad hoc sull’opera e/o sull’autore, fino alla scelta della veste grafica, l’uso delle immagini e dei colori della copertina, le dimensioni del libro, le caratteristiche della carta, dei caratteri, dell’impaginazione, e così via.
Attraverso tutti questi passaggi di marketing editoriale passa però, carsicamente, un’altra forma di comunicazione, una metacomunicazione appunto, che ci racconta dei modi con cui l’editoria co-costruisce trame, personaggi, autori, brand editoriali e in definitiva modelli di riferimento che riguardano complessivamente il tipo umano contemporaneo. Editori e lettori co-costruiscono, metacomunicativamente, un medesimo intreccio di intenti, contenuti e codici simbolici.
Dunque tutto comunica e tutto metacomunica, ed è ingenuo pensare che l’industria culturale non programmi nei minimi dettagli il consumo di massa dei propri prodotti volendo al contempo incontrare, anzi interpretare e anticipare, bisogni e desideri dei lettori. Dice Edgar Morin a proposito dell’industria culturale:
“Si può asserire che una cultura costituisce un corpo complesso di norme, simboli, miti ed immagini che penetrano l’individuo nella sua intimità, strutturano gli istinti, orientano le emozioni. Questa penetrazione si effettua grazie a degli scambi intellettuali di proiezione e di identificazione polarizzati sui simboli, miti ed immagini della cultura come sulle personalità mitiche o reali che incarnano i valori (gli antenati, gli eroi, gli dei). Una cultura fornisce dei punti d’appoggio pratici alla vita immaginaria: nutre l’essere metà reale, metà immaginario, che ciascuno elabora all’interno di sé (la sua anima); l’essere metà reale, metà immaginario che ciascuno elabora all’esterno di sé e con cui si ricopre (la sua personalità)” .
A tal proposito è importante sottolineare che gli esperti di marketing distinguono il pull marketing, il marketing orientato all’offerta, alla proposta di prodotti, che incontra i gusti della clientela e dialoga direttamente con essa, dal push marketing, il marketing che offre la mercanzia alla clientela soprattutto attraverso la promozione verso gli intermediari della vendita (distributori), invogliandoli a spingere il prodotto indipendentemente dai gusti della clientela.
Nell’epoca in cui viviamo, dei big data e della Psicopolitica, dove l’idea stessa di libertà appare minata alle radici, si è avverata la profezia di Morin: non è più possibile concettualmente poter distinguere nettamente tra queste due modalità di vendita (pull e push) di un prodotto. Non è più possibile, vista la massa enorme di conoscenze sempre più dettagliata e profonda sulle abitudini delle clientele, distinguere quanto il bisogno di quel prodotto sia dal punto di vista di chi lo vende recepito o costruito o, come ipotizziamo qui, continuamente co-costruito. Il ruolo attivo e compiacente del consumatore – ogni consumatore – nella costante retroazione su abitudini di consumo, ci conduce su un paradigma di civiltà, ma anche di funzionamento del mentale, del tutto inedito.
In questo quadro, il prodotto narrativo best seller, a largo consumo, non fa eccezione rispetto a tutti gli altri, esso contribuisce in maniera decisa, anzi forse maggiormente rispetto ad altri considerata la sua natura narrativa, a dare forma al materiale del nostro inconscio collettivo e a definire tipologie umane, ruolizzazioni sociali e orizzonti valoriali, dove però ciò che viene utilizzato nella co-costruzione di questo apparato è uno strumentario molto più esteso e molto più raffinato, integrato e totalizzante. I corrispondenti modelli umani e narrativi dell’epoca moderna e pre-moderna, i cosiddetti classici, pur essendo long-sellers, non reggono il confronto rispetto alla penetrazione profonda nella vita mentale delle persone e del tessuto sociale. Se non altro per le limitate diffusioni mediatiche delle epoche precedenti alla nostra e per le limitate diffusioni e stratificazioni sociali legate all’alto tasso di analfabetismo.
Vediamo come avviene questa penetrazione e secondo quali criteri e significati.
Il prodotto da bancarella: l’esperienza sensoriale
Entrare in una grande libreria e osservare i banchi dei best sellers in bella vista con le loro copertine sgargianti, le edizioni speciali ed economiche, è esperienza molto diversa rispetto ad entrare in una polverosa biblioteca o anche in una libreria di pochi anni fa dove i tomi erano messi in ordine alfabetico e per categorie e ben poco spazio era concesso all’immagine. Il libro, compreso il romanzo, era l’apologia del contenuto ed una copertina troppo vistosa casomai raccontava del cattivo gusto dell’editore.
Le grandi librerie contemporanee sono organizzate più o meno come gli altri centri commerciali con i loro labirintici percorsi obbligati, con le loro musiche di sottofondo, le loro luci da ambiente, con i loro studiati posizionamenti e dislocazioni della merce sugli scaffali: nell’atrio, appena entrati vicino alle casse, best sellers recenti e non, edizioni economiche, offerte e sconti. Il consumatore di letteratura ad alto consumo non deve perdere tempo: i best sellers in genere sono impilati in alte colonne in bella vista. Anche questa è una metacomunicazione ben precisa come a dire che non si tratta di un libro che devi sfilare da uno scaffale o da una fila, un libro che devi fare la fatica di cercare, ma di un prodotto che va via come il pane e che non occorre nemmeno consultare. Compra e zitto!
Via via proseguendo tutti gli altri settori, in fondo, su altri piani, con i libri più seri che richiedono spesso l’intervento del commesso e della sua sapiente ricerca.
Prendere in mano un best seller oggi e immaginarlo in bella vista nella nostra libreria di casa o sul tavolino del salotto o sul comodino, è diventata un’esperienza sensoriale già molto significativa. Immagini esplicative, copertine a tutta immagine, carta lucida, spesso con colori primari, grafica essenziale, presentazioni in quarta di copertina brevi e catturanti, nelle edizioni speciali immagini e caratteri in rilievo per consentire esperienze tattili e sinestetiche (Fig. 1).
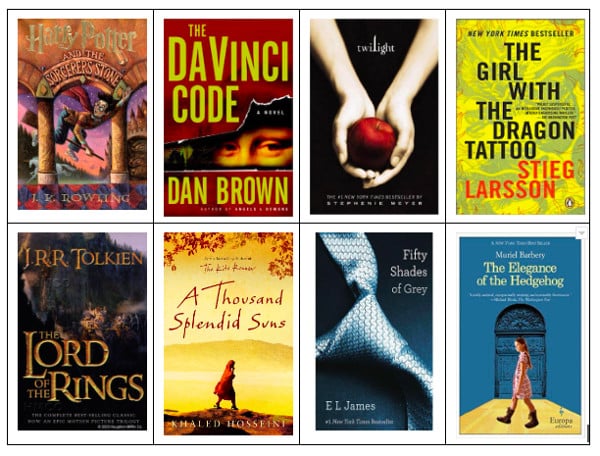
Fig. 1 Qui alcuni esempi di copertine di best sellers
Jean Baudrillard nel suo primo saggio, “Il sistema degli oggetti”, affrontava esattamente questo piano sensoriale-elementare della fruizione del prodotto indicando la differenza esistente, nella espansiva società dei consumi del dopoguerra, tra valore funzionale, cioè l’uso concreto del prodotto, e il valore segnico, per indicare il valore sociale interno ad un sistema di oggetti che rimanda ad uno status sociale ad esso collegato (oggi diremmo il brand). Il valore segnico è ancora diverso dal valore simbolico che indica invece il valore individuale, affettivo e biografico che ciascuno assegna ad un oggetto.
L’oggetto-di-consumo-culturale-libro, come accaduto con innumerevoli altri oggetti di consumo, nella attuale società dei consumi, tende a con-fondere e far confluire il valore simbolico nel valore segnico. Tale oggetto (meta)comunica che un best seller non è un libro qualunque, di quelli seri o seriosi, che vuole educarti, istruirti, informarti, approfondire, farti pensare o riflettere. No, nulla di tutto questo: già a partire dall’esperienza sensoriale, il best seller si candida ad essere oggetto esclusivo del nostro arredamento domestico (e di quello interiore), come prevalente oggetto ludico, di intrattenimento puro. L’oggetto-best-seller deve intrattenere e catturare divertendo, al limite rapendo il lettore in un flusso di coscienza che già dagli aspetti sensoriali ci racconterà qualcosa di noi, ma senza impegnarci molto, in altre parole deve realizzare la paradossale esperienza di spiazzarci senza metterci in discussione. Deve inoltre diventare ordine del giorno nelle discussioni tra amiche e amici come se si parlasse del proprio partner o del vicino di casa molesto o bizzarro.
Le regole implicite metacomunicative che il marketing editoriale vuole trasmettere, già da questo piano elementare sensoriale, sono quelle dell’omologazione ad altri criteri comunicativi, quelli televisivi in primis e poi quelli multimediali di cui il prodotto-best-seller è semplicemente punto di snodo di una lunga sequenza commerciale, corollario di una lunga catena di eventi mediatici plurimi e interattivi: libro, film, serial tv, talk e trasmissioni tv, forum web, fan fiction, talora graphic novel e videogioco, etc.
Il libro sgargiante troneggiante sul banco della libreria ci dice in buona sostanza che “tutta la città ne parla”, qui trovi, già dall’esperienza sensoriale, il rimando all’esperienza di cui altri milioni di individui stanno godendo in tv sia nelle serie televisive collegate che nelle trasmissioni specchietto per le allodole, al cinema, sul web (nei forum specializzati). Insomma, questo è il testo sacro, il racconto primigenio o l’ennesimo di una sequenza, da cui originano tutte le esperienze ludiche, empatiche e identificatorie che coinvolgono milioni di persone come te. Per essere protagonista del tempo presente e sentirsi parte adeguata di una collettività, seppure solo virtuale e delocalizzata, occorre vivere l’esperienza che questo oggetto ti propone.
Il prodotto empatico: l’esperienza emotiva
Procedendo in un ideale percorso dal “basso” verso l’“alto” delle funzioni psicologiche, l’esperienza sensoriale del best seller avanza verso quella emotiva ed allo stesso tempo ne è preludio e l’esperienza emotiva precede ed integra l’esperienza narrativa. Naturalmente la suddivisione che qui operiamo tra i paragrafi di questo capitolo è meramente descrittiva e occorre quindi dire che dal punto di vista psicologico esiste un continuum/circolarità piuttosto strutturale e coerente tra esperienza sensoriale, emotiva e cognitivo-narrativa, per cui l’esperienza del lettore non è mai scindibile ed isolabile, seppure prevalgano nella fruizione ora un aspetto psicologico, ora un altro, a seconda del contesto in cui esso viene osservato.
Non esiste esperienza cognitiva e narrativa senza un preciso marker emotivo, l’emozione in sostanza colora e fissa la memoria di un’esperienza letteraria. È per questo che sul piano dell’esperienza emotiva troviamo il terreno applicativo elettivo degli sforzi del marketing globale.
Analizziamo ora solo alcuni recenti studi psicologici sull’esperienza emotiva del lettore. In generale, gli studi empirici provano a scoprire le diverse risposte emotive dei lettori rispetto ad un testo e a comprenderne le variazioni durante e dopo la lettura sia sul piano emotivo sia su quello cognitivo.
Mar ed altri in una recente rassegna sulla ricerca empirica sul tema delle emozioni dei lettori di narrativa, del 2010 esaminano dapprima le differenze tra fruizione emotiva della letteratura rispetto ad altri media e altro genere di narrazione. Chi sceglie la finzione narrativa sembrerebbe in grado di gestire le emozioni meglio (con possibilità di differimento, metabolizzazione e controllo) di chi fruisce di altri media più “economici” e passivizzanti come tv o cinema e questo farebbe pensare che la scelta di questo genere di intrattenimento sia legata ad una fruizione più attiva e interessata e non soggetta ad un flusso emotivo semplice.
Mar differenzia i diversi piani del coinvolgimento emotivo del lettore che, pur correlati tra di loro, sono distinti: esistono le emozioni estetiche legate alla fruizione del testo letterario come opera d’arte ed esistono le emozioni “immersive” legate all’ingresso nel mondo immaginario del romanzo. Le emozioni immersive a loro volta si differenziano in: emozioni recenti ed emozioni evocative, queste ultime legate alla rappresentazione sia personale che collettiva delle narrazioni.
Le emozioni recenti si suddividono in: emozioni di simpatia, di identificazione e di empatia. Le emozioni di simpatia sono il correlato di una partecipazione più semplice (rispetto alla identificazione) alla situazione descritta come se il lettore fosse un testimone privilegiato degli accadimenti, cosa che produce emozioni di simpatia rispetto a quanto accade nel bene e nel male ai personaggi. Le emozioni di identificazione sono legate alla situazione soggettiva del lettore e alla sovrapposizione dei piani esistenziali tra lui e il protagonista. Le emozioni di empatia invece implicano la comprensione emotiva e cognitiva dei piani descritti riguardo situazioni e personaggi sotto forma di modelli mentali, teorie della mente, ma le emozioni del lettore sono distinte da quelle dei personaggi.
Ma sono le emozioni evocative quelle che appaiono avere maggiore influenza duratura sulla personalità del lettore anche dopo la fine della lettura, incidendo più profondamente sull’esperienza del lettore.
Mar, infine, cita alcune ricerche nelle quali è risultato evidente come le narrazioni consentano una maggiore possibilità di metabolizzare emozioni mantenute a distanza a causa della loro virulenza o per cause traumatiche personali, dimostrando quella valenza terapeutica della narrazione che l’uomo conosce dalla notte dei tempi.
In un altro studio si evidenzia invece come vi sia complementarietà nella lettura della letteratura tra processi di empatia, qui declinati come esperimenti morali di assorbimento-immersione nelle vicende altrui e come assunzione di ruolo, e processi di auto-riflessione che implicano invece un distacco e un relativo estraniamento, una sorta di alternanza tra un’emotività veloce e una più lenta e riflessiva.
In un’altra rassegna del 2013, Susanne Keen sostiene che l’empatia, da differenziare dai processi di identificazione, sovrasta ogni altro aspetto narrativologico a livello psicologico. L’autrice riferisce che “gli psicologi che studiano l’empatia narrativa in laboratorio hanno identificato le caratteristiche principali dei testi di fiction narrativa tra cui troviamo un uso massiccio di immagini che invitano il lettore alla simulazione mentale e all’esperienza dell’immersione e a rendere i rapporti soggettivi più fluidi come se ‘avessero lasciato il mondo reale alle spalle durante la visita di mondi narrativi'”.
L’autrice inoltre esplora le tecniche narrative utilizzate dagli autori (e, aggiungiamo noi, dal sistema di marketing sottostante) per evocare e approfondire le risposte empatiche dei lettori: “queste tecniche comprendono le manipolazioni di situazioni narrative nella prospettiva di un personaggio della narrazione o di una rappresentazione interiore di personaggi immaginari, l’uso di punti di vista e paratesti. Altri elementi si ritiene siano coinvolti nell’evocazione dell’empatia dei lettori compreso l’utilizzo vivido di sconfinamenti, metalessi, ripetizioni seriali di racconti immersi in un mondo narrativo stabile, lungaggini, l’incoraggiare i lettori ad immergersi o lasciarsi trasportare, l’uso di convenzioni generiche, interiezioni metanarrative, l’uso dei primi piani, il disordine o l’estraniamento indotto dal rallentamento della lettura” (Susanne Keen, ibidem).
Possiamo concludere che gli stili narrativi dei prodotti editoriali a largo consumo, se ci soffermiamo su questo piano emotivo, puntino a evocare nel lettore, specie laddove tali stili narrativi si appiattiscono su quelli delle serie tv e cinematografiche, soprattutto (ma non solo) l’esperienza dello smarrimento empatico, cioè una sorta di esperienza ludica del perdersi nel dedalo delle situazioni narrative di vicende e personaggi puntando più sulla gamma di emozioni recenti, specialmente empatiche che su quelle identificatorie. Come detto, l’empatia ha a che fare con la capacità dell’individuo (e del lettore) di costruire teorie della mente dei suoi interlocutori acquisendo una comprensione emotiva non necessariamente identificatoria o simpatica. Le narrazioni contemporanee con i loro personaggi variegati, talora anonimi, talora antieroi, talora onirici, riescono a immergere il lettore in flussi di vissuti emotivi nei quali è richiesto al lettore il semplice sforzo del lasciarsi trasportare e talora di cambiare prospettiva, ma non quello di cambiare idea.
In tal senso la massimizzazione delle risposte empatiche nel lettore sembrerebbe ottenere un risultato “a-pedagogico” ovverosia il risultato di ampliare il lessico emotivo dei lettori, ma di scoraggiare l’uso di modelli emotivi identificatori.
Questo non significa affatto che le trame e i personaggi dei best sellers contemporanei non seguano modelli e codici, almeno dal punto di vista emotivo, “esemplari”, cioè identificatori. Solo che in questo caso ciò che non viene definito esplicitamente dall’autore, diventato nella postmodernità, laico e antiideologico, viene definito implicitamente.
Il prodotto pervasivo: l’esperienza narrativa
L’ipercodifica che avviene su ogni piano della realizzazione del prodotto-best-seller e su ogni piano della sua fruizione psicologica e culturale, del soggetto-consumatore, coincide in definitiva con una sorta di παιδεία implicita (per i greci antichi, paideia = educazione valoriale e sociale) che avviene laddove esperienza sensoriale ed esperienza emotiva confluiscono coerentemente con il sistema simbolico-valoriale del tempo presente.
Per molti psicologi, specie i cosiddetti post-razionalisti, la mente è narrazione, utilizza esclusivi schemi narrativi come strumenti adattativi alla realtà circostante. Senza dover aderire totalmente a questo costrutto, di sicuro possiamo asserire che la mente utilizza la funzione narrativa ai piani alti della propria funzionalità. Tende cioè a rappresentare il dialogo tra i personaggi del proprio mondo interno attraverso piani anticipatori, trame e intrecci, più o meno brevi/lunghi, che assumono carattere di temi narrativi ricorrenti.
Le attuali società dell’era neoliberista e iperconsumista hanno prima annullato la dialettica produzione-consumo invitando il consumatore a partecipare attivamente alla produzione della propria felicità, eleggendo il consumatore di fatto a protagonista e co-costruttore di senso del proprio essere al mondo attraverso il proprio consumo. Poi hanno progressivamente esteso ad ogni esperienza psichica tale compartecipazione compiacente attraverso la spinta adoperata dai vecchi e nuovi media. Secondo Byung-Chul Han (op. cit.) questo sviluppo coerente, all’interno dello stesso paradigma economico-sociale, segna il passaggio dall’era della biopolitica a quella della psicopolitica, dove in gioco non è più solo il controllo della vita della popolazione e dei suoi confini e della sua etica, ma la vita loro psichica ormai migrata sui nuovi territori inaugurati dai nuovi media e da internet. Vita psichica caratterizzata, diversamente dal bios, dalla sua intrinseca illimitatezza riguardo il mondo immaginario, le emozioni e i desideri.
In altre parole, la capacità di penetrazione delle regole che presiedono alla formazione dell’individuo passa oggi attraverso dispositivi e canali tecnologici e simbolici particolarmente pervasivi e strutturanti.
Come dimostra l’illuminante testo di Stefano Calabrese, “Anatomia del Best Sellers”, nelle trame dei best seller, come in quelle delle serie tv più popolari, l’immersività delle esperienze nelle vite immaginarie dei protagonisti riproduce, attraverso una nuova fluidità dell’esperienza estetica, analogo annullamento dialettico di cui sopra, questa volta non semplicemente tra produttore e consumatore, ma più specificatamente tra lettore, autore e protagonisti.
Inoltre, sempre secondo Calabrese, la frequente fusione e sovrapposizione, operata dal marketing editoriale tra autore, narratore, protagonista e talora anche lettore, tende a creare dal punto di vista narrativologico una sorta di effetto totalizzante, un mitologema, che risulta fortemente favorevole alla creazione di “casi” letterari, che ben presto si offrono al mercato mediatico globalizzato sottoforma di narrazioni parallele nelle cosiddette fan fiction, serie tv, film, graphic novel, forum, fan art e videogiochi, etc.
L’esperienza narrativa totalizzante di un fan
Massimo (nome fittizio) è un ragazzo di 21 anni, seguito in psicoterapia da circa due anni, in genere in seduta racconta le proprie esperienze personali, familiari e sociali sullo sfondo delle sue difficoltà, originate già nell’infanzia, ma in via di risoluzione. Oggi Massimo lavora felicemente nel negozio di famiglia, ha superato molti suoi problemi iniziali e comincia a sentirsi un ragazzo della sua generazione.
Massimo però è anche un fan assiduo e informatissimo sia delle serie tv più diffuse (“Trono di Spade” su tutte, ma anche “Harry Potter”) che dei best sellers connessi. Solo una volta in ben due anni di incontri, racconterà di questa esperienza di fan e poi mai più.
Nel racconto della sua esperienza narrativa, egli apre nuovi mondi allorquando illustra, facendolo assolutamente dall’interno, il complesso sistema mediatico che presiede una serie di successo.
Seguendo il racconto in seduta di Massimo, possiamo comprendere come un fan come lui abbia la possibilità di seguire storie e personaggi della serie o del best seller preferito nei seguenti spazi:
- Libro (o serie di libri in sequel)
- Serie di film al cinema (alcuni best sellers diventano film e produzioni cinematografiche di successo anche in serie: “Harry Potter”, “Il Codice da Vinci”, “Twilight”, “50 Sfumature di grigio”, “Il Signore degli Anelli”, tra gli altri)
- Serie TV (alcuni best sellers diventano serie TV. Molti autori di best sellers nascono come autori e sceneggiatori per la TV)
- Fan fiction (spazio dedicato ai fans della serie o del libro che costruiscono storie parallele dette spin off a partire dalle trame principali. Ricordiamo che “50 Sfumature di Grigio” nasce come spin off di “Twilight”)
- Forum dedicati ai fans (spazi di discussione nei quali i fans discutono nei diversi topic relativi a questo o quell’evento relativo a trame o dettagli di trame della serie tv o del libro. Massimo racconta delle centinaia di pagine di discussione dedicate dai fans alla frase di chiusura dell’ultimo libro di “Trono di Spade”, volutamente ambigua, per la quale non era chiaro se il personaggio accoltellato morisse o sopravvivesse)
- Fan art (siti web dove vengono disegnati i personaggi delle serie e dei romanzi)
- Video Recensioni (ogni episodio tv o libro viene ripetutamente recensito su Youtube)
- Video Tributi (sono tributi e presentazioni dei vari personaggi di serie e libri, sempre su Youtube)
- Gruppi facebook (sono gruppi dedicati ai fan di questo o quel best seller, serie, autore, film, etc)
- Graphic Novel (versioni fumettistiche di serie e libri)
- Cosplay (è la pratica di travestirsi nei personaggi di una serie tv o cinematografica, di un fumetto o di un libro, spesso utilizzata in riunioni e esibizioni pubbliche)
- Fiere e presentazioni (sono occasioni pubbliche dove i fans di una certa serie o libro si possono – finalmente – incontrare dal vivo per conoscersi e scambiare opinioni)
- Videogiochi (sono trasposizioni ludiche per consolle di giochi elettronici con gli stessi personaggi, ambientazioni e vicende di serie e libri)
Massimo si limiterà, come detto, solo una volta ad aprirsi in seduta a questi mondi articolati, per il resto del tempo ri-confinerà questa esperienza nel territorio parallelo e nascosto (una sorta di vita virtuale parallela e segreta, condivisa con pochissimi amici) dalla quale era emersa. Non prima però di confessare che il venire in possesso del fatidico e agognato sesto libro della serie “Trono di Spade” (atteso da oltre 6 anni e ancora non uscito) nella sua personale classifica esistenziale avrebbe scalzato addirittura il derby cittadino. Ed è tutto dire!
Assistiamo qui, dunque, in particolare riferendoci alla narrativa con elementi fantasy o similia (ma il discorso è facilmente estendibile a molti altri best sellers anche di genere diverso), all’esplosione di un nuovo epos partecipativo-immersivo dove troviamo alcune ricorsività delle strategie narrative, ne elenchiamo qui le principali tra tante:
- Enfasi dei processi identificativi con i personaggi (con i correlati emotivi descritti nel paragrafo precedente);
- Utilizzo di ambientazioni esotiche, immaginifiche, irreali, astoriche;
- Utilizzo massiccio e ripetuto di colpi di scena emotivamente scuotenti;
- Utilizzo massiccio e ripetuto di dettagli ambigui e di finali aperti (tali da alimentare le cosiddette “teorie” dei fans sui contenuti del testo e le loro discussioni);
- Utilizzo di riferimenti esoterici, misteriosi, magici
Queste strategie narrative (accanto a quelle descritte da S. Keen nel precedente paragrafo sull’esperienza emotiva), ed altre ancora, attraverso strumenti di dissonanza e spiazzamento emotivo/cognitivo (specie i colpi di scena e i finali aperti), molto simili a quelli utilizzati in ipnosi per approfondire la trans ipnotica, hanno l’effetto di ingigantire a dismisura l’esperienza immersiva del lettore/spettatore e di incollarlo letteralmente alla storia, creando, attraverso il circuito mediatico, illustrato così dettagliatamente da Massimo, un cerchio chiuso tra narrazione televisiva e narrazione letteraria, che finiscono per alimentarsi e trascinarsi (anche commercialmente) a vicenda e ad assomigliarsi sempre più, ma anche, come sottolineato da Calabrese, tra personaggi immaginari e personaggi reali (gli autori, i fans, i personaggi).
L’immersività, l’enfasi empatica sul piano emotivo, poi quella identificativa su quello narrativo e l’emozionalizzazione dell’esperienza, in generale, rimandano all’uso sfrenato di un’attività immaginifica, spesso con coloriture ludico-grandiose, che molto richiamano la fenomenologia dell’organizzazione di personalità dello spettro narcisistico, per la quale la gran parte del tempo della propria intimità psichica e del proprio dialogo interiore è occupato in fantasie grandiose e di successo. Per comprendere quanto detto basti fare riferimento al personaggio di un noto film, interpretato da Ben Stiller, “Walter Mitty” (“I sogni segreti di Walter Mitty”, 2013), il quale è continuamente immerso in fantasie grandiose di successo e di avventura, in sogni vividi ad occhi aperti molto immanenti, pur avendo nella realtà una vita noiosa e piuttosto mortificata. Fino a quando un evento lavorativo lo dirige verso impreviste avventure reali.
Conclusioni
Chiudere e saldare il cerchio tra realtà ed immaginazione, tra strumenti comunicativi, tra media, tra forme di narrazione, tra lettori-spettatori-autori-editori-personaggi, tra venditori e compratori, serve in sostanza a esaltare ed imporre uno storytelling compartecipativo sulla realtà attuale che investe ogni piano dell’esperienza umana, da quella sensoriale a quella cognitiva, ogni piano della comunicazione mediatica, annullando i confini tra vita e racconto, tra verosimiglianza e verità, tra chi progetta le storie e chi le compra-legge-vede.
L’esito di questa saldatura così minuziosa e articolata tra parti e controparti, tutte partecipanti al medesimo obiettivo e nella medesima sostanza fluida e collosa, è la blindatura dell’immaginazione e dei processi culturali che a loro volta hanno come conseguenza l’omologazione dei processi creativi.
È difficile infatti immaginare un atto creativo, nell’arte come nella letteratura, senza un pensiero divergente, senza un’innovazione, un atto realmente sorprendente e inedito che emerga dall’inquietudine più o meno disciplinata dell’artista che ha dato forma comunicativa alla sua opera. La creatività senza imprevedibilità trasforma l’opera in prodotto in serie, finemente e astutamente confezionato affinché evochi una gamma altrettanto prevedibile di risposte ludiche, emotive, cognitive del consumatore che si fa egli stesso co-autore del fenomeno esperienziale in questione.
Il consumatore di best seller appare, in questa compartecipazione attiva, il prodotto di una mutazione antropologica, una creatura modificata ad arte dal marketing evoluto dei big data, tale da poter godere pienamente delle esperienza immersive, totalizzanti, emotivamente oniriche, dei propri sconfinati mondi immaginari nel rapporto coautorale e circolare costruito dal marketing emozionalizzante.
Non è solo il concetto di creatività che entra in crisi, ma anche quello di libertà, resa condizionata e colonizzata, o sfruttata, come dice Han (op.cit.) in questa epoca neoliberista avanzata. La compartecipazione circolare e pervasiva elimina ogni controparte sfruttante e rende ognuno padrone della propria schiavitù, padrone e schiavo coincidono nel nuovo soggetto detto consumatore, ipnoticamente adattato alle eternamente sovraordinate esigenze del marketing.