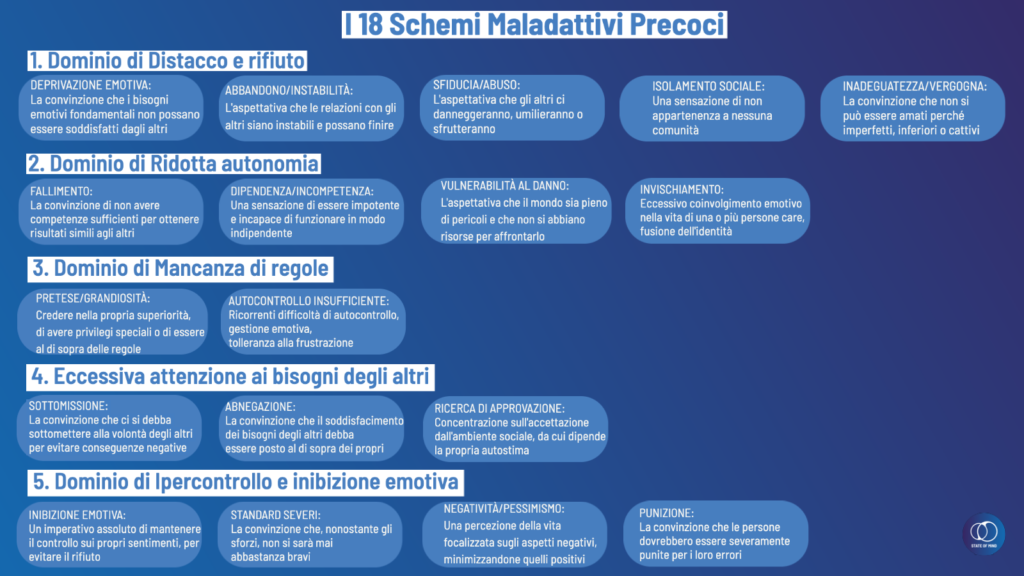Le opportunità di un Centro Diurno. La riparazione della bicicletta come metafora di riparazione del Sé
Questo articolo descrive la nascita e lo sviluppo di un laboratorio di ciclo-officina in un Centro Diurno (CD) romano.
La vita è come andare in bicicletta. Per restare in equilibrio devi muoverti. Einstein.
Introduzione
Il Centro Diurno è uno spazio del Servizio Sanitario Regionale che ospita persone con difficoltà di tipo psichiatrico che necessitano di aiuto per riprendere in mano la propria vita e padroneggiare quelle competenze o abilità che la sofferenza psichica ha bloccato o non ne ha permesso il pieno sviluppo. Abilità sociali, familiari, professionali, autostima, risoluzione dei problemi, resilienza e gestione dello stress sono alcune delle abilità che il lavoro clinico e riabilitativo contribuisce a rafforzare.
Proprio perché ogni individuo è unico, per progettare e costruire un programma che l’aiuti a trovare nuovi significati di vita, di speranza e di crescita personale, è fondamentale individuare insieme i suoi punti di forza (Rapp & Goscha, 2006; Bello et al., 2008) e i suoi bisogni. Nel Centro Diurno lavorano operatori sanitari di varie discipline e spesso maestri d’arte che trasferiscono ai pazienti, attraverso un approccio non giudicante e cooperativo, il loro sapere tecnico e ne verificano il percorso. Tutti gli operatori provano ad integrare interventi e competenze, pensando insieme nello spazio della riunione d’équipe. Questa resta uno strumento unico perché fornisce la possibilità di sospendere l’azione, di pensare emozioni e reazioni controtransferali e di riformulare il progetto offerto al singolo paziente. Il Centro Diurno si pone l’obiettivo di essere un luogo sicuro affinchè i suoi ospiti possano sperimentare socializzazione, esprimere e dare un senso alle proprie emozioni ed apprendere anche competenze professionali. È noto infatti, che se ci sentiamo produttivi in ambito lavorativo, anche l’autostima, l’umore e le relazioni sociali migliorano.
La bicicletta
La bicicletta è un mezzo di locomozione consueto nella vita di tutti i giorni, la usiamo per andare a comprare il giornale, per fare la spesa o l’attività sportiva. È diffusa in tutto il mondo proprio perché è versatile, leggera ed economica e non richiede alcun carburante per essere alimentata, se non la forza muscolare della persona che pedala. Per molti di noi è stato il primo oggetto per esplorare il mondo circostante e per spostarci velocemente da un luogo ad un altro.
Il primo a disegnare una “macchina” con due ruote, un’asse di legno che le teneva insieme, un manubrio e una specie di catena che collegava i pedali alla ruota posteriore, è stato Leonardo da Vinci. Per la sua invenzione però, dobbiamo attendere il barone tedesco Karl von Drais che nel 1817 realizzò la draisina, dalla quale è derivata l’attuale bicicletta che, nel tempo, ha assunto moltissimi significati. Possiamo dire che rappresenta una forma di libertà e che ci fornisce quella forza per sentirci padroni di un pezzo di mondo, ma in cambio richiede equilibrio, controllo del corpo e dei movimenti. Alcuni ricollegano la bicicletta a quei movimenti per la riappropriazione delle strade, o che combattono contro il riscaldamento globale, contro le guerre per il petrolio, che rifiutano la vita moderna e scelgono di vivere in un modo diverso.
Di certo, la bicicletta è entrata con forza nella nostra vita e nel nostro immaginario, tanto da diventare protagonista di brani musicali, oggetto di poesia, di racconti e di storie cinematografiche. Per quanto riguarda il cinema, si ricorda “Ladri di biciclette” di Vittorio De Sica (1948) e il film d’animazione “Appuntamento a Belleville” di Sylvain Chomet (2003), che le conferisce il potere di curare la tristezza del giovane protagonista. Recentemente, l’artista Roberto Sironi le ha dedicato una mostra personale dal titolo “Arte su due ruote”. Infine, è doveroso ricordare che la bicicletta è protagonista di uno sport che ha entusiasmato intere generazioni, il ciclismo. È stato “[…] lo sport più seguito e amato fino agli anni ’60, quando, ormai svuotato di potenziale simbolico, gli succederà l’altro grande fenomeno sportivo di massa, il calcio” (Barsella, 1999, pag. 70).
Ogniqualvolta parliamo della bicicletta, parliamo anche di noi stessi perché essa “[…] fa parte della storia di ognuno di noi. Il momento in cui impariamo ad andare in bici appartiene ai ricordi speciali dell’infanzia e dell’adolescenza. È così che abbiamo scoperto un po’ del nostro corpo, delle nostre capacità fisiche e abbiamo sperimentato la libertà legata a queste scoperte” (Augé, 2009, pag. 7). La bicicletta aiuta a conoscere e comprendere limiti e capacità ed è una fonte di apprendimento della resilienza, ossia la capacità di superare le difficoltà ed adattarsi agli imprevisti.
La ciclo-officina in un Centro Diurno
Circa un anno fa, per pura coincidenza, il nostro Centro Diurno ha partecipato ad un progetto che ha permesso di allestire un laboratorio di ciclo-officina e di retribuire per un periodo circoscritto un meccanico esperto. Inizialmente abbiamo illustrato questa novità senza grosso slancio ed aspettative, nonostante l’entusiasmo mostrato da alcuni dei nostri utenti che si sono candidati immediatamente. Sin dalle prime riunioni, abbiamo registrato che gli utenti arrivavano puntuali, non si assentavano e progressivamente aumentava il desiderio di partecipazione. Si divertivano, erano più attivi che in altri laboratori e il clima generatosi dopo pochi mesi era giocoso, affettivo e cooperativo. Un utente ha chiesto di frequentare solo la ciclo-officina perché “[…] qui mi diverto davvero e imparo a fare cose pratiche ed utili; se continuo ad impegnarmi, tra un po’ potrò aggiustare la bicicletta di mia sorella!”. Questo inaspettato successo ci ha spinto a rivedere le aspettative iniziali e a cercare –ed infine a trovare– altri fondi per continuare l’esperienza. Dopo un anno dalla sua attivazione, siamo riusciti a rendere stabile e sicuro questo laboratorio e registriamo con piacere che continua ad essere molto gradito ai nostri utenti, tanto che qualcuno fantastica di farlo diventare una vera e propria fonte di reddito.
“L’officina nel suo complesso e la bicicletta più specificamente ospitano un determinato sistema di atti in cui le persone e le cose sono viste trasformarsi senza che alcun elemento della loro composizione fisica di base cambi davvero” (Marks 2021, pag. 1706). Non pensiamo però che aggiustare le biciclette in un Centro Diurno sia solo un’attività relazionale e socializzante dal forte impatto simbolico; sappiamo molto bene che, per farlo, bisogna usare le mani, sporcarsi, mettere in moto tutto il corpo e sviluppare capacità di problem solving. Gli utenti, dopo una prima fase di apprendimento di base, sono invitati ad intervenire insieme sull’oggetto da riparare mentre il meccanico osserva e indirizza, astenendosi dal suggerire soluzioni definitive. Aspetta pazientemente che il movimento o l’azione giusta emerga dal confronto e dagli errori. In questo modo, in un clima spesso ironico e giocoso, si rafforza l’interdipendenza positiva e si pongono le basi per un vero e proprio apprendimento cooperativo (Comoglio, 1999).
Un paziente da anni chiuso in casa – che chiameremo Antonio – ha accettato di frequentare la ciclo-officina a patto che non fosse obbligato ad indossare abiti da lavoro e a “sporcarsi le mani”. Gli piace osservare, commentare e, pur correggendo spesso chi, secondo lui, sta sbagliando l’intervento tecnico, non si pone in contrapposizione con il gruppo ed accetta le mediazioni del conduttore. Abbiamo permesso che in questo gruppo scegliesse dove posizionarsi per aiutarlo a tollerare ciò che per anni lo ha tenuto lontano dalla vita sociale. Il gruppo ha accettato il parziale coinvolgimento di Antonio, non vive le sue critiche come offensive e spesso ricorre all’ironia per tentare di avvicinarlo di più.
A differenza di Antonio, un altro utente prova piacere proprio nello sporcarsi le mani. Questo spazio assume caratteristiche terapeutiche non solo perché insegna nuove competenze, ma soprattutto perché, accettando le persone con i loro limiti e le loro stravaganze, permette di costruire e riparare anche relazioni.
Nella ciclo-officina “[…] la realtà è fatta ed agita (enacted) piuttosto che osservata […], viene manipolata da vari strumenti nel corso di diverse operazioni. […] La ciclo-officina promuove una serie di azioni che consentono di sperimentare la sensazione – inizialmente piuttosto singolare – che il proprio mondo interno riemerga in modo nuovo e senza limitazioni” (Marks 2021, pag. 1710). Mentre le mani lavorano, le persone si raccontano e potenziano il loro senso di appartenenza.
Mettere più mani su una bicicletta rotta diventa un gesto di cura ed attenzione gruppale che dall’oggetto si trasferisce simbolicamente alle persone; pensare e fare insieme, attraverso lo scambio di saperi ed esperienze concrete, stimola la condivisione di ricordi individuali che facilitano la tessitura di una trama di relazioni che spesso continuano anche all’esterno del laboratorio e del Centro Diurno. In quest’ottica, possiamo definire la bicicletta da riparare una specie di “oggetto transizionale ferito ma riparabile” sul quale mettono le mani e proiettano le loro emozioni tutti i partecipanti che, in maniera cooperativa e gruppale, la riparano e la rendono di nuovo utilizzabile. Da un punto di vista simbolico, riparare una bici diventa anche un gesto di potenziale riparazione del Sé che si completa con il collaudo finale. Questa operazione consiste nel “provare e sentire” l’oggetto riparato attraverso il pedalare all’aria aperta, cosa che non tutti sono in grado di fare spontaneamente e non solo per un mero problema di equilibrio o di capacità di pedalare. Pedalare una bici comporta autonomia, libertà, sensazione di benessere ed autodirezionalità, caratteristiche che spesso i pazienti psichiatrici hanno perso o temono di esternare. Colui che si offre per il collaudo, dalla posizione stabile (in piedi davanti al banco di lavoro), inforca la bicicletta, controlla l’equilibrio del proprio corpo nello spazio e comincia a pedalare nell’ampio cortile del Centro Diurno. Il collaudatore non solo diventa portavoce del lavoro gruppale ma anche motivatore poiché, condividendo le sue impressioni tecniche e soprattutto le emozioni provate, coinvolge anche gli altri nella condivisione del piacere appena sperimentato. Spesso è necessario eseguire un ulteriore intervento meccanico e ripetere il collaudo, che può essere eseguito anche da un’altra persona; alla fine è tutto il gruppo che ha riparato una bicicletta e insieme può anche gioire.
Tutto ciò può essere letto come una metafora della sofferenza mentale e dei suoi vari percorsi di cura e di miglioramento che possono avviarsi solo all’interno di uno spazio libero e protetto e in comunione con altre persone.
Infine, in questa dimensione educativo-relazionale e formativo-professionale, diamo risalto anche al recupero di biciclette abbandonate alle quali ridare nuova vita ed evitare che diventino rifiuti. Si avvia così un percorso, oltre che ecologico, anche etico e di riabilitazione della persona, sfruttando il forte potere simbolico che il riciclo e la bicicletta posseggono.
Conclusioni
Un concetto molto discusso negli ultimi decenni in ambito psichiatrico è quello di recovery (Anthony, 1993; Deegan, 2004; Peterson et al., 2006; Maone & D’Avanzo, 2015). È stato tradotto in italiano in molti modi, ma in nessuna accezione coincide con la scomparsa della malattia mentale, piuttosto rispecchia lo sviluppo di abilità perdute e il recupero di un ruolo valido e soddisfacente all’interno della società (Carozza, 2006). Liberman e Kopelowicz (2005) suggeriscono di parlare di recovery quando i sintomi della malattia non interferiscono più con il funzionamento della persona nella vita quotidiana. L’agenzia governativa statunitense SAMHSA (Substance Abuse and Mental Health Services Administration), lo definisce come:
“[…] un processo di cambiamento attraverso cui l’individuo migliora la propria salute e il proprio benessere, vive in modo self-directed e si impegna a vivere al meglio delle proprie potenzialità”.
La stessa organizzazione identifica quattro dimensioni che supportano il recovery:
- Health: capacità di gestire la propria malattia.
- Home: un luogo sicuro dove vivere.
- Purpose: attività significative, ad esempio il lavoro, lo studio, il tempo libero.
- Community: sentirsi parte di una rete sociale (ad es., amici, famiglia, quartiere o paese dove si vive).
Anche se i servizi di salute mentale italiani si sono mostrati sensibili a questo concetto, resta ancora da completare “[…] il loro ri-orientamento verso il supporto agli utenti nel raggiungimento dei propri obiettivi di vita, piuttosto che sugli obiettivi dei professionisti o sulle rappresentazioni di questi ultimi in relazione agli interessi dei loro utenti. In tale ottica, va proposto e valorizzato il processo di autonomizzazione degli utenti nella gestione del loro budget di cura. Conseguenze importanti della partecipazione degli utenti dei Servizi agli obiettivi da raggiungere sono la facilitazione della loro inclusione nella comunità e la riduzione della loro dipendenza dal sistema dei Servizi per la salute mentale” (Bruschetta et al., 2016). Il budget di cura o di salute può essere definito come “[…] insieme di risorse economiche, professionali e umane necessarie per innescare un processo finalizzato alla ri-acquisizione di abilità sociali della persona, attraverso un progetto terapeutico-riabilitativo individuale” (Gruppo europeo di cooperazione territoriale). Questo discorso vale anche per gli operatori dei Centri Diurni che, pur fornendo ascolto, comprensione e rispetto, non sempre riescono ad evitare di orientare il modo in cui una persona gestisce il proprio disturbo e la propria vita. Siamo sulla buona strada, ma c’è ancora del lavoro da svolgere, sia in ambito formativo, sia in ambito di stanziamento di risorse.
Per quanto riguarda l’oggetto di questo articolo –la ciclo-officina– vorrei concludere riportando la richiesta che mi ha fatto qualche giorno fa un paziente: “dottore, ma perché non apriamo una vera e propria officina per riparare le biciclette?”.
Spesso le persone sono più avanti delle istituzioni!