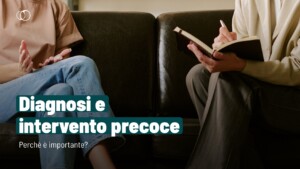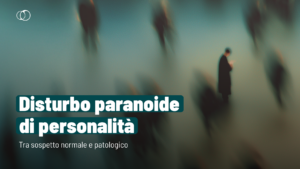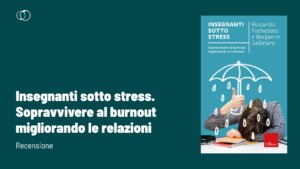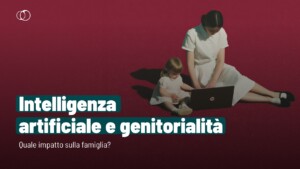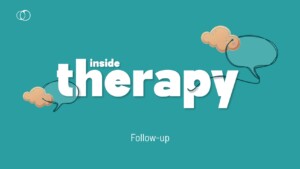Psicopatologia oggi: la struttura del Sé nei Disturbi Alimentari
Sabba Orefice
 La distorsione dello stimolo della fame inizia a instaurarsi rapidamente. Le madri che riportano situazioni di maternità critica descrivono spesso, per esempio, che dopo un iniziale periodo di generica “passività”, è accaduto qualcosa alla neonata: quello che chiamiamo il disturbo subclinico può consistere in alcuni casi in una tendenza al ritiro momentaneo dal seno (o dal biberon!) o in un altrettanto momentaneo rifiuto di poppare, in alcuni casi alternato a un mangiare allarmato che può essere percepito come “avido”: “Succhiava come se fosse l’ultimo pasto”.
La distorsione dello stimolo della fame inizia a instaurarsi rapidamente. Le madri che riportano situazioni di maternità critica descrivono spesso, per esempio, che dopo un iniziale periodo di generica “passività”, è accaduto qualcosa alla neonata: quello che chiamiamo il disturbo subclinico può consistere in alcuni casi in una tendenza al ritiro momentaneo dal seno (o dal biberon!) o in un altrettanto momentaneo rifiuto di poppare, in alcuni casi alternato a un mangiare allarmato che può essere percepito come “avido”: “Succhiava come se fosse l’ultimo pasto”.
Questo articolo si pone come una succinta, e necessariamente non esaustiva, esemplificazione di una proposta di riorganizzazione della psicopatologia, attualmente in elaborazione e recentemente in parte già illustrata, di cui è allo studio un’esposizione ben più ampia e compiuta.
Lo accenno qui perché con i colleghi di State of Mind e Studi Cognitivi è in avvio uno scambio di riflessioni sulla psicopatologia clinica, che riprende un filo lasciato sospeso dal convegno del 2000 su “Il futuro della psicoterapia”.
Lo farò utilizzando lo studio dei disturbi alimentari cui mi sono riferito nel precedente articolo “La maternità conflittuale” come un’occasione per accennare al modello psicopatologico cui faccio riferimento con i colleghi dell’A.R.P. Consapevole che questo “pretesto clinico” possa risultare un buon vettore per esemplificare alcuni concetti teorici e metodologici di quel modello, sono al contempo consapevole della mole di fattori ed elementi strutturali che dovrò inevitabilmente omettere o solo troppo brevemente accennare, in uno sforzo di sintesi che lascerà volutamente aperte molte tematiche.
Nel suddetto contributo su questa rivista illustravo come le testimonianze delle madri spesso forniscono elementi preziosi per la ricostruzione del sorgere e dell’instaurarsi dei DCA a partire dalle loro difficoltà affettive iniziali, con l’emergere di un sentimento di verità che permette e facilita l’individuazione degli sviluppi di quelle difficoltà nelle osservazioni cliniche delle pazienti.
Mi riservo in un prossimo intervento di descrivere come questo modello possa modificare l’approccio terapeutico ai DCA e le relative tecniche, ivi inclusa una differente teorizzazione dei fattori terapeutici, cui accennerò qui solo brevemente.
Rispetto ad altri modelli psicopatologici – tra cui quelli di orientamento fenomenologico, che hanno il pregio di descrivere molto accuratamente “disfunzioni” dell’apparato psichico come la disregolazione, i disturbi di mentalizzazione, i deficit metacognitivi o l’alessitimia – il metodo di lavoro clinico da me seguito insieme ai colleghi A.R.P. procede in una direzione opposta e per certi versi complementare.
Come ha acutamente affermato M. Lang, ci troviamo dinanzi a un fenomeno di “figura–sfondo”. Ci si può infatti porre il quesito opposto: come e da cosa è regolato il funzionamento, peraltro serrato e rigoroso, di queste pazienti, ivi comprese le profonde modificazioni della mentalizzazione riguardo al funzionamento del loro Sé?
Ciò vale per tutta la metodologia psicopatologica attualmente in atto, che prevede lo studio accurato di come gli stati affettivi elementari del Sé strutturino e organizzino, in molti casi secondo modalità estremamente rigide, le diverse modalità patologiche – incluse quelle relazionali – descrivendole secondo il loro processo evolutivo: “dall’interno” e non “dall’esterno”.
Le interviste anamnestiche con le madri di pazienti con DCA – a cui ho accennato nel mio precedente contributo, di cui questo scritto rappresenta un seguito e una parentesi – descrivono quadri di “maternità conflittuale” molto diversi tra loro.
Esse contengono però alcuni elementi pressoché invarianti, che dominano la scena nei primi mesi di vita e, come vedremo, persisteranno negli anni coinvolgendo madre e figlia, e che sono comuni a situazioni cliniche anche molto diverse. Mi limiterò qui a una descrizione concisa di questi elementi, “narrata” e non sistematizzata, tralasciando necessariamente complessità e diversità dei quadri psicopatologici osservabili nella clinica. Lo scopo è fornire una traccia, mi auguro chiara e comprensibile, di quanto può accadere nello strutturarsi dei sentimenti del sistema del Sé (6) comunemente alla base di questa particolare psicopatologia.
Alcuni di questi elementi divengono veri e propri assi portanti, “strutture” forti che si inseriscono nella più ampia e sfaccettata organizzazione del Sé delle pazienti, come una sorta di cuneo affettivo stabile che ne determina il decorso evolutivo. Ed è su queste strutture che si è organizzato l’apparato sintomatologico, con il suo rituale, che qui denomineremo apparato secondario.
Le tecniche di derivazione cognitivo-comportamentale, le più utilizzate nel trattare l’apparato sintomatologico secondario e ritualistico dei DCA, sono a mio avviso quelle che più hanno presente, e in modo particolarmente attento, tale apparato. Ritengo che gli elementi psicopatologici di base possano contribuire a fornire a tali tecniche maggiore profondità, spessore ed efficacia. Una modifica delle tecniche sulla base delle informazioni derivanti dalla psicopatologia del Sé è attualmente allo studio presso il Servizio DCA dell’A.R.P.
Ricostruendo, attraverso le descrizioni dalle madri, le intense situazioni emotive venutesi a creare nei primi mesi di vita delle loro bambine, è innanzitutto possibile rilevarne la continuità e la persistenza nelle diverse fasi della coppia madre-figlia, a partire dal ripudio conflittuale brevemente descritto nel precedente articolo, fino al quadro sintomatologico che giunge all’osservazione clinica.
È necessario ricordare che, poiché il neonato è fortemente, direttamente e fisicamente influenzabile dalle emozioni e dai sentimenti che l’ambiente di accudimento trasmette, questi rapidamente contribuiscono a dar forma all’incipiente funzionamento emotivo del suo Sé – emergente prima, nucleare poi – che molto presto entra, quindi, a far parte della relazione disturbata.
Poco dopo le prime settimane di vita compare comunemente nel neonato una rudimentale attività previsionale. Nelle situazioni più tranquille, infatti, l’attesa del cibo diventa più quieta man mano che una primitiva sicurezza che il cibo arriverà riduce progressivamente l’effetto della fame, inizialmente percepita come uno stimolo esplosivo; il sopraggiungere della sazietà placa progressivamente l’allarme dei primi giorni, in cui il piccolo non poteva ancora contare sull’esperienza di soddisfazione puntuale e costante del suo bisogno.
Sono questi i segnali dell’instaurarsi di una progressiva fiducia di base o, potremmo dire meglio oggi, di un sentimento più fiducioso dei vari aspetti del Sé (1), e del Sé con il mondo. Questo sentimento si basa sulla “previsione” e sulla memoria fisica della continuità tra gli stati di fame e quelli di sazietà, nonché dei vari aspetti del contatto con il mondo esterno che hanno luogo tramite l’accudimento.
Nei casi di maternità conflittuale, invece, il momento del pasto diventa – nei racconti delle mamme – un momento carico di tensione, temuto e disturbante, per la madre e per la figlia. Situazioni simili possono verificarsi in molte situazioni neonatali che hanno poi una loro risoluzione naturale che ne modifica il decorso, lasciando solo tracce più lievi.
Nei casi che evolveranno in DCA, invece, l’allarme descritto riguardo alla nutrizione e all’accudimento diviene specifico e persistente. Questa tensione di solito si attenua dopo lo svezzamento e nei periodi successivi ma continua – spesso sottotraccia, come un semplice cruccio – fino alla recrudescenza adolescenziale, quando l’allarme per l’ora del pasto sarà un sentimento dominante nell’esistenza della giovane paziente.
Nei casi di DCA infatti, anche per la piccola oltre che per la madre, questo tormento è inevitabile, inesorabile come il continuo ritorno della fame. E se non si è instaurata un’aspettativa fiduciosa e calma, ma al contrario vi è la previsione di una situazione disturbata e disturbante e di un contatto carico di tensione con la madre, anche l’attesa del cibo diviene inquieta: accompagnata da risvegli bruschi, allarmati dall’oscura percezione che sta insorgendo nuovamente lo stimolo della fame. In queste situazioni sia la fame sia il contatto divengono un disturbo e con essi si costituisce il sentimento iniziale del proprio corpo e della propria mente sempre in allerta.
La distorsione dello stimolo della fame inizia a instaurarsi rapidamente. Le madri che riportano situazioni di maternità critica descrivono spesso, per esempio, che dopo un iniziale periodo di generica “passività”, è accaduto qualcosa alla neonata: quello che chiamiamo il disturbo subclinico può consistere in alcuni casi in una tendenza al ritiro momentaneo dal seno (o dal biberon!) o in un altrettanto momentaneo rifiuto di poppare, in alcuni casi alternato a un mangiare allarmato che può essere percepito come “avido”: “Succhiava come se fosse l’ultimo pasto”.
Possiamo dire che “avido” corrisponde al fatto che sia la fame sia il contatto divengono un disturbo e una paura, da eliminare impazientemente, e che questo modo di sentire è comune a diverse “dipendenze”. Mangiare avidamente significa spesso, come succede anche in molti casi di disturbi alimentari differenti (2), che la fame va eliminata rapidamente, anziché essere una normale esperienza sensoriale, e ciò può valere per qualunque bisogno (3) e caratterizzare, anzi, un funzionamento più generale della mente riguardo ogni sua funzione.
Si può invece osservare, in situazioni in cui il clima emotivo iniziale tra madre e figlia è di fondo più “depresso”, che si instauri per un certo periodo nella piccola una sorta di neghittosità, un ritiro dolente o un addormentamento dopo poche poppate. “Sentiva che non ce la facevo a nutrirla” è un frequente commento di madri che hanno attraversato un periodo post partum caratterizzato da una deflessione dell’umore, in cui il loro profondo scoraggiamento e il ritiro dal mondo, talora addirittura con la paura/sensazione di poter morire o che la piccola potesse a sua volta non farcela, hanno pervaso in qualche modo anche il contatto con la figlia.
La necessità di nutrire può indurre il tentativo di forzare la piccola a mangiare e ciò può sia aumentare il ritiro, sia indurre un rifiuto della situazione disturbata.
Queste emozioni sono da tener presenti, perché faranno parte del corredo di sentimenti connessi al cibo e al Sé nelle epoche successive dello sviluppo.
Preferisco usare il termine generico di “disturbo” perché esprime l’insieme di quello stato, ma i sentimenti saranno differenti se prevarrà il fastidio, il disgusto, l’impazienza. Saranno queste qualità a connotare l’intonazione generale dello sfondo emotivo di ogni specifico caso.
Dobbiamo tenere presente che, poiché la situazione è dominata dalla lotta interiore della madre con il suo ripudio conflittuale essa, già sofferente, si ritrova con una ulteriore difficoltà: il disturbo subclinico infatti la farà sentire ancor più alle prese con una bambina difficile che si ritira, rifiuta o mangia avidamente per poi esprimere un rifiuto spazientito, non solo per il cibo ma anche nel contatto. Ciò finisce inevitabilmente per accrescere la propria difficoltà e contrarietà come madre, facendo aumentare l’impazienza e dando vita al fenomeno del tragico equivoco che coinvolge ulteriormente il Sé della piccola e quello della madre.
Lo sforzo di essere una madre efficiente introduce nel contatto con la bambina e con la nutrizione l’
iperattivazione (4) che già le è propria e che sarà sempre presente, caratterizzata dal dover rigidamente eliminare qualunque intoppo, sia pratico sia emotivo: come per esempio scacciare dalla mente, spesso rabbiosamente, sentimenti e pensieri disturbanti, un rito costante nella lotta al proprio “difetto”.
Grande peso, nel determinismo di tutte queste situazioni di crisi, ha il sistema familiare: la madre della madre, in primis, ma anche la suocera, l’atteggiamento del coniuge, l’ostilità o rivalità tra i figli. Ognuno di questi fattori ha una sua capacità di orientare, facilitare o disturbare, spesso attraverso sentenze come: “Non si può scegliere di non allattare al seno”, “Questa bambina è proprio incorreggibile, come la cugina” o “Te l’ho sempre detto che non avresti dovuto fare la madre”. La presenza di un marito anche solo silenziosamente critico o rassegnato all’irreparabilità della situazione, aggraverà notevolmente il clima. Il conflitto silenzioso all’interno della coppia potrà avere un particolare peso perché finirà per accentuare il conflitto madre-paziente, per esempio attraverso le future silenziose complicità tra padre e figlia.
Queste componenti emotive sono importantissime in quanto agiscono sempre nel mantenere un massiccio e pesante sentimento di immodificabilità della condizione di maternità difficile. Un altro elemento invariante nei DCA è infatti un più o meno profondo sentimento di ineluttabilità, in cui va inclusa l’affaccendata lotta perché tutto funzioni. Si riscontra spesso in questi quadri un pesante e misconosciuto fatalismo negativo, che rappresenta uno degli elementi costitutivi del convincimento di sottostare a un destino sovrastante (5), particolare che dominerà la scena familiare e il sistema del Sé della figlia.
La fase evolutiva della latenza è un periodo più oscuro, più nell’ombra dal punto di vista psicopatologico. È caratterizzato da vicende diverse, a seconda che vi siano fratelli e sorelle o che si creino situazioni di continuo confronto tra i membri della fratria o della famiglia allargata sulle varie qualità fisiche e psichiche.
La nostra bambina potrà essere lievemente, o decisamente, iperattiva e meticolosa, tenderà a sforzarsi di essere la più brava e diligente, ma al contempo potrà essere timida e silenziosamente in conflitto con la sorella, oltre che con la madre, riguardo al proprio Sé corporeo o alle prestazioni scolastiche.
Oppure, nel caso non infrequente in cui abbia indotto sin da neonata una più o meno evidente soggezione nella madre, tenderà a imporsi e a prevalere in modo incontrollato, pur attraversando comunque momenti di ritiro. Soffrirà anch’essa dei confronti con la sorella o con la madre, e svilupperà un contatto più polemico e un vissuto di costante “estraneità” e diversità, spesso cercando un rapporto particolare, esclusivo, con il padre. Il cibo sarà un problema presente ma attenuato, mentre l’aspetto corporeo rappresenterà sempre un cruccio, rinviato al futuro.
Il momento cruciale verrà con l’adolescenza emotiva, non necessariamente quella anagrafica, che avrà luogo quando la ragazza avvertirà una profonda trasformazione in sé.
Gli esseri umani esperiscono in adolescenza un inevitabile senso di momentaneo smarrimento, una particolare inquietudine fatta di eccitazione e paura, emozioni psichiche e fisiche, non pensate ma vissute intensamente: “Cosa sto diventando, in cosa mi sto trasformando?”, mentre escono dal bozzolo e salgono sul palcoscenico della vita, il mondo circostante.
Si tratta di una nuova edizione, dal punto di vista emotivo, del Sé emergente, con cui ha in comune insicurezza, indefinitezza e paura dovute alla forte qualità di trasformazione della fase in atto, alle porte di un futuro ignoto e di una inesorabile discontinuità, di fronte alla quale non c’è rimedio né possibilità di rallentamento o freno.
Nella paura e nell’eccitazione della mutazione, il cambio di pelle può essere carico di orgogliose conquiste e paurose incognite, accompagnato dalla carica di inevitabile esibizione di sé e dai tentativi di farsi valere, innanzitutto nella compagine dei coetanei e dei compagni di scuola.
L’inquietudine della nostra ragazzina sarà molto particolare. Mentre guarderà in avanti verso il palcoscenico come tutti gli adolescenti e tenderà dunque a cercare le vie di imporsi, definirsi, affermarsi, si farà vivo prepotente e con effetto inesorabilmente frenante una sorta di ingombrante cuneo nel Sé: quel complesso, organizzato e tormentoso modo di sentire e pensare che ha iniziato ad abbozzarsi nei primi mesi di vita e nella silente quiescenza della latenza, e che la fa ora percepire e muovere nel mondo come “diversa e con un differente destino”. Come tutti gli adolescenti “spierà” le proprie trasformazioni fisiche e il loro effetto sugli altri con un certo allarme.
Nel Sé emergente della neonata la sensazione sgradevole era diventata poi percezione sgradevole del corpo, e così accade ora. La percezione sgradevole diventa, attraverso l’attività immaginativa, anche rappresentazione, e la ragazzina può immaginarsi e vedersi orribile anche solo per un particolare “sbagliato” del proprio corpo, prevedendo lo sguardo sprezzante del mondo circostante.
La forte spinta della crescita e la sensazione della ineluttabile trasformazione in atto la porteranno a temere di essere oggetto di una orribile mutazione, comunque catastrofica e non voluta. Molto spesso comparirà il rimpianto malinconico (7) dell’epoca passata per sempre persa, a causa della trasformazione ineluttabile e per molti versi odiosa.
Il sentimento disturbato del cibo riappare, particolarmente intenso, amplificato dalle spinte della crescita e connesso alla paura dello sviluppo somatico. Quest’ultimo sarà immaginato anche in relazione alle figure di riferimento presenti in quel momento nella sua vita: la nonna, la compagna di banco, la vicina di casa obesa o al contrario una sorella magra e slanciata; l’inquietudine per la trasformazione in atto si manifesta con quella che la ragazzina definirà “paura di ingrassare”. Questa paura può essere connessa a esperienze come un leggero sovrappeso in fase preadolescenziale o alle prese in giro dei compagni di scuola, ma insorgerà anche in modo assolutamente indipendente, solo per il fatto che il corpo sta evolvendo per spinte proprie e incontrollabili nella sua trasformazione, anche se scatenata da qualche improvvido commento sul suo aspetto, a cui la ragazzina è ora attentissima.
Qui si inserisce una considerazione che i clinici non dovrebbero mai dimenticare: il timore della trasformazione si unisce a una percezione dello sviluppo del corpo dettati dalla paura, ma anche “ingenui”. Il corpo, un po’ estraneo, come è stato nei primi contatti con la madre, è percepito solo per il suo aspetto e non per le sue funzioni. Si tratta di un elemento importante, perché anche le teorie della ragazzina su come tentare di plasmarlo non terranno conto delle necessità dei suoi organi, cervello incluso. Proprio perché estraneo, il corpo diviene un’entità che sfugge al potere della mente, una delle attività del Sé a cui tutti i ragazzi si dedicano e si addestrano con particolare energia e dedizione, soprattutto nelle dispute familiari e con i coetanei, nel momento in cui il tentativo di superare la soggezione verso gli adulti farà loro agire prove di forza per cercare di fortificare il sentimento di padronanza di sé.
La nostra ragazzina, in questa condizione, guarda il proprio corpo infastidita e impaurita, vergognandosene, immaginando come dovrebbe essere ma soprattutto detestando come è e come può essere visto da un mondo esterno sempre critico e incontentabile. Così farà per tutto quanto la riguarda, compresa la propria mente e le proprie difficoltà.
Nelle interviste alle adolescenti con DCA è possibile riscontrare, rispetto al corpo come temo stia diventando, un repertorio di immaginazioni alternative su come dovrebbe invece essere, dal più semplice “Vorrei essere una ballerina che vola sulle punte” a “Il mio ideale è essere senza forme come una pertica” o addirittura “Ambisco a essere un puro spirito, e infatti penso che sarei più bella da morta”.
Non uso volutamente il termine “ideale di Sé” o “ideale dell’Io” perché questo modo di immaginare non è solo il frutto di “Vorrei essere come mia zia, alta e bella”, ma è strettamente connesso alla fobia del corpo che vedremo più avanti; la zia non è una pertica ma essere una pertica o un puro spirito, invece, può eliminare perfettamente e definitivamente tutti gli aspetti del corpo che possono evocare la fobia. Il cosiddetto ideale è prevalentemente l’espressione immaginativa di “Non dovrei avere questo corpo”, il che talvolta può coinvolgere l’identità di genere, quando nel ripudio è compreso il sentimento “non avresti dovuto essere femmina”.
La nostra ragazzina deciderà di stare attenta al cibo, magari di seguire una dieta, un ingenuo tentativo di fermare la pericolosa trasformazione in atto, di tenere a bada la paura e il profondo ma non riconosciuto disturbo del sentimento della fame: un obiettivo ben più ambizioso del semplice controllo del peso – e proprio da qui si instaurerà progressivamente un sistema organizzato.
L’ora del pasto diventerà presto il problema, l’incubo centrale della giornata, che occuperà con viva preoccupazione, e sin dal risveglio, la mente e la capacità di progettare, con la necessità di prevedere tutte le possibili implicazioni, compreso il tenere a bada l’impulso disturbato della fame.
L’attività previsionale è infatti profondamente alterata dalla situazione di allarme.
Già solo questo sentimento di allarme per l’ora del pasto ha una capacità invasiva che ho tradotto come prima componente del “cuneo nel Sé”: mentre mi occupo della vita di tutti i giorni, dei miei progetti per il futuro, del compito in classe o del ragazzino che mi piace, gran parte della mia mente ha a che fare con questa preoccupazione costante di cosa farò alla fatidica ora. E di cosa farà e dirà e penserà la mamma in proposito. È proprio questo allarme che organizza la necessità del rituale: come affronterò il momento fatidico, dove tutto può accadere.
Ciò che i cognitivisti denominano “rimuginio” è in effetti in parte frutto della preoccupazione allarmata e continua per l’ineliminabile problema da affrontare tutti i giorni con la forza della mente: il Sé si mette al lavoro con tutti gli strumenti di cui dispone, rabbia compresa. L’iperattivazione che caratterizza queste pazienti è simile a quella delle madri, che devono continuamente combattere per scacciare i pensieri e i sentimenti che le fanno sentire mamme cattive o inefficienti. Questo rigido rituale auto-educativo si ripete per tutti gli aspetti del Sé, sia fisici sia mentali, da correggere continuamente tramite l’attività eliminatoria, tanto da organizzare sovente specifiche modalità caratteriali, simili a quelle efficientistiche della madre.
L’iperattivazione finisce quindi per caratterizzare tutte le attività principali del lavoro del Sé, che è incessante e diventa un continuo tormento nell’estenuante tentativo di far sparire l’intero problema della fame, purtroppo ineliminabile, il che certamente sostiene e rafforza l’attività continua del rimuginare. Si organizza un apparato che tenta di esorcizzare e padroneggiare le paure, ancor più che solamente controllare il peso.
È per questo che la vera definizione di questo lavorio quotidiano è quella di un “apparato rituale”: il rito di organizzare il momento del pasto come un’assunzione padroneggiata e orgogliosa del cibo, attraente e pericoloso. Talvolta, come accade di osservare, è come un sacerdotale esorcismo del demone della fame nel corpo maledetto, che è entrato a far parte del destino speciale.
Altre volte il rito è invece, nelle pazienti più abbattute, un desolato tentativo mantenuto faticosamente in piedi con la forza della disperazione.
Si stabilizza quindi una paura generalizzata, connessa al timore della trasformazione, di vedersi mutare in “mostro”. Si creano due tipi di fobie: quella che comunemente chiamiamo dismorfofobia, per cui un singolo particolare o una parte del proprio aspetto suscita disgusto, fastidio o addirittura orrore e diventa indizio e prova di mostruosità. L’altra, misconosciuta, si struttura molto spesso come fobia del cibo. L’assunzione del cibo è di per sé pericolosa e l’atto incosciente di introdurlo in bocca può far diventare immediatamente una grande obesa deforme: tagliare un boccone in due parti è un rito per ridurre e padroneggiare il pericolo. Questa fobia è connessa appunto al sentimento di trasformazione: ogni volta che si manda giù un boccone si cede alla tentazione che esso impone, pericoloso e invasivo, e al rischio di divenire mostruosa che comporta il fatto di assumerlo.
Il mostruoso, nelle versioni più attenuate, può essere appunto l’esempio di una grande obesa o ciò che agli occhi della paziente appare tale: la nonna, la vicina di casa o la signora vista in televisione, ma può essere anche un’orribile visione, come per una giovane che si immaginava trasformata in un personaggio tipo “Elephant Man”.
La psicopatologia ci insegna, quindi, che ci faremmo fuorviare se accettassimo la versione proposta dalle pazienti sotto forma di “paura di ingrassare”: l’equivoco è tra ciò che intendiamo noi con questo termine e ciò che intendono loro. Solitamente è necessario tradurre la paura “di ingrassare” come paura di trasformazione mostruosa, per renderne davvero l’aspetto pauroso. A me accade di allargare le braccia in modo teatrale, a indicare che so bene che la paura di ingrassare sottende il terrore della trasformazione in un essere informe e mostruoso, come minimo appunto una grande obesa.
Il cibo, non ci si pensa mai abbastanza, può avere per gli esseri umani una vita propria, animistica, perché – da sempre grande tentazione – può esigere di essere mangiato se solo viene visto: è come una madre che si offre, che lo offre o che lo impone. È un sentimento molto diffuso, basta pensare ai gesti che si compiono per sottrarre alla propria vista un alimento che rappresenta una tentazione irresistibile.
Poiché l’ingestione del cibo è per noi umani ineliminabile, il rituale per queste ragazze (che, prese dalla loro iperstimolazione, aspirano a un funzionamento efficientemente disumano) può divenire – come frequentemente accade – il mettere in tavola una certa quantità di cibo e poi suddividerla in porzioni sempre più piccole per non diventare succubi della demoniaca tentazione e, con un sentimento di orgoglio crescente, esercitare con la forza della mente la capacità del proprio spirito, superiore alla materia, di reggere al supplizio quotidiano della fame.
Il rito, in questi quadri, è anche la messa in scena di sé e di quanto il momento del cibo sia, e sia sempre stato, drammatico.
La drammatizzazione può coinvolgere fortemente la vita familiare, per esempio con un frigorifero dedicato, un luogo apposito per i pasti, un orario diverso da quello degli altri membri della famiglia. La dimostrazione rituale ha spesso uno o più destinatari: la madre, innanzitutto, ma quasi sempre anche altri familiari. Il significato della dimostrazione si potrebbe tradurre in: “Condannata dal mio ineluttabile e speciale destino, dimostro a me stessa e agli altri di far di tutto per essere capace di padroneggiarlo, seguendo regole rigide e diverse da quelle che vorrebbe il sistema familiare, da cui mi sento incompresa e a cui non vado mai bene per come sono e per come mangio, da sempre”.
Inoltre il rituale, che può essere serratissimo e comprendere l’uso di lassativi e simili, rappresenta il lavoro continuo del Sé per liberarsi delle brutte sensazioni, purificarsi per scacciare il sentirsi fatta male, disgustosa e incapace di resistere alla fame.
Verso la madre sta ancora a significare: “Guarda come sono brava nel respingere la corruzione che tu vorresti indurmi facendomi mangiare”.
Tutto ciò avviene, se non c’è stato un chiarimento decisivo con la mamma, come conseguenza del tragico equivoco: l’apparato rituale diventa la prosecuzione del fatto che la figlia si sente da sempre un disturbo, e le modalità di intervento della madre vengono percepite come una critica continua, non sul rito ma sul proprio Sé: “Sei sbagliata”, e così il comportamento alimentare “speciale” oggetto di preoccupazione e critiche finisce per divenire un contrattacco e una sfida alle obiezioni della madre e della famiglia. Le connotazioni di “superiorità” dipendono dalla riuscita nel rito: “Mal considerata da te, conquisto la capacità di fare a meno del tuo cibo e della tentazione, scegliendolo invece io, in modo speciale”.
L’altro interlocutore, al di sopra di tutti, è spesso proprio il Destino: “È penoso come vivo, ma ho la speranza che prima o poi qualcosa cambi repentinamente e che il grande sforzo che faccio venga premiato”. Per questo il rituale ha anche una qualità che ho definito “sacerdotale”, e in questi casi è necessario tenere conto che oltre al Sé ci può essere un sistema di credenze “sovrannaturali”.
Ogni volta che mi trovo a trattare questo tipo di casi non posso fare a meno di pensare che i disturbi alimentari, spesso descritti come disregolazioni o comportamenti disorganizzati e autodistruttivi siano curiosamente proprio l’opposto di quanto risultano visti “da fuori”. La “regolazione” del funzionamento del Sé presente in queste pazienti è al contrario rigorosissima, innanzitutto ad opera dei sentimenti che abbiamo descritto e in secondo luogo dall’apparato rituale secondario. Il concetto stesso di “autodistruttività” appare spesso incomprensibile per alcune pazienti: arrivare a lasciar morire il proprio corpo è infatti, paradossalmente, l’estremo e disperato tentativo di salvare il proprio Sé dal corpo pericoloso e disturbante a cui la creatura, che ambirebbe a essere un puro spirito, si sente condannata e vincolata. Ciò può avvenire accedendo al sentimento di rinuncia, al cibo e al mondo, già sperimentato nei primi mesi di vita come un ritiro dal mondo disturbato e disturbante in cui si è sentita, e continua a sentirsi, un disturbo per la madre sofferente.
Questa descrizione è in stretta connessione con l’apparato di sentimenti descritti dalle madri nei primi contatti con la figlia, ma non solo: esse raccontano spesso, apparentemente senza operare collegamenti, come “Il cibo sia da sempre un problema: mia figlia, se ci penso, è sempre stata un problema per me, è stato un problema nutrirla allora e osservare come si nutre ora”, ma anche “Mia figlia ha sempre capito che ero in difficoltà” oppure “Ha sempre saputo che ero in difficoltà e mi ha continuamente accusata di non essere capace di reagire”.
Il decorso dell’apparato secondario è particolare e si seleziona nel tempo, in base ai diversi fattori in gioco.
Sul versante “ritiro dal cibo” e quindi anoressico, il cuneo nel Sé si può organizzare in modo stabile, con un equilibrio ai limiti della sopravvivenza ma, come si usa dire, “cronicizzato”, il che comporta che anche tutto l’apparato rituale ha trovato una sua efficienza: si è un po’ impoverito nelle sue manifestazioni, divenendo più discreto e mantenendo una convivenza con il Sé in cui è incuneato e che pervade per gran parte della giornata. L’impoverimento fisico e psichico può indurre però la sensazione di soggiacere a un destino irrimediabile a cui non si ha più energia per reagire.
Sull’altro versante, bulimico, l’efficienza eliminatoria e spesso “aziendale” può selezionare e spingere verso un equilibrio tra un approccio al cibo vorace e un’organizzazione sufficientemente stabile con un ricorso al vomito che, come pratica di vita ordinaria anche se spesso clandestina, acquisisce le caratteristiche della normale riservatezza attribuite alle pratiche corporee.
La classificazione di D. Westen dei DCA è a mio avviso utile in quanto fa tener presente la “forza” delle pazienti e quindi anche l’opportunità o meno di azioni farmacologiche, assistenziali o sostitutive. È però importante, dal punto di vista psicopatologico, avere in mente che la questione della forza è connessa a quella, già citata, del decorso: oltre alle situazioni di scompenso, che vedremo, va considerato che, man mano che la fase “trasformativa” si riduce, la paziente tende in qualche modo lentamente a stabilizzarsi. Questo passaggio avviene spesso con una progressiva “cronicizzazione”, un impoverimento e indebolimento fisico e psichico che, al pari dell’amenorrea, corrispondono a una ulteriore riduzione del livello dello stato di coscienza, tutti fattori che ostacolano fortemente l’attività psicoterapeutica. Questo dato, da sempre presente nella mente dei clinici come l’aggravamento da considerare sempre possibile, sembrerebbe essere confermato anche da recenti dati di neuroimaging.
Per quanto riguarda lo scompenso, vi sono alcune situazioni che richiedono molta attenzione. Una frequente causa di scompenso è la rottura del rapporto madre-figlia, spesso determinata dall’esasperazione della madre che, per motivi diversi (inclusi certi interventi terapeutici “emancipativi”!) esprime a suo modo l’esigenza di disfarsi della figlia, in quanto irrisolvibile ed esasperante disturbo. È una situazione molto critica, che va nella direzione contraria alla possibilità di sanare, quando possibile, il conflitto tra le due. La rottura, infatti, rischia di mantenere e decretare come definitivo il sentimento di incurabilità: “Per me non c’è niente da fare”.
L’altra causa di scompenso pone una questione non solo diagnostica sulle caratteristiche del tipo di disturbo. Si tratta infatti di casi in cui si assiste a un “impazzimento del rituale”, certamente collegato all’influenza di elementi esterni, ma anche determinato da un particolare tipo di psicopatologia che va considerato e differenziato:
- Nelle situazioni bulimiche il lavoro del Sé tenta di mettere in atto una condotta che viene comunemente definita restrittiva: il tentativo di reprimere l’impulso distorto della fame. Questo tentativo sfocia regolarmente in un’abbuffata, e la clinica dimostra che questo avviene perché la restrizione ripropone un fastidioso insieme di sentimenti di ripudio, castigo, deprivazione, miseria, paura e rabbia, non essendo invece accessibile a queste pazienti – come ho spiegato nel mio precedente contributo su questa rivista – il ritiro e la conseguente rinuncia. Tutto ciò è solo in parte simile a quanto accade ai cosiddetti binge eaters. Nelle pazienti bulimiche l’abbuffata è prevalentemente seguita dal vomito, per il già citato “disturbo della sazietà”, mentre ciò non accade nei casi di binge eating.
- Nelle pazienti anoressiche, come ho già detto, la regolazione stabilizzata tra la rinuncia cronica al cibo (attraverso la possibilità di accedere allo stato di ritiro “ascetico” dalla fame e dal corpo sperimentata nelle prime settimane di vita) e la necessità di sopravvivenza può trovare un equilibrio cronicizzato, a livelli differenti di sofferenza somatica, che può mantenersi per molti anni.
- Accanto ai casi che alternano fasi diverse, prevalentemente bulimiche o prevalentemente anoressiche, vi sono pazienti che possono, in determinate fasi della propria esistenza, presentare un altro disturbo, che potremmo definire “misto”. In questi quadri si susseguono invece in tempi brevissimi (addirittura più volte nel corso della stessa giornata) momenti anoressici e momenti bulimici: la paziente cerca di attingere al sentimento anoressico di rinuncia al cibo ma poi finisce per scivolare nello stato opposto dell’attacco di fame e del tentativo restrittivo, cioè di rifiuto attivo del cibo malgrado il senso di fame. Quest’ultimo genera inevitabilmente l’attivazione della paura “da ultimo pasto” e quindi spesso un ulteriore terribile attacco di fame, che fa sì che il rito venga concluso in modo liberatorio ribellandosi alla restrizione e mangiando spropositatamente, per poi avvilirsi profondamente di fronte al proprio drammatico fallimento. Quest’alternanza scomposta caratteristica dei quadri misti, che può generare un vero e proprio impazzimento del rituale, contraddistingue i casi con momenti di crisi più drammatici, e andrebbe tenuta ben presente. Il fallimento della strategia fisica e mentale tipica di questi casi fa esasperare e spaventare ulteriormente le pazienti, che entrano in uno stato disorientato e famelico, con improvvisi aumenti di peso e conseguente panico, o al contrario con dimagrimenti critici conseguenti all’esasperazione delle condotte eliminatorie, che possono determinare la necessità di ricovero in reparti specializzati.
È importante poi, sempre a proposito di decorso, tener presente un altro tipo di crisi, che rischia di essere un motivo di fallimento anche nei trattamenti più riusciti: il colpo di coda inaspettato.
Tale “agguato” psichico può sorprendere improvvisamente in qualunque momento ed è una modalità nota, che caratterizza molte delle interruzioni nei casi di pazienti pluritrattate. Mi riferisco però in questo caso a una situazione più imprevedibile. La paziente alimentare, da tempo uscita, spontaneamente o in seguito a un trattamento idoneo, dalla situazione serrata del disturbo alimentare e dal suo più intenso corredo sintomatologico, dinanzi a nuove tappe dell’esistenza può sentire nuovamente comparire, senza riconoscerlo, un sentimento di crollo ineluttabile: “Tanto per me, geneticamente alterata e condannata dal destino, non c’è niente da fare”: si possono riattivare sentimenti che sembravano superati, come l’incapacità di vivere o l’indegnità per il proprio danno ontologico.
È necessario saper riconoscere questa situazione, perché rappresenta il riemergere di quella parte del disturbo del sentimento di Sé che ricompare anche senza il corredo sintomatologico più corporeo. L’esperienza insegna che è importante per il clinico non solo riconoscerlo ma sapere che non andrebbe mai dimenticato, per non lasciar travolgere dalla crisi un momento evolutivo oppure, qualora avvenga durante una psicoterapia, perché un trattamento riuscito non si traduca in un fallimento catastrofico.
Insisto su questo punto perché riguarda il sentimento di fondo su cui tutto si muove, anche i trattamenti, e rappresenta un nodo centrale. La tendenza all’immodificabilità dei quadri clinici è infatti spesso la spia di una caratteristica di fondo, per certi versi “rassegnata”. Il Sé non è affatto in grado di riconoscere un “attaccamento invischiante”: sa solo che il sentimento di fastidio, di estraneità, di ripudio sono sensazioni reali, che prova da sempre, e proprio questa persistenza finisce per trasformarle rapidamente in percezione stabile e quindi in percezione di Sé, senza alcuna possibilità di collegarle al ricordo del sentimento di ripudio.
Semmai, nel tragico equivoco, si instaura una continua polemica con la madre riguardo alla sua incapacità di comprendere la difficoltà in cui la ragazza si trova e le complesse esigenze che ne derivano, così come la madre in difficoltà finisce per attivarsi ulteriormente, ma anche per scontrarsi con un continuo senso di fallimento e con l’esasperazione di non uscire dal suo tormento, provando sempre più insofferenza per la situazione e per la figlia.
Ci vuole poco perché, con la memoria fisica del fastidio, il corpo estraneo e fastidioso venga non solo percepito ma anche pensato e rappresentato come un vero e proprio disturbo, con caratteristiche che possiamo definire “ontologiche”, o genetiche. Ci vuole poco perché il sentirsi diversa dalla compagna di banco o dalla sorella, unito alla relazione “particolare” con la madre, confermino il convincimento di essere inserita in un destino speciale, qualunque ne sia la qualità e la causa: per esempio essere una persona con particolari doti spirituali e ascetiche che aspira orgogliosamente a liberarsi delle miserie del corpo e del mondo circostante. Per inciso, è proprio questa ritualità orgogliosa e spesso un po’ diabolica che può creare il denominatore comune delle “sette di culto anoressico” che a più riprese si diffondono sul web.
Nell’organizzazione del modo di sentire di queste pazienti ciò che viene descritto come alessitimia – un deficit di mentalizzazione delle emozioni – oltre che, come spesso accade, essere connesso alla persistente traduzione somatica delle stesse, trova una ragion d’essere specifica: quell’emozione non è infatti riconoscibile come tale perché non è esperita come un sentimento ma come un dato di fatto.
Queste pazienti non sperimentano “mi sento un mostro” ma lo “sono”: non si tratta, nel loro vissuto, di un sentimento di ineluttabilità ma di una realtà ineluttabilmente immodificabile. Il sentimento del Sé che diventa percezione sta a significare che la memoria dell’emozione è divenuta reale e fisica. Questo aspetto rappresenta uno degli ostacoli più seri nel trattamento di questi quadri. Esso determina la perplessa sufficienza e la compiacenza benevola con cui le “spiegazioni” dei dottori vengono spesso accolte, che a sua volta inducono nel clinico la sensazione di una sorta di ideazione delirante.
Avere in mente questo livello di funzionamento ha evidentemente una notevole rilevanza per chi si accinge a curare una fanciulla con questi sentimenti e convincimenti di fondo, che divengono sempre più vere e proprie certezze in grado di tarpare sia le prospettive evolutive sia, conseguentemente, quelle terapeutiche.
Il sentimento di fondo relativo al Sé – “Sono fatta così” o “Questo è il mio destino” – si è nel corso del tempo rafforzato, con un conseguente profondo scoraggiamento, a seguito del fallimento dei tentativi spontanei di modificazione. Lo specchio continua a riflettere il mostro malgrado le diete e i rituali, tutto resta immutato, compresa la persistente conflittualità con la madre, latente o palese. L’incredulità rispetto alle proposte terapeutiche può quindi essere del tutto comprensibile.
Lo scacco degli interventi terapeutici può avvenire però anche per un’altra serie di motivi.
L’intervento del clinico viene spesso sentito come “Sei l’ennesimo che mi dice che non vado bene malgrado tutti gli sforzi che faccio”. La sensazione che il rituale del cibo venga toccato e l’attivarsi della sindrome delle mani nel piatto sono un tutt’uno: rappresenta una rievocazione dei tentativi maldestri, critici e disturbanti dei familiari ed è una delle più frequenti cause di rottura precoce, come ho già accennato, anche solo in fase di prenotazione telefonica.
Va inoltre a finire sul sentimento pervasivo: “Tanto per me non c’è niente da fare e io, che per un attimo mi sono illusa di farcela, posso solo ritirarmi e attaccare il telefono o interrompere la consultazione”.
Un’altra componente di questa sfiducia generale nei trattamenti e nella modificabilità della propria condizione è la magia dell’umore, del rito e del destino: nell’esperienza di molte di queste pazienti c’è una certa sotterranea propensione a sperare che in fondo tutto il tormento a cui si sottopongono con notevole tenacia avrà infine come premio un improvviso sollievo, che peraltro conoscono perché già sperimentato. Accade infatti a volte che, dopo un lungo periodo di accanita resistenza nel dividere le carote e mangiarne solo metà, qualcosa cambi improvvisamente nella loro esistenza. Ciò può apparentemente accadere per qualche fortuito evento esterno come la comparsa di un nuovo fidanzato o anche solo di un presunto pretendente. Il repentino e inaspettato cambio di umore viene interpretato come un esaurimento definitivo della sofferenza e della contrizione, con un viraggio per cui improvvisamente sparisce – del tutto momentaneamente, ma al momento la paziente non può saperlo – il sentimento di fastidio e di disturbo del corpo e del cibo, creando il sentimento di un nuovo, piacevole e felice equilibrio. Il segreto pensiero diventa allora che la vera cura sia perseguire questo cambiamento “magico” che è il prodotto della propria tenace via di cura tramite il rito, anziché le noiose sedute con i dottori da cui per giunta la paziente può sentirsi incompresa e a cui si deve dedicare come un compito in più tra i tanti che già pesano sulla sua esistenza.
È in quest’area che si inserisce la questione del trattamento farmacologico antidepressivo molto frequentato dai colleghi e dalle pazienti. A tal proposito mi sento di segnalare, sempre per proseguire nella disamina degli aspetti psicopatologici, un aspetto rischioso, caratteristico del trattamento farmacologico di varie condizioni adolescenziali: infatti la condotta eliminatoria può costituire la base di una “
suicidarietà strutturale”, la tendenza a eliminare ogni parte di sé ritenuta estranea e indegna per salvare il
sé incorrotto. Lo psicofarmacologo deve saper utilizzare una particolare accortezza affinché l’antidepressivo non dia energia proprio a questa componente, con l’effetto più volte descritto del paziente che si uccide perché sta meglio.
Tutto l’aspetto “rassegnato” di fondo può, quindi, avere un suo notevole peso nelle capacità evolutive, perché può corrispondere ad alcune precise alterazioni funzionali.
Mi riferisco, per esempio, a ciò che accade con alcune delle tecniche, comprese quelle cognitive che, correttamente, mirano all’esplorazione delle paure di queste pazienti: esplorare le paure significa indurre e aiutare la paziente ad utilizzare le sue capacità immaginative. Posso individuare tre difficoltà nell’utilizzo di questo importante approccio, potenzialmente fortemente modificatorio:
- La prima, più generale, è che il sistema del Sé di queste pazienti è ingabbiato nel suo modo di sentire e ciò corrisponde a un massiccio slivellamento verso il basso dello stato generale di coscienza e comporta una ridotta capacità immaginativa proprio nel campo delle paure, oltre che rappresentare la causa del frequente impoverimento generale.
- La seconda è che esse descrivono le paure con le parole che conoscono e che hanno il più delle volte un diverso significato, come ho accennato a proposito dell’ingrassare.
- La terza è che l’iperattività e l’ipervigilanza, come sempre, comportano di fatto un notevole restringimento del campo di coscienza, che finisce per farle esprimere solo nel territorio della preoccupazione prevalente, di cui ripetono con un particolare accanimento le definizioni e i contenuti a cui l’allarme è destinato. L’accanimento è infatti espressione dell’uso della forza della mente e della rabbia contro il contenuto che non dovrebbe esserci, oggetto della fobia, e proprio questa intenzione eliminatoria mantiene la paziente ancorata al percetto disturbante, contribuendo al persistere del rimuginio. Ciò può impedire di ampliare il suo campo cognitivo per esplorare punti di vista diversi o altri aspetti dello stesso problema, e finisce per determinare una rigidità di pensiero spesso molto tenace e strutturare una frequente caratterialità di difficile maneggiamento.
È evidente che lo “spessore” dell’intervento terapeutico può essere diverso avendo in mente l’apparato del Sé che si è costruito in quella determinata paziente, in quanto con le diverse tecniche si può lavorare e far lavorare la paziente in una direzione condivisa e più aderente al suo mondo.
Ma la conseguenza più immediata per il clinico è che riconoscere la struttura e la profondità del disturbo può permettere, mentre si esplora una paura, di non banalizzarla involontariamente, con il rischio che la paziente si senta incompresa. È invece di fondamentale importanza assicurarsi di riservare alle paure emerse e al rigido funzionamento rituale il giusto spazio e riconoscimento, al fine di riuscire ad aiutare queste pazienti a esplorare i loro timori e i sentimenti connessi.
L’altro rischio, più frequente, è che queste pazienti, diligenti, mostrino di aver capito e superato la difficoltà o la fobia, per poi ritrovarcisi da sole, finendo nel peggiore sconforto.
Nel trattare pazienti con DCA, inoltre, va sempre tenuto presente l’aspetto del sentimento di estraneità del corpo, che richiede grande attenzione e una cura specifica; se sottovalutato, rischia al contrario di evolvere in situazioni fisiche che andranno a rafforzare il senso di ineluttabilità descritto.
Ciò che ritengo importante, soprattutto, è che dovremmo saper sfruttare l’insegnamento che deriva dall’intervento più semplice e diretto: quello con le madri.
È proprio dalla comprensione degli elementi potenzialmente mutativi in ogni quadro sintomatologico che possiamo infatti trarre indicazioni preziose sulle linee fondamentali da seguire per orientare le tecniche di trattamento, anche nei casi in cui non sia stato possibile l’intervento congiunto.
Tornando allo scopo di questo articolo, ho scelto di utilizzare i DCA come una possibile occasione per illustrare un ripensamento sulla psicopatologia. Ritengo infatti che la psicopatologia possa oggi essere riconcettualizzata a partire dall’individuazione di riconoscibili organizzazioni affettive elementari alla base dei vari disturbi, a partire da quelle del Sé. Il sentimento di verità derivante dalle testimonianze delle madri permette in questo caso di uscire dalla macchinosità della psicopatologia teorica e scendere, molto più direttamente ed efficacemente, sul terreno delle emozioni e del loro effetto.
L’esperienza mostra che il pensiero clinico può divenire più utile per il paziente, e questa può essere la via dell’efficacia clinica, se gli permette di riappropriarsi di quanto gli accade davvero, e del lavoro del suo Sé. Rimanere, invece, ancorati alla rilevazione di un deficit, con pazienti come queste, non fa che aumentare il rischio di confermare la loro percezione di immodificabilità.
ARGOMENTI CORRELATI:
ARTICOLO CONSIGLIATO:
Note:
(1) Come ho avuto modo di affermare nel Seminario Psicopatologia oggi del 16 novembre 2013, il costrutto “fiducia di base” può essere più efficacemente sostituito da quello unitario di “sentimento del Sé più o meno fiducioso”, anziché costituire un’entità a parte.
(2) Come i binge eaters
(3) Ha a che fare per esempio con la comorbilità con l’acquisto compulsivo, la cleptomania, la promiscuità.
(4) Si tratta di uno dei numerosi temi che meriterebbe una trattazione ben più ampia e approfondita. Caratteristica precocemente acquisita e in grado di organizzare massicciamente l’intero funzionamento del Sé, l’iperstimolazione rappresenta un concetto fondamentale all’interno del modello che mi sto limitando ad accennare in questa sede ed è del resto individuabile, in modo trasversale, in un ampio spettro di casistiche psicopatologiche.
(5) Al pari dell’iperstimolazione, anche il sentimento di dover ineluttabilmente sottostare a un Destino sovrastante rappresenta un elemento centrale del modello, rintracciabile in quadri sintomatologici anche molto diversi tra loro, e che per questo meriterebbe una trattazione a se stante.
(6) Nel modello di riorganizzazione della psicopatologia cui mi riferisco, il “sistema del Sé” indica il fatto che con molti pazienti può essere ingannevole pensare solo al Sé, omettendo come stanno nel mondo. Infatti in alcune persone può esservi un aspetto strutturale da considerare: il fatto di sentirsi governati dall’alto da entità come il Destino, il Fato, i pianeti, la Sfortuna, in modo non “collaterale” come nelle comuni superstizioni, ma come sentimento stabile e continuo. Una vera e propria struttura, in quanto sentimento/percezione/rappresentazione persistente, che il clinico deve necessariamente saper rilevare e tenere in giusta considerazione. Molti fenomeni psicopatologici possono risultare incomprensibili, incluse alcune gravi situazioni di sfiducia nei trattamenti psicoterapeutici, motivate dal convincimento e il conseguente sentimento che “Contro il mio destino nulla si può fare”.
(7) Le innumerevoli tonalità malinconiche rappresentano un altro grande capitolo del modello a cui mi riferisco, capaci di organizzare il funzionamento del Sé, e per questo meritorie di una trattazione ben più approfondita di quella presente.
BIBLIOGRAFIA:
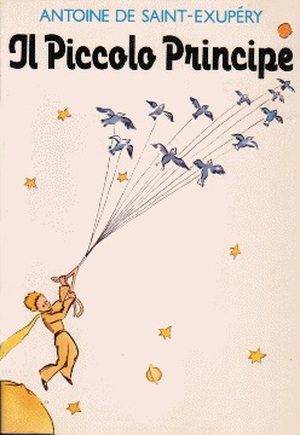 “Il Piccolo Principe” è un piccolo e magico trattato di psicologia umana, di sentimenti delicati, un viaggio in forma di favola attraverso una realtà immaginaria e più vera del reale, fra i sentieri dell’irrazionale amore per la vita.
“Il Piccolo Principe” è un piccolo e magico trattato di psicologia umana, di sentimenti delicati, un viaggio in forma di favola attraverso una realtà immaginaria e più vera del reale, fra i sentieri dell’irrazionale amore per la vita.


 La stragrande maggioranza degli esperti dà per scontato che la strategia ottimale o obbligata sia quella di incontrare per la prima volta l’adolescente non richiedente e non collaborante da solo.
La stragrande maggioranza degli esperti dà per scontato che la strategia ottimale o obbligata sia quella di incontrare per la prima volta l’adolescente non richiedente e non collaborante da solo.

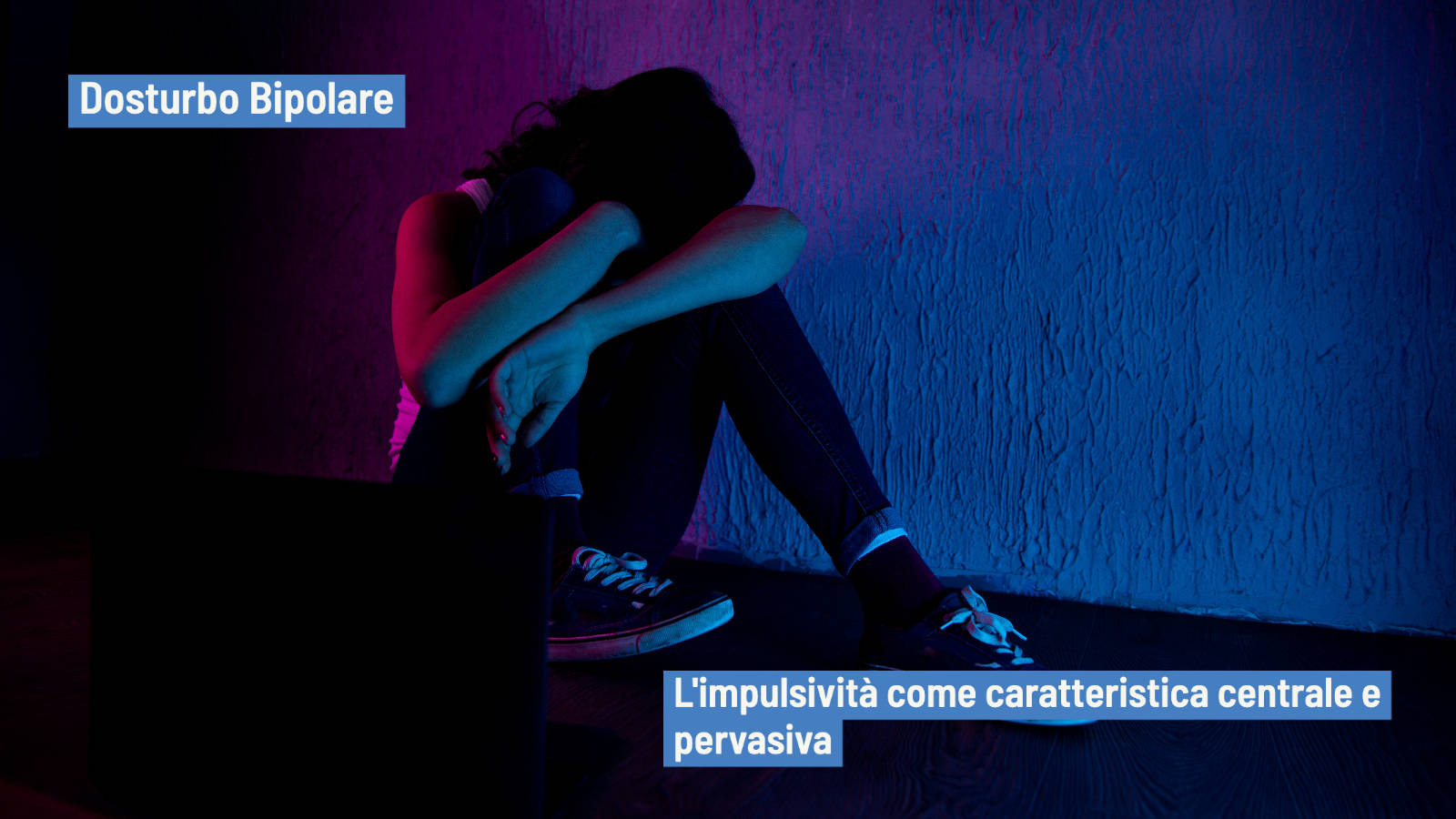



















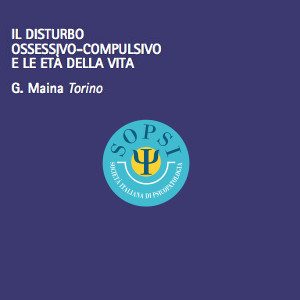 La descrizione classica del
La descrizione classica del 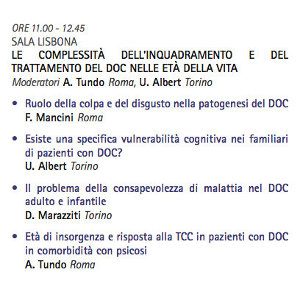


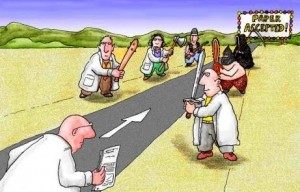 La pubblicazione dei giudizi pronunciati nelle procedure di abilitazione nazionale, che decide sulla possibilità di diventare professore associato ed ordinario nell’università italiane, ha suscitato molte critiche e proteste.
La pubblicazione dei giudizi pronunciati nelle procedure di abilitazione nazionale, che decide sulla possibilità di diventare professore associato ed ordinario nell’università italiane, ha suscitato molte critiche e proteste. Adozioni: uno dei momenti nei quali tradizionalmente la persona adottata sente il bisogno di reperire informazioni sulla famiglia biologica è l’adolescenza , fase nella quale la costruzione della propria identità spinge i ragazzi a raccogliere i pezzi della loro storia (anche quelli perduti) per integrare le informazioni in un immagine di sé coerente.
Adozioni: uno dei momenti nei quali tradizionalmente la persona adottata sente il bisogno di reperire informazioni sulla famiglia biologica è l’adolescenza , fase nella quale la costruzione della propria identità spinge i ragazzi a raccogliere i pezzi della loro storia (anche quelli perduti) per integrare le informazioni in un immagine di sé coerente.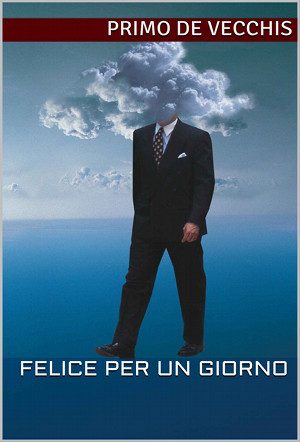
 La distorsione dello stimolo della fame inizia a instaurarsi rapidamente. Le madri che riportano situazioni di maternità critica descrivono spesso, per esempio, che dopo un iniziale periodo di generica “passività”, è accaduto qualcosa alla neonata: quello che chiamiamo il disturbo subclinico può consistere in alcuni casi in una tendenza al ritiro momentaneo dal seno (o dal biberon!) o in un altrettanto momentaneo rifiuto di poppare, in alcuni casi alternato a un mangiare allarmato che può essere percepito come “avido”: “Succhiava come se fosse l’ultimo pasto”.
La distorsione dello stimolo della fame inizia a instaurarsi rapidamente. Le madri che riportano situazioni di maternità critica descrivono spesso, per esempio, che dopo un iniziale periodo di generica “passività”, è accaduto qualcosa alla neonata: quello che chiamiamo il disturbo subclinico può consistere in alcuni casi in una tendenza al ritiro momentaneo dal seno (o dal biberon!) o in un altrettanto momentaneo rifiuto di poppare, in alcuni casi alternato a un mangiare allarmato che può essere percepito come “avido”: “Succhiava come se fosse l’ultimo pasto”. 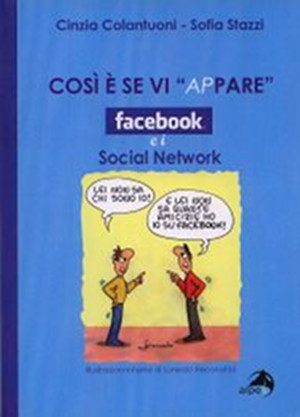
 Rimane così un mirabile romanzo sulla famiglia, sull’amore, sulla perdita e sulla bellezza. E anche sui legami di attaccamento, in tutte le sfumature concepibili, declinati mirabilmente da una penna profana. Delle pagine che meritano di essere tenute strette.
Rimane così un mirabile romanzo sulla famiglia, sull’amore, sulla perdita e sulla bellezza. E anche sui legami di attaccamento, in tutte le sfumature concepibili, declinati mirabilmente da una penna profana. Delle pagine che meritano di essere tenute strette.