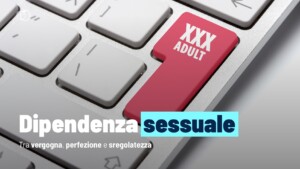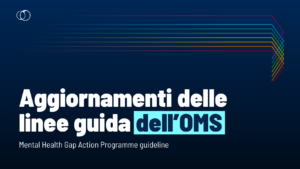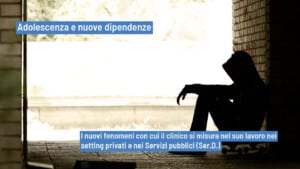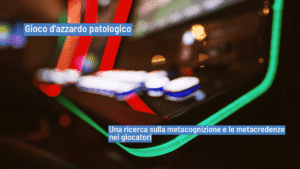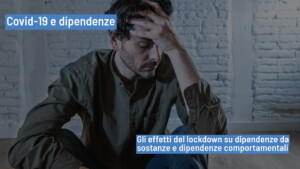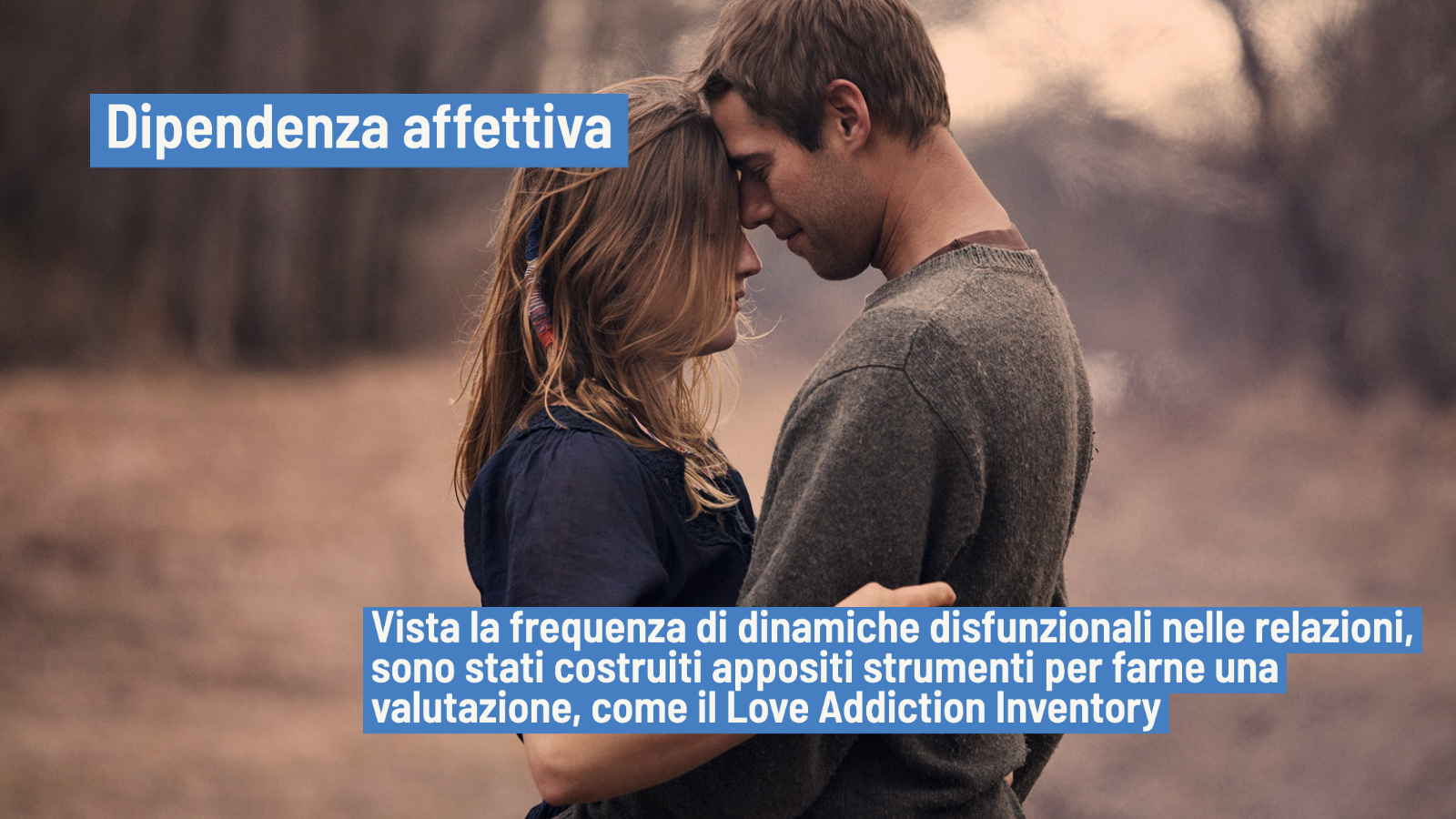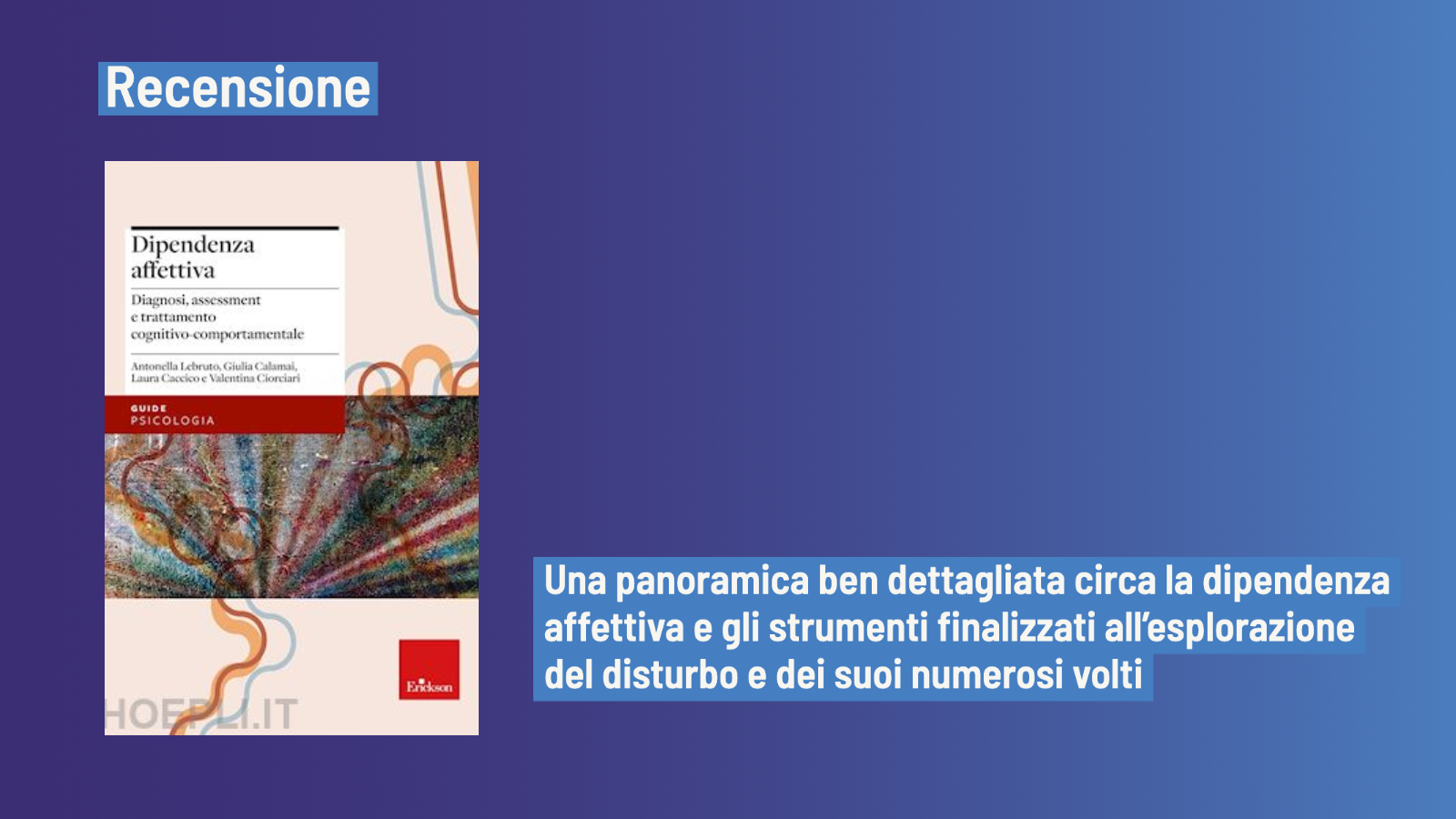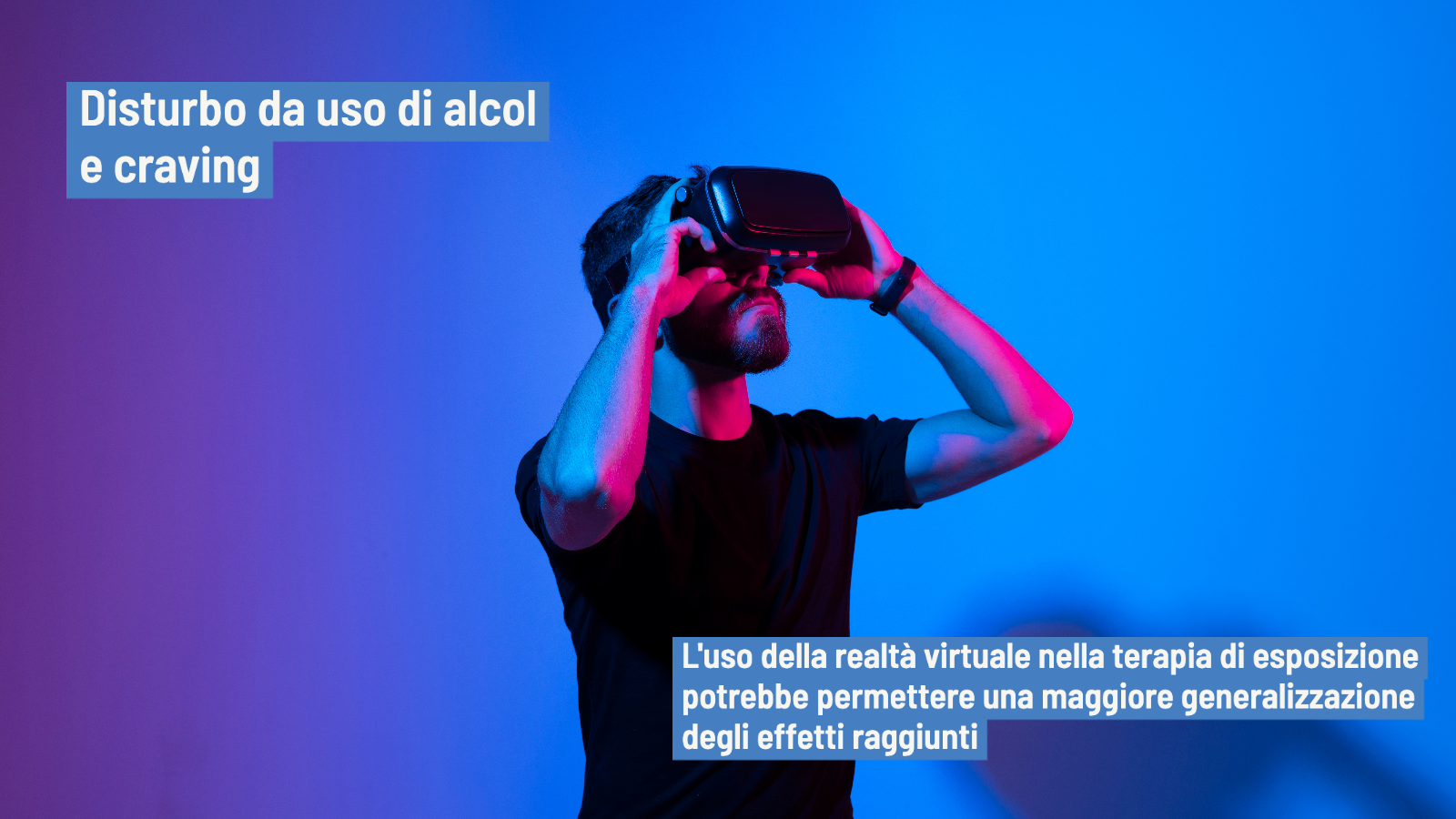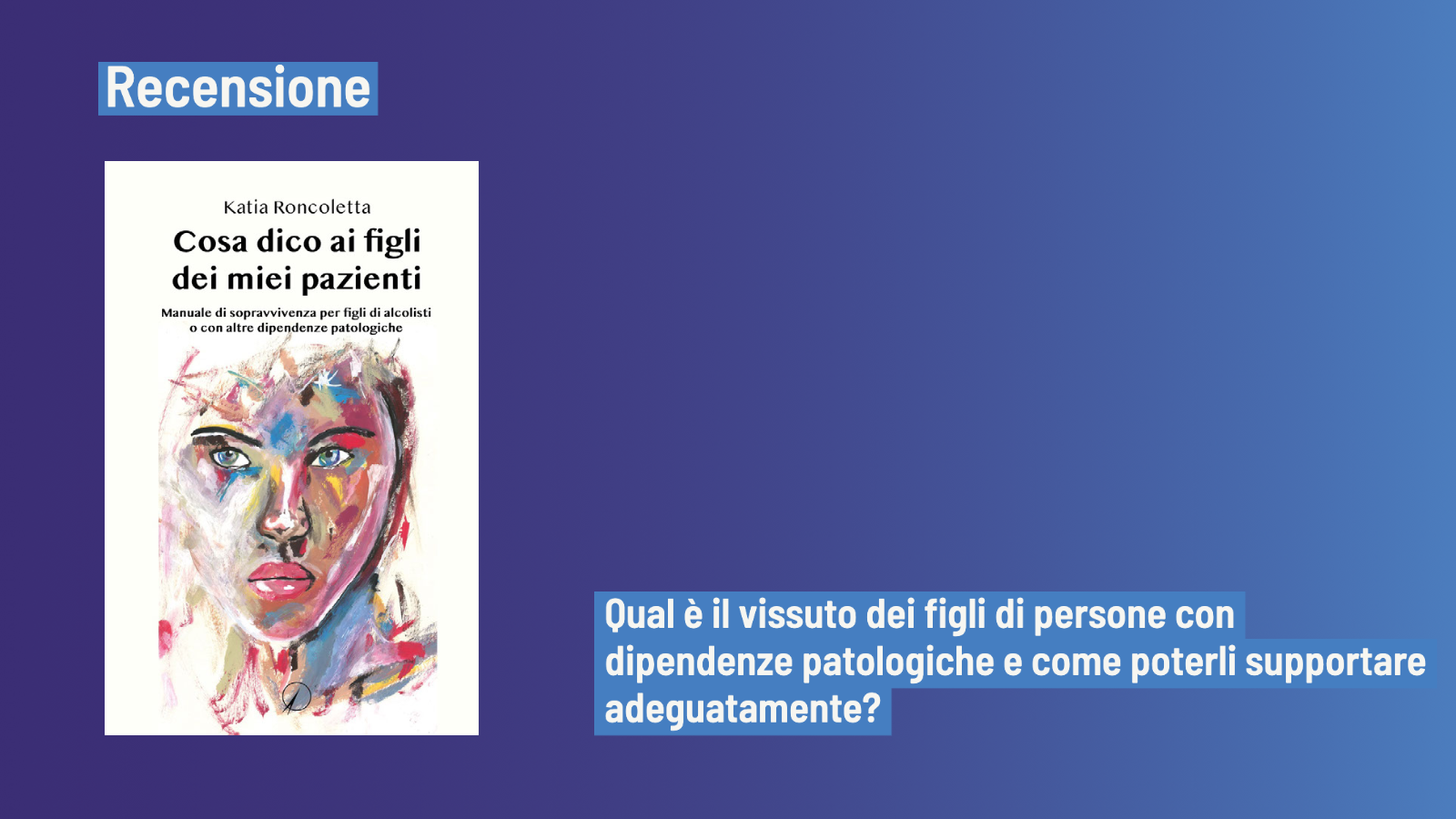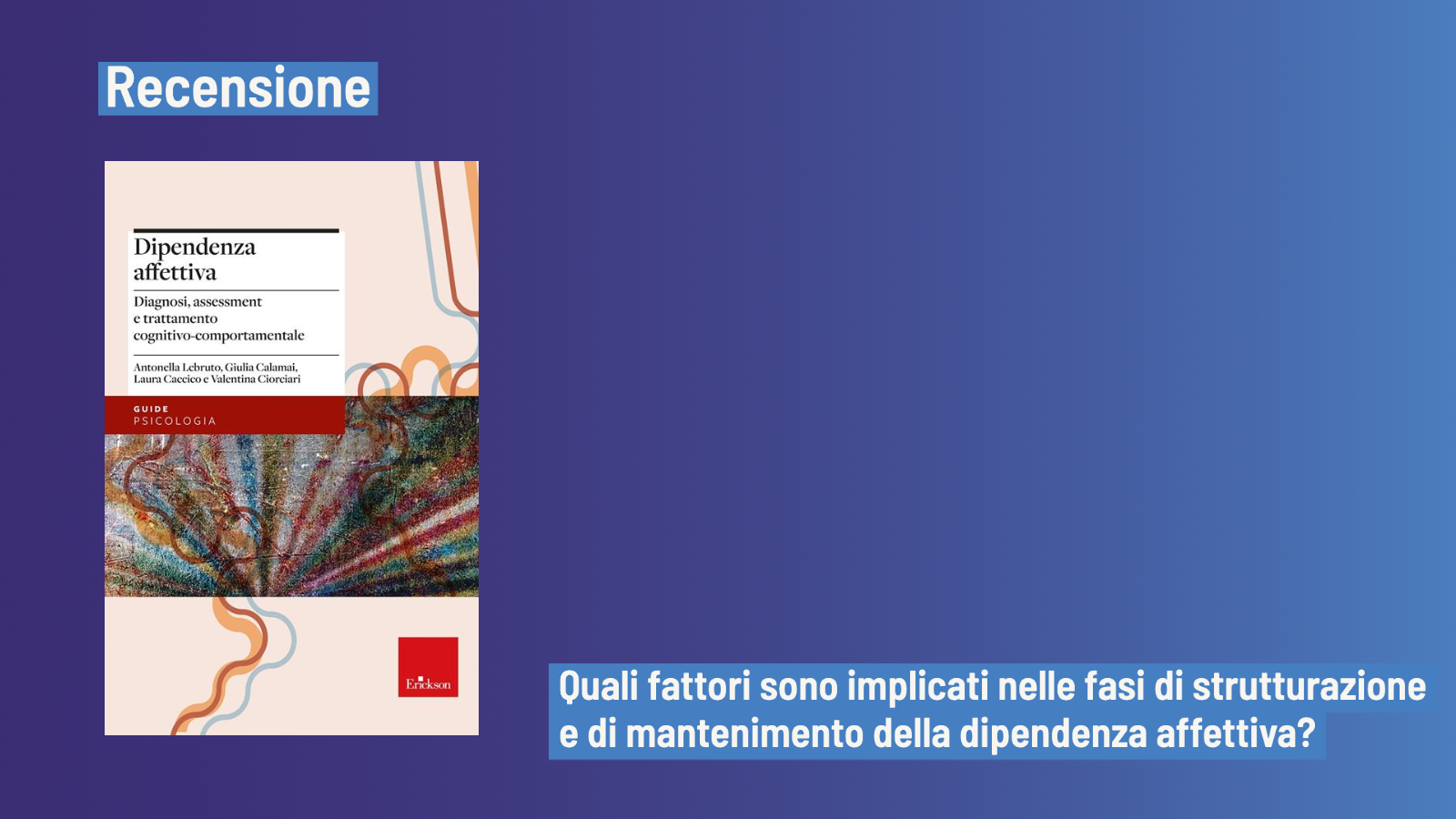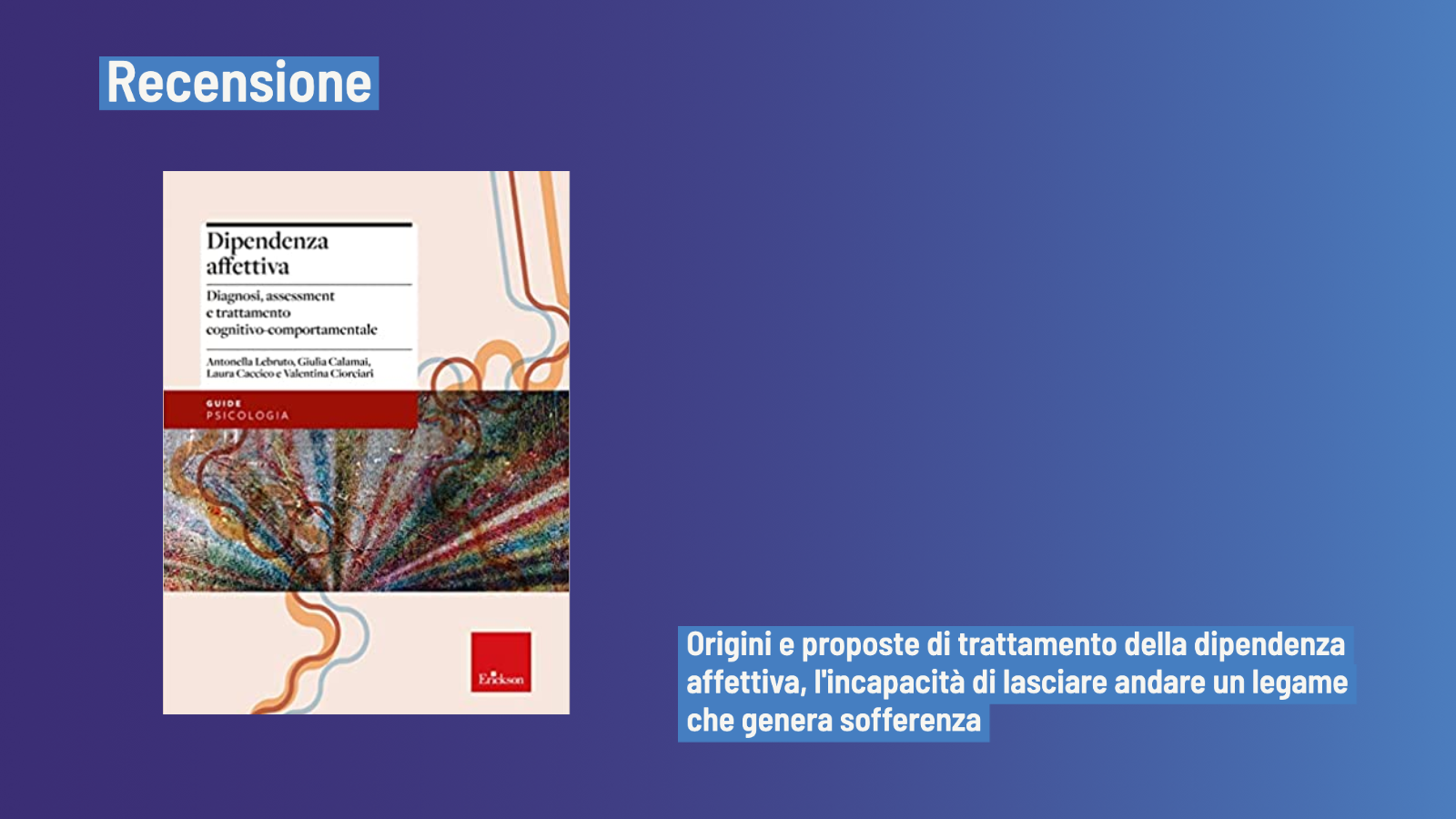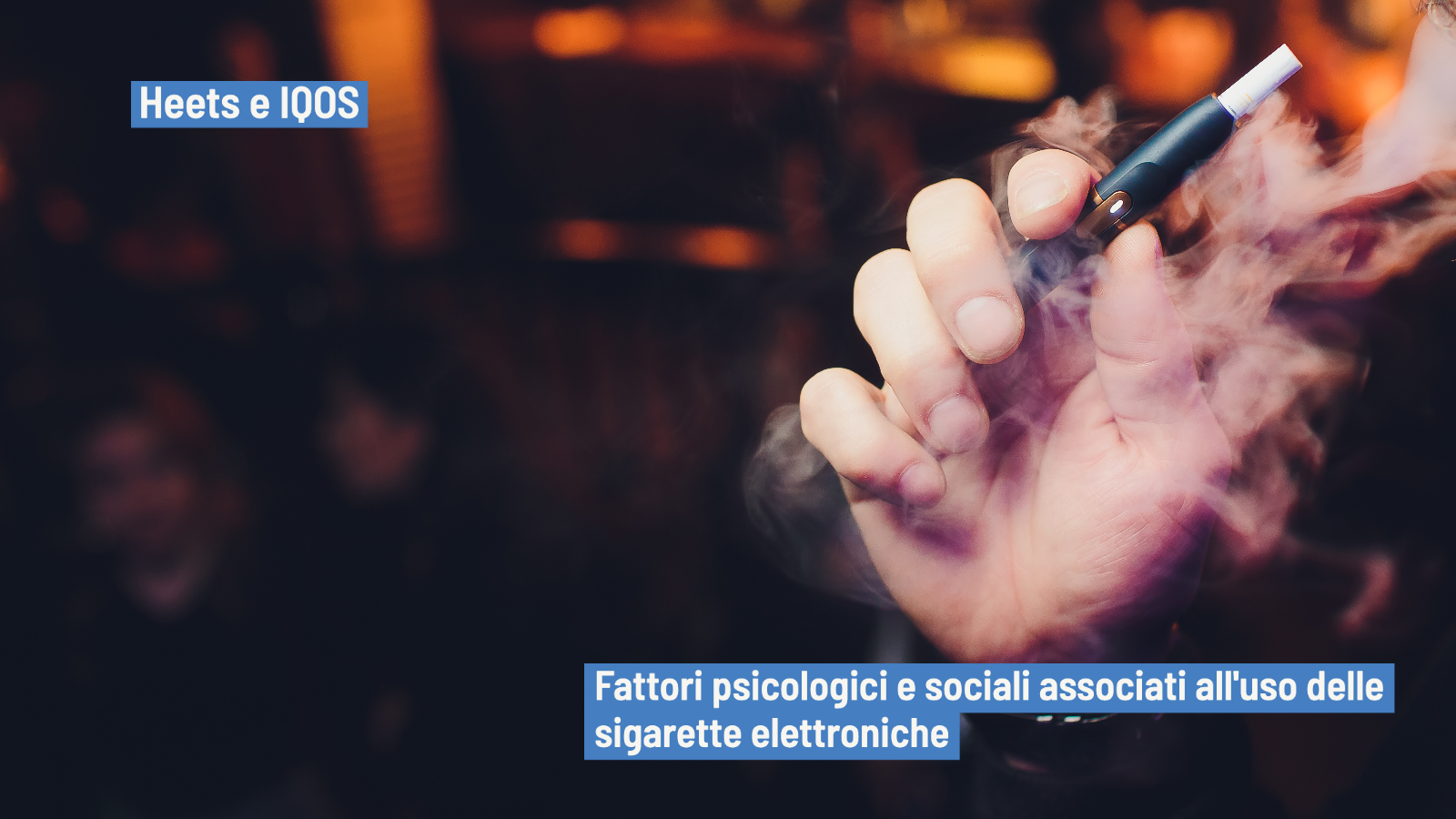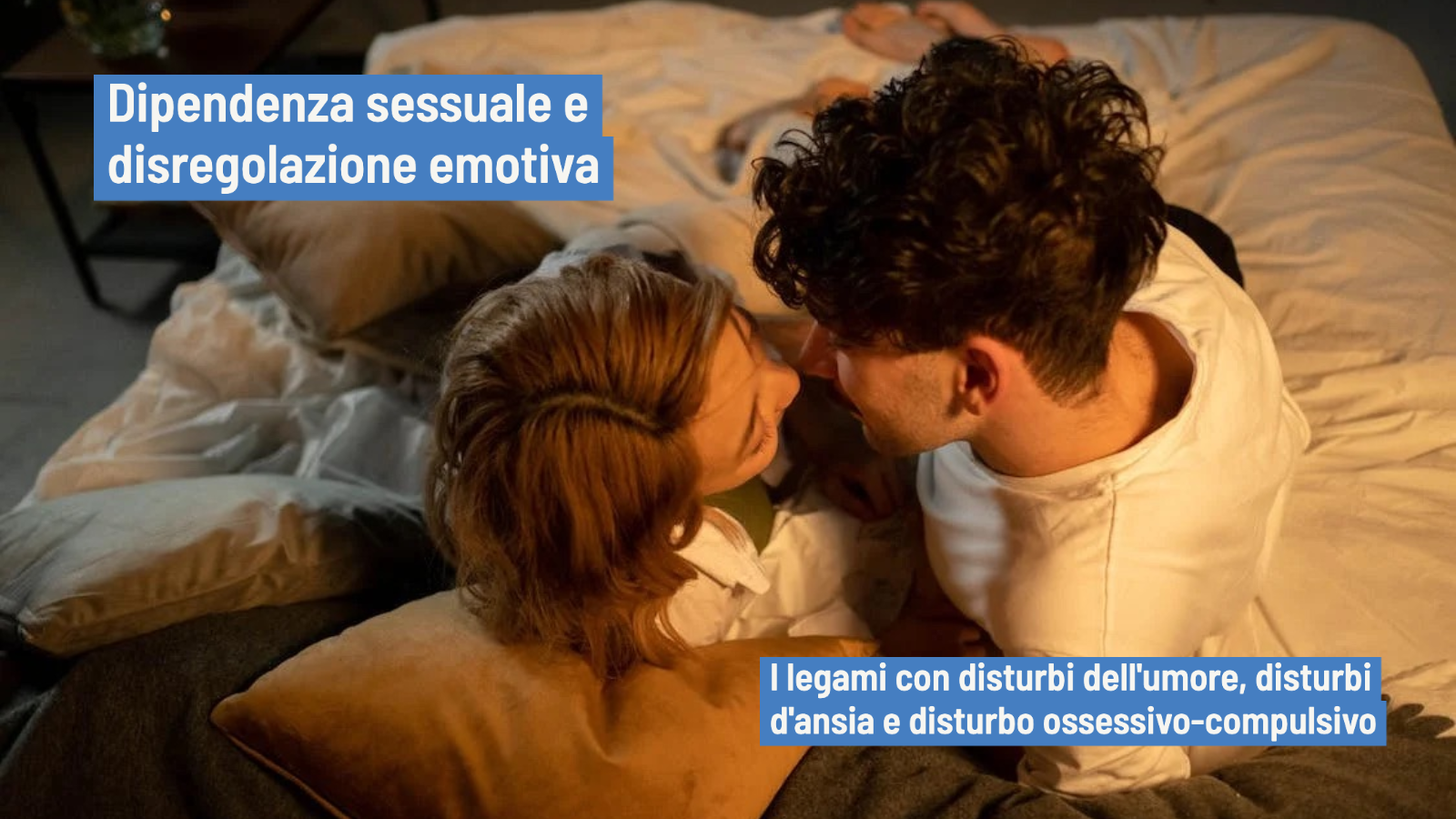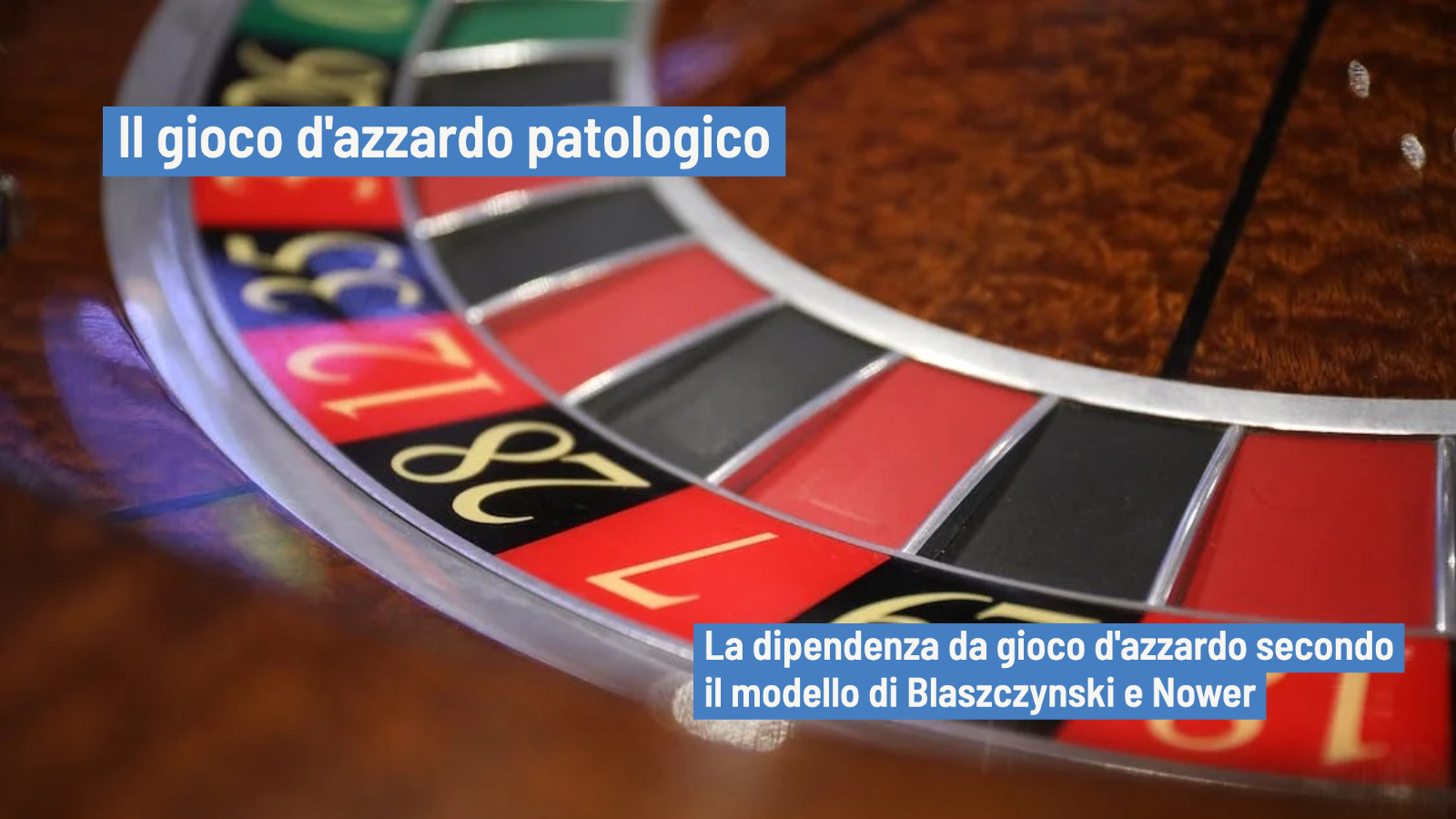Il ruolo dell’attaccamento madre-bambino nella regolazione emotiva
Mancini Raffaella e Monica Mascolo – OPEN SCHOOL – Studi Cognitivi San Benedetto Del Tronto
Perché la qualità dell’attaccamento è importante nello sviluppo della regolazione emotiva? Diverse sono le ricerche che hanno approfondito il legame tra regolazione emotiva e attaccamento, molte delle quali sono giunte alla conclusione che la capacità di regolare in modo più o meno efficace le emozioni potrebbe derivare dall’esperienza delle nostre relazioni di attaccamento primario.
In particolare, si ipotizza che la regolazione emotiva possa essere influenzata dalla relazione di attaccamento attraverso le aspettative del bambino circa il comportamento del genitore.
La regolazione delle emozioni è una componente importante della competenza emotiva, che si sviluppa nei primi anni di vita e ha particolare importanza per lo sviluppo di un adeguato e flessibile comportamento sociale (Eisenberg et al., 1996; Eisenberg, Murphi, Maszk, Smith et al., 1995; Thompson, 1994, citato in Fox e Calkins, 2003).
Nel tempo sono state date varie definizioni riguardo questo concetto. Frijda (1986) è stato tra i primi ad occuparsi di regolazione, e afferma che le persone oltre a provare le emozioni, le manipolano nella misura in cui assumono una certa posizione verso le proprie emozioni e verso le conseguenze delle proprie azioni di tipo emotivo; le giudicano positive o negative e si comportano di conseguenza (Frijda, 1986, citato in Grazzani Gavazzi, 2009).
Successivamente Thompson ha definito la regolazione emotiva come quel processo che, consciamente o inconsciamente, esercita un’azione di monitoraggio, valutazione, modificazione, e più in generale, di mediazione della risposta emotiva (Thompson, 1994, citato in Barone, 2007). Gross, che insieme a Thompson è uno tra i più significativi studiosi dell’argomento, definisce la regolazione emotiva come quell’insieme dei processi attraverso i quali le emozioni sono esse stesse regolate. I processi possono essere di tipo intrinseco, quando è il soggetto che agisce autoregolandosi (regulation in self), o di tipo estrinseco (regulation in other), quando qualcuno agisce per regolare le emozioni dell’altro.
Tali processi entrano in gioco sia in relazione a emozioni positive che negative. Gross ritiene che l’attività di regolazione avviene a diversi livelli del processo emotivo e gli atti regolatori hanno il loro impatto principale in differenti punti. Le principali tipologie di processi regolatori, presenti nel suo modello di regolazione emotiva, sono: selezione della situazione, modificazione della situazione, direzione selettiva dell’attenzione (o focalizzazione), cambiamento cognitivo e modulazione della risposta. I primi quattro sono focalizzati sull’antecedente, mentre l’ultimo è centrato sulla risposta ed è successivo alle reazioni emotive (Gross, 2008, citato in Grazzani Gavazzi, 2009).
La regolazione delle emozioni inizialmente è mediata dal caregiver, successivamente nel corso dello sviluppo si presenta come una modalità maggiormente autonoma e consapevole.
Volendo tracciare le principali fasi dello sviluppo della regolazione emotiva possiamo individuarne la prima che copre il primo anno di vita in cui è fondamentale il ruolo esterno dell’adulto per dare significato alle esperienze del bambino, ad esempio rispondendo prontamente al pianto o ai sorrisi. Tuttavia sono presenti anche condotte autoregolatorie, come la suzione del pollice per calmarsi o il distogliere lo sguardo da uno stimolo eccitante. Inizialmente tali condotte sembrano automatiche per poi divenire sempre più consapevoli nel corso del primo anno.
Tra i 12 e i 36 mesi le strategie di regolazione emotiva sono prevalentemente di tipo comportamentale, infatti si osservano condotte di evitamento di situazioni indesiderate, la ricerca attiva di alcune persone, la richiesta di vicinanza e il contatto fisico per ottenere conforto, sicurezza e consolazione. Inoltre grazie alla capacità di gioco simbolico e di finzione i bambini iniziano ad utilizzare l’attività ludica per rielaborare e dare un senso ad esperienze emotive intense. In tale periodo il caregiver, pur avendo un ruolo minore nella regolazione emotiva, continua comunque a svolgere una funzione fondamentale, soprattutto fornendo sostegno durante esperienze emotive intense e di lunga durata.
Alla fine del primo anno di vita compare anche il fenomeno del riferimento sociale in cui il bambino usa l’emozione espressa dal genitore per regolare il proprio stato emotivo e il proprio comportamento.
Successivamente, nel periodo prescolare (3-5 anni circa), matura gradualmente la capacità di autoregolazione emotiva. Anche in questa fase la mutua regolazione tra bambino e genitore è importante ma in maniera diversa. La figura del genitore è usata come base per contenere gli impulsi, definire i limiti e le regole, mentre il bambino assume gradualmente un ruolo più attivo e promotore di iniziativa. Il pieno sviluppo della capacità di giocare e di utilizzare gli oggetti e le persone in modo simbolico rappresenta una forma fondamentale di regolazione emotiva che, utilizzata insieme al linguaggio, aiuta nella gestione delle emozioni. Inoltre la conoscenza di una gamma più estesa e articolata di emozioni gli consente di incrementare le proprie capacità espressive e di indirizzare la richiesta emotiva in maniera finalizzata.
Dopo i 5-6 anni i cambiamenti nell’ambito dello sviluppo cognitivo, sociale e morale comportano l’adozione di strategie regolatorie più mirate e complesse che consentono al bambino di mettere in atto meccanismi di appraisal più specifici e strategie di coping appropriate ai diversi contesti sociali (Saarni, 1999, citato in Barone, 2007). Il bambino utilizza, in maniera più continua ed efficace, varie strategie di regolazione emotiva in sé e negli altri, ad esempio non pensando alle fonti di sofferenza, ma anche spingendo l’altro a non pensare per aiutarlo nei momenti di stress.
Le acquisite abilità metacognitive gli consentono inoltre di riflettere esplicitamente sulle emozioni e sui modi di regolarle.
In preadolescenza e in adolescenza, dagli 11 anni in poi, le esperienze emotive si fanno particolarmente intense, dovute anche allo sviluppo ormonale e neurologico. In tale periodo iniziano a prendere forma stili di regolazione emotiva molto personali, per far fronte alle richieste dell’ambiente sul piano sia dell’apprendimento che delle relazioni sociali, particolarmente importanti in questo periodo. Tuttavia le abilità regolatorie negli adolescenti sembrano essere ancora immature rispetto a quelle degli adulti, infatti uno dei loro compiti evolutivi sarà proprio quello di sviluppare modalità regolatorie flessibili e congruenti con le richieste provenienti dall’ambiente.
A contribuire allo sviluppo della regolazione emotiva e all’origine delle differenze individuali nell’apprendimento delle strategie di regolazione vi sono sia i fattori intrinseci che estrinseci. Anche se i fattori biologici, temperamentali e cognitivi (fattori intrinseci) giocano un ruolo importante per la nascita e lo sviluppo della regolazione emotiva, quest’ultima è influenzata, in misura diversa, da numerosi fattori esterni (Cicchetti, Ganiban e Barnett, 1991;Thompson, 1994,1998, citato in Fox e Calkins, 2003).
Primo fra tutti è la qualità dell’interazione con il caregiver (Cassidy, 1994; Field, 1994, citato in Fox e Calkins, 2003) e successivamente gli insegnamenti espliciti grazie ai quali il bambino impara a comportarsi in accordo con le norme e con le aspettative dei genitori (Thompson, 1998 citato in Fox e Calkins, 2003).
Bowlby teorizza l’attaccamento come un sistema motivazionale primario, ovvero una predisposizione biologica del bambino verso chi si prende cura di lui. La sua funzione biologica è quella di garantire la sopravvivenza mentre quella psicologica è di ottenere un senso di sicurezza interna, attraverso il contatto e la prossimità fisica. Secondo Bowlby esiste un periodo sensibile, nei primi 2-3 anni di vita, durante il quale vi è lo sviluppo del rapporto affettivo, tra bambino e caregiver, suddivisibile in quattro fasi. Nella prima fase, definita di preattaccamento, il bambino orienta i propri segnali senza discriminazione verso gli adulti con cui interagisce.
Nella seconda fase, invece, rivolge i propri segnali verso una o più persone discriminate. Verso il sesto-ottavo mese inizia la fase di attaccamento vera e propria in cui il bambino protesta per la separazione dalla figura di attaccamento e utilizza quest’ultima come base sicura per esplorare l’ambiente. Infine l’ultima fase, a partire dai 18 mesi del bambino, è caratterizzata dalla costruzione da parte di quest’ultimo dei Modelli Operativi Interni, ossia rappresentazioni mentali di se stesso e dell’altro che riflettono la storia relazionale del bambino con l’adulto di riferimento (Bretherton, 1985, citato in Simonelli e Calvo, 2002).
Il metodo maggiormente utilizzato nella valutazione dell’attaccamento nella prima infanzia è la Strange Situation (Ainsworth, Blehar, Waters e Wall, 1978; Ainsworth e Witting, 1969, citato in Simonelli e Calvo, 2002), una procedura osservativa che può essere somministrata a bambini di età compresa tra i 12 e i 24 mesi. Tale procedura mette il piccolo in una condizione di stress moderato ma crescente che lo spinge a manifestare i propri comportamenti di attaccamento nei confronti dell’adulto di riferimento. La Strange Situation conduce a una classificazione dell’attaccamento sulla base di quattro categorie: attaccamento sicuro (B), attaccamento insicuro-evitante (A), attaccamento insicuro-ambivalente (C) e disorganizzato (D) (Simonelli e Calvo, 2002).
Relativamente al legame tra attaccamento e regolazione emotiva Jude Cassidy (1994) sostiene che il bambino regola le proprie emozioni al fine di mantenere la vicinanza con la figura di attaccamento.
Ella giunge a questa tesi prendendo in considerazione da un lato la teoria dell’attaccamento di Bowlby, secondo la quale uno degli obiettivi primari del bambino è quello di mantenere una certa vicinanza con la figura dell’attaccamento (Bowlby, 1969/1982, 1973, 1980, citato in Cassidy, 1994) e dall’altro l’idea di Thompson, il quale sottolinea la natura adattiva della regolazione emotiva: le emozioni possono essere regolate al fine di raggiungere i propri obiettivi in un contesto dato.
Secondo Cassidy il bambino, fin da piccolo, fa uso delle risposte della figura di attaccamento nell’adattare le proprie strategie che gli servono per favorire la stretta vicinanza a quest’ultima. I pattern di regolazione emotiva, quindi, svolgono la funzione per il bambino di mantenere la vicinanza con la figura di attaccamento. Non tutti i caregiver però rispondono allo stesso modo ai segnali affettivi del bambino, quindi quest’ultimo metterà in atto la strategia di regolazione più efficace e più appropriata per mantenere il rapporto con la propria figura di attaccamento. Numerosi studi sostengono che i bambini le cui madri rispondono in modo sensibile ai loro segnali avranno maggiori possibilità di sviluppare un attaccamento sicuro (Ainsworth et al, 1978; Beisky, Rovine e Taylor, 1984; Egeiand e Farber, 1984, citato in Cassidy, 1994).
La strategia del bambino sicuro in riposta a queste esperienze materne è quella di utilizzare la madre come base sicura da cui partire per esplorare l’ambiente, quando non vi è alcuna minaccia da quest’ultimo, e come rifugio in presenza di pericolo (Ainsworth et al, 1978; Main e Solomon, 1986, citato in Cassidy, 1994). Il bambino sicuro, convinto che i suoi segnali emotivi riceveranno una risposta sensibile, segnalerà apertamente i propri desideri e le proprie emozioni con il genitore, inoltre, nella maggior parte dei casi, ci si aspetta che sperimenti poche emozioni negative con quest’ultimo. Tuttavia quando fa esperienza di un’emozione negativa, la strategia maggiormente utilizzata prevede l’espressione aperta, diretta e attiva nei confronti del genitore. Il bambino, quindi, in tale situazione chiederà aiuto e non nasconderà il distress. D’altro canto, quando le esperienze con un caregiver sensibile danno luogo a sensazioni piacevoli, le espressioni aperte di felicità hanno la funzione di mostrare interesse nel mantenere il rapporto.
La comunicazione affettiva tra genitore e bambino fornisce il contesto in cui quest’ultimo arriva a capire ed organizzare l’esperienza affettiva. Poiché il genitore è sensibile ai segnali del bambino, l’affetto verrà vissuto come utile per avvisare il genitore durante i periodi di distress. La riposta sensibile del genitore a sua volta migliorerà la percezione del bambino nel modulare le sue emozioni (Bell e Ainsworth, 1972, citato in Cassidy, 1994). L’idea che l’accettazione delle emozioni sia associata con l’attaccamento sicuro coincide con una serie di prospettive teoriche, tra cui quella di Bretherton (1990, citato in Cassidy, 1994) riguardo la comunicazione aperta.
Ella sostiene che la comunicazione tra i due partner ha importanti conseguenze per la sicurezza/insicurezza della relazione. Ha descritto la comunicazione diadica aperta, fluida e coerente come caratteristica delle diadi sicure, in cui entrambi i partner esprimono le emozioni in modo chiaro e apertamente, con la certezza che dall’altro lato ci sia qualcuno che le comprenda e con il quale condividerle.
Anche Stern (1985, citato in Cassidy, 1994) con la sua sintonizzazione affettiva converge con queste idee. Egli descrive la madre sensibile come colei che riconosce i segnali affettivi del suo bambino, accetta questi segnali e li condivide con quest’ultimo. Attraverso queste esperienze il bambino apprende che una serie di emozioni sono accettabili e che possono essere vissute e condivise all’interno delle relazioni sociali. Le difficoltà emergono quando la madre sottovaluta o sopravaluta i segnali emotivi del suo bambino.
I bambini insicuro-evitanti tendono a minimizzare gli affetti. Durante la Strange Situation, nella riunione, mostrano poco interesse alla prossimità e al contatto fisico con il genitore e lo evitano attivamente. Tali bambini sembrano affettivamente neutri, non mostrano apertamente né distress alla separazione e né piacere alla riunione con il caregiver. Ci si domanda quale esperienza di attaccamento possa aver contribuito allo sviluppo di una strategia in cui i bambini tendono a minimizzare le emozioni.
Main e Solomon (1986, citato in Cassidy, 1994) propongono che, le situazioni in cui l’attivazione del sistema di attaccamento ha avuto sempre come conseguenza un rifiuto, portano i bambini a sviluppare delle strategie che riducono l’attenzione sulla relazione di attaccamento e che minimizzano l’importanza del caregiver come fonte di conforto.
Diversi studi suggeriscono che i bambini insicuri-evitanti hanno sperimentato il rifiuto costante da parte dei genitori, soprattutto nei momenti di difficoltà in cui avevano cercato conforto, volte in cui il loro sistema di attaccamento è stato altamente attivato (Ainsworth et al., 1978; Grossmann, Grossmann, Spangler, Suess, e Unzner, 1985, citato in Cassidy, 1994). Quindi la tendenza del bambino evitante a minimizzare le emozioni negative come la rabbia, la tristezza e l’angoscia consente a quest’ultimo la possibilità di garantirsi la prossimità con il caregiver (Main, 1981, citato in Cassidy, 1994).
La strategia di regolazione emotiva, in questi casi, sembra essere: la mamma starà con me se eviterò qualsiasi trambusto, proprio perché l’obiettivo ultimo è quello di mantenere la vicinanza alla figura di attaccamento. L’evitamento e il mascheramento delle emozioni riducono il livello di eccitazione del bambino (Bowlby, 1980, citato in Cassidy, 1994) e quindi prevengono la diretta e possibile espressione pericolosa di rabbia verso la figura di attaccamento, in modo da non distruggere il legame con quest’ultima (Cassidy, 1994).
Il mascheramento di emozioni negative protegge il bambino sia dal rifiuto rispetto ai suoi tentativi di cercare il contatto della figura di attaccamento e sia dalla dolorosa paura di allontanarsi dalla figura di attaccamento, da cui dipende per la sopravvivenza (Bowlby, 1980; Main, 1981, citato in Cassidy, 1994). E’ necessario sottolineare come l’avversione per gli affetti negativi non indica che l’attivazione emozionale non è sperimentata, quanto che non viene espressa, e pertanto si caratterizza come una modalità di sovra-regolazione. Non solo le emozioni negative, ma anche le altre emozioni sono minimizzate dal bambino insicuro-evitante. Ad esempio la gioia potrebbe essere ridotta perché segnala l’apertura e la disponibilità per l’interazione. Inoltre se la strategia di minimizzazione delle emozioni negative può risultare adattiva nel contesto del rapporto con la figura di attaccamento, può essere disadattiva in altri contesti.
Numerosi studi hanno rilevato che le madri dei bambini evitanti, durante le interazioni con i loro bambini, esprimono una gamma più ristretta di emozioni, rispetto alle madri dei bambini sicuri (Ainsworth et al., 1978; Main, Tomasini e Tolan, 1979; Malatesta et al., 1989, citato in Cassidy, 1994). Tali risultati suggeriscono che i bambini evitanti tendono a minimizzare le emozioni non solo in risposta alla tendenza del caregiver a rifiutare i loro bisogni affettivi e a scoraggiare il contatto fisico, ma anche per imitazione diretta di un modello, in questo caso il caregiver.
Un altro studio in cui è stata utilizzata una situazione di gioco libero tra madre e bambino ha mostrato come le madri dei bambini evitanti giocavano con questi ultimi nelle situazioni in cui erano contenti, mentre si ritiravano quando i loro bambini esprimevano emozioni negative (Escher-Graueb e Grossmann, 1983, citato in Cassidy, 1994); tale allontanamento da parte delle madri insegnava ai bambini che le emozioni negative in quella determinata situazione erano fuori luogo. Atteggiamento opposto avevano le madri dei bambini sicuri, le quali interagivano e partecipavano al gioco del loro bambino quando quest’ultimo esprimeva emozioni negative.
Se i bambini insicuro-evitanti tendono a minimizzare le emozioni, gli insicuro-ambivalenti tendono a incrementare gli affetti. Questi ultimi vengono espressi in misura maggiore rispetto all’intensità con cui sono sperimentati, quindi in questo caso vi è una sotto-regolazione emozionale. I bambini insicuro-ambivalenti durante la Strange Situation manifestano forte disagio alla separazione mentre alla riunione sono inconsolabili. Anche in questo caso ci si domanda quale esperienza di attaccamento abbia portato il bambino ambivalente a sviluppare una strategia in cui intensifica le sue emozioni. Generalmente il caregiver è imprevedibile nel rispondere alle richieste del bambino: manifesta un comportamento molto affettivo o rifiutante del tutto scollegato alle esigenze del figlio.
Questa disponibilità irregolare da parte della madre porta il bambino a sviluppare una strategia in cui aumenta le sue richieste di attenzione. Egli intensifica l’emotività negativa per attirare l’attenzione della madre, infatti spesso accade che tali bambini, anche di fronte a stimoli benigni, manifestano spavento, proprio perché ritengono che tale strategia sia funzionale per aumentare la probabilità di ottenere l’attenzione da parte di un genitore spesso non disponibile (Main e Hesse, 1990, citato in Cassidy, 1994). Tuttavia Bowlby (1973, citato in Cassidy, 1994) ritiene che tale strategia, se è pervasiva, può risultare disfunzionale in quanto può minacciare l’esistenza della relazione e, inoltre, può interferire con gli altri compiti di sviluppo, come l’esplorazione.
Esistono delle prove che dimostrano come i bambini insicuro-ambivalenti siano più timorosi degli altri. La Ainsworth (1992, citato in Cassidy, 1994) attraverso analisi post-hoc del suo studio a Baltimora ha riferito che i bambini classificati come insicuro-ambivalenti mostravano una chiara paura nell’episodio della Strange Situation prima che entrasse l’estraneo. Si è anche scoperto che questi bambini erano più timorosi rispetto ai bambini sicuri nelle procedure di laboratorio anche all’età di 7 mesi (Miyake, Chen e Campos, 1985, citato in Cassidy, 1994) e all’età di 2 anni (Calkins e Fox, 1992, citato in Cassidy, 1994). Inoltre erano spaventati anche nell’esplorare un nuovo ambiente (Hazen e Durret, 1982; Jacobs e Wille, 1986, citato in Cassidy, 1994) e mostravano spavento e ritiro nelle interazioni con i pari (Pastor, 1981; Renken, Egeland, Marvinney, Mangelsdorf et al., 1989, citato in Cassidy, 1994).
Oltre all’incostante disponibilità del caregiver alle richieste e ai bisogni del bambino ambivalente, vi sono altre caratteristiche del genitore che contribuiscono ad aumentare l’emozionalità negativa dei bambini.
Una di queste può essere il fallimento nell’aiutare il bambino a regolare le emozioni negative, ad esempio nella Strange Situation anziché consolarlo lo reinteressa al gioco (Ainsworth et al., 1978, citato in Cassidy, 1994). Tale comportamento può contribuire a rendere relativamente più intenso e prolungato il distress dei bambini.
Cassidy, dunque, nella sua ipotesi teorica sottolinea l’importanza della qualità dell’attaccamento nella regolazione emotiva del bambino. A tal proposito sono stati condotti degli studi in cui è stato indagato come la qualità dell’attaccamento possa influire sullo sviluppo delle strategie di regolazione emotiva.
Roque, Verissimo, Fernandes e Rebelo (2009), hanno condotto uno studio su 55 bambini di età compresa tra i 18 e i 26 mesi, in cui è stato utilizzato il paradigma di regolazione emotiva di Diener e Mangelsdorf (1999). I bambini partecipavano a tre episodi che elicitavano rispettivamente rabbia, paura e affetto positivo attraverso la presentazione di tre giochi distinti. Ogni episodio durava sei minuti: nei primi tre la madre veniva istruita a non avviare l’interazione con il proprio bambino (episodio passivo), mentre nei successivi tre minuti poteva interagire liberamente con il figlio (episodio attivo).
Tra gli obiettivi dello studio vi era quello di indagare la relazione tra il legame di attaccamento e le strategie di regolazione emotiva dei bambini durante differenti contesti situazionali (paura, affetto positivo e rabbia) e sociali (madre passiva e madre attiva). Le strategie di regolazione emotiva del bambino sono state codificate attraverso 19 categorie divise in quattro domini: strategie legate alla madre, disimpegno delle strategie attentive, occuparsi dello stimolo e ridirezionamento delle azioni. La qualità dell’attaccamento è stata valutata tramite l’Attachment Q-Sort (Waters, 1995, citato in Roque, Verissimo, Fernandes e Rebelo, 2009).
Dai risultati è emerso che le strategie comportamentali dei bambini differivano in funzione del contesto situazionale (episodi) e sociale (coinvolgimento materno) ma soprattutto in funzione della qualità dell’attaccamento. Si è osservato che durante gli episodi di paura i bambini con attaccamento sicuro e insicuro aumentavano la frequenza delle loro strategie comportamentali quando le loro madri erano attive. Tale risultato è coerente con la prospettiva di Bowlby (1969/1982, citato in Roque et al., 2009), secondo cui i comportamenti di prossimità e contatto fisico con la figura di attaccamento vengono esibiti soprattutto durante le situazioni stressanti e pericolose, dove il caregiver viene utilizzato come rifugio sicuro (Bowlby, 1969/1982; Ainsworth, 1967; Ainsworth et al., 1978, citato in Roque, Verissimo, Fernandes e Rebelo, 2009).
Nei contesti di affetto positivo, quando la possibilità di aumentare la vicinanza emotiva con la madre è possibile attraverso il gioco, solo i bambini sicuri mostravano strategie comportamentali, soprattutto negli episodi in cui la madre era attiva ed interagiva con loro, mentre durante gli episodi che elicitavano rabbia non mostravano differenze significative tra i periodi in cui le madri erano attive e quelle in cui erano passive. Ciò potrebbe dipendere dalla presenza di un modello operativo interno positivo della figura di attaccamento, basato su esperienze passate durante le quali la partecipazione attiva e l’intervento delle madri è stato benefico e ha aiutato il bambino a regolare le proprie emozioni e a raggiungere i propri obiettivi.
Al contrario i bambini insicuri, non avendo sviluppato un modello operativo interno basato sull’aiuto sensibile delle madri, devono aumentare le strategie per richiamare l’attenzione del caregiver alle loro esigenze (Bowlby. 1973, 1980; Ainsworth et al., 1978; Acque et al., 1995, citato in Roque, Verissimo, Fernandes e Rebelo, 2009).
A differenza di ciò che si aspettavano gli autori, ovvero che i bambini sicuri mostrassero maggiori strategie comportamentali in tutti e tre gli episodi, è emerso che differenze significative tra i bambini sicuri e insicuri nell’uso delle strategie di regolazione emotiva emergono principalmente nei contesti di affetto positivo, quando la mamma è disponibile all’interazione e in cui il distress non è presente, mentre negli episodi di paura e di frustrazione sia i bambini sicuri che insicuri coinvolgevano la madre allo stesso modo, dalla quale potevano trovare protezione per il pericolo (episodio paura) e conforto (episodio frustrazione). Tale risultato è coerente con la tesi di Bowlby (1969/1982, citato in Roque, Verissimo, Fernandes e Rebelo, 2009) secondo la quale il legame di attaccamento è un sistema comportamentale regolatorio caratterizzato non solo dalla ricerca di un rifugio sicuro ma anche dalla formazione di un legame d’amore, caratterizzato dalla capacità di cercare e mantenere la vicinanza emotiva tra i partner durante i contesti emozionali positivi.
Diener, Mangelsdorf, McHale e Frosch (2002) hanno condotto uno studio su 85 bambini in cui hanno analizzato la relazione tra le strategie comportamentali di regolazione emotiva e l’espressione emotiva del bambino con la qualità dell’attaccamento madre-bambino e padre-bambino. La sicurezza dell’attaccamento è stata valutata tramite la Strange Situation (Ainsworth et al., 1978, citato in Diener, Mangelsdorf, McHale e Frosch, 2002). All’età di 12 mesi i bambini sono stati sottoposti a tale procedura con i padri, mentre all’età di 13 mesi con le loro madri. Subito dopo la Strange Situation veniva creata in laboratorio una situazione in cui il bambino provava un leggero distress, in modo da poter valutare le strategie comportamentali utilizzate da quest’ultimo per regolare le proprie emozioni.
Le strategie di regolazione emotiva identificate e codificate per ciascun genitore sono le seguenti: coinvolgimento della madre, riferimento sociale, distrazione, auto-consolazione, agitazione diretta, disimpegno passivo e congedo. L’espressione emotiva è stata codificata in: distress, affetto positivo e altro. I risultati hanno indicato che le strategie di regolazione emotiva utilizzate dai bambini con i loro padri erano simili a quelle che sono state documentate negli studi con le madri (Buss e Goldsmith, 1998; Diener et al., 1999, citato in Diener, Mangelsdorf, McHale e Frosch, 2002). In particolare, i bambini hanno favorito con i padri le stesse strategie che hanno utilizzato con le madri, e le strategie comportamentali hanno mostrato associazioni simili con l’espressione emozionale, indipendentemente dal contesto del genitore.
La coerenza nell’uso delle strategie con le madri e con i padri era significativamente correlata alla qualità dell’attaccamento che il bambino aveva con ciascun genitore. In linea con le aspettative degli autori la strategia maggiormente utilizzata dai bambini con attaccamento insicuro-evitante era la distrazione, strategia utilizzata con meno frequenza dai bambini sicuri. Inoltre è emerso che vi erano delle differenze, collegate alla qualità dell’attaccamento, nel livello di distress provato dai bambini di tale studio. Coerentemente con l’ipotesi teorica di Cassidy (1994, citato in Diener, Mangelsdorf, McHale e Frosch, 2002), i bambini insicuro-ambivalenti mostravano alti livelli di distress sia con le madri che con i padri, rispetto ai bambini sicuri. Ciò dimostra come tali bambini intensificano le proprie emozioni per attirare e mantenere l’attenzione di un caregiver imprevedibilmente responsivo.
I risultati di entrambi gli studi sopra citati sono in linea con l’ipotesi teorica di Cassidy (1994), la quale sottolinea come le differenze individuali nelle strategie di regolazione emotiva del bambino siano collegate alla qualità dell’attaccamento: il bambino regola le proprie emozioni al fine di mantenere la vicinanza con la figura di attaccamento. Ciascun bambino, dunque, sulla base della modalità con cui il caregiver risponde ai propri segnali affettivi, metterà in atto la strategia più efficace e più appropriata per mantenere la vicinanza con quest’ultimo.
Alla luce di quanto detto emerge quanto sia importante, sin dai primi mesi di vita del bambino, promuovere un’interazione positiva tra genitore e figlio e un legame di attaccamento sicuro al fine di avere degli effetti positivi sullo sviluppo socio-emotivo corrente e futuro del bambino. Nonostante la rilevanza teorica del legame tra regolazione emotiva e attaccamento, pochi sono gli studi che hanno verificato empiricamente questa relazione. E’ auspicabile, dunque, che in futuro la ricerca continui ad indagarla con il fine di comprendere maggiormente il fenomeno e utilizzare tali informazioni in ambito clinico per costruire nuovi strumenti di indagine e protocolli di intervento.
ARTICOLO CONSIGLIATO:
Le relazioni di attaccamento tra bambino e caregiver – Introduzione alla Psicologia nr. 21
BIBLIOGRAFIA:
- Barone, L. (2007). Emozioni e sviluppo. Roma: Carocci.
- Cassidy, J. (1994). Emotion regulation: influences of attachment relationships. The development of emotion regulation: Biological and behavioral considerations. Monographs of the society for research in child development, 59(2/3), 228-249.
- Diener, M. L., Mangelsdorf, S. C. (1999). Behavioral strategies for emotion regulation in toddlers: associations with maternal involvement and emotional expressions. Infant Behavior and Development, 22(4), 569-583.
- Diener, M. L., Mangelsdorf, S. C., McHale, J. L., Frosch, C. A. (2002). Infants’ behavioral strategies for emotion regulation with fathers and mothers: associations with emotional expressions and attachment quality. Infancy, 3(2), 153-174.
- Fox, N. A., Calkins, S. D. (2003). The development of self-control of emotion: intrinsic and extrinsic influences. Motivation and Emotion, 27(1), 7-22.
- Grazzani Gavazzi, I. (2009). Psicologia dello sviluppo emotivo. Bologna: Il Mulino.
- Lavelli, M. (2007). Intersoggettività. Origini e primi sviluppi. Milano: Raffaello Cortina.
- Roque, L., Verissimo, M., Fernandes, M., Rebelo, A. (2009). Emotion regulation and attachment: relationships with children’s secure base and mothers’ attachment representations, during different situational and social contexts in naturalistic settings. Poster presentato al Congresso Biennale SRCD, Denver, Aprile 2009. DOWNLOAD
- Simonelli, A., Calvo, V. (2002). L’attaccamento: teoria e metodi di valutazione. Roma: Carocci.