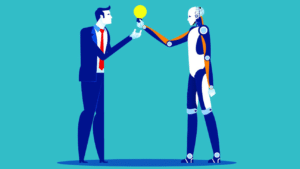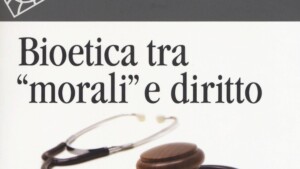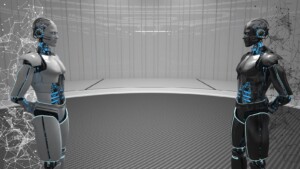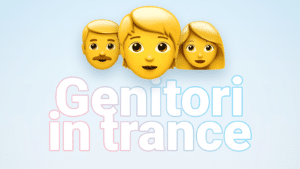La depressione post-natale: definizione, conseguenze cognitive ed emotive nei figli e trattamento
Marta Merenda, Noemi Monti, Francesca Turra, OPEN SCHOOL Studi Cognitivi
Il DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder; American Psychiatric Association) considera la depressione post-natale come una forma di depressione generale specificata come “depressione postpartum” se ha esordio entro le prime quattro settimane successive al parto.
In molte culture, tra cui quella occidentale, la nascita di un bambino viene sempre accolta e considerata come un evento felice e un’occasione di festa. Questa immagine idealizzata della maternità è però, talvolta, in forte contrasto con il vissuto intimo della madre stessa. La nascita di un figlio non è sempre una strada in discesa e costellata solo di rose e fiori: diventare madre comporta molti cambiamenti nella vita della donna e della coppia.
La nuova vita comporta l’integrazione del ruolo di genitore, oltre che la modificazione dei ruoli precedenti: le continue richieste di accudimento del neonato, una nuova organizzazione del proprio tempo e delle proprie abitudini, eventuali difficoltà nell’ambito lavorativo sono solo alcune delle difficoltà che la donna incontra in questa delicata fase di vita.
Anche la relazione con il partner può incontrare alcune avversità legate al nuovo assetto di vita; il coniuge, molto spesso, viene avvertito dalla compagna come poco presente e supportivo rispetto alle sue maggiori necessità di aiuto e sostegno. Se a tutto ciò si sommano problemi ulteriori, quali la mancanza di una rete sociale, difficoltà finanziarie o un parto inaspettatamente problematico, lo sviluppo di manifestazioni depressive di varia intensità è un evento al quale non è assolutamente raro assistere (Zaccagnino, 2009).
Nei giorni immediatamente successivi al parto è considerato fisiologico un periodo caratterizzato da calo dell’umore e instabilità emotiva (la cosiddetta baby blues o maternity blues): si stima che una percentuale collocabile tra il 30% e l’85% delle donne (O’Hara et al., 1990; Gonidakis et al., 2007) sperimenta e manifesta sintomi associabili a una leggera depressione post partum, ma caratterizzati da transitorietà (presentano una durata variabile da poche ore ad alcuni giorni) e che non necessariamente si trasformano in un vero e proprio disturbo.
La notevole diffusione del baby blues suggerisce un adattamento psicofisico agli importanti cambiamenti che intervengono nella vita di una donna quando diventa madre; per il suo carattere transitorio e la scarsa entità della sintomatologia non richiede generalmente trattamenti specifici e non implica conseguenze a lungo termine. E’ importante tuttavia identificare le donne con maternity blues perché è stato stimato che circa il 20% dei casi evolve in un episodio depressivo maggiore nel corso del primo anno successivo al parto (Najman et al., 2000).
La vera e propria depressione post-partum o depressione post-natale (DPN) sembra invece colpire circa il 10-15% (Centers for Disease Control and Prevention, 2008) delle donne. Il DSM (Diagnostic and Statistica Manual of Mental Disorder; American Psychiatric Association) considera la depressione post-natale come una forma di depressione generale specificata come “depressione postpartum” se ha esordio entro le prime quattro settimane successive al parto. I criteri del DSM 5 per questo disturbo richiedono che sia presente, quasi ogni giorno per un periodo di almeno due settimane:
umore depresso, per la maggior parte del tempo, quasi tutti i giorni, come riportato dall’individuo (per esempio si sente triste, vuoto, disperato) o come osservato da altri (per esempio appare lamentoso);
marcata diminuzione di interesse o piacere per tutte, o quasi tutte, le attività per la maggior parte della giornata, quasi ogni giorno.
Devono inoltre essere presenti almeno 5 o più dei seguenti sintomi, perduranti per un periodo di almeno due settimane:
significativa perdita di peso, senza essere a dieta, o aumento di peso, oppure diminuzione o aumento dell’appetito;
insonnia o ipersonnia quasi tutti i giorni;
agitazione o rallentamento psicomotorio quasi tutti i giorni;
faticabilità o mancanza di energia quasi tutti i giorni;
sentimenti di autovalutazione o di colpa eccessivi o inappropriati quasi tutti i giorni;
ridotta capacità di pensare o di concentrarsi o indecisione quasi tutti i giorni;
pensieri ricorrenti di morte, ricorrente idea suicidaria senza un piano specifico, o un tentativo di suicidio, o l’ideazione di un piano specifico per commettere suicidio.
I sintomi causano disagio clinicamente significativo o compromissione del funzionamento sociale, lavorativo, o di altre aree importanti. Si presentano in modo conclamato tra le otto e le dodici settimane dopo il parto, periodo che è stato individuato come picco di insorgenza più frequente (Guedeney & Jeammet, 2001).
I sintomi della depressione post partum non sono transitori e possono persistere, variando d’intensità, anche per molti anni, e quindi avere conseguenze più o meno significative non solo sulla salute mentale della donna, ma anche sulla relazione madre-bambino, sullo sviluppo del bambino e sull’intero nucleo familiare.
Effetti della depressione post-natale sulla relazione madre-bambino
Per le madri è molto importante occuparsi del bambino, rispondere appropriatamente alle sue comunicazioni e provvedere alle sue cure stimolandolo dal punto di vista emotivo, cognitivo e sociale. Occorre trovare un buon equilibrio tra i bisogni propri, del neonato e quelli del partner e ciò è difficilmente attuabile in presenza di un disturbo disabilitante quale la depressione. E’ risaputo però come lo sviluppo sociale ed intellettivo dei bambini sia modulato dalle loro precoci esperienze e dal clima emotivo fornito dai genitori (Zaccagnino, 2009). L’importanza della prima relazione madre-bambino per il successivo sviluppo di questo è ampiamente documentata. Esistono degli specifici comportamenti della madre che rendono l’interazione con il bambino positiva ed efficace: il contatto visivo, le risposte immediate ed appropriate ai segnali del neonato, la creazione di un ambiente che suscita l’aspettativa di un’interazione, la ricerca di un equilibrio tra stimolazione e calma, la stimolazione emotiva e fisica.
Ricevere delle risposte appropriate dalla madre aiuta non solo a sviluppare un senso di sé ma anche una relazione di attaccamento sicuro che permette al bambino di essere flessibile, curioso e socialmente competente (Winnicott, 1965). La depressione materna interferisce con gli scambi emotivi e comportamentali ritenuti necessari perché si possa sviluppare un’interazione efficace tra la madre e il bambino (Milgrom et al., 2003). I sintomi della DPN e le cognizioni negative associate comportano una minor abilità di supporto della regolazione emotiva del bambino, espressioni affettive poco positive e sincronizzate e livelli bassi di responsività materna.
La mancanza di un’interazione sensibile, responsiva e psicologicamente disponibile per il bambino in un periodo tanto importante per il suo sviluppo avrebbe delle conseguenze negative dal punto di vista affettivo-relazionale: numerosi studi sostengono che l’esposizione precoce alla depressione materna contribuisca in modo significativo alla formazione di una relazione insicura di attaccamento (Milgrom et al., 2003).
Come già affermato, in letteratura sono numerose le evidenze riguardo al fatto che la depressione interferisca in modo significativo sulle funzioni e sull’accudimento genitoriale e incida profondamente sul comportamento materno, limitando l’espressione emozionale e la qualità degli scambi relazionali madre-bambino (Cohn, 1990; Kurstjens & Wolke, 2001). E’ stato sottolineato come la tristezza, l’irritabilità e il ritiro sociale che caratterizza le madri depresse comprometta la loro abilità di fornire un ambiente responsivo, sensibile e “nutritivo” per i loro bambini. Da un riesame di alcuni articoli emerge che la depressione produce nelle madri una generale limitazione nell’espressione dell’affettività, vale a dire che esse dimostrano di essere meno sensibili e responsive ai bisogni del bambino (Righetti-Veltema et al., 2003; Stanley et al., 2004).
In particolare è frequente che le madri non riescano a provare emozioni nei confronti del bambino, si ritengano incapaci e temano i momenti di solitudine insieme al piccolo nato (Zaccagnino, 2009). La ricerca indica che molte donne affette da DPN incontrano delle difficoltà nell’interazione con i loro bambini: li guardano meno (Field et al., 1985), li cullano meno (Murray, 1992), reagiscono più lentamente alle loro richieste e sono meno affettuose, più ritirate o più intrusive (Bettes, 1988). I figli di madri depresse sono descritti come più assonnati e capricciosi (Cox, 1988; Milgrom et al., 2003), mostrano scarse vocalizzazioni positive, pianti eccessivi, poche espressioni facciali positive e pochi comportamenti interattivi positivi (Monti et al., 2004). Essi sperimentano una predominanza di stati affettivi negativi a cui possono rispondere con la tristezza, con l’isolamento, con il pianto o con la rabbia.
Alcuni studi si sono occupati di indagare il linguaggio delle madri sofferenti di depressione post natale confrontandolo con quello di madri non depresse (Reissland et al., 2003; Kaplan et al., 2001). I due gruppi si differenziano innanzitutto per il contenuto delle verbalizzazioni: le madri depresse verbalizzano molto più frequentemente riguardo a se stesse e non riguardo al bambino; in aggiunta il contenuto di tali verbalizzazioni è negativo e riferito all’ambiente esterno e poco sullo stato interno e sulle emozioni. Un’ulteriore differenza riguarda gli aspetti formali: le madri non depresse si adeguano all’età del bambino, usando ad esempio nei confronti di bambini piccoli frasi più brevi e parole semplici, mentre quelle che soffrono di depressione non riescono a costruire un dialogo con il bambino adeguato alla sua età.
Depressione post-natale: ricadute sul versante emotivo e cognitivo del bambino
La depressione post natale rappresenta un considerevole fattore di rischio per l’esordio di un ampio ventaglio di esiti psicopatologici nel bambino: problemi nei processi di regolazione affettiva; disturbi comportamentali con tendenza all’aggressività; disturbi ansiosi; deficit nello sviluppo cognitivo; deficit dell’attenzione; incompetenza sociale; deficit dell’apprendimento con difficoltà di adattamento scolastico; difficoltà temperamentali; disorganizzazione emozionale; sintomatologia depressiva subclinica o disturbi depressivi veri e propri; modelli di attaccamento di tipo prevalentemente insicuro (Cicchetti, Rogosh & Toth, 1998; Downey & Coyne, 1990; Field, 1989; Goodman & Gotlib, 1999; Spieker & Booth, 1988). I quadri depressivi materni associati al rischio cumulativo di vari fattori di stress psicosociale, sembrerebbero i più forti elementi predittivi delle conseguenze negative nel bambino ad un anno di vita (Seifer, Dickstein, Sameroff, Magee & Hayden, 2001).
E’ stato riscontrato che i figli di madri depresse sono maggiormente esposti a sentimenti negativi e a intense situazioni di stress: questo influisce significativamente sulla loro capacità di regolazione emotiva (Murray, Fiori, Cowley & Hooper, 1996). Come affermato nel paragrafo precedente, la depressione post-partum può compromettere la capacità materna e di conseguenza, anche quella della diade madre-bambino di regolare reciprocamente l’interazione (Cohn & Tronick, 1989); ciò comporterebbe una disregolazione degli affetti nell’interazione che andrebbe ad interferire con il processo di apprendimento del bambino. In particolare la DPN può influenzare due aspetti della regolazione dell’attenzione: la consapevolezza delle contingenze ambientali e la capacità di modulare il proprio stato emotivo contemporaneamente all’ elaborazione dell’informazione (Cooper e Murray, 1997).
In letteratura è emersa una sostanziale differenza a seconda del genere dei figli di mamme affette da Depressione Post-Partum. I maschi sembrano mostrare maggiori problemi d’autoregolazione dell’eccitabilità e delle emozioni (Cooper & Murray, 1997). È stato osservato che lo sviluppo cognitivo, soprattutto nei maschi, in un contesto di depressione materna è fortemente a rischio (particolarmente aggravata qualora sia presente anche una condizione di deprivazione socioeconomica). Inoltre, questi bambini mostrano un livello più elevato di disturbi comportamentali a 5 anni e sviluppano in percentuale superiore un legame di attaccamento insicuro a 18 mesi (Cooper & Murray, 1998). Quando invece la diade è composta da madre depressa-figlia femmina le alterazioni interattive che si osservano sono più numerose, sia per ciò che riguarda compromissioni nelle interazioni corporee vocali e gestuali (maggiore passività e indifferenza negli scambi corporei tra mamma e figlia), sia in termini di mancanza di reciprocità.
Gli aspetti emotivi di questi bambini non sono quindi gli unici ad essere compromessi dalla depressione materna: alcuni studi hanno evidenziato compromissioni riguardanti anche la sfera cognitiva e lo sviluppo. La disregolazione degli affetti nell’interazione causata dalla depressione materna interferisce anche con il processo di apprendimento del bambino.
Nel 1992 Murray ha esaminato quale fosse l’effetto della DPN sullo sviluppo intellettivo del bambino nel corso del primo anno di vita. Il compito cognitivo esaminato era quello del test di permanenza dell’oggetto (Utzgiris & Hunt, 1975) in bambini a 9 e 18 mesi d’età. Ciò che è apparso è che i figli di madri depresse, valutate con l’EPDS (Edimburgh Postnatal Depression Scale; Cox et al., 1987) presentano una maggiore percentuale di fallibilità in questo compito cognitivo. Altri studi hanno utilizzato come strumento il Mc Carthy of Children’s Abilities (Cogill et al., 1986; Sharp et al., 1995) per rilevare la correlazione tra DPN e lo sviluppo cognitivo del bambino. Dal lavoro eseguito da Cogill e colleghi nel 1986 si è effettivamente avuto conferma della discrepanza tra figli di madri depresse e figli di madri non depresse: nel corso del primo anno di vita i primi avevano punteggi inferiori rispetto ai secondi.
Nello studio eseguito invece da Sharp e colleghi nel 1995 il campione era più ampio ma al contempo erano numerose le diadi madre-bambino provenienti da contesti socio-culturali particolarmente deprivati il che ha inciso notevolmente sull’esito dello studio. Nonostante ciò, è stato comunque possibile riscontare l’influenza della depressione materna sullo sviluppo delle abilità del bambino specie se la diade era composta da madre depressa-figlio maschio.
Anche Murray nel 1993 ha messo in relazione la depressione materna con la classe sociale/ livello di educazione materna e il genere sessuale del bambino tramite l’utilizzo del Bayley Scales of Infant Development (BSID; Bayley, 1969). Anche in questo studio la relazione tra la malattia della madre ed il genere del bambino è risultata significativa: nei figli di madri non depresse i maschi presentano punteggi più alti mentre tra i figli di madri depresse i maschi ottengono punteggi inferiori rispetto alle femmine.
Nonostante siano necessarie ancora numerose ricerche, alcuni lavori svolti su primati non umani hanno dimostrato che la causa dell’aumento della reattività emotiva nei piccoli di sesso maschile sia dovuta ad un’ organizzazione cerebrale immatura, a differenza delle femmine, che alla stessa età hanno raggiunto un maggiore grado di regolazione emisferica (Hopkins & Bard, 1993) che nella nostra specie è implicata nella regolazione delle emozioni (Cicchetti et al., 1991).
Il fatto di necessitare di un maggiore aiuto nell’autoregolazione da parte del bambino maschio risulta pertanto un problema dal momento che, nel caso di una madre depressa, ciò non può essere fornito. Per tale ragione, Hay (1997) suggerisce che il genere sessuale rappresenti un fattore di rischio per i maschi ed un fattore protettivo per le femmine.
La depressione materna oltre che influenzare le emozioni, le capacità cognitive ed i comportamenti potrebbe avere anche ripercussioni sulla salute fisica del bambino. I figli di madri depresse sono risultati più vulnerabili ai disturbi del sonno, dell’alimentazione, della digestione, alle infezioni ricorrenti, alle allergie e varie forme di asma (Righetti-Veltema et al., 2003).
In sintesi, gli effetti a lungo termine della depressione postnatale materna sono associati ad un’ampia gamma di persistenti svantaggi nel funzionamento del bambino, che includono rallentamenti nello sviluppo neurocognitivo, disturbi della relazione di attaccamento e sviluppo di psicopatologia specifica dell’età evolutiva. In letteratura è ipotizzato un percorso evolutivo che dai problemi iniziali di attenzione e di regolazione delle emozioni conduca a successivi deficit cognitivi (Murray et al., 2003). Va comunque sottolineato che lo stato di depressione non determina automaticamente un comportamento interattivo alterato della madre; in alcuni casi infatti le madri depresse dimostrano di essere ugualmente in grado di interagire e fornire un feedback adeguato ai bisogni del bambino. Si tratta di situazioni in cui lo stato depressivo non è particolarmente grave e in cui agiscono come fattori protettivi alcuni fattori ambientali, come ad esempio la presenza di un partner supportivo e di sostegno sociale (Monti & Agostini, 2006).
Prevenzione della depressione post-natale
Molto si sta facendo a livello generale per individuare e supportare i cosiddetti “soggetti a rischio” di depressione post partum (incontri psicoeducativi precedenti al parto, screening di routine nelle settimane immediatamente successive al parto, affiancamento e supporto nelle cure al neonato alle donne che ne facciano richiesta dopo il parto da parte del Servizio Sanitario Nazionale sono solo alcuni esempi), ma resta il fatto che spesso la depressione post natale non viene riconosciuta in tempo: in parte per la sua insorgenza insidiosa e in parte perché la maggior parte delle neo-mamme tende a nascondere i propri sintomi di depressione. Sono pochissime quelle che ricercano spontaneamente l’aiuto di uno specialista, così da ridurre la propria sofferenza e limitare quelle che, inevitabilmente, possono diventare le conseguenze che questo disturbo potrebbe avere su madri e figli. E’ dunque fondamentale la tempestività, avere la possibilità di parlarne con professionisti del settore (ginecologi, ostetriche, infermieri, medici di base), che potranno indirizzare le donne interessate a psicoterapeuti specializzati nella cura della depressione post partum.
Trattamento della depressione post-natale
La terapia cognitivo-comportamentale è considerata, ad oggi, la metodologia più efficace nel trattamento della depressione. Nonostante ciò, sono poche le ricerche che si sono occupate di verificare i risultati che questo approccio terapico permette di ottenere nel trattamento di madri con depressione post partum. Più precisamente, non è stato solo il trattamento di questa patologia ad essere trascurato dagli studiosi di settore, ma anche la patologia stessa: la maggioranza delle ricerche sul tema si è occupata di identificare i fattori di rischio per prevenirne l’insorgenza. Negli ultimi anni si assiste invece ad un’inversione di tendenza, tanto che gli studi sulla depressione post partum stanno diventando sempre più numerosi non solo in ottica preventiva, ma anche di trattamento. Un dato che fa riflettere a tal proposito è che da osservazioni cliniche emerge che chi soffre di depressione post natale non chiede facilmente aiuto ai professionisti. Occorre quindi creare degli strumenti e delle opportunità che permettano di identificare precocemente queste donne e coinvolgerle in un programma di trattamento.
Due autori che si sono occupati diffusamente di questa patologia sono J. Milgrom e P. Martin dell’Università di Melbourne in Australia. Il loro modello di intervento è di tipo evidence-based, ovvero si basa sulle prove raccolte nel corso di anni di esperienza clinica con più di 300 donne sofferenti di depressione post natale che li hanno portati ad identificare ciò che funzionava realmente. Questo li ha spinti ad adottare un approccio di tipo cognitivo comportamentale derivato, in parte, dai lavori di Lewinsohn (1984) e di Olioff (1991).
Nell’elaborazione di questo modello, Milgrom e Martin sono partiti dagli approcci che davano buoni risultati nel trattamento della depressione post partum al fine di mutuarne gli aspetti fondamentali:
– il trattamento con approccio cognitivo proposto da Olioff nel 1991 per il trattamento della depressione post partum. Con questo paradigma, l’autore voleva fornire uno strumento terapeutico che, da un lato, consentisse di cogliere la complessità del disturbo e, dall’altro, fosse sufficientemente flessibile da essere utilizzato in diversi contesti. Olioff inoltre, identificò tre differenti tipologie di depressione post natale: depressione post natale con presenza di contenuti cognitivi depressivi, depressione post natale con presenza di schemi di pensieri distorti inerenti la maternità e depressione post natale con presenza di ricorrenti episodi depressivi. Egli infine individuò nei suoi studi tre temi cognitivi che contraddistinguevano le madri che presentavano una depressione post partum da quelle che avevano una diagnosi di depressione durante una diversa fase del ciclo di vita: la percezione di autoefficacia come madre, l’autovalutazione delle proprie abilità materne e la vulnerabilità percepita del bambino;
– il trattamento cognitivo-comportamentale elaborato da Lewinson e collaboratori (1984) per curare la depressione maggiore negli adulti. Esso si basa sul fornire al paziente indicazioni chiare sul programma terapeutico, sull’insegnare abilità sociali che vengono inizialmente sperimentate nel contesto di seduta ma che successivamente devono essere applicate nella vita di tutti i giorni e sull’incoraggiamento a vedere tutti i miglioramenti sul tono dell’umore riscontrati come conseguenze delle abilità acquisite piuttosto che come risultati ottenuti grazie al terapeuta;
– la terapia di gruppo per il trattamento della depressione post natale offre dei vantaggi rispetto a quella individuale, innanzitutto dal punto di vista economico (aspetto significativo considerato che le madri che sono maggiormente colpite da questa patologia appartengono alle classi sociali meno abbienti). In secondo luogo, essa consente alle madri di non sentirsi sole ad affrontare questa “avventura”, e di condividere, con tante altre, gli stessi timori, aspettative irrealistiche, sentimenti di vuoto e incapacità. Avere uno spazio di discussione all’interno di una terapia consente inoltre di percepire, con maggior facilità, le distorsioni cognitive che, donne e madri come loro, mettono in atto nei loro ragionamenti e prendere spunto dai racconti altrui per trovare soluzioni creative alle proprie difficoltà. Nell’ambito della depressione post partum, alcuni autori tra cui Cox (1996) e Stern e Kruckman (1983) hanno riscontrato che le madri che subito dopo la nascita del figlio erano sostenute socialmente presentavano livelli più bassi di depressione. Anche per questo Milgrom e Martin hanno previsto di inserire, all’interno del loro modello di trattamento, il coinvolgimento del padre del bambino.
Trattamento farmacologico della depressione post-natale
Discorso a parte merita invece il trattamento farmacologico. Ad oggi i dati di letteratura sull’efficacia del trattamento farmacologico della depressione post partum sono limitati. La motivazione è essenzialmente di tipo etico: le madri sono restie ad assumere farmaci durante il periodo di allattamento per gli effetti che questi potrebbero avere sul bambino. Anche se i pochi studi che sono stati condotti finora sembrano dimostrare che la quantità di farmaci a cui potrebbe essere esposto il bambino è minima (Buist et al., 1998) e che non trattare adeguatamente una depressione post partum potrebbe portare a delle conseguenze cognitive ed emotive più gravi sul bambino (Lanza di Scalea, Wisner, 2010) rispetto al non trattarla affatto, è orientamento diffuso quello di non trattare farmacologicamente queste madri.
Trattamento psicoterapico della depressione post-natale
La terapia cognitivo comportamentale risulta essere una valida alternativa: gli studi realizzati hanno portato a equiparare il livello di efficacia nel breve-medio periodo di TCC e farmaci, evidenziando i risultati migliori della TCC nel lungo periodo. Milgrom e Martin, nella loro analisi sugli approcci più funzionali al trattamento della depressione post partum hanno analizzato anche questo tipo di trattamento, decidendo comunque di non inserirlo all’interno del loro modello di intervento.
A partire dall’analisi dei differenti approcci qui presentati, gli autori hanno elaborato un modello biopsicosociale della depressione post partum. Questo modello tiene conto dei fattori di vulnerabilità come degli elementi socioculturali e scatenanti che hanno portato all’insorgenza della patologia, aiutando le donne a divenirne consapevoli. In seguito, con approccio cognitivo-comportamentale affronta i fattori che aggravano e mantengono la depressione.
Il modello prevede un intervento di gruppo che coinvolge sei-otto partecipanti ed è suddiviso in tre fasi:
interventi comportamentali (fase 1);
interventi cognitivi (fase 2);
prevenzione delle ricadute e valutazione (fase 3).
Gli autori raccomandano di formare i gruppi tenendo presenti alcune caratteristiche delle donne interessate: età, numero dei figli, livello di depressione, status socio-economico e affettivo. E’ importante che all’interno dei gruppi ci sia una certa omogeneità così da stimolare il confronto reciproco e il senso di appartenenza. Milgrom e Martin hanno elaborato un programma suddiviso in moduli specifici e costituito da 9 incontri di circa un’ora e mezza ciascuno. Al termine di questi incontri è prevista una sessione di follow up per verificare i risultati raggiunti e la loro “stabilità”.
Nel corso di ciascun incontro alle madri viene fornito del materiale su cui lavorare sia durante l’ora di terapia sia successivamente, a casa. In ogni sessione infatti alle donne vengono forniti dei compiti a casa che tengono conto del loro essere madri.
Il modello qui presentato è pensato per un trattamento di gruppo. Tuttavia, precisano gli autori, è possibile utilizzarlo anche in terapia individuale.
Interventi comportamentali
Gli interventi comportamentali, previsti nei primi quattro incontri, si rivolgono in particolar modo all’analisi dei fattori scatenanti la patologia (ad esempio le complicazioni durante il parto) e di quelli di vulnerabilità (come la presenza di una relazione problematica con uno o entrambi i genitori) con un particolare focus sui modelli parentali sperimentati ed appresi nel corso dell’infanzia.
Primo incontro
Durante questo incontro il terapeuta (o i terapeuti), dopo essersi presentati, illustrano alle madri gli scopi, le procedure e le aspettative del gruppo. Inoltre propongono alcune regole di base che sono fondamento della buona riuscita della terapia (rispetto della privacy, sostenersi l’un l’altra, partecipare attivamente agli incontri). L’incontro continua con un esercizio di conoscenza in cui le donne hanno il compito di presentarsi alla persona seduta accanto a loro. Il focus durante questa attività è legato al loro essere madre e al vissuto ad esso connesso. Infine viene introdotto il tema principale dell’intervento, ovvero la depressione post natale e la possibilità di farvi fronte.
Secondo incontro
L’incontro si apre esplorando il vissuto legato alla prima sessione e rispondendo alle domande che le madri hanno maturato durante la settimana. Il focus è centrato sul far comprendere quanto emozioni e comportamenti siano connessi tra loro e si affronta in particolare il vissuto depressivo. Il terapeuta spiega che la depressione si sperimenta quando le attività spiacevoli superano quelle piacevoli e che un primo passo verso la guarigione è quello di incrementare queste ultime. Proprio per questo le attività piacevoli vengono in un certo senso prescritte, come se fossero farmaci, e viene affrontato il senso di colpa che nasce nelle madri quando si dedicano a loro.
Terzo incontro
L’incontro è incentrato sull’insegnamento delle tecniche di rilassamento ed in particolare sul rilassamento muscolare progressivo di Jacobson della durata di 30 minuti. Le donne vengono invitate a riconoscere i momenti della giornata più stressanti (spesso dalla sei alle otto del pomeriggio quando in casa ci sono il bambino piccolo, gli altri figli e il marito) e ad applicare le tecniche imparate.
Quarto incontro
L’incontro verte sull’insegnamento delle abilità sociali ed in particolare sull’assertività: “dire agli altri quello che penso e come mi sento”. In questa sessione il terapeuta deve insistere con forza sulla differenza tra essere assertivi ed essere aggressivi poiché spesso le madri tendono a scambiare l’assertività per aggressività. Possono essere utilizzati dei giochi di ruolo per incrementare queste abilità. Si conclude con un affondo sull’autostima e su alcune esercitazioni per incrementarla.
Interventi cognitivi
Gli interventi cognitivi, previsti nei successivi quattro incontri, si concentrano sull’esplorazione dei fattori di mantenimento e di quelli aggravanti la patologia come i pensieri negativi e la presenza di uno scarso supporto sociale. Questi verranno affrontati attraverso la messa in discussione dei processi cognitivi e tramite il problem solving.
Quinto incontro
In questo incontro il tema centrale è la modalità di educazione dei figli e le aspettative. Assume un ruolo preponderante la spiegazione che non esiste uno stile giusto e uno sbagliato, ma semplicemente ogni stile è diverso e deve tener conto delle differenze e delle peculiarità di ciascun figlio.
Sesto incontro
Durante questa sessione viene approfondito il legame tra pensieri ed emozioni. Viene così esplicitato il potere delle autoaffermazioni, sotto forma di pensieri, come strumento per modificare le emozioni negative. Inoltre buona parte dell’incontro è incentrato sulla presentazione del percorso di guarigione dalla depressione post partum che è un percorso in salita e che può prevedere delle “ricadute”.
Settimo incontro
Questo incontro verte sulla capacità di identificare e monitorare le convinzioni erronee legate alla maternità (ad esempio che sia inaccettabile non provare gioia per la maternità o che si debba conoscere tutto sull’accudimento del piccolo per essere una buona madre) e sulle tecniche che permettono di aumentare i pensieri positivi e di diminuire quelli negativi (come l’interruzione del pensiero o lo stabilire un tempo per le preoccupazioni).
Ottavo incontro
Ci si focalizza sulla messa in discussione delle credenze irrazionali e dei pensieri automatici ad esse associati. E’ un incontro particolarmente delicato in cui alcune madri potrebbero trovare delle difficoltà a mettere in pratica quanto suggerito dal terapeuta. Le madri vengono invitate a mettere in discussione i pensieri disfunzionali legati ad una bassa autostima (“se mi sento poco amabile, vuol dire che gli altri non mi amano”), alla doverizzazione e al catastrofismo e all’eccessivo altruismo. A questi pensieri disfunzionali devono essere sostituiti pensieri più costruttivi interrogandosi, ad esempio, sulla veridicità di quanto pensato o sulla corretta attribuzione di importanza.
Prevenzione delle ricadute e valutazione
Questa fase rappresenta il nono ed ultimo incontro ed è funzionale a fare il cosiddetto punto della situazione. E’ importante che il terapeuta incoraggi le madri nel continuare il lavoro iniziato durante il trattamento e che le inviti a considerare la propria famiglia, gli amici e la rete sociale più ampia per essere sostenuta nel suo delicato compito.
Proprio l’importanza che Martin e Milgrom assegnano alla rete sociale e più nello specifico a quella familiare e al partner ha spinto gli autori a creare, all’interno del programma, un modulo aggiuntivo ad hoc sul coinvolgimento del padre nel trattamento della depressione post partum. Il padre viene coinvolto più attivamente alla fine del percorso “di base” anche se è auspicabile renderlo partecipe, informandolo sulla possibilità di questo modulo aggiuntivo, già all’inizio del percorso. Sebbene spesso le madri mostrino perplessità sulla loro disponibilità ad intraprendere questo percorso, la ricerca clinica evidenzia come buona parte dei padri siano interessati e anzi richiedano di essere maggiormente coinvolti.
Gli obiettivi degli incontri di coppia sono molteplici:
dare informazioni sulla natura e sul trattamento della depressione post partum;
fornire strumenti per migliorare la comunicazione tra i genitori;
spiegare in che modo i padri possono gestire al meglio il loro compito al fine di prendersi cura della nuova famiglia;
incoraggiare i padri nel supportare le compagne, anche attraverso l’esercizio del problem solving.
Le nuove tecnologie e il trattamento della depressione post-natale
Il nesso tra nuove tecnologie e interventi psicoterapeutici è un binomio che negli ultimi anni si sta affermando con forza. I bassi costi di sviluppo e implementazione, la sempre maggior fruibilità degli strumenti anche da parte di un pubblico generico e non specializzato e la capillare diffusione degli strumenti 2.0 costituiscono i presupposti per la sperimentazione di tecniche innovative e non convenzionali di terapia. E’ sulla base di queste riflessioni che un team di ricerca della Saint Louis University ha realizzato uno studio pilota sulla fattibilità e sull’efficacia di un protocollo SMS per madri a rischio di depressione post partum. La ricerca, chiamata “Happy Mothers, Healthy Families”, è stata pubblicata sul Journal of Medical Internet Research lo scorso marzo e ha visto coinvolte 54 donne residenti a Saint Louis, in maggioranza afro-americane (82,8%) con un livello di scolarizzazione piuttosto basso (il 25% non aveva completato o frequentato la scuola superiore) e aventi la maggior parte (63,8%) un reddito inferiore ai 15.000 dollari annui.
Per selezionare il campione da includere nel progetto, le donne (reclutate in occasione delle visite pediatriche presso la clinica Cardinal Glennon di Saint Luis) sono state sottoposte a uno screening della Depressione Post Partum. Lo screening è stato attuato tramite la somministrazione di due test: l’EPDS – Edinburgh Postnatal Depression Scale – (Cox, Holden & Sagovsky, 1987) che valutava la possibile presenza di una diagnosi di depressione post partum e il BDI-II – Beck Depression Inventory – (Beck, 1967) che misurava la gravità della depressione. Durante il periodo della ricerca, (6 mesi), le donne ricevevano sul loro telefonino 4 sms a settimana. I messaggi, realizzati ad hoc dal team di ricerca della Saint Luis, erano volti a supportare le madri nel delicato periodo che stavano attraversando fornendo loro sia informazioni di tipo pratico-gestionale sull’accudimento del piccolo, sia incoraggiamenti e supporto sulla bontà di quanto stavano facendo.
Oltre a queste due tipologie di messaggi – informativo e motivazionale/di supporto – alle madri venivano inviati anche messaggi di tipo cognitivo-comportamentale, ovvero volti a stimolare una riflessione sulle distorsioni cognitive cui potevano andare incontro: “Concentrarsi su quello che dovrebbe o potrebbe essere esaurisce le energie; concentrati su quello che puoi ottenere”. In alcuni di questi messaggi inoltre venivano forniti recapiti telefonici a cui poter rivolgersi in caso di bisogno. Al termine della ricerca alle madri è stato chiesto di rispondere a un sondaggio volto a verificare l’efficacia del programma. Oltre l’80% delle donne intervistate hanno dichiarato che il protocollo SMS aveva avuto un’influenza positiva sulla motivazione al cambiamento e sul miglioramento dei sintomi depressivi. Inoltre, risultava molto apprezzata la possibilità di avere un contatto telefonico diretto con dei professionisti che potevano supportarle nel loro meraviglioso e, al tempo stesso, estremamente complesso ruolo di madri.
Quest’ultimo dato fornisce uno spunto di riflessione importante: se è vero che un protocollo SMS può fornire un buon supporto alla terapia, è anche vero che la relazione diretta con un terapeuta rimane fondamentale per il trattamento. Dalla ricerca qui presentata è possibile individuare tre principali punti di forza di questo protocollo:
il basso costo del sistema di SMS permette di coinvolgere nel trattamento della Depressione Post Partum anche quelle donne che appartengono a fasce disagiate della popolazione;
la ricezione quotidiana di SMS porta già di per sé ad una lieve riduzione dei sintomi depressivi delle madri;
gli SMS terapeutici amplificano gli effetti della consulenza psicologica tradizionale.
Come studio pilota questa ricerca presenta dei limiti legati alla scarsità del campione e alla verifica dell’efficacia dell’intervento realizzata unicamente attraverso interviste ai partecipanti. Sarebbe quindi interessante realizzare un nuovo studio ampliando la numerosità dei partecipanti e realizzando dei follow up a 6 mesi e a 1 anno dalla raccolta dei risultati.
ARTICOLO CONSIGLIATO:
Depressione Post-Partum: la tecnologia al servizio della diagnosi
BIBLIOGRAFIA:
- American Psychiatric Association (2014). Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali. Quinta editione. DSM-5. Milano: Raffaello Cortina Editore.
- Agostini, F., Monti, F., Marano, G. & Baiamonte C. (2004). Interazione madre depressa bambino a 9 mesi: differenze di genere. Psychofenia, VII, 11.
- Bayley, N. (1969). Manual for the Bayley scales of infant development. New York: The Psychological Corporation.
- Beck, A.T. (1967). The diagnosis and management of depression. Philadelphia, PA: University of Pennsylvania Press.
- Bettes, B.A. (1988). Maternal depression and motherese: Temporal and intonational features. Child Development, 59, 1089-1096.
- Buist A, Westley D & Hill C. (1998). Antenatal prevention of postpartum depression. Arch Wom Health, 1,167-173.
- Centers for Disease Control and Prevelance of self-reported post partum depressive symptoms – 17 states. (2008). MMWR Morbility and Mortality Weekly Report, 57 (14), 361-366.
- Cicchetti, D., Ganiban, J. & Barnett, D. (1991). “Contributions form the study of high risk populations to understanding the development of emotion regulation” in J. Garber, K. Dodge (a cura di), The development of emotion regulation and disregulation, Cambridge, England: Cambridge University Press.
- Cicchetti, D., Rogosh, F.A. & Toth, S.L. (1998). Maternal depressive disorder and contextual risk: contributions to the development of attchment in security and behavior problems in toddlerhood. Development and Psychopatology, 10, 283-300.
- Cogill, S., Caplan, H., Alexandra, H., Robson, K. & Kumar R., (1986). Impact of postnatal depression on cognitive development in young children. British Medical Journal, 292, 1165-1167.
- Cohn, J.F. & Tronick, E. (1989). Specificity of infants respons to mothers affective behavior. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 28, 242-248.
- Cooper, P.J. & Murray, L. (1997). “Effetti delle terapie per la depressione postpartum sull’umore della madre e sullo sviluppo del bambino”, in Murray L., Cooper P. (a cura di), Depressione del post-partum e sviluppo del bambino. Roma: CIC Edizioni Internazionali.
- Cooper, P.J. & Murray, L. (1998). Fortnightly review: Postnatal depression. British Journal, 316, 1884-1886.
- Cox, J.L., Holden, J.M. & Sagovsky, R. (1987). Detection of postnatal depression. Development of the 10-item Edinburgh Postnatal Depression Scale. British Journal of Psychiatry, 150, 782 -786
- Cox, A.D. (1988). Maternal depression and impact on children’s developments. Archives of Disease in Childhood, 63, 90-95.
- Cox, J.L. (1996). Perinatal mental disorders – a cultural approach. International Review of Psychiatry, 8, 9 -16.
- Downey, G. & Coyne, J.C. (1990). Children of depressed parents: an integrative review. Psychological Bulletin, 108, 50-76.
- Field, T., Sandberg, D., Garcia, R., Vega-Lahr, N., Goldstein, S., & Guy, L. (1985). Pregnancy problems, postpartum depression and early mother-infant interactions. Developmental Psychology, 21(6), 1152-115.
- Gonidakis, F., Rabavilas, A.D., Varsou, E., Kreatsas, G., & Christodoulou, G.N. (2007). Maternity blues in Athens. Greece: a study during the first 3 days after delivery. Journal of Affective Disorders, 99, 107-115.
- Goodman, S.H. & Gotlib, I.H. (1999). Risk for psychopathology in the children of depressed mothers: A developmental model for understanding mechanism of transmission. Psychological Review, 106, 458-490.
- Guedeney. N. & Jeammet P. (2001). Depression Postnatales et decisions d’orientation thérepeutiques, Devenir, 13(3), 51-64.
- Hay, D.F. (1997). “Depressione post-partum e sviluppo cognitivo” in L. Murray e P. Cooper (a cura di), Depressione del post-partum e sviluppo del bambino, CIC Edizioni Internazionali, Roma, 1999.
- Hopkins, W.D. & Bard, K.A (1993). Hemispheric specialization in infant chimpanzees (Pan troglodytes): evidence for a relation with gender and arousal. Developmental Psychobiology, 26, 219-235.
- Kaplan, P. S., Bachorowski, J.A., Smoski, M.J. & Zinser, M. (2001). Role of clinical diagnosis and medication use in effects of maternal depression on infant-directed speech. Infancy, 2, 537–548.
- Kurstjens, S. & Wolke D. (2001). Effects of maternal depression on cognitive development of children over the first 7 years of life. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 42(5), 623-36.
- Lanza di Scalea, T. & Wisner, K.L. (2010). Antidepressivi e terapie ormonali nel trattamento della depressione post-partum. NÓOς, 2, 45-57.
- Lewinsohn, P. M., Antonuccio, D. O., Breckenridge, J. S., & Teri, L. (984). The “Coping with Depression” course. Eugene, OR: Castalia.
- Milgrom J., Martin, P.M. & Negri, L.M. (2003). Depressione Postnatale. Trento: Erickson.
- Monti, F. & Agostini, F. (2006). La depressione post natale. Roma: Carocci.
- Monti, F., Agostini, F. & Martini, A. (2004). Il silenzio degli affetti: la depressione post partum e il bambino. Clinica e ricerca, Contrappunto, 34, 61-87.
- Murray L. (1992). The impact of postnatal depression on infant development. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 33, 43-61.
- Murray, L., Fiori Cowley, A., Hooper. R. & al. (1996). The impact of postnatal depression and associated adversity of early mother- infant interactions and later infant outcome. Child development, 67, 2512-2526.
- Murray, L. & Cooper, P.J. (1997). “Il ruolo dei fattori attribuibili al bambino ed alla madre nella depressione post-partum, i rapporti madre-figlio e gli esiti nel bambino” in Murray L., Cooper P. (a cura di), Depressione del post-partum e sviluppo del bambino, CIC Edizioni Internazionali, Roma, 1999.
- Murray, L. & Cooper, P. (2003). lntergenerational transmission of affective and cognitive processes associated with depression, infancy and the preschool years. London: Oxford University Press.
- Najman, J.M., Anderson, M.H., Bor, W., O’Callaghan, M.J., & Williams, G.M. (2000). Postnatal depression – myth and reality: maternal depression before and after the birth of a child. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 35, 19-27.
- O’Hara M.W., Zekpski, E.M., Philipps, L.H. & Wright, E.J. (1990). Controlled prospective study of post partum mood disorders: comparison of childbearing and nonchilbearing women. Journal of Abnormal Psychology, 99, 3-15.
- Olioff, M. (1991). The application of cognitive therapy to postpartum depression. In: T. M. Vallis, J. L. Howes, J. L. & P C. Miller (Eds.), The challenge of cognitive therapy: Applications of non-traditional populations. New York: Plenum Press.
- Reissland, N., Sheperd, J., & Herrera, E. (2003). The pitch of maternal voice: a comparison of mothers suffering from depressed mood and non-depressed mothers reading books to their infants. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 44,1-7.
- Righetti-Veltema, M., Bousquet, A. & Manzano, J. (2003). Impact of Postpartum Depressive Symptoms on mother and her 18-month-old infant. European Child and Adolescent Psychiatry, 12, 75-83.
- Seifer, R., Dickstein, S., Sameroff, A.J., Magee, K.D. & Hayden, L.C. (2001). Infant mental health and variability of parental depression symptoms. Child & Adolescent Psychiatry. 40, 1375-1382.
- Sharp, D., Hay, D.F., Pawlby, S., Schumucker, G., Allen & H., Kumar, R. (1995). The impact of postnatal depression on boys’ intellectual development. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 36, 1315-1336.
- Spieker, S.J. & Booth, C.L. (1988). Maternal antecedents of attachment quality. In Belsky, J. & Nezworsky, T. (a cura di), Clinical implications of attachment, 95-135.
- Stanley, C., Murray, L. & Stein, A. (2004). The effect of postnatal depression on mother-infant interaction, infant response to the still-face perturbation, and performance on a instrumental learning task. Development and Psychopatology, 11-18.
- Stern, G. & Kruckman, L. (1983) .Multidisciplinary perspectives on postpartum depression: an anthropological critique. Social Science and Medicine, 17, 1027-1041.
- Utzgiris, I.C. & Hunt, J. McV. (1975). La valutazione nella prima infanzia. Scale ordinali dello sviluppo psicologico. Scandicci: La Nuova Italia Editrice.
- Winnicott D.W. (1965). The role of maternal care in the maturational process facilitating environment. London: Hogarth Press.
- Zaccagnino M. (2009). I disagi della maternità: Individuazione, prevenzione e trattamento. Milano: Franco Angeli.