L’arte di comunicare con gli altri e in terapia di Francesco Aquilar
Il libro Parlare per capirsi, scritto da Francesco Aquilar ed edito da Franco Angeli, apre una finestra sul mondo della comunicazione, arte quotidianamente utilizzata per poter interagire con l’altro in ogni ambito della vita.
Capita, spesso di non riuscire a comunicare sempre in maniera efficacie quello che si pensa, e questo porta a una compromissione dei rapporti e delle relazioni, anche in ambito terapeutico.
Ed è proprio su come riuscire a comunicare in maniera efficace che si focalizza que sto libro. Mira, infatti, a esplorare i diversi aspetti della comunicazione inter-personale e sociale non solo nelle diverse situazioni di vita, ma, anche, nella psicopatologia, con l’obiettivo di indicare le modalità che permettono di uscire da un empasse comunicativo.
Lo scopo, dunque, è quello di migliorare la qualità della vita migliorando la qualità della comunicazione.
Ognuno di noi comunica secondo una propria modalità che riflette, inevitabilmente il proprio modo di essere ed è figlia dell’ambiente nel quale si è vissuti. Questo perché la forma della comunicazione dipende dalle caratteristiche personologiche presentate, dal carattere che ognuno possiede e, di conseguenza, dal tipo di organizzazione di personalità mostrata. Quindi, è possibile identificare alcune forme di comunicazione efficaci e inefficaci tipiche di alcune strutture di personalità.
Individuare dei modelli comunicativi permetterebbe non solo di capire in che modo si affrontano le relazioni, ma anche, e soprattutto, quali conseguenze adducono.
Il libro si divide sostanzialmente in tre parti: una didattica, in cui si parla largamente delle difficoltà di co municazione incontrate in una serie di situazioni significative, come la famiglia, il partner, gli amici, etc., una psicoterapeutica, in cui sono illustrate le modalità secondo cui è possibile implementare le abilità di comunicazione grazie ad una serie di tecniche riferitesi alla terapia cognitiva e cognitiva-sociale, e, infine, una scientifica, dove si fa riferimento alla letteratura, per capire cosa è più idoneo adottare nella comunicazione partendo dai dati empirici.
In generale, è possibile affermare che l’esperienza del comunicare permette di apprendere sempre cose nuove e innovative e questo è importante non solo nella relazione con gli altri, ma anche per incrementare il proprio dialogo interiore in maniera funzionale e non fallace.
Ma oltre al dialogo con gli altri esiste il dialogo interno. Come possiamo parlare con noi stessi per capirci? Come possiamo usare il nostro dialogo interiore per aumentare lo stato di benessere e le emozioni positive, distaccandoci dagli stati negativi?
La strada più semplice da adottare sembrerebbe quella dell’Auto-Osservazione Guidata che favorisce la consapevolizzazione dei propri pensieri, delle proprie emozioni, delle proprie azioni e delle proprie conclusioni e prospettive.
Ogni metodo di Auto-Osservazione Guidata, il più famoso è l’ABC proposto da Ellis, consente di avere una maggiore coscienza del proprio modo di pensare e delle possibili conseguenze.
In questo libro la tecnica di auto-osserva zione proposta dall’autore è identificata con l’acronimo SEMPRE, che renderebbe possibile aumentare le proprie capacità di auto-osserva zione e di integrazione consapevole fra pensieri, emozioni e azioni.
Cosa significa SEMPRE?
S :Situazione, contesto, ante fatto, premessa;
E :Emozioni, stati d’animo, stati corporei
M: Meta-emozioni: cosa ho provato per aver provato “E”
P:Pensieri, idee, immagini mentali
R:Risposta: Che cosa ho fatto io e che cosa hanno fatto gli altri;
E:Esito: Come è andata a finire e che ho imparato dall’evento
In sostanza questo schema permetterebbe di essere coscienti di cosa accade dentro di noi e consente, in questo modo, di essere guardinghi su cosa determina malessere e come poterlo affrontare in maniera funzionale. Insomma, mette ordine al dialogo interiore permettendo di individuare in maniera strutturata il problema, le conseguenze e le alternative che poi, una volta comprese, possono essere anche comunicate all’altro in maniera funzionale.
Per concludere, dopo aver capito cosa comunicare possiamo farlo in modo efficacie seguendo i suggerimenti riportati nel libro:
– stiamo attenti a noi stessi e agli altri per negoziare migliori soluzioni e goderci mag giormente la comunicazione e le relazioni;
– decentriamo e descriviamo con chiarezza il nostro punto di vista.
– legittimiamo e ridimensioniamo le emozioni e le opinioni degli altri
– prendiamoci cura psichica e fisica di noi stessi e degli altri
– ricordiamoci dei valori personali, che sono in una gerarchia diversa per ciascuno,
– evitiamo di ripetere le stesse cose per evitare circoli viziosi inutili, monotoni, ripetitivi, inefficaci
– sviluppiamo noi stessi tenendoci in esercizio mentale
– dividiamo la torta in parti uguali, ma non dimentichiamoci della nostra parte. legittimando una parte di sano egoismo.
– dedichiamo tempo a situazioni che ci portino gioia procedendo verso i propri obietti vi realizzabili.
– lasciamo liberi noi stessi e gli altri non cercando di organizzare gli altri secondo i propri schemi mentali
– incrementiamo la creatività dedicando un po’ di tempo e di attenzione a cose che piaccino
– esercitiamo la memoria non solo su cose e episodi negativi, ma anche di quelli positivi.
La speranza è che, imparando a comunicare meglio, ognuno di noi possa non solo tollerare, ma anche amare e apprezzare la diversità da sé, e concepirla e viverla come ricchezza e anche come straordinario antidoto alla solitudine e alla noia esistenziale.
ARTICOLO CONSIGLIATO:
Riconoscere le emozioni di Francesco Aquilar – Recensione
BIBLIOGRAFIA:
- Aquilar, F. (2013). Parlare per Capirsi. Strumenti di psicoterapia cognitiva per una comunicazione funzionale. Franco Angeli Editore. ACQUISTA ONLINE




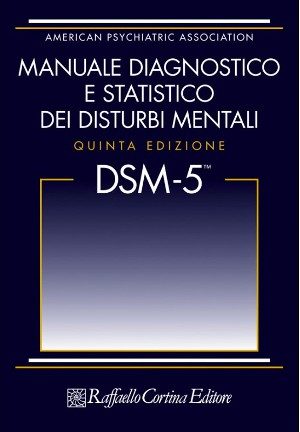
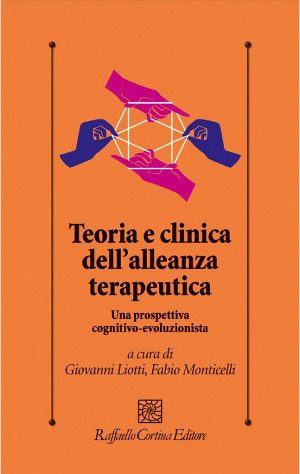 Negli otto capitoli di cui è composto il libro, divisi tra teoria e pratica terapeutica, si enuclea dettagliatamente il concetto di alleanza terapeutica. Attraverso la presentazione di casi clinici e di ricerche scientifiche svolte nell’ambito, i concetti qui brevemente sintetizzati trovano maggiore spazio e dimensione.
Negli otto capitoli di cui è composto il libro, divisi tra teoria e pratica terapeutica, si enuclea dettagliatamente il concetto di alleanza terapeutica. Attraverso la presentazione di casi clinici e di ricerche scientifiche svolte nell’ambito, i concetti qui brevemente sintetizzati trovano maggiore spazio e dimensione.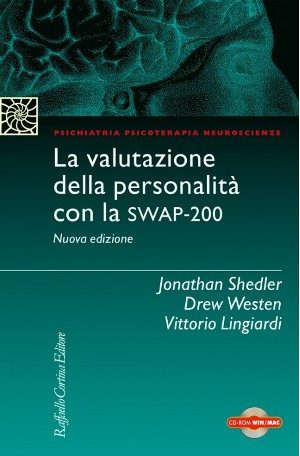 Lo scopo degli autori (impegnati da oltre 15 anni in tale progetto) è stato quello di sviluppare una metodologia di valutazione della personalità che colmasse lo spazio concettuale che intercorre tra la necessità dei clinici di uno studio complesso del paziente – dove peculiari componenti strutturali e funzionali risultano embricate tra loro – e il rigore dei dati empirici derivati dalla ricerca.
Lo scopo degli autori (impegnati da oltre 15 anni in tale progetto) è stato quello di sviluppare una metodologia di valutazione della personalità che colmasse lo spazio concettuale che intercorre tra la necessità dei clinici di uno studio complesso del paziente – dove peculiari componenti strutturali e funzionali risultano embricate tra loro – e il rigore dei dati empirici derivati dalla ricerca.

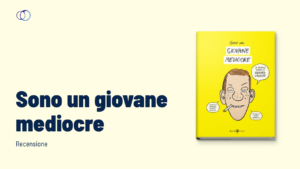

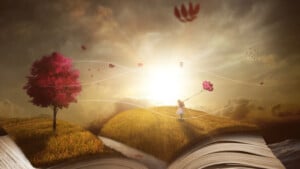
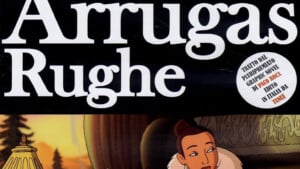
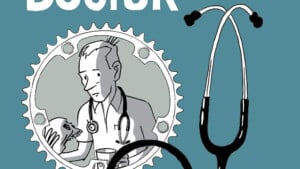
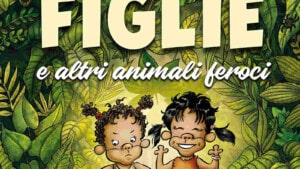


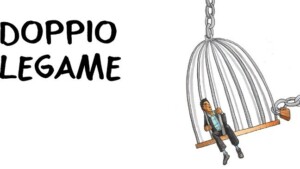
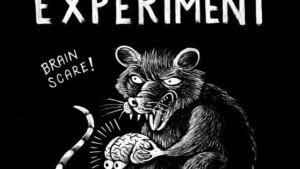



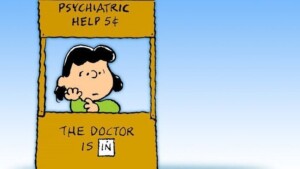
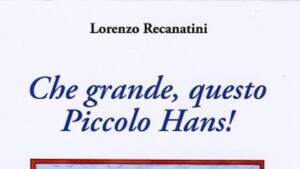
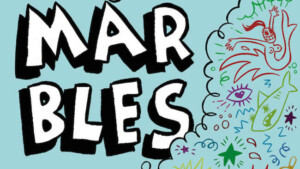


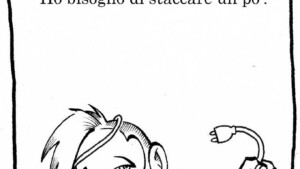

 Nel trattamento del tabagismo sia il trattamento farmacologico sia l’approccio di tipo psicologico si sono rivelati efficaci. Quale che sia l’approccio psicologico, la fase diagnostica iniziale è determinante.
Nel trattamento del tabagismo sia il trattamento farmacologico sia l’approccio di tipo psicologico si sono rivelati efficaci. Quale che sia l’approccio psicologico, la fase diagnostica iniziale è determinante.