Ricerca: caratteristiche e qualità del rapporto di coppia nella famiglia omogenitoriale – LGBT
Lo scopo della ricerca è quello di esplorare le dinamiche delle coppie gay e lesbiche tramite un questionario strutturato che indaga il livello di soddisfazione/insoddisfazione dei/delle partner in vari ambiti, tra cui il rapporto con i figli e la loro educazione.
I risultati dei questionari verranno in seguito confrontati con quelli di coppie eterosessuali al fine di far emergere analogie e difformità tra le tre tipologie di coppia. Il presente studio potrà fornire spunti di riflessione per successive ricerche che hanno l’obiettivo di approfondire le tematiche dell’omogenitorialità e della qualità della relazione delle coppie gay e lesbiche.
Un’indagine della Scuola di Psicologia dell’Università degli Studi di Firenze: un lavoro di ricerca che studia la qualità della relazione nelle coppie gay e lesbiche con figli. La ricerca sarà svolta in collaborazione con il Dott. Paolo Antonelli e il Prof. Davide Dèttore del Dipartimento di Scienze della Salute dell’Università degli Studi di Firenze.
L’argomento della nostra ricerca supporta la tesi, condivisa e dimostrata dalla comunità scientifica internazionale, secondo la quale la capacità genitoriale delle persone omosessuali è totalmente sovrapponibile a quella delle persone eterosessuali. L’adeguatezza e la competenza nell’accudire e crescere i propri figli non dipende dall’orientamento sessuale dei genitori, ma dalla loro capacità di offrire affetto e cure necessarie a garantire uno sviluppo psicologico ed emotivo equilibrato. Gli studi più recenti dimostrano che l’orientamento sessuale non compromette in nessun modo la salute mentale dei genitori, né influenza negativamente le abilità genitoriali.
Per qualsiasi dubbio o chiarimento relativo alla compilazione del questionario, Potete contattare la responsabile dello studio (Dott.ssa Vanessa Magazzini) al: 347-1271876 oppure all’indirizzo e-mail [email protected].
PARTECIPA ALLA RICERCA!
ATTENZIONE! IL QUESTIONARIO E’ ANONIMO MA DEVE ESSERE COMPILATO DA ENTRAMBI I MEMBRI DELLA COPPIA
ARGOMENTI CORRELATI:
LGBT – FAMIGLIA
ARTICOLO CONSIGLIATO:
Le Famiglie Omogenitoriali nella Scuola e nei Servizi Educativi – Report da Firenze 2014
Donne nella grande guerra. Presentazione del libro
Qual è stato il ruolo delle donne italiane nella Grande Guerra? In tutti i paesi belligeranti, il conflitto fu un’occasione di emancipazione per le donne, che si trovarono a rimpiazzare in molte funzioni gli uomini partiti per il fronte, e in qualche modo andarono in guerra anche loro: come crocerossine, in Carnia come portatrici, nelle retrovie come prostitute a sollievo delle truppe. Ma il libro ci racconta anche di una spia, di un’inviata di guerra, della regina Elena che trasformò il Quirinale in ospedale, delle intellettuali che militarono pro o contro la guerra: da Margherita Sarfatti a Eva Amendola e Angelica Balabanoff, alla dimenticata maestra antimilitarista Fanny Dal Ry, per finire con Rosa Genoni, pioniera della moda italiana, che abbandona il lavoro e si batte contro la guerra.
Le autrici del volume fanno parte di Controparola, un gruppo di giornaliste e scrittrici nato nel 1992 per iniziativa di Dacia Maraini. Come opere collettive hanno pubblicato anche Piccole italiane (Anabasi, 1994), Il Novecento delle italiane (Editori Riuniti, 2001), Amorosi assassini (Laterza, 2008) e, con il Mulino, Donne del Risorgimento (2011).

Raccontare e definire se stessi: analisi dei temi di vita con l’Adult Attachment Interview
 Nell’accingersi a raccontare e a raccontarsi la propria storia, ciascuno, contribuisce alla definizione di Sé, alla costruzione di un’identità individuale sollevando domande, ponendo questioni, azzardando ipotesi e provando ad impreziosire e personalizzare, con i propri sensi e significati, le esistenze.
Nell’accingersi a raccontare e a raccontarsi la propria storia, ciascuno, contribuisce alla definizione di Sé, alla costruzione di un’identità individuale sollevando domande, ponendo questioni, azzardando ipotesi e provando ad impreziosire e personalizzare, con i propri sensi e significati, le esistenze.
La costruzione di storie, di intrecci narrativi e trame di vita, appartiene, in modo imprescindibile, a tutte le culture, popoli, etnie, nelle varie epoche, attraversando l’umanità intera.
Nell’accingersi a raccontare e a raccontarsi la propria storia, ciascuno, contribuisce alla definizione di Sé, alla costruzione di un’identità individuale sollevando domande, ponendo questioni, azzardando ipotesi e provando ad impreziosire e personalizzare, con i propri sensi e significati, le esistenze.
Sull’indicazione di cinque attrattori di significato, tra le tante storie, quelle riguardanti i racconti di attaccamento e accudimento tra bambino e caregivers nella prima infanzia, possono prestarsi a fungere da traccia per i temi critici dell’Amore, del Valore, del Potere, della Libertà e della Verità.
Quesiti quali: “Esistono i temi di vita radicati nelle storie reali delle persone? Sono costrutti teorici indipendenti l’uno dall’altro? O si intrecciano semanticamente tra loro? Come è possibile ravvisare la loro presenza nei racconti?”, hanno ispirato e guidato uno studio descrittivo dalla natura squisitamente qualitativa nell’osservare l’emergere, implicitamente ed esplicitamente, delle tematiche narrative attraverso l’analisi metodica e sistematica delle parole scelte da 20 soggetti intervistati attraverso l’Adult Attachment Interview.
Coniugando una prima metodologia di stampo bottom up, coniata dalla Grounded Theory, ad un approccio top down, l’esame linguistico ha reso possibile una misurazione qualitativa, con la creazione di un vocabolario ad hoc, e una quantitativa, attraverso la rilevazione delle frequenze dei vocaboli, dei temi di vita. In questo modo, la descrizione, ha potuto avanzare da un’iniziale prospettiva lessicale ad un’ottica più semantica dove i temi si connettono, si sovrappongono e sono collegati da una linea sottile di sfumature di significato. L’analisi, con i suoi risultati, porta verso una validazione della teoria stessa e, nell’andamento ciclico e ricorsivo qualitativo, a nuove ipotesi esplorative che tengono conto di reti concettuali più ampie che fanno da sfondo narrativo ai temi di vita.
Abstract
Parole chiave: Temi di Vita, Adult Attachment Interview, analisi lessicale, approccio narrativo, semantica
Sullo sfondo dell’approccio narrativo e della teoria delle tematiche critiche di Veglia (1999) è stata condotta un’indagine qualitativa finalizzata ad esplorare criticamente, da un punto di vista squisitamente lessicale, cinque Temi di Vita: Amore, Valore, Potere, Libertà, Verità. Ai fini dello studio sono state passate in rassegna venti interviste di soggetti alle prese con la ricostruzione delle proprie esperienze di attaccamento con i caregivers; in queste storie di vita si è ipotizzato che tra le parole scelte dagli individui per allestire le loro narrazioni vi fossero vocaboli emblematici e concettualmente rappresentativi delle tematiche di vita. L’intento è stato quello di giungere alla realizzazione di un vocabolario di termini potenzialmente salienti ed indicativi della presenza dei temi all’interno di resoconti autobiografici analizzati e di confrontare la loro ricorrenza all’interno delle categorie degli state of mind per offrire spunti di riflessione utili a supportare, approfondire o eventualmente corroborare la teoria. Utilizzando una prima metodologia, di stampo deduttivo, sono state rintracciate nei testi, tra tutte le parole, quelle supposte come semanticamente più affini alla teoria proposta dall’Autore. In un secondo momento, è stata rilevata la loro frequenza mediante uno strumento di analisi testuale che ha permesso di stabilire confronti tra le varie ricorrenze e di istituire parallelismi con altre porzioni di testo in cui è stata inserita un’apposita domanda “tematica”. I risultati ottenuti hanno permesso di argomentare eventuali nessi semantici e avanzare l’ipotesi di reti concettuali in cui i Temi sono intimamente connessi e le categorie di significato inizialmente argomentate sfumano magistralmente l’una nell’altra.
Abstract
Keywords: Life Themes, Adult Attachment Interview, lexical analysis, narrative approach, semantic
In the background of the narrative approach and of the theory of critical themes (Veglia, 1999) was conducted a qualitative survey aimed to explore critically, from a purely lexical point of view, five life themes: Love, Value, Power, Freedom, Truth.
For the purposes of the study were reviewed twenty interviews with subjects grappling with the reconstruction of their own experiences of attachment with the caregivers; in these stories of life it is assumed that between the words chosen by individuals to establish their narratives there were emblematic words representative of the issues of life.
The aim was to achieve the implementation of a vocabulary of terms potentially salient and indicative of the presence of the themes within autobiographical reports analyzed and compare their occurrence within the categories of state of mind to offer insights useful to support, deepen or possibly corroborate the theory. Using a first deductive methodology, were traced in the texts, between all the words, those suppositories as semantically more akin to the theory proposed by the Author. In a second time, it has been detected their frequency by means of an instrument of textual analysis that has allowed us to establish comparisons between the various frequencies of words and to establish parallels with other portions of text which has been inserted a special “thematic” question. The results obtained have allowed to argue any semantic links and hypothesis of conceptual networks in which Life Themes are intimately connected, and categories of significance initially argued soften masterfully one into the other.
SCARICA ARTICOLO COMPLETO
ARGOMENTI CORRELATI:
ATTACCAMENTO – TEORIA DELL’ATTACCAMENTO – PREMIO 2013 – PREMIO STATE OF MIND
ARTICOLO CONSIGLIATO:
Intervista a John Bowlby. Londra 1990 (A cura del Prof. Leonardo Tondo)
Autore dell’articolo:
Dott.ssa Alessia Ricci. Articolo tratto dalla tesi di laurea magistrale discussa il 13/11/2012 presso la Facoltà di Psicologia dell’Università degli Studi di Torino dal titolo “La lettura delle narrative personali attraverso la teoria dei Temi di Vita”, (relatore Prof. Fabio Veglia) durante l’anno accademico 2011/2012 del corso di Laurea in Psicologia Clinica e di Comunità.
Questo articolo ha partecipato al Premio State of Mind 2013
Oltre la Violenza: nasce a Napoli il primo sportello del Sud Italia per uomini violenti
 Il servizio è rivolto a uomini autori di violenza o che esprimono difficoltà a vivere rapporti non conflittuali con l’altro sesso, parenti, familiari o conoscenti di autori di violenza e operatori di servizi che nella loro pratica professionale entrano in contatto con fenomeni di maltrattamento e di violenza.
Il servizio è rivolto a uomini autori di violenza o che esprimono difficoltà a vivere rapporti non conflittuali con l’altro sesso, parenti, familiari o conoscenti di autori di violenza e operatori di servizi che nella loro pratica professionale entrano in contatto con fenomeni di maltrattamento e di violenza.
‘Oltre la violenza’ (O.L.V.). Si chiama così lo sportello istituito dall’Asl Na1Centro e rivolto agli uomini responsabili di violenze di genere. Il servizio è completamente gratuito ed è il primo nel suo genere in Campania e tra i primi in tutto il sud Italia nell’ambito della sanita’ pubblica.
Lo sportello sarà inaugurato a maggio presso la sede del’Unità Operativa di Psicologia Clinica in Piazza Nazionale, sarà aperto il venerdì pomeriggio e si avvarrà della collaborazione volontaria dell’Ente di ricerca ‘Anima’ per lo svolgimento di consulenze on-line e dell’Associazione di promozione sociale ‘Pensare Più’ (i cui membri da molti anni collaborano in forma volontaria con l’Unità Operativa), che si occuperà di allestire spazi di riflessione attraverso gruppi di sostegno e di auto aiuto e si farà promotrice, attraverso diverse forme di progettualità, di una cultura della non violenza.
In attesa dell’inaugurazione, sarà possibile già prendere contatti telefonando al 3385004398 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 15, il mercoledì e venerdì dalle 16 alle 18), inviando un messaggio alla pagina Facebook ‘O.L.V.’ o scrivendo una mail all’indirizzo [email protected].
Il servizio è rivolto a uomini autori di violenza o che esprimono difficoltà a vivere rapporti non conflittuali con l’altro sesso, parenti, familiari o conoscenti di autori di violenza e operatori di servizi che nella loro pratica professionale entrano in contatto con fenomeni di maltrattamento e di violenza.
Oltre ai colloqui individuali e ai gruppi di sostegno e di auto aiuto, sarà possibile richiedere consulenze psicologiche on line attraverso il sito www.animaonline.org, anche per garantire un livello ancora maggiore di anonimato.
Psicologa referente del progetto è la vulcanica Antonella Bozzaotra, presidente dell’Ordine degli Psicologi della Campania e didatta dell’IIPR (Istituto Italiano Psicoterapia Relazionale) presso la sede di Napoli, che abbiamo intervistato per meglio comprendere le ragioni che sottendono la creazione di questo nuovo Servizio.
Dottoressa Bozzaotra perché dedicare uno sportello agli uomini violenti?
Quello della violenza di genere è, a mio avviso, un fenomeno molto complesso che richiede una molteplicità di interventi di contrasto che abbraccino tutto il contesto sociale nel quale la violenza si esplica. Dedicare uno spazio agli uomini violenti, consapevoli delle proprie difficoltà, è a mio avviso assolutamente necessario per offrire loro la possibilità di ripensare la propria storia e poter così tentare di porre fine alla reiterazione del reato.
Non crede possa essere interpretato in modo sbagliato offrire un intervento di cura a chi è stato carnefice di brutali violenze?
Come ho già detto lo sportello si rivolge a uomini che sono già consapevoli della gravità del reato commesso e che hanno voglia di mettersi in discussione. Allargare la possibilità di intervento all’intero contesto socio-culturale comprendendo anche gli uomini maltrattanti sarà la risposta più efficace che si potrà mettere su contro la violenza di genere, non dimenticando nel frattempo di allestire contesti di promozione di una cultura della non-violenza: sono convinta che presto anche gli scettici se ne renderanno conto.
Ci parla dello staff dell’O.L.V.? Da chi è costituito?
Proprio per fornire risposte complesse che agiscano sull’intero contesto socio-culturale in cui la violenza di genere attecchisce, lo staff del nuovo sportello sarà multidisciplinare, costituito da psicologi, un’assistente sociale e un’infermiera professionale. L’O.L.V. è uno sportello innovativo sia perché attraverso esso la sanità pubblica si occuperà di qualcosa generalmente appannaggio del mondo delle associazioni e del privato sociale, sia perché stileremo un protocollo d’intesa con un ente di ricerca per osservare questo fenomeno, allargando lo sguardo. Siamo consapevoli che si tratta di una sfida complessa, perché è facile schierarsi a favore di chi subisce violenza, ma chi commette violenza è parte di questo fenomeno e non va dimenticato.
Simbolo dello sportello è un bagna asciuga, ci spiega la scelta di tale immagine?
Perché in materia di violenza i confini sono sempre molto sottili… quando si parla di violenza si parla anche di relazioni, contesti… tutti aspetti complessi che difficilmente possono essere circoscritti in modo lineare.
ARGOMENTI CORRELATI:
PSICOLOGIA & PSICHIATRIA PUBBLICHE – ABUSI E MALTRATTAMENTI
ARTICOLO CONSIGLIATO:
Legge anti stalking: novità e criticità – Report dal convegno
Dimmi che musica ascolti e ti dirò quanti anni hai! La musica e le fasi della vita
Un nuovo studio suggerisce che, nonostante il nostro interesse per la musica possa diminuire con l’avanzare dell’età, i nostri gusti musicali cambiano negli anni, adattandosi alle varie fasi della vita e alle sfide, sempre diverse, che questa ci propone.
L’esplosione del consumo di musica nel corso dell’ultimo secolo ha trasformato ciò che ascoltiamo in qualcosa che ci descrive, che parla di noi, in poche parole in un costrutto di personalità.
Ora un nuovo studio suggerisce che, nonostante il nostro interesse per la musica possa diminuire con l’avanzare dell’età, i nostri gusti musicali cambiano negli anni, adattandosi alle varie fasi della vita e alle sfide, sempre diverse, che questa ci propone.
Una delle tesi sostenute dai ricercatori è che ci avviciniamo alla musica per mettere alla prova la nostra identità e definire noi stessi, poi la utilizziamo come veicolo sociale per stabilire l’appartenenza al gruppo e trovare un partner, infine la usiamo come solitaria espressione del nostro intelletto, del nostro status e per una maggiore comprensione emotiva.
Lo studio, pubblicato sul Journal of Personality and Social Psychology, è il primo a documentare il modo in cui le persone interagiscono con la musica dall’adolescenza alla mezza età.
Utilizzando i dati raccolti da più di un quarto di milione di persone per un periodo di dieci anni , i ricercatori hanno diviso i generi musicali in cinque grandi categorie che hanno chiamato MUSIC model – dolce, senza pretese , sofisticato , intenso , contemporaneo – e tracciato modelli di preferenza per fasce d’età .
Queste cinque categorie comprendono generi diversi che condividono tratti musicali e psicologici comuni, come ad esempio l’intensità e la complessità.
Lo studio ha scoperto che, ovviamente, la prima grande epoca musicale è l’adolescenza: definita da un breve picco di intenso (come il punk e il metal, che declina prima dell’età adulta, segna l’inizio di un costante aumento di contemporaneo – come il pop e rap) fino alla mezza età.
L’adolescenza è dominata dalla necessità di definire la propria identità e la musica è un modo economico ed efficace per farlo, sostiene Jason Rentfrow, ricercatore senior dello studio.
La rivendicazione dell’autonomia e dell’indipendenza è una delle sfide della vita che gli adolescenti affrontano anche grazie alla musica: la scelta di una musica intensa, aggressiva, caratterizzata da forti suoni distorti, ha quella connotazione ribelle che permette loro di sentire una contrapposizione con i genitori e l’istituzione.
La preferenza per l’intenso, nella prima età adulta, cede il passo alla crescente ondata di contemporaneo e all’introduzione del dolce (come l’elettronica e l’R & B). Queste due dimensioni privilegiate sono considerate romantiche, emotivamente positive e ballabili, scrivono i ricercatori.
Una volta superata la fase del bisogno di autonomia, la sfida successiva riguarda il trovare l’amore e di essere amati e più in generale coinvolge il tema dell’accettazione da parte degli altri: queste forme di musica rafforzano il desiderio di intimità e fanno da sfondo ai contesti in cui le persone si uniscono con l’obiettivo di stabilire rapporti stretti, come feste, bar, discoteche e così via.
L’ultima epoca musicale identificata dai ricercatori è quella dominata dalla musica sofisticata (come il jazz e classica) e senza pretese (come country, folk e blues), che comincia con la mezzà età.
Entrambe sono viste come positive e rilassanti. La sofisticata esprime gusto estetico, cultura e intelligenza, che potrebbero anche essere legati allo status sociale, mentre quella senza pretese riecheggia i sentimenti della famiglia, dell’amore e della perdita, cioè una musica, anche in questo caso, che parla delle esperienze salienti in questa fase della vita.
ARGOMENTI CORRELATI:
MUSICA
ARTICOLO CONSIGLIATO:
Strange but true: Music doesn’t make some people happy – Psicologia
BIBLIOGRAFIA:
- Bonneville-Roussy, A., Rentfrow, P.J., Xu, M.K., Potter, J. (2013). Music through the ages: Trends in musical engagement and preferences from adolescence through middle adulthood. J Pers Soc Psychol, 105(4):703-17. doi: 10.1037/a0033770. Epub 2013 Jul 29.
Vittorio Lingiardi: Le neuroscienze sono oggi imprescindibili per capire la psiche
Un articolo di Vittorio Lingiardi, pubblicato sul Sole 24 Ore di Domenica 18 Maggio 2014
Le neuroscienze sono oggi imprescindibili per capire la psiche

Il dialogo con altri saperi disciplinari, in particolare le neuroscienze cognitive e l’infant research, si rivela necessario per qualunque ipotesi sul funzionamento psichico…
All’origine dell’esperienza psichica: divenire soggetti è il titolo del diciassettesimo congresso della Società Psicoanalitica Italiana (SPI). Si svolgerà presso l’Università degli Studi di Milano dal 22 al 25 maggio e a giudicare dal programma molte relazioni affronteranno il tema, che più freudiano non si può, della formazione delle strutture psichiche. Come sappiamo, le psicoanalisi sono molte, ma nessuna può sottrarsi all’arduo compito di definire che cosa intende per “struttura psichica”. Per questo ci sembra appropriata l’idea di inserire nel titolo quel “divenire soggetti” che sembra richiamare il complicato divenire se stessi in tempi di identità, psichiche e sociali, indefinite e a volte fragili. Ma, soprattutto, che sembra interrogarsi sugli ingredienti del processo di soggettivazione.
«L’incontro tra gli elementi idiomatici e le qualità dell’accudimento – dice Tiziana Bastianini, segretaria scientifica della SPI – dà luogo a una relazione in cui si sviluppa la nostra soggettività. Un processo che la teoria psicoanalitica ha raccontato con diverse metafore: contenimento, holding, riconoscimento, sintonizzazione affettiva». E che, aggiungerei, vive della tensione tra unico e molteplice e della capacità, direbbe Bromberg, di stare tra gli spazi. Infine, continuando a circumnavigare il titolo del convegno, nelle parole “origine” e “soggetto” ravvisiamo l’intenzione di riportare la psicoanalisi alla centralità della funzione materna senza consegnarsi alla nostalgia di un patriarcato perduto.
Temi che non possono più essere affrontati dalla posizione di «(non troppo) splendido isolamento», per usare la nota espressione di Fonagy, in cui a lungo parte della psicoanalisi si era rifugiata. Il dialogo con altri saperi disciplinari, in particolare le neuroscienze cognitive e l’infant research, si rivela necessario per qualunque ipotesi sul funzionamento psichico.
Sembra dunque intersoggettività la parola chiave di questo convegno, come anche dimostra la scelta di conferire il Premio Musatti a Vittorio Gallese, neuroscienziato dell’Università di Parma, autore, con Rizzolatti e altri, della scoperta dei “neuroni specchio” (una classe di neuroni che si attiva quando compiamo un’azione e anche quando solamente osserviamo un altro che compie quell’azione) e ideatore della teoria intersoggettiva della “simulazione incarnata” (uno specifico meccanismo mediante il quale il nostro sistema cervello/corpo modella le proprie interazioni con il mondo, processo non metarappresentazionale dove l’intercorporeità descrive un aspetto cruciale dell’intersoggettività). «Rispetto alle teorie dello sviluppo infantile – leggiamo nelle motivazioni al Premio – si comprende oggi che il processo di graduale riconoscimento dell’oggetto come soggetto indipendente, dotato di una propria realtà psichica, non passa solo per le vie della mentalizzazione e della rappresentazione simbolica, attraverso le quali egli formula inferenze cognitive sulle intenzioni proprie e altrui, ma anche attraverso accessi mimetici preriflessivi, molto più diretti e automatici, la cui mediazione è corporea».
La scelta di un esecutivo psicoanalitico di premiare l’ingegno scientifico di Gallese vuole sottolineare la centralità del dialogo tra discipline biologiche e psicologiche. «Un approccio neurobiologico alla comprensione dei processi mentali – scrive del resto Gallese – non può limitarsi a indagare la relazione tra i concetti con cui li descriviamo e le aree cerebrali che si attivano durante l’applicazione di tali concetti, ma deve studiare come dal sistema cervello-corpo nelle sue situate relazioni mondane scaturisca l’attività mentale e venga recepita quando espressa dagli altri. Detto altrimenti, il livello di descrizione offerto dalle neuroscienze cognitive è necessario ma non sufficiente. Dobbiamo partire dal tema dell’esperienza degli individui, decostruirla, naturalizzarla studiandola con l’indagine sub-personale propria delle neuroscienze, e utilizzare i risultati così ottenuti per ridiscutere il livello personale da cui eravamo partiti, instaurando così un virtuoso circolo conoscitivo».
In un momento in cui è forte il rischio di polarizzare il confronto (come la formula neuromania vs neurofobia ci vuole ricordare) è importante affermare, e questo premio sembra farlo, che discipline diverse possono e devono mantenere la loro autonomia senza per questo rinunciare a un’inevitabile interdipendenza. Evitiamo così di imboccare le scorciatoie che pretendono di utilizzare, spesso opportunisticamente, le grandi conquiste delle neuroscienze per spiegare ogni complessità della vita psicologica e psicopatologica. E di abbracciare semplificazioni pseudocliniche che pretendono di riassumere le vicissitudini del processo terapeutico (dall’incontro diagnostico al momento della separazione) nella comoda raccomandazione, suggellata dall’inevitabile riferimento ai mirror neurons, di essere “empatici e relazionali” (peraltro riesce difficile pensare a una relazione terapeutica senza empatia e senza relazione).
Quello intersoggettivo è un orientamento che vanta una lunga tradizione clinica e teorica e oggi informa, con sfumature diverse, molte correnti di pensiero psicoanalitico. Una tradizione che si è sviluppata e rinforzata grazie all’incontro tra teoria dell’attaccamento, studio dei sistemi motivazionali, infant research, neuroscienze cognitive e ricerca empirica sulle specifiche componenti della relazione psicoterapeutica (tra cui l’alleanza e il ritmo delle rotture e delle riparazioni). Grazie al contributo di autori come Daniel Stern e molti altri è stato finalmente messo a fuoco come le manifestazioni delle caratteristiche temperamentali del bambino interagiscano in processi di regolazione reciproca bambino-caregiver.
Sul piano clinico l’intersoggettività, può essere definita un processo in gran parte implicito di comunicazione e creazione di senso tra i due mondi intrapsichici di paziente e terapeuta. Un’esperienza che produce cambiamento in entrambi e nella loro relazione. E inevitabilmente ci porta a ridisegnare l’idea di psicoanalista.
Pensando al convegno SPI penso a Luciana Sica che ne avrebbe scritto su «Repubblica». Ma Luciana non è più con noi. Amava la psicoanalisi e proprio l’anno scorso aveva ricevuto il premio Musatti.
TI POTREBBE INTERESSARE:
Pensiero matematico & Linguaggio: cosa hanno in comune?

I primi risultati di questo lavoro suggeriscono che il linguaggio e la matematica condividono delle rappresentazioni sintattiche e utilizzano processi di analisi simili.
Sappiamo che alcune proprietà sono condivise sia dal linguaggio verbale che da quello aritmetico. Pensiamo ad esempio alla possibilità di costruire delle parole a partire da lettere e delle frasi a partire da parole: allo stesso modo siamo in grado di generare e comprendere numeri composti da più cifre, proprio grazie all’assegnazione di un posto specifico alle unità, alle decine e via dicendo, e di risolvere delle espressioni aritmetiche sulla base di alcune regole che indicano quali operazioni vadano svolte per prime.
Sembra quindi che anche nella matematica ci sia la necessità di strutturare il materiale attraverso l’uso di regole sintattiche.
La difficoltà che si pone è come studiare le dimensioni comuni tra il linguaggio e la matematica.
Un paradigma che si è rivelato efficace per studiare l’esistenza di un qualche processo comune nell’analisi sintattica è quello del priming strutturale.
Gli esperimenti classici di priming lessicale dimostrano una riduzione del tempo di elaborazione di una parola come dottore se questa è preceduta da una parola come infermiera, che è semanticamente collegata alla prima.
In generale se due stimoli sono legati tra loro su una particolare dimensione, e l’elaborazione dell’uno influenza l’elaborazione dell’altro, possiamo attribuire la causa dell’effetto di facilitazione (o di inibizione) proprio alla dimensione condivisa (Branigan et al., 1995).
Questo principio si applica non solo alla dimensione lessicale e semantica, ma anche a quella strutturale o sintattica. In letteratura sono riportati numerosi esempi di facilitazione dell’elaborazione di una frase dopo aver elaborato già un’altra frase con la stessa struttura sintattica (Pickering & Ferreira, 2008).
Ci siamo chiesti però se questo assunto si possa applicare anche a due codici tanto diversi tra loro, come la matematica e il linguaggio. Scheepers et al. (2011) hanno dimostrato come la risoluzione di espressioni aritmetiche influenzi la produzione di frasi.
Abbiamo pensato di replicare lo studio nella lingua italiana, rendendo il paradigma di studio un po’ più complesso (Caruso et al., 2012). In un esperimento 54 soggetti dovevano risolvere delle semplici espressioni aritmetiche prima di leggere e comprendere delle frasi ambigue del tipo “Ho visto la figlia della signora che è andata in Egitto”.
I risultati hanno mostrato che la struttura sintattica delle espressioni aritmetiche influenzava l’interpretazione di questo tipo di frasi. Soprattutto quando si trattava di espressioni che contenevano parentesi, quindi gerarchicamente organizzate rispetto a espressioni lineari, si osservava una tendenza maggiore ad interpretare il primo nome della frase ambigua come soggetto della frase relativa.
I primi risultati di questo lavoro suggeriscono che il linguaggio e la matematica condividono delle rappresentazioni sintattiche e utilizzano processi di analisi simili.
Questi risultati però non sono interessanti solo per chi si occupa di linguistica, ma possono essere utilizzati nei protocolli di intervento clinico, come nel lavoro di Byrne e Varley (2011) in cui dei pazienti venivano aiutati a sviluppare delle nuove capacità sintattiche legate al linguaggio a partire dalle operazioni aritmetiche.
Questo potrebbe essere uno dei tanti esempi di come la ricerca sui processi cognitivi di base possa spiegare dei fenomeni mentali complessi ed essere d’aiuto alla pratica clinica.
ARGOMENTI CORRELATI:
LINGUAGGIO & COMUNICAZIONE
ARTICOLO CONSIGLIATO:
Pensiero matematico e linguaggi anumerici
BIBLIOGRAFIA:
- Branigan, H.P., Pickering, M.J., Liversedge, S.P., Stewart, A.J., Urbach, T.P. (1995). Syntactic Priming: Investigating the Mental Representation of Language. Journal of Psycholinguistic Research. 24(6): 489-506.
- Byrne, C., & Varley, R. (2011). From mathematics to language: A novel intervention for sentence comprehension difficulties in aphasia. Journal of Neurolinguistics, 24(2), 173-182.
- Caruso, C., Garraffa, M., & Fairfield, B. (2012). Cross-Domain Structural Priming from Mathematics to Language: Relative Clause Attachment in Italian. In: Architectures And Mechanisms For Language Processing (Amlap). 2012, 6-8 September Riva Dal Garda, Italy, Pp.178.
- Pickering, M.J., Ferreira, V.S. (2008). Structural Priming: A Critical Review. Psychol Bull. 134(3): 427–459.
- Scheepers, C., Sturt, P., Martin, C.J., Myachykov, A., Teevan, K., Viskupova, I. (2011). Structural Priming Across Cognitive Domains: From Simple Arithmetic To Relative-Clause Attachment. Psychological Science. 22(10): 1319-26.
Decontestualizzare la sfera emotiva dal ricordo: una strategia di regolazione emotiva
 Il ricordo è un traditore che ferisce alle spalle.
Il ricordo è un traditore che ferisce alle spalle.
Nella memoria emotiva autobiografica sono immagazzinate le nostre emozioni riguardanti eventi di vita particolarmente significativi: ad esempio la nascita di un figlio, la vincita di un premio ad una competizione sportiva, o la bocciatura a un esame. Questo tipo di memoria gioca un ruolo importante nella costruzione dell’identità, nonché nella pianificazione di comportamenti, progetti, decisioni.
Tuttavia, il ricordo delle emozioni provate durante un’esperienza di vita negativa (quanto ci siamo sentiti tristi, spaventati, imbarazzati…) può indurre stati di stress emotivo, specialmente quando non si riesce più a smettere di ripensarci e il ricordo si traduce in ruminazione (Nolen-Hoeksema et al., 2008). Effettivamente, un’eccessiva focalizzazione sul ricordo delle emozioni sperimentate durante un evento di vita stressante, è associata a un maggior rischio d’insorgenza di disturbi psichiatrici, quali la depressione maggiore, o il disturbo post-traumatico da stress (Brewin et al., 1999; Rubin et al., 2008), entrambi caratterizzati da deficit nella Regolazione Emotiva. Quest’ultima può essere definita come la capacità individuale di regolare le proprie emozioni, sia positive che negative, attenuandole, intensificandole o semplicemente mantenendole (Gross, 2008). Il concetto di Regolazione Emotiva ha stimolato molte ricerche, poiché si ritiene che una buona capacità di adattarsi a eventi emozionalmente intensi abbia importanti ricadute, sia sulla salute fisica sia sulla salute mentale. Lo studio della Regolazione Emotiva è inoltre mirato al perfezionamento dei trattamenti psicoterapeutici dei disturbi affettivi (Gross, ibidem).
Un team di ricercatori afferenti all’università dell’Alberta e al Beckman Institute dell’Università dell’Illinois ha indagato i meccanismi neurali e comportamentali che avvengono durante il recupero di eventi autobiografici: secondo gli Autori (Denkova, Dolcos & Dolcos, 2014) l’impatto emotivo causato dal ricordo di un evento del passato può essere ridotto spostando l’attenzione sugli elementi contestuali del ricordo (una persona presente nella scena, il tempo atmosferico, o qualsiasi altro dettaglio non emotivo). Una volta che l’attenzione sarà rivolta su altri dettagli dell’evento, e continuerà a vagare su di essi, la concentrazione sul contenuto emozionale negativo sarà ridotta.
Questa semplice strategia sembrerebbe configurarsi come un’alternativa promettente ad altre strategie di regolazione emotiva, come la soppressione o il reappraisal.
La soppressione emotiva può essere metaforicamente immaginata come “imbottigliare un’emozione”, tentare di inscatolarla e metterla da parte: questa strategia, secondo gli Autori, può essere vantaggiosa nel breve termine, ma a lungo rischia di accrescere stati di ansia o depressione, configurandosi come una forma di evitamento. Il reappraisal consiste invece nel cercare una chiave di lettura alternativa agli eventi, cercando ad esempio di “vedere il bicchiere come mezzo pieno”, e non come mezzo vuoto.
Tuttavia il reappraisal, per quanto efficace, sembra essere una strategia molto più faticosa e richiede maggiori risorse cognitive rispetto alla focalizzazione sugli elementi contestuali.
Quest’ultima sembra non solo essere efficace nel breve-termine, ma potrebbe avere la capacità di ridurre il carico emozionale negativo qualora fosse ripetutamente esercitata; inoltre, la strategia potrebbe essere altrettanto efficace se impiegata con l’obiettivo di incrementare l’impatto positivo di ricordi piacevoli e gratificanti.
Allo studio di Denkova e coll. (2014) hanno partecipato 18 soggetti, ai quali è stato inizialmente richiesto di individuare e condividere un certo numero di ricordi, caratterizzati da una forte valenza emotiva, sia in negativo sia in positivo. Trascorse alcune settimane, i soggetti sono stati ricontattati e sottoposti a un esame di fRMI (Risonanza Magnetica Funzionale). Durante l’esame gli sperimentatori hanno chiesto ai soggetti di focalizzare l’attenzione sulle caratteristiche emotive o contestuali del ricordo, per poi stimolare la rievocazione di ricordi mediante la proposizione di diversi indizi. Ad esempio, se l’indizio consisteva nel richiamare il ricordo del funerale di un caro amico, il contenuto emotivo poteva riguardare sentimenti di pena, afflizione, mentre il contenuto contestuale poteva riguardare l’abito che si era indossato, le persone presenti, o altro.
I risultati prodotti dalle scansioni fRMI indicano che la focalizzazione sul contesto è associata a un’attivazione della corteccia prefrontale ventro-mediale (un’area cerebrale che influisce sulla Regolazione Emotiva), e parallelamente a una riduzione nell’attività dell’amigdala (un’area cerebrale responsabile dell’attivazione emozionale).
Gli Autori ipotizzano infine la messa a punto di nuove ricerche su questa strategia, che potrebbero riguardare una valutazione dell’efficacia in uno studio longitudinale, valutandone l’efficacia in un orizzonte temporale di medio – lungo termine, nonché all’applicazione su popolazioni cliniche, quali soggetti con disturbi d’ansia o di depressione, valutandone le ricadute sulla sintomatologia emotiva.
ARGOMENTI CORRELATI:
REGOLAZIONE EMOTIVA – MEMORIA
ARTICOLO CONSIGLIATO:
Strategie per incrementare l’efficacia della regolazione emotiva.
BIBLIOGRAFIA:
- Brewin, C.R., Reynolds, M., Tata, P. (1999). Autobiographical memory processes and the course of depression. Journal of Abnormal Psychology, 108(3), 511–7.
- Denkova, E., Dolcos, S., Dolcos, F. (2014). Neural correlates of ‘distracting’ from emotion during autobiographical recollection. Social Cognitive and Affective Neuroscience, 2014 (in press).
- Nolen-Hoeksema, S., Wisco B. E., Lyubomirsky, S. (2008). Rethinking rumination. Perspectives on Psychological Science, 3(5), pp. 400-424.
- Rubin, D.C., Berntsen, D., Bohni, M.K. (2008a). A memory-based model of post traumatic stress disorder: evaluating basic assumptions underlying the PTSD diagnosis. Psychological Review, 115(4), 985–1011. DOWNLOAD
La PET come strumento di valutazione delle possibilità di recupero in pazienti cerebrolesi
La tomografia a emissione di positroni (PET), una tecnica di imaging funzionale, sembra essere uno strumento promettente nella valutazione delle possibilità di recupero dello stato di coscienza in pazienti gravemente cerebrolesi.
Questi risultati sono importanti se pensiamo che con gli esami clinici tradizionali fino al 40 % dei pazienti cerebrolesi sono mal diagnosticati: gli esami clinici standard dovrebbero servire a discriminare se i pazienti sono in uno stato di coscienza minimo (MCS), in cui vi è qualche evidenza di consapevolezza e di risposta agli stimoli, o in stato vegetativo (VS), noto anche come unresponsive wakefulness syndrome, nel quale la possibilità di recupero è molto bassa.
Nei pazienti con edema cerebrale, però, la previsione di recupero sulla base di un esame clinico standard è poco più accurata del lancio di una moneta, sostengono i ricercatori che hanno condotto lo studio all’Università di Liegi.
Grazie alla PET sembra invece possibile rilevare processi cognitivi che non sono visibili attraverso i test tradizionali, e che possono essere usati per completare le valutazioni comportamentali standard, rendendole più accurate.
Lo studio ha valutato se due nuove tecniche di imaging funzionale del cervello – la PET con fluorodeossiglucosio come agente di imaging (FDG) e la risonanza magnetica funzionale (fMRI) eseguita durante compiti di immaginazione mentale – fossero in grado di distinguere tra VS e MCS in 126 pazienti con gravi lesioni cerebrali (81 MCS , 41 VS , e 4 con locked-in syndrome, un gruppo di controllo di pazienti che non rispondono a livello comportamentale ma che sono coscienti).
I ricercatori hanno poi confrontato i risultati ottenuti con quelli del Coma Recovery Scale- Revised ( CSR – R ), un test comportamentale standardizzato, considerato fino ad ora il metodo più sensibile per discriminare i livelli minimi di coscienza.
I risultati indicano che la FDG -PET è meglio della fMRI nel rilevare uno stato di coscienza in pazienti apparentemente incoscienti; in particolare l’accuratezza previsionale del grado di recupero entro l’anno successivo era circa del 74 % per la FDG -PET , rispetto al 56 % della fMRI.
ARGOMENTI CORRELATI:
NEUROPSICOLOGIA
ARTICOLO CONSIGLIATO:
MEG Neurofeedback: una nuova tecnica riabilitativa – Neuropsicologia
BIBLIOGRAFIA:
- Stender, J., Gosseries, O., Bruno, M.A., Charland-Verville, V., Vanhaudenhuyse, A., Demertzi, A., Chatelle, C., Thonnard, M., Thibaut, A., Heine, L., Soddu, A., Boly, M., Schnakers, C., Gjedde, A., Laureys, S. (2014). Diagnostic precision of PET imaging and functional MRI in disorders of consciousness: a clinical validation study. The Lancet; DOI: 10.1016/S0140-6736(14)60042-8
Io non mi piaccio! Body Image Modular Therapy per i disturbi dell’immagine Corporea
La Body Image Modular Therapy
per trattare i disturbi dell’immagine corporea
 Io cosi’ non mi piaccio!…chissà cosa penseranno di me quando mi vedono gli altri…vorrei essere come lei/lui… etc etc
Io cosi’ non mi piaccio!…chissà cosa penseranno di me quando mi vedono gli altri…vorrei essere come lei/lui… etc etc
Quante volte avrete detto queste frasi o quante volte le avrete pensate o sentite dire da qualcuno accanto a voi? Beh, siete in buona compagnia.
Poche sono le persone che si accettano e approvano al 100% e molti, invece, coloro che modificherebbero qualcosa del proprio aspetto (Tantleff-Dunn et al., 2011).
Dal peso al colore degli occhi, dall’altezza sino al proprio sesso, l’immagine corporea non è solo ciò che percepiamo guardandoci allo specchio, sopratutto identifica una rappresentazione mentale del corpo da un punto di vista cognitivo, affettivo e meta-cognitivo (Mian, 2006).
In sostanza, come ci vediamo e “sentiamo” nel nostro corpo e come pensiamo che gli altri ci vedano, sono quesiti che ci poniamo quotidianamente, quasi senza accorgercene, e rappresentano le dimensioni che compongono questo costrutto (Mian & Gerbino, 2009).
La percezione, le emozioni e le convinzioni riguardo il nostro apparire orientano i progetti, le relazioni interpersonali, il nostro benessere quotidiano, l’autostima e la tendenza ad sviluppare disturbi di natura psicologica, non solo quindi un disturbo del comportamento alimentare.
Nella pratica clinica di qualsiasi psicoterapeuta, sempre più spesso giungono persone preoccupate per il proprio aspetto e che per questo si sentono a disagio in molte situazioni, siano essi adolescenti o adulti, maschi o femmine e questo, anche senza presentare reali difetti fisici (APA DSM 5, 2013; Kostanski & Gullone, 2003).
Molti hanno un tono dell’umore e stati d’ansia in grado di rendere difficile la vita quotidiana, comportamenti alimentari problematici e vivono lo specchio in maniera ossessiva o al contrario, scappano da qualsiasi superficie ne rifletta la loro immagine. Altri utilizzano lo sport e la cosmesi sino a desiderare (e spesso ottenere) numerosi interventi in chirurgia plastica al fine di correggere i supposti o amplificati difetti, rimanendo intrappolati nel giogo della propria insoddisfazione corporea.
Non lasciatevi trarre in inganno, perché questi sono i pazienti più esigenti e complessi da trattare.
Come detto, sono rare, le persone che si ritengono soddisfatte e non cambierebbero anche solo una parte del proprio corpo, ma la differenza per chi sviluppa una vera psicopatologia sta nel grado di insoddisfazione e, soprattutto, nel come questa interferisca sulla vita quotidiana e nel funzionamento generale dell’individuo.
L’importanza clinica dell’immagine corporea e la centralità di questa in una psicoterapia di successo è facilmente intuibile, ma la sua interdipendenza con il comportamento verso il cibo, la gestione dell’ansia, dell’umore e dei pensieri ossessivi rendono complessa anche l’alleanza terapeutica e la motivazione se non viene utilizzato un metodo strutturato ma flessibile che, modulandosi insieme alle esigenze e risorse del paziente, tenga conto della sua individualità.
Proprio per la peculiarità di queste persone, la terapia dell’immagine corporea dovrebbe prendere in considerazione e sfruttare gli sviluppi della ricerca scientifica e le nuove tecnologie con un approccio evidence-based, manualizzato, replicabile e che tenga conto della necessaria multidisciplinarietà nella cura di queste problematiche.
L’immagine corporea come abbiamo visto è un complesso costrutto multidimensionale, e l’utilizzo di un’unica tecnica terapeutica, risulta insufficiente; per questo nasce la terapia modulare dell’immagine corporea o Body Image Modular Therapy (BIMT-Mian, E., 2014).
La BIMT è una strategia d’intervento integrabile agli approcci psicoterapeutici standard, con moduli adatti e adattabili a tutte le problematiche che coloro con una immagine corporea deficitaria “portano in seduta”. Questo specifico approccio, in parte mutuato dalla CBT-BDD ovvero la psicoterapia cognitivo-comportamentale per il dismorfismo corporeo (Wilhelm, Phillips & Steketee, 2013) considera più economico ed efficace, rispetto alla pratica clinica corrente, individuare strategie specifiche per affrontare ciascuno dei processi che fanno parte del disagio del paziente relativo all’immagine corporea, permettendo una flessibilità ed una personalizzazione del trattamento psicoterapeutico al fine di affrontare le particolari sintomatologie che sono caratteristiche di alcuni ma non di tutti i pazienti (Chorpita, 2007; Eifert et al., 1997;).
Non solo il disturbo alimentare quindi, ma anche la gestione dello sport ossessivo, del pensiero ricorsivo verso il proprio corpo o alcune sue parti (thigh-gap, thinspiration, body teasing, body related internet addiction, pro/ana/mia site addicion etc etc) devono essere indirizzate con competenza del fenomeno ed il terapeuta dovrebbe sapere “dove mettere o non mettere il naso” in seduta.
Perché quindi la Body Image Modular Therapy?
Molti tipi di psicoterapia cognitivo comportamentale includono interventi basati sullo “skill-training” con sessioni che vengono presentate in modo sequenziale. Ogni sessione è costruita in modo da includere un training in una o più specifiche abilità come ad esempio, per la terapia della depressione negli adolescenti (Reinecke et al., 2006), nel Social Skills Training (Thase, 2012) o nella Dialectical Behavioural Therapy (Booth et al.,2014). Questi approcci, prevedono che ogni seduta abbia momenti dedicati al training in specifiche abilità e le sessioni siano correlate fra loro sequenzialmente. Per esempio, un approccio al rilassamento è trattato in una specifica sessione, seguita da altre che ne approfondiscono ulteriormente questa abilità. Dal punto di vista psicoeducativo la sequenza delle sessioni è settata ed ordinata in modo che quelle successive vengano gestite in base a quanto appreso nelle precedenti sessioni.
Nella Body image Modular Therapy, invece, non c’è bisogno che i moduli seguano una sequenza predefinita, proprio per aderire meglio alla storia di vita del paziente e del momento del “qui ed ora”. Inoltre, i vari moduli, non sono dei semplici “skill training”, ma veri e propri assetti di gestione terapeutica all’interno della sessione di seduta e fra le sedute stesse, indipendentemente dalla loro sequenzialità.
Una critica ai trattamenti manualizzati è che manchino di flessibilità sia nella gestione globale che all’interno di ogni singola seduta di psicoterapia e la domanda che ci si è posti nella creazione della struttura di sessione e dei vari moduli è stata di come poteva una terapia rispondere ai bisogni immediati di un paziente se il manuale di riferimento gli imponeva di gestire alcuni argomenti che potevano non essere aderenti al 100% ai bisogni specifici del momento. La risposta è l’utilizzo dell’approccio modulare della BIMT, un approccio che inoltre tiene conto delle nuove tecnologie per quanto riguarda l’esposizione guidata ed il “perceptual retraining” mediante videosimulazione come nell’uso del Body Image Revealer e tecniche mutuate dalla mindfulness e dall’acceptance and committment therapy (Pearson et al., 2011; Lillis et al., 2009) per la gestione della body avoidance e food phobia.
Body Image Revealer:
L’integrazione dei sedici moduli di cui attualmente la Body Image Modular Therapy si compone, permette inoltre di inserirla nella “cassetta degli attrezzi” di ogni professionista impegnato con i sempre piu’ numerosi pazienti che presentano problematiche a carico dell’immagine corporea.
POTREBBE INTERESSARTI:
Body Image Modular Therapy – Training di primo livello – Milano 7 Giugno 2014
ARGOMENTI CORRELATI:
DISMORFOFOBIA – IMMAGINE CORPOREA
BIBLIOGRAFIA:
- Lillis, J.,Hayes,S.C. Bunting K, M.A. Masuda,A. Teaching Acceptance and Mindfulness to Improve the Lives of the Obese: A Preliminary Test of a Theoretical Model Ann. Behav. Med. (2009) 37:58–69 DOWNLOAD ARTICLE
- Mian, E. “Approccio modulare ai disturbi dell’immagine corporea: la Body Image Modular Therapy”- XVII Congresso Nazionale della Società di Terapia Comportamentale e Cognitiva (2014)
- Mian, E. “Specchi: viaggio all’interno dell’immagine corporea”– Phasar Ed. Firenze (2006) DOWNLOAD PREVIEW
- Mian, E., Gerbino, W. (2009) “Body Image Assessment in the Computer Aided Psychological Support for Eating Disorders” Frontiers in Neuroengineering. Ann. CyberTherapy and CyberPsychology
- Pearson, A., Follette, V.M. & Hayes, S.C. A pilot study of Acceptance and Commitment Therapy as a workshop intervention for body image dissatisfaction and disordered eating attitudes. Cognitive and Behavioral Practice. (2011)
- Tantleff-Dunn S., Barnes R.D., Larose JG. It’s not just a “woman thing:” the current state of normative discontent. Eat Disord. 2011 Oct-Dec;19(5):392-402 DOWNLOAD POSTER
- Wilhelm S., Phillips K.A., Fama J.M., Greenberg J.L., Steketee G. (2011) Modular cognitive-behavioral therapy for body dysmorphic disorder. Behaviour Therapy. Dec;42(4):624-33.
Emanuel Mian. Psicoterapeuta, PhD in Neuroscienze.
Docente nel Master in “Dietistica e Nutrizione Clinica”- Università di Pavia
Pratiche erotiche estreme. E’ sempre lecito praticarle? Psiche e Legge #11
PSICHE E LEGGE #11
Quando la mente criminale “scrive” il processo penale
Pratiche erotiche estreme. E’ sempre lecito praticarle?
 In chiusura della rubrica dedicata alla recensione del film “Tulpa” (regia di Federico Zampaglione) si anticipava al tema trattato nell’odierno appuntamento, rilevandone la stretta connessione con la realtà del sesso estremo attorno alla quale si snoda la pellicola.
In chiusura della rubrica dedicata alla recensione del film “Tulpa” (regia di Federico Zampaglione) si anticipava al tema trattato nell’odierno appuntamento, rilevandone la stretta connessione con la realtà del sesso estremo attorno alla quale si snoda la pellicola.
Un legame a doppio filo, dunque, tra i racconti sui quali è tessuta la trama del lungometraggio, e le vicende giudiziarie che sempre più frequentemente vedono coinvolti amanti i cui giochi erotici finiscono, purtroppo, in tragedia.
Ma quale è il nesso con le vicende giudiziarie? Praticare sesso estremo, ci si chiederà, è forse reato? Certo che no. Anzi. La Costituzione – offrendo tutela, ai sensi dell’art. 2, ai diritti inviolabili dell’uomo – si rivolge anche al diritto alla libertà sessuale, inteso quale espressione dell’affettività e dimensione essenziale della persona. Va da sé, allora, che, elevandosi la sfera sessuale ad asse espressivo portante dell’essere umano, la libertà di disporne andrà protetta garantendo che ogni singola scelta inerente tale alveo sia assunta nella più totale consapevolezza e spontaneità.
Di qui, la punizione – da parte del Codice Penale – di ogni condotta a sfondo sessuale che sia imposta, con violenza fisica o psicologica, o comunque subdolamente indotta. Ecco che, qualora si attesti la perpetrazione di comportamenti che appaiano lesivi dell’altrui autodeterminazione sessuale, andrà posto, sul piatto della bilancia, sia l’oggettivo pregiudizio arrecato al bene protetto, che il legittimo esercizio del diritto ad abbracciare e seguire le proprie preferenze sessuali.
Saranno lecite, dunque, tutte quelle condotte che – seppur a primo impatto connotate da profili di costrizione o aggressività – siano, in realtà, desiderate da soggetti adulti la cui libido si soddisfi nell’infliggere sofferenza (sadismo) o nel subirla (masochismo). Ed è intuibile, come nell’esplicarsi di un tal genere di congiungimenti, si compiano, inevitabilmente, atti violenti o tesi ad umiliare l’altro. Modalità esplicative della sessualità – talora connotanti persino il classico ménage familiare – che gli studi di settore, invero, non collegano necessariamente a disfunzioni della sfera psicologica o a forme di psicopatologia.
Del resto, il DSM suole qualificare il sadomasochismo come “una sana forma di espressione sessuale fino a quando non danneggia la normale vita quotidiana del soggetto”. Ad ogni modo, se in un contesto ordinario tali azioni verrebbero senz’altro a delineare ipotesi di reato (lesioni, percosse, ingiurie, sequestro di persona, violenza privata, stupro), nell’ambito dei giochi erotici ad alto rischio, esse perderanno l’intrinseca valenza criminale, per divenire, invece, legittime, stante il consenso prestato dall’avente diritto.
Tutto lecito, allora, purché si tratti di un gioco di ruoli concordato e regolato nei minimi dettagli. Dato di estrema rilevanza, ove si pensi – e i casi mediatici di cui siamo informati lo confermano – alle non isolate ipotesi in cui da una cattiva o disattenta gestione delle regole del gioco derivi un serio pregiudizio alla salute degli amanti o, addirittura, il decesso. Conseguenze più che ipotizzabili, alla luce del concreto modularsi dei congiungimenti, in cui la sfida al dolore ed alla morte, induce i soggetti a perpetrare pratiche pericolosissime, quali lo shibari, la mummification, il breath play o la suspension.
Ma se il consenso è linea di confine tra il lecito e l’illecito, la questione, solo in apparenza lineare, si complica notevolmente ove – nello svolgersi di tali giochi – sarà proprio il consenso prestato da uno dei partecipanti a vacillare durante il rapporto o ad essere ritrattato. In altre parole, è come se le parti stipulassero un contratto di “schiavitù sessuale”, offrendosi disponibili a compiere o subire determinate azioni, nel rispetto delle regole stabilite, prima fra tutte, la parola d’ordine da pronunciare per bloccare il gioco.
Va sottolineato, però, che – al fine di scriminare la condotta e renderla lecita – il consenso dovrà innanzitutto riguardare diritti disponibili.
Ma cosa vuol significare esattamente questa espressione? Il riferimento, è al fatto che la legge – pur tutelando la libertà personale – non permetterà mai all’essere umano di consentire ad altri di ucciderlo o di procurargli menomazioni permanenti o contrarie alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume.
Ebbene, tanto chiarito, interessa prender nota degli ulteriori requisiti di validità del consenso scriminante. Lo si riterrà valevole, in primo luogo, solo ove sia stato prestato con riferimento a quelle specifiche modalità dell’azione poste in essere dagli amanti.
Così, per recare un esempio, ove nel corso di un amplesso sadomaso si siano alternati atti violenti commessi nel concordato assenso delle parti (perciò leciti) ad episodi imposti solo da uno dei partecipanti, a carico dell’agente potrà scattare una condanna per violenza sessuale. Il consenso, poi, dovrà essere personale, fornito da un soggetto capace d’intendere e volere, nonché manifestato, nel senso che risponderà di stupro, anche chi abbia commesso un’azione repentina, senza previamente accertarsi dell’assenso del destinatario. Tuttavia, nei descritti contesti, non sarà sempre agevole distinguere il consenso solo apparentemente estorto – ma in realtà consapevolmente prestato – da un dissenso effettivo, dunque esulante dal copione concordato.
Sarà probabile, in effetti, che il dominato, pur desiderando quel violento trattamento, urli il suo dissenso o si divincoli, solo per restare fedele al suo ruolo e per soddisfare il partner.
Spetterà al giudice, allora, ricostruire – in caso di denuncia presentata dal partecipante che sostenga di non aver recitato nell’opporsi all’atto sessuale, ma di aver davvero espresso il suo dissenso a proseguire l’amplesso estremo – il concreto svolgersi degli eventi. Andrà accertato, in particolare, se il ripensamento della presunta vittima, sia stato percepito o fosse stato comunque percepibile dall’altro, cui sarà addebitata la responsabilità penale, solo ove si provi che abbia portato a termine il rapporto nella consapevolezza del sopravvenuto dissenso.
Si integrerà, pertanto, il reato di stupro nel caso in cui, durante la consumazione del rapporto, l’agente abbia appreso il dissenso della vittima la quale, seppur fisicamente bloccata, sia riuscita a manifestare una tempestiva reazione.
Ma cosa accade, invece, nell’ipotesi in cui una delle parti, nel subire l’atto violento, perda la vita per via di preesistenti patologie (cardiologiche o respiratorie) che lo abbiano reso vulnerabile? Il responso dipenderà dalle specifiche circostanze. Il dominatore, lo si annoti, potrebbe anche non rispondere affatto dell’accaduto, purché ignaro del cagionevole stato di salute del partner. Ciò, tuttavia, solo ove non sia ravvisabile alcuna probabilità che avesse potuto accettare il rischio del verificarsi dell’evento, o solo prefigurarsene la possibilità.
Andrà operato, poi, un puntuale raffronto tra l’azione da questi esigibile, secondo il metro dell’uomo modello, e quella concretamente posta in essere. Da valutare, inoltre, anche l’eventuale mancato soccorso alla vittima che abbia esternato difficoltà. Si valuti, infine, come l’esecuzione stessa della pratica sessuale possa aver cagionato l’evento, per mero errore nell’uso di corpi estranei, o per cattiva interpretazione dei segnali concordati. Ebbene, in tali evenienze, sarà il rinvio ai ben noti parametri dell’imperizia, della negligenza, dell’imprudenza, o della riconoscibilità del vizio, a dettare la colpevolezza del soggetto, o a liberalo da ogni responsabilità.
Nel tirare le fila del discorso, allora, potrà sostenersi come nello svolgersi delle pratiche sessuali estreme, l’eventuale conseguenza tragica del gioco sarà imputabile al soggetto che l’abbia procurata in via diretta ed immediata, nei soli casi in cui la lesione o la morte della vittima siano ricollegabili alla violazione, colposa (dunque non voluta) o intenzionale, delle regole pattuite, o dall’aver agito nonostante il dissenso espresso, o in costanza di un invalido consenso.
Questioni delicatissime, come si evince dai rilievi appena esposti, che meriteranno in sede processuale, un’attenta verifica sull’elemento psicologico proprio dell’imputato, sulle reali dinamiche dei fatti e su ogni altro elemento idoneo a ricostruire i fatti.
LEGGI LA RUBRICA: PSICHE & LEGGE
LEGGI ANCHE:
AMORE E RELAZIONI SENTIMENTALI – SESSO – SESSUALITA’
PSICHE & LEGGE: QUANDO LA MENTE CRIMINALE “SCRIVE” IL PROCESSO PENALE
BIBLIOGRAFIA:
- Pascasi, S. (2014). Giochi erotici ad alto rischio. Responsabilità e scriminante del consenso in Il Sole 24 Ore, VENTIQUATTRORE AVVOCATO n. 1/14, 81-89.
- Pascasi, S. (2013). Il consenso al congiungimento o ad altri atti deve perdurare senza soluzione di continuità in Guida al Diritto n. 21/13, 67-70
- Pascasi, S. & Lusa, V. (2011). La persona oggetto di reato. Torino, Giappichelli Editore.
La psicopatia di Saverio in Senza pelle (1994) – Cinema & Psicoterapia #25
Antonio Scarinci.
Psicologo Psicoterapeuta. Socio Didatta SITCC
RUBRICA CINEMA & PSICOTERAPIA #25
Senza pelle (1994)
Proposte di visione e lettura (Coratti, Lorenzini, Scarinci, Segre, 2012)
Il film si chiude con un messaggio di speranza che le persone affette da patologie gravi possano avere una vita dignitosa e di qualità. Con Saverio possiamo dire: Perché ci sia qualcosa che si trova ci deve essere sempre qualcosa che si perde.
Diretto da Alessandro D’Alatri. Interpretato da Kim Rossi Stuart, Anna Galiena, Massimo Ghini. Italia 1994.
Trama
Saverio, un giovane psicopatico, si innamora di Gina, convivente di Riccardo e madre di un bimbo di quattro anni. Il corteggiamento fatto di lettere d’amore si fa insistente e indispone sia la donna che il convivente. Dopo un incontro con la madre del ragazzo i due decidono di aiutarlo. Gina convince un amico, proprietario di una serra, ad assumere il giovane.
Ogni tanto passa dalla serra, e Saverio un giorno le chiede un bacio. La donna cede influenzata anche dalla bellezza, dalla dolcezza e dalle splendide poesie che il giovane le dedica. Si pente subito, però, di fronte allo choc emotivo di Saverio.
Gina per sfuggire alla situazione incresciosa scompare e Saverio ha una grave crisi. Arrestato è ricoverato in ospedale e in seguito entra in una comunità terapeutica dove, dopo qualche tempo, un bigliettino gli cade accanto: è una ragazza del centro che gli lancia un messaggio di affetto e di speranza.
Motivi d’interesse
Saverio è un senza pelle, così lo definisce la psicologa che lo ha in cura: è cioè trasparente, subisce senza mediazioni gli stimoli dall’esterno. Gina lo spinge a scrivere poesie bellissime e a mandare meravigliosi cesti di fiori.
L’avvenenza delle modelle delle riviste stimolano la sua sessualità negata dalla situazione psicologica e familiare. La madre aiuta Saverio, ma il trattamento farmacologico certo non è da solo sufficiente. Il giovane ha bisogno di relazioni, di accettazione, di affetto, di accoglienza. Il mondo invece è tutt’al più indifferente, se non ostile, intorno a lui.
Lo stigma segna la sua presenza e l’evitamento è l’atteggiamento diffuso e prevalente. Gina e Riccardo si rendono conto, entrando in contatto con Saverio, di quanto il pregiudizio caratterizzi le valutazioni e i rapporti con “il matto”, ma per un breve lasso di tempo il calore umano e la comprensione riescono a rompere il circolo vizioso.
Basta, però, un errore, un’involontaria spinta emotiva per rompere il sottile equilibrio e precipitare di nuovo il giovane nel vortice di sofferenza.
Il film si chiude però con un messaggio di speranza che le persone affette da patologie gravi possano avere una vita dignitosa e di qualità. Con Saverio possiamo dire: Perché ci sia qualcosa che si trova ci deve essere sempre qualcosa che si perde.
Indicazioni per l’utilizzo
Indicato per combattere lo stigma e per programmi di psicoeducazione con le famiglie di pazienti psicotici. Crea spazi e tempi non convenzionali che aprono la speranza alla possibilità di poter curare e includere nella società anche pazienti affetti da gravi patologie psichiatriche.
Trailer
LEGGI ANCHE:
PSICOPATIA – RUBRICA CINEMA & PSICOTERAPIA
BIBLIOGRAFIA:
- Coratti, B., Lorenzini, R., Scarinci, A., Segre, A., (2012). Territori dell’incontro. Strumenti psicoterapeutici, Alpes Italia, Roma. ACQUISTA ONLINE
Ippoterapia e Alzheimer: quando gli animali aiutano i più anziani
Ioana Marchis

L’ ippoterapia, utilizzata soprattutto con bambini e adolescenti con disturbi emotivi e di apprendimento, può essere applicata anche nel lavoro con le persone adulte e fornire un modo unico per alleviare i sintomi della demenza senza utilizzo di farmaci.
Grazie ad una ricerca condotta in collaborazione tra l’Università di Stato dell’ Ohio, un centro d’ippoterapia e un centro di cura diurno per gli anziani, è emerso che le persone affette da Alzheimer sono in grado di curare i cavalli (dandogli da mangiare e facendoli camminare) sotto un’accurata supervisione. Questa esperienza, inoltre, sostengono i ricercatori, fa migliorare il loro umore rendendoli più collaborativi verso le cure che ricevono durante la giornata.
Dallo studio pilota, pubblicato sulla rivista Anthrozoös emerge che l’ippoterapia – utilizzata soprattutto con bambini e adolescenti con disturbi emotivi e di apprendimento – possa essere applicata anche nel lavoro con le persone adulte. Holly Dabelko-Schoeny, professore associato presso l’Università dell’Ohio, sostiene che l’ippoterapia potrebbe integrare forme più comuni di terapia assistita con gli animali come cani e gatti e fornire un modo unico per alleviare i sintomi della demenza senza utilizzo di farmaci.
Le persone affette da Alzheimer, oltre alla perdita della memoria, spesso vanno incontro ai cambiamenti di personalità. Essi possono diventare depressi, solitari e finanche aggressivi. Per venire incontro a questi cambiamenti le terapie odierne si focalizzano di più su come alleviare il carico emotivo dei pazienti e delle loro famiglie. Il focus della terapia è cogliere l’attimo e far divertire le persone affette dalla demenza “in quel preciso momento” anche se poi non se la ricordano più, sostiene Holly Dabelko-Schoeny.
Al presente studio hanno partecipato 16 persone, in cura in un centro diurno per anziani di Columbus (Ohio) affette da Alzheimer, di cui 9 femmine e 7 maschi. Una volta alla settimana, per un mese, otto di loro (gruppo sperimentale) venivano accompagnati in un centro di ippoterapia dove, sotto la supervisione del personale, si prendevano cura dei cavalli dando loro da mangiare, da bere e facendoli camminare; gli altri otto (gruppo di controllo) rimanevano nel centro diurno dove partecipavano alle attività proposte dal centro.
Per monitorare il comportamento dei partecipanti, i ricercatori hanno utilizzato una scala “Modified Nursing Home Behavior Problem Scale” grazie alla quale il personale del centro poteva riportare da 1 a 4 la frequenza di comportamenti problematici come tristezza, agitazione, irritamento e resistenza alle cure sia nei giorni in cui gli ospiti venivano accompagnati al centro di ippoterapia che nei giorni in cui rimanevano nel centro diurno. Dai risultati è emerso che il punteggio dei partecipanti accompagnati al centro d’ippoterapia era inferiore di un punto rispetto a quelli che rimanevano nel centro diurno. Inoltre, i ricercatori hanno misurato i livelli del cortisolo, l’ormone dello stress, nella saliva dei partecipanti allo studio, riscontrando un aumento del livello di cortisolo nel gruppo sperimentale, probabilmente dovuto allo “stress positivo” collegato alla nuova esperienza vissuta.
Dallo studio è emerso anche un beneficio inatteso: l’ippoterapia potenziava l’attività fisica dei partecipanti. Le persone del gruppo sperimentale, tutte con delle limitazioni fisiche, nelle attività con i cavalli provavano a spingersi oltre questi limiti, chiedendo aiuto per alzarsi dalla sedia rotelle o prendendo fiducia nel camminare da soli (dove possibile). I familiari, i cui cari sono stati accompagnati al centro d’ippoterapia, riferivano nella maggior parte dei casi che rimanevano ancorati nella nuova esperienza riportandola a casa. La figlia di uno degli ospiti sostiene che sua madre non avrebbe mai ricordato quello che faceva nel centro durante il giorno, ma che ha sempre ricordato quello che ha fatto nel centro d’ippoterapia.
Dai risultati di questo studio sembrerebbe quindi che l’ippoterapia abbia degli effetti benefici non soltanto nel lavoro terapeutico con i bambini ma anche nelle persone affette di demenza.
ARGOMENTI CORRELATI:
Demenza
ARTICOLI CONSIGLIATI:
Gli effetti positivi di un cane in famiglia: indagine tra genitori di bambini autistici
BIBLIOGRAFIA:
- Dabelko-Schoeny, H., Phillips, G., Darrough, E., DeAnna, S., Jarden, M., Johnson, D., Lorch, G. (2014). Equine-Assisted Intervention for People with Dementia. Anthrozoos: A Multidisciplinary Journal of The Interactions of People & Animals. DOI: 10.2752/175303714X13837396326611
Neurotipico, definizione
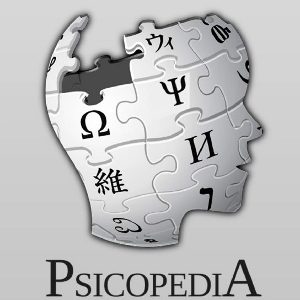
Neurotipico è il termine convenzionalmente utilizzato per descrivere tutta la popolazione non autistica, con un organizzazione neurologica che non induce cioè le caratteristiche comportamentali che determinano una diagnosi di autismo.
In tale accezione per contrapposizione gli autistici vengono definiti neurodiversi. Il termine neurodiversità tuttavia non è sinonimo di disabilità in quanto esistono condizioni autistiche non patologiche.
Così come il termine neurotipico non può essere inteso come sinonimo di salute in quanto esistono condizioni neurotipiche patologiche.
In termini più generali e letterali neurodiversità indica del resto qualsiasi differenza neurologica tra gli individui, per esempio quella tra maschi e femmine.
Argomenti correlati: Autismo & Disturbi dello spettro autistico
Dai contenuti ai processi mentali: la terza ondata della Terapia Cognitiva
La nuova sfiducia post-moderna nell’intelligenza può generare anche una nuova capacità di apprezzare l’attesa, l’attesa che la mente da sola elabori soluzioni senza che l’attenzione sia costantemente e ansiosamente focalizzata sui problemi, sulle difficoltà e sugli ostacoli. Ovvero, il saper pensare dopo, invece che prima. Il che, per Epimeteo, potrebbe essere una bella rivincita, dopo che per millenni lo abbiamo considerato il fratello scemo di Prometeo (Graves, 1955).
Credo che per molti di noi, cresciuti in un’atmosfera culturale differente, i nuovi paradigmi di terza ondata della terapia cognitiva pongano qualche difficoltà.
Nei nuovi trattamenti metacognitivi, nei nuovi interventi di mindfulness c’è minore fiducia nella terapia come comprensione.
L’attenzione si è spostata dai contenuti ai processi mentali, dagli interventi concettuali a quelli meditativi ed esperienziali. Tutto questo sembra suggerire una maggiore sfiducia nelle parole e nei significati logici e verbali.
Centrale diventa l’accettazione, che sta prevalendo sul paradigma precedente, che poneva al centro la conoscenza. La validazione emotiva ha svolto un ruolo intermedio, un interregno sentimentale tra la logica occidentale del comprendere che dominava un tempo e la nuova attitudine orientale dell’accettare e del non giudicare.
In realtà il seme era già piantato nei primi sviluppi della terapia cognitiva, ed era un seme non del tutto orientale. Anche il pragmatismo anglo-sassone non condivide da secoli la concezione mediterranea e platonica che privilegia il sapere esplicito e teorico, le idee, e lo fa coincidere con l’eudamonia, ovvero -semplificando- con la serenità del saggio e in qualche modo con il benessere del paziente. L’attitudine anglo-sassone ha sempre visto il benessere clinico come azione concreta da ottenere e non come frutto automatico del capire e del sapere.
Il luogo comune vuole che la centralità del conoscere e del contenuto del pensiero sia frutto di una mentalità soprattutto europea. È plausibile, però –a mio parere- non del tutto esatto.
Credo sia più corretto collegare questa mentalità a fenomeni storici più precisi e definiti. Per esempio, in Italia questa mentalità è nutrita dalla centralità degli studi classici e umanistici. In Europa non saprei se è davvero così. Forse è vero per la Francia o per altri paesi latini. Onestamente, in fondo non lo so. Sono però abbastanza sicuro che gli studi classici sono poco importanti nei paesi del nordeuropa. Almeno questa è la mia esperienza.
I colleghi nordeuropei che ho incontrato in occasioni di lavoro avevano per lo più frequentato scuole professionali dalla forte impronta pragmatica e parevano abbastanza a digiuno di studi umanistici e storici. Il che li portava a sviluppare una mentalità molto pratica, in cui i concetti e le parole hanno un valore funzionale e non sono portatori di una verità in sé.
Non è quindi un caso che le varie terapie cognitive, non solo negli Stati Uniti ma anche nel nordeuropa, abbiano in realtà sempre dato poca importanza al contenuto mentale e alla storia personale. È stata semmai la corrente costruttivista l’unica scuola cognitiva che davvero ha dato importanza centrale ai contenuti.
E questa corrente si è diffusa in Italia e in Spagna, ma anche in Gran Bretagna e negli Stati Uniti. A conferma che l’attenzione ai contenuti può essere a sua volta coltivata dagli anglo-sassoni e non è un fatto necessariamente solo europeo.
Credo che il costruttivismo in Italia abbia probabilmente soddisfatto una mentalità forgiata nell’atmosfera del Liceo Classico, dove si da grande importanza agli studi umanistici e dove vige la concezione greca della verità che libera.
Non penso che tutto questo sia destinato a finire. Certo però che questa mentalità deve integrarsi -ma anche ridimensionarsi- con la sempre maggiore influenza delle tradizioni filosofiche che accordano meno importanza al pensiero verbale, all’intelligenza e alla derivazione logica.
E, ancora una volta, questa sfiducia nell’intelligenza logica è -credo- non solo orientale (ma non mi pronuncio, dato che nulla so di filosofie orientali), ma anche del pragmatismo anglo-sassone, almeno da Charles Pierce in poi (1839-1914; 2003 ed. italiana).
Un’immagine mi viene in mente quando penso alle difficoltà dell’incontro tra una cultura che da importanza ai contenuti di pensiero e alle idee intelligenti -perfino a costo di continuare a rimuginare fino alla morte sulle proprie preoccupazioni- e una mentalità che invece tende all’economia del pensiero e alla non sopravvalutazione dell’intelligenza.
L’immagine è quella di Prometeo, il titano che rubò il fuoco agli dei e lo donò agli uomini, dando inizio al progresso tecnologico. Prometeo è, letteralmente, colui che pensa prima. Ovvero la persona intelligente, che pensa (medomai) prima (pro). Con tutto il correlato di retorica che in Occidente ci portiamo dietro in favore dell’intelligenza.
Il guaio o la fortuna è che, da qualche decennio, o da qualche secolo, mi pare che anche in Occidente si sia diventati sempre meno disposti ad adorare la ragione e l’intelligenza. Si teme sempre più spesso che il “pensare prima” sia apparentato non solo con il nome greco Prometeo, ma anche con la parola di derivazione latina “preoccupazione”, a sua volta legata all’ansia. E i latini già erano meno legati dei greci al mito intellettualistico del primato del pensiero.
Prometeo, come tutte le persone intelligenti, aveva un gran bisogno di definirsi in relazione al suo opposto: le persone (supposte) stupide. E infatti Prometeo aveva un fratello: Epimeteo, colui che pensa dopo. Ovvero lo stupido. E tale è stato considerato nella tradizione occidentale. Almeno finora.
La nuova sfiducia post-moderna nell’intelligenza può generare anche una nuova capacità di apprezzare l’attesa, l’attesa che la mente da sola elabori soluzioni senza che l’attenzione sia costantemente e ansiosamente focalizzata sui problemi, sulle difficoltà e sugli ostacoli. Ovvero, il saper pensare dopo, invece che prima. Il che, per Epimeteo, potrebbe essere una bella rivincita, dopo che per millenni lo abbiamo considerato il fratello scemo di Prometeo (Graves, 1955).
ARGOMENTI CORRELATI:
PSICOTERAPIA COGNITIVA
ARTICOLO CONSIGLIATO:
CBT, Terza Ondata e il rifiuto del Comportamentismo: una lettera aperta
BIBLIOGRAFIA:
- Graves, R. (1955). The Greek Myths. Harmondsworth: Penguin. Ed. Italiana I miti greci, Longanesi, 1954.
- Peirce, C. (2003). Opere. Bompiani, Milano.
Bambini & Emozioni: parlarne aiuta a migliorare le capacità cognitive
Teresita Forlano
 Uno studio condotto dai ricercatori del Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione dell’Università di Milano-Bicocca dimostra che, se i bambini parlano delle emozioni a scuola, in piccoli gruppi e sotto la guida di un adulto, riescono ad essere più empatici e migliorano le loro capacità cognitive.
Uno studio condotto dai ricercatori del Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione dell’Università di Milano-Bicocca dimostra che, se i bambini parlano delle emozioni a scuola, in piccoli gruppi e sotto la guida di un adulto, riescono ad essere più empatici e migliorano le loro capacità cognitive.
La ricerca, svolta in collaborazione con l’Università di Manitoba del Canada, ha coinvolto 110 bambini delle scuole elementari dell’hinterland milanese. I bambini, distribuiti in un gruppo sperimentale e in uno di controllo, avevano tra i 7 e gli 8 anni.
Quattro le fasi dello studio: pre-test, training, post-test e follow-up.
Nella fase di pre-test sono state proposte ai bambini prove individuali di comprensione delle emozioni, di empatia e di teoria della mente (prova cognitiva), per valutare il livello di partenza.
Nella fase di training che è durata circa due mesi, i bambini del gruppo sperimentale, dopo aver ascoltato delle storie a contenuto emotivo, venivano coinvolti nelle conversazioni sulla comprensione della natura, delle cause e della regolazione delle emozioni. Per promuovere la partecipazione attiva di tutti i bambini, il gruppo è stato a sua volta suddiviso in piccole classi di circa sei bambini.
Le attività si sono concentrate su cinque emozioni, di cui quattro di base (felicità, rabbia, paura e tristezza) e una complessa (senso di colpa).
Ciascuna di queste emozioni è stata oggetto di conversazione per tre incontri: il primo focalizzato sulla comprensione dell’espressione, il secondo sulla comprensione delle cause e il terzo sulla comprensione delle strategie di regolazione dell’emozione target. Ogni incontro è stato strutturato in quattro momenti: introduzione al tema da parte dell’adulto, un racconto di vita quotidiana, avvio della conversazione, e riflessione finale da parte dell’adulto.
I bambini del gruppo di controllo non partecipavano alla conversazione. Ascoltavano le storie e poi veniva chiesto loro di fare un disegno.
Nel post-test, ai bambini sono state nuovamente proposte le prove; dopo due mesi, a tutti i partecipanti è stata riproposta la prova di comprensione delle emozioni per verificare la persistenza degli effetti prodotti dall’intervento.
E’ emerso che il gruppo dei bambini sottoposti all’intervento migliora significativamente, rispetto al gruppo di controllo, in vari aspetti della comprensione delle emozioni: nella dimensione cognitiva dell’empatia, e nella prova cognitiva di teoria della mente.
La spiegazione dei risultati, secondo i ricercatori, sta nell’uso della conversazione in piccolo gruppo; essa ha favorito l’assunzione del punto di vista dell’altro, la consapevolezza delle differenze individuali e il collegamento da parte dei bambini tra mondo interno non visibile e azioni manifeste.
La novità dello studio consiste nell’avere scoperto che l’intervento sulle emozioni produce miglioramenti anche nella capacità cognitiva della teoria della mente, ossia nella capacità di prevedere i comportamenti degli altri sulla base dell’inferenza dei loro stati mentali (“se ha fatto questo, forse è perché desiderava qualcosa; “se ha agito in un certo modo doveva essere arrabbiato”).
Quindi dallo studio si evince che: all’interno della scuola primaria è possibile realizzare interventi che, oltre a potenziare le abilità socio-emotive, come la comprensione delle cause delle emozioni, l’empatia e l’aiuto nei confronti dell’altro, producono anche miglioramenti su capacità di tipo cognitivo, per esempio, rappresentarsi la mente dell’altro e prevederne i comportamenti, un’abilità indispensabile nella vita sociale.
ARGOMENTI CORRELATI:
EMPATIA – BAMBINI – TEORIA DELLA MENTE
ARTICOLO CONSIGLIATO:
Effetti della TV sullo sviluppo della Teoria della Mente nei bambini
BIBLIOGRAFIA:
- Ornaghi, V., Brockmeier, J., Grazzani. I. (2013). Enhancing social cognition by training children in emotion understanding: A primary school study. Journal of Experimental Child Psychology, DOI:10.1016/j.jecp.2013.10.005
La CBT per la famiglia nel trattamento di bambini con disturbo ossessivo-compulsivo
La terapia cognitivo-comportamentale rivolta alla famiglia risulta più vicina ai bisogni di sviluppo del bambino con disturbo ossessivo-compulsivo e del suo contesto familiare, fornendo ai genitori un supporto adeguato che consente di vivere il trattamento in modo più tollerabile e accettabile.
Un recente studio, condotto da Jennifer Freeman presso il Bradley Hasbro Children’s Research Center di Rhode Island, ha dimostrato come la terapia cognitivo-comportamentale (CBT) rivolta alla famiglia possa costituire un’importante risorsa nel trattamento di bambini con una diagnosi di disturbo Ossessivo-Compulsivo (OCD). Una terapia di questo tipo, che includa interventi di prevenzione ed esposizione alla risposta (EX/RP), è risultata, infatti, più efficace nella riduzione dei sintomi ossessivo-compulsivi e nel promuovere un miglioramento delle modalità di funzionamento rispetto ad una terapia con una struttura simile ma basata su di un programma di rilassamento.
Ricerche precedenti avevano già dimostrato l’efficacia di un approccio CBT nel lavoro con adolescenti, ma è grazie ai risultati ottenuti da Freeman che è stato possibile dare sostegno all’ipotesi che anche bambini più piccoli potessero trarre beneficio da questo tipo di trattamento.
Il campione oggetto dello studio è stato raccolto nell’arco di cinque anni presso tre centri medici del territorio e ha coinvolto 127 bambini di età compresa tra i cinque e gli otto anni con una diagnosi primaria di OCD. Ciascuno di loro ha poi ricevuto una terapia familiare CBT o una terapia sempre familiare ma di rilassamento.
Lo scopo della terapia familiare CBT era quello di fornire al bambino e ai genitori gli “strumenti” necessari per capire, gestire e ridurre i sintomi ossessivo-compulsivi. Questo approccio includeva pertanto interventi psicoeducativi, sulle strategie parentali e di rivelazione familiare. In questo modo, i bambini potevano gradualmente imparare a fronteggiare situazioni paurose e allo stesso tempo a tollerare i propri sentimenti ansiosi. La terapia familiare di rilassamento, invece, si concentrava sull’insegnamento ai genitori di strategie di distensione muscolare da proporre ai figli al fine di diminuire il loro livello di ansia.
Al termine del periodo sperimentale, il 72% dei bambini che avevano ricevuto un trattamento CBT con EX/RP venivano valutati come “migliorati” o “molto migliorati” alla Clinical Global Impression-Improvement Scale, contro il 41% dei bambini che avevano ricevuto una terapia familiare di rilassamento.Secondo Freeman, i risultati dello studio sostengono la maggiore efficacia del trattamento EX/RP familiare in bambini con una precoce manifestazione di sintomi ossessivo-compulsivi. Questo approccio risulterebbe, infatti, più vicino ai bisogni di sviluppo del bambino e del suo contesto familiare, fornendo ai genitori un supporto adeguato che consente di vivere il trattamento in modo più tollerabile e accettabile.
L’auspicio è che, quindi, anche altri comincino ad utilizzare questo modello di trattamento in bambini con un esordio precoce del disturbo, al fine di combattere gli aspetti di cronicità che sono spesso all’origine di un impatto debilitante dello stesso nel corso dell’intero percorso di crescita dell’individuo.
ARGOMENTI CORRELATI:
Bambini e Adolescenti
ARTICOLI CONSIGLIATI:
Terapia cognitivo- comportamentale nei pazienti con disturbo ossessivo compulsivo
BIBLIOGRAFIA:
- Freeman, J., Sapyta, J., Garcia, A., Compton, S., Khanna, M., Flessner, C., FitzGerald, D., Mauro, C., Dingfelder, R., Benito, K., Harrison, J., Curry, J., Foa, E., March, J., Moore, P., Franklin, M. (2014). Family-Based Treatment of Early Childhood Obsessive- Compulsive Disorder. JAMA Psychiatry. DOI: 10.1001/jamapsychiatry.2014.170



