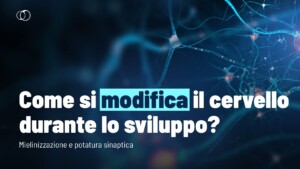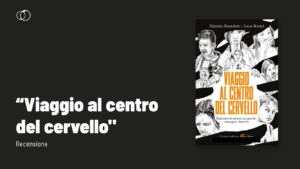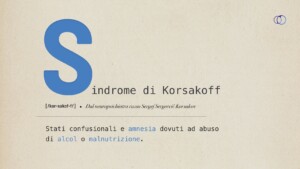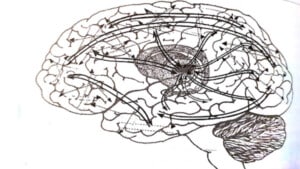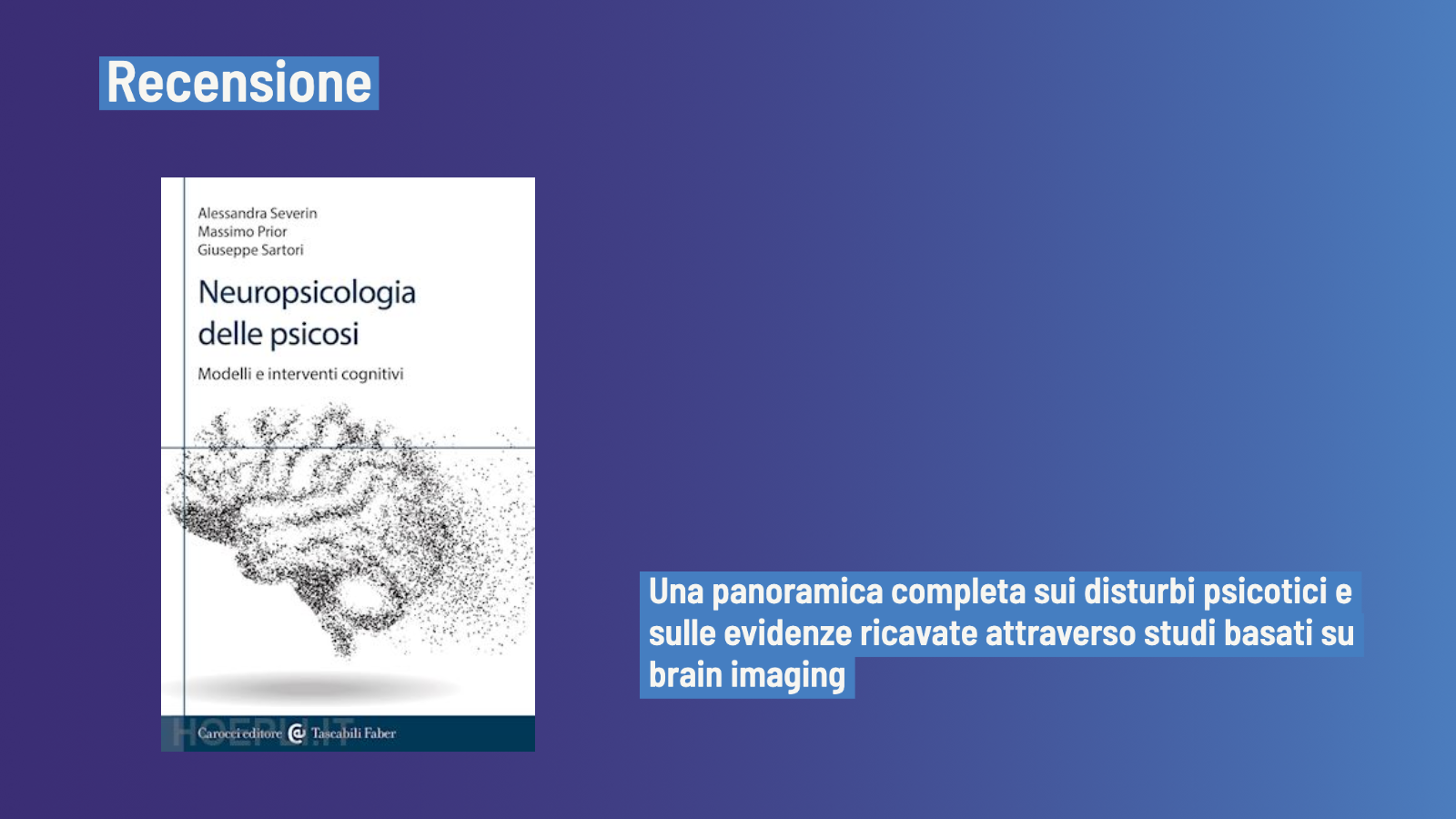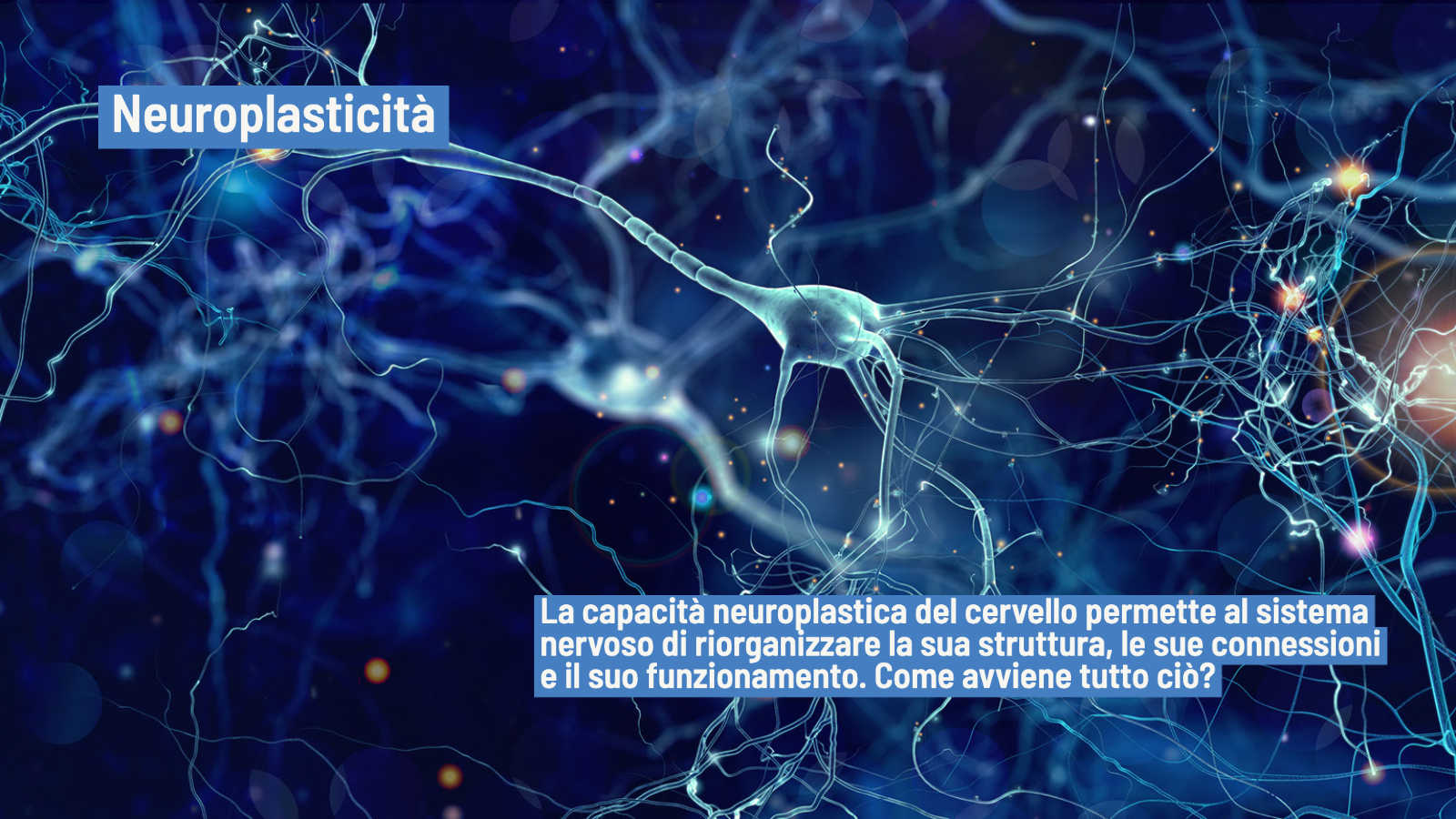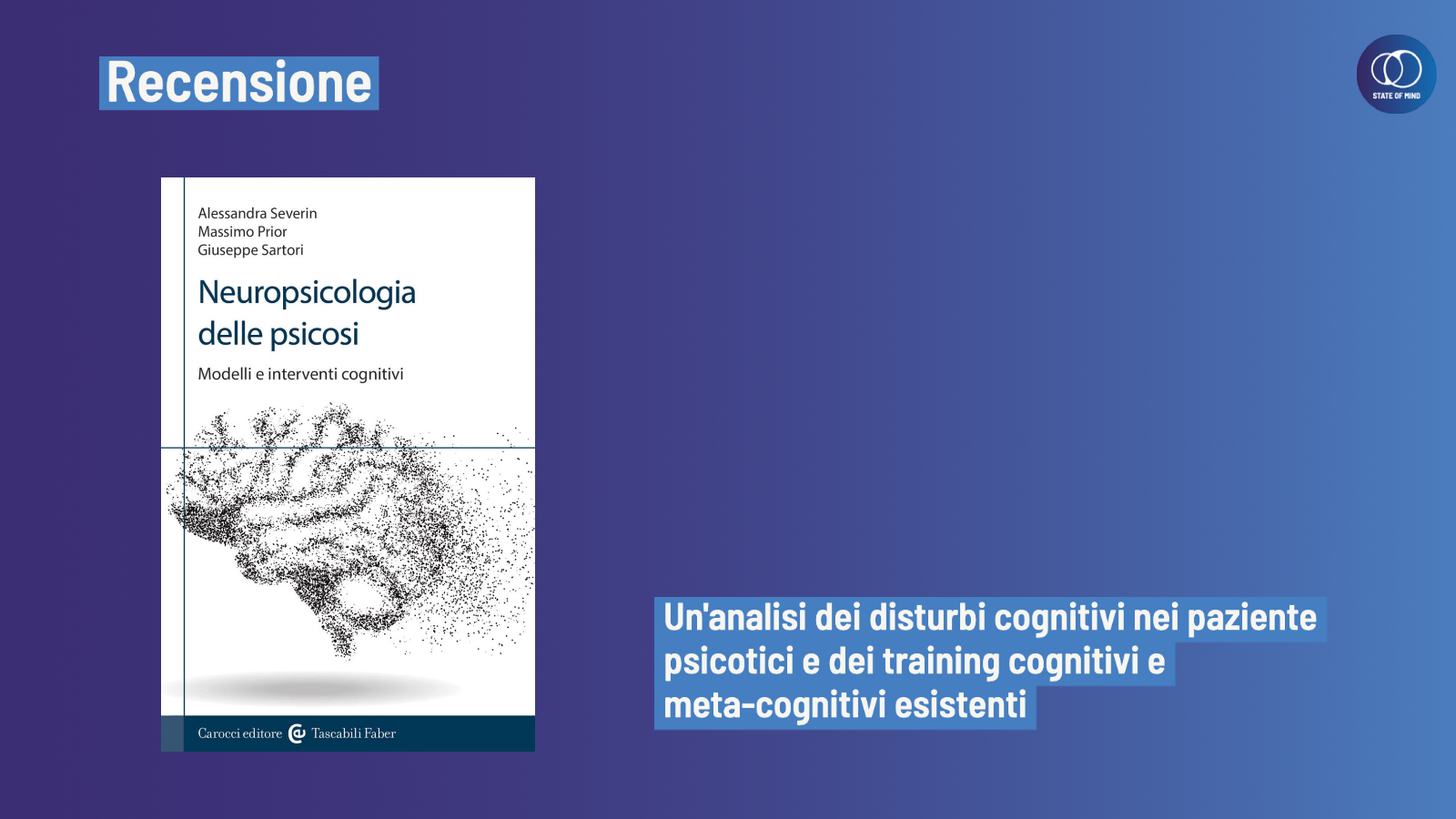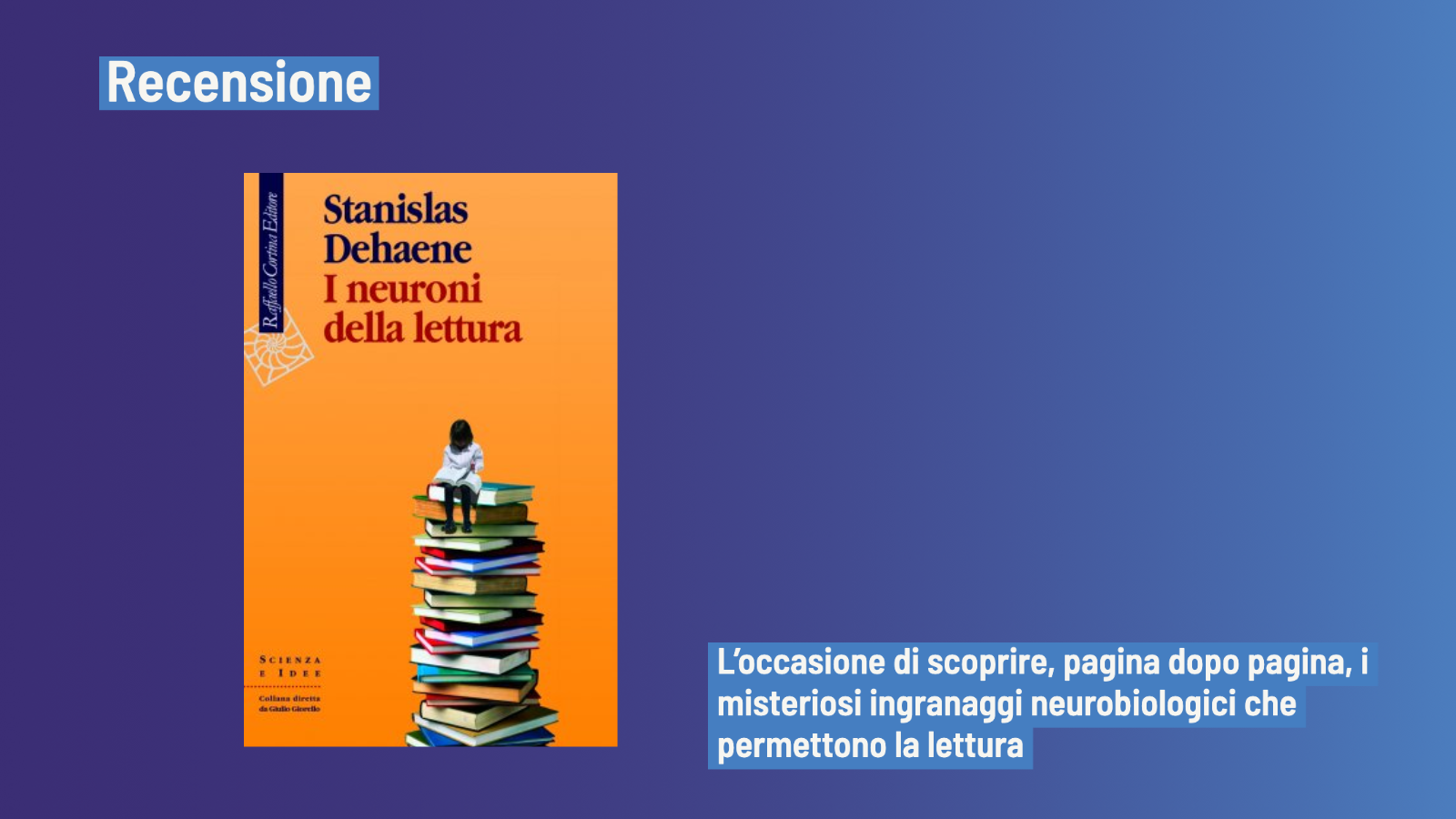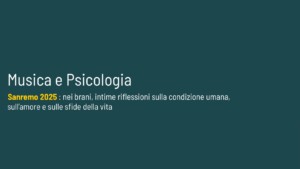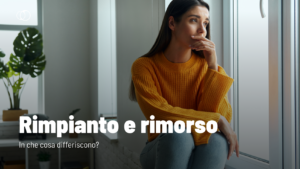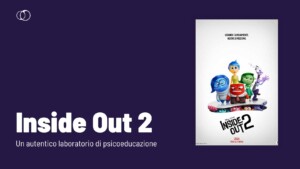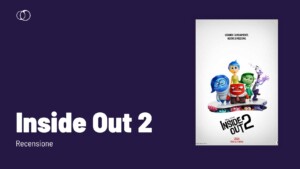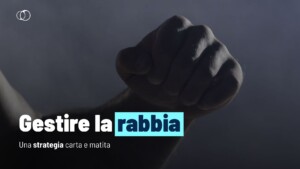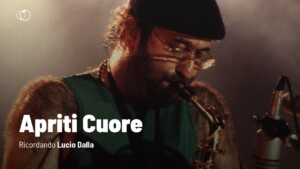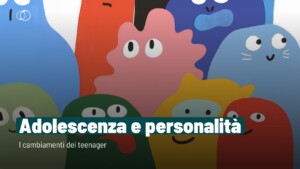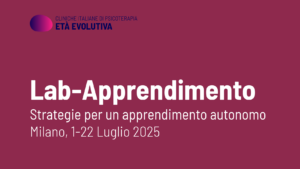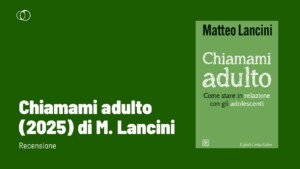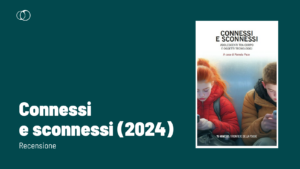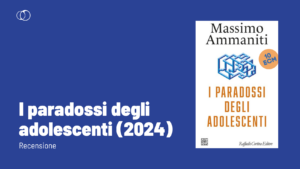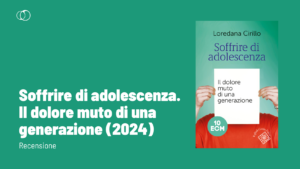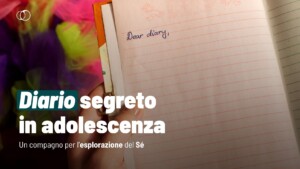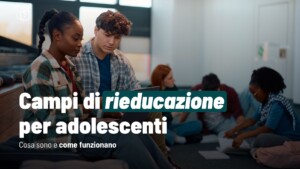Il dilemma del trolley, il conflitto tra colpa deontologica e colpa altruistico/umanitaria e il disturbo ossessivo
Il dilemma del trolley sembra mettere in conflitto due tipi di morale, una per così dire orizzontale, interpersonale, funzionale a salvaguardare il bene degli altri, dunque una morale essenzialmente umanitaria. L’altra verticale cioè orientata verso il rispetto della autorità morale, riconosciuta autorevole e spesso introiettata, e funzionale a limitare i diritti decisionali del singolo individuo, dunque una morale deontologica.
È pubblicato online, sul JBTEP, un articolo di Mancini e Gangemi (2015), che include due ricerche che corroborano due tesi, già suffragate da studi precedenti. La prima è di psicologia generale, e sostiene l’esistenza di due sensi di colpa: uno altruistico/umanitario e l’altro deontologico. La seconda, invece, è di psicologia clinica e afferma che i pazienti ossessivi siano più preoccupati di evitare colpe deontologiche piuttosto che colpe umanitarie/altruistiche.
Entrambe le ricerche hanno utilizzato il cosiddetto paradigma del trolley, in particolare la versione basica che consente di porre in conflitto i due sensi di colpa. Il conflitto tra i due sensi di colpa non è raro, basti pensare al problema morale posto dalla eutanasia: è giusto aiutare una persona che soffre senza speranza, a morire? O, piuttosto, nessun essere umano ha il diritto di sostituirsi a Dio o al destino, e dunque nessuno ha il diritto di decidere di morire o di aiutare un altro a farlo? Fino a che punto il desiderio altruistico e umanitario di non far soffrire un’altra persona autorizza a mettersi nei panni di Dio?
La storia dice che la prima formulazione del dilemma del trolley, la cosiddetta switch version, fu pubblicata nel 1967 da Philippa Bonsanquet (poi Foot) su Oxford Review. Da allora ne sono state formulate molte versioni dando vita alla cosiddetta trolleylogy che costituisce il paradigma più utilizzato nelle ricerche di psicologia morale e nella experimental phlilosophy (Edmonds, 2014).
La leggenda vuole che la Foot abbia preso spunto da un episodio reale avvenuto durante la seconda guerra mondiale (Edmonds, 2014).
Alle 4.13 am del 13 giugno 1944, Londra fu colpita dalla prima bomba volante, denominata dai nazisti V1. Le V1 erano una sorta di missile lanciate da basi poste nella Francia occupata. Alla prima V1 ne seguirono centinaia che colpirono Londra con effetti devastanti. Erano ordigni potenti ma imprecisi e i tedeschi avevano bisogno di sapere dove cadevano le V1, per adeguarne la traiettoria e colpire il centro di Londra, al fine di causare il maggior numero di vittime e danni. Gli inglesi, tramite agenti segreti doppi, tra i quali Greta Garbo, erano in grado di passare ai nazisti informazioni false sui reali luoghi di caduta delle V1, quindi potevano far modificare le traiettorie delle bombe volanti in modo da salvaguardare le zone centrali di Londra, più abitate e frequentate, a discapito di aree più periferiche e meno affollate della città.
Era possibile, perciò, salvare molti a discapito di pochi, ma era giusto? Il conflitto morale di chi doveva decidere, è evidente. Da una parte c’era l’opportunità di ridurre il numero di morti, e quindi una motivazione sostanzialmente umanitaria, ma dall’altra la responsabilità di decidere quali cittadini sarebbero morti e quali no, e quindi il freno della norma morale intuitiva “not play God” vale a dire: “Chi sono io per decidere chi vive e chi muore?”.
La decisione ultima spettava al primo ministro, Winston Churchill, il quale, già in altre occasioni, sembra che avesse dimostrato di non avere molte remore a mettersi nei panni di Dio. Churchill impartì l’ordine di depistare il nemico e con questo si riconobbe il diritto di decidere quali cittadini far morire e quali salvare. I servizi segreti inglesi fecero arrivare ai nazisti informazioni false. L’operazione ebbe successo e le V1 cominciarono a cadere sui quartieri meridionali di Londra. Furono salvate 10.000 vite ma, dopo la guerra, non fu mai data grande pubblicità alla notizia.
Nel 1967 Philippa Foot formalizzò il dilemma di Churchill: il trolley dilemma. [blockquote style=”1″]Un vagone, completamente fuori controllo, procede a tutta velocità lungo un binario sul quale sono bloccate cinque persone che, sicuramente, saranno travolte e uccise. L’unica possibilità di salvezza dei cinque sei tu che ti trovi vicino a uno scambio. Se muovi lo scambio, dirotti il vagone su un altro binario dove però si trova un’altra persona che non avrà scampo e morirà. Cosa devi fare?[/blockquote].
Studi successivi hanno rilevato che circa l’80 – 90 % delle persone decide di muovere lo scambio (Greene, 2002). Da una ricerca di Gangemi e Mancini (2013) risulta che le persone che decidono di muovere lo scambio, affermano di farlo “perché così si salvano quattro vite”, cioè sono mosse dalla intenzione di ridurre il più possibile la sofferenza degli altri, dunque da una motivazione umanitaria. Diversamente, chi decide di non muovere lo scambio riferisce di non riconoscersi il diritto di stabilire chi vive e chi muore, dunque intende rispettare la norma morale Not play God e lasciare la decisione al destino (Gangemi e Mancini, 2013).
Il dilemma del trolley, pertanto, sembra mettere in conflitto due tipi di morale, una per così dire orizzontale, interpersonale, funzionale a salvaguardare il bene degli altri, dunque una morale essenzialmente umanitaria. L’altra verticale cioè orientata verso il rispetto della autorità morale, riconosciuta autorevole e spesso introiettata, e funzionale a limitare i diritti decisionali del singolo individuo, dunque una morale deontologica.
In una versione modificata del dilemma (Gangemi e Mancini, 2013) era chiesto ai soggetti di immaginarsi accanto allo scambio ma con vicino una autorità autorevole, come ad esempio un giudice. A queste condizioni, la maggior parte dei soggetti non muoveva lo scambio. Ciò suggerisce che a frenare la motivazione umanitaria possa intervenire il riconoscimento del limite della propria libertà decisionale, cioè il rispetto del principio “Not play God”.
Al contrario, tutti i soggetti ai quali era chiesto di vedersi accanto allo scambio ma vicino alle cinque vittime potenziali, ritenevano che fosse giusto muovere lo scambio e salvare i cinque, anche se ciò avrebbe comportato la morte certa di un altro individuo. Sembra quindi confermato che la mente umana tenga conto di due morali che non sempre vanno d’accordo: una umanitaria/altruistica e una deontologica. A conferma di questa differenza c’è la dimostrazione che sia possibile indurre separatamente i due sensi di colpa, ad esempio attraverso l’esposizione a facce e frasi di dialogo interno (Basile e Mancini, 2011).
Per giunta, questo tipo di induzione attiva, alla fMRI, aree cerebrali diverse e, fatto interessante, l’induzione di senso di colpa deontologico attiva le insulae e la paleocorteccia che è anche il substrato neurale del disgusto, mentre il senso di colpa altruistico attiva aree cerebrali normalmente coinvolte nei compiti di teoria della mente (Basile et al., 2011). I due sensi di colpa possono essere indotti pure attraverso l’immedesimazione in storie e la rievocazione di episodi della propria vita.
Come riscontrato nella ricerca di Mancini e Gangemi (2015), l’induzione di senso di colpa deontologico implica scelte prevalentemente omissive, vale a dire una preferenza per il rispetto del principio Not play God, mentre l’induzione del senso di colpa altruistico implica la scelta di muovere lo scambio per salvare il maggior numero possibile di vite, cioè prevale lo scopo altruistico/umanitario.
Nello stesso articolo, assieme a questa ricerca che ha coinvolto soggetti non clinici, è stata pubblicata una seconda ricerca con pazienti ossessivi. Il risultato è stato che i pazienti ossessivi risolvono il dilemma decidendo di non muovere lo scambio e dunque di rispettare il principio Not play God, al contrario di altri pazienti con disturbi d’ansia e di soggetti non clinici. Dunque i pazienti ossessivi sembrano più preoccupati di prevenire una colpa deontologica che una colpa umanitario/altruistica.
Questo dato arricchisce e rende più precisa la tesi “morale” del disturbo ossessivo, vale a dire che alla base della sintomatologia ossessiva vi sia lo scopo di prevenire una colpa. Non si tratterebbe quindi di una colpa qualsiasi ma di una colpa deontologica. Questa tesi è suffragata da ricerche precedenti, in particolare dal fatto che l’induzione di senso di colpa deontologica attiva il cervello degli ossessivi, come risulta dalla fMRI, in modo diverso da quanto accade nei soggetti non clinici, mentre non ci sono differenze se è indotto senso di colpa altruistico (Basile et al., 2013). Altro sostegno alla tesi viene dalla dimostrazione che l’induzione di senso di colpa deontologico in soggetti non clinici implica controlli e lavaggi simil ossessivi mentre ciò non accade se è indotto senso di colpa altruistico (D’Olimpio e Mancini, 2014).
Per giunta è nota la tendenza dei pazienti ossessivi a essere ossessionati da pensieri che suscitano il sospetto di essere persone perverse o blasfeme anche se ciò non implica in alcun modo danni o sofferenze per alcuno, ed è altresì ben dimostrato che la riduzione della responsabilità, e dunque della possibilità di essere colpevoli, implichi riduzione della sintomatologia ossessiva, anche se alla riduzione di responsabilità non si accompagna la riduzione del rischio per gli altri. Ad esempio la riduzione della responsabilità di un’eventuale fuga di gas implica la riduzione dei rituali di controllo, pur se il rischio per le potenziali vittime rimane lo stesso (Lopatcka e Rachman, 1995; Shafran, 1997).
In conclusione, i due esperimenti appena pubblicati aggiungono prove a favore della tesi che distingue due sensi di colpa, uno altruistico/umanitario e l’altro deontologico, e anche della tesi secondo la quale alla base del disturbo ossessivo vi sarebbe un timore particolarmente grave di essere colpevoli in senso deontologico.
ARTICOLO CONSIGLIATO:
Superare la colpa in due terapeuti italiani: Davide Lopez e Francesco Mancini
BIBLIOGRAFIA:
- Basile B., Mancini F. (2011). Eliciting Guilty Feelings: A Preliminary Study Differentiating Deontological and Altruistic Guilt. Psychology. 2 (2), pp. 98-102.
- Basile, B., Mancini, F., Macaluso, E., Caltagirone, C., Frackowiak, R.S.J. e Bozzali, M. (2011). Deontological and Altruistic Guilt: Evidence for Distinct Neurobiological Substrates. Human Brain Mapping. Inc. 32, 229-239
- Basile, B., Mancini, F., Macaluso, E., Caltagirone, C., Bozzali, M. (2013). Abnormal processing of deontological guilt in obsessive-compulsive disorder – Brain Structure and Function, pp 1- 11
- D’Olimpio, F., Mancini, F., (2014). Role of Deontological Guilt in Obsessive-Compulsive Disorder Like Checking and Washing Behaviors. Clinical Psychological Science, Published online before print April 30, 2014, doi:10.1177/2167702614529549
- Edmonds, D. (2014) Would you kill the fat man? Princeton University Press
- Greene, J. D., & Haidt, J. (2002). How (and where) does moral judgment work? Trends in Cognitive Sciences, 6, 517–523. DOWNLOAD
- Foot, P., (1967) The problem of Abortion. Oxford Review, 5.
- Lopatcka, C., & Rachman, S. (1995). Perceived responsibility compulsive and checking: and experimental analysis. Behaviour Research and Therapy, 33, 673-684.
- Mancini, F. and Gangemi A. (2015). Deontological Guilt and Obsessive-Compulsive Disorder. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, in press Published online before print, May, 16th, 2015 http://dx.doi.org/10.1016/j.jbtep.2015.05.003 DOWNLOAD
- Shafran, R. (1997). The manipulation of responsibility in obsessive-compulsive disorder. British Journal of Clinical Psychology, 36, 397- 407.