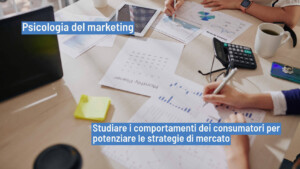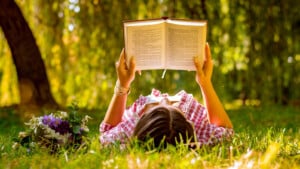Psiconcologia: affrontare la malattia oncologica
Martina Lattanzi – OPEN SCHOOL Studi Cognitivi San Benedetto Del Tronto
I sentimenti suscitati sono molto intensi, come un senso di irrealtà, diniego, incredulità, disorientamento, rabbia. In seguito diverse domande invadono la mente del paziente: “Perché è successo proprio a me?”, “Cosa mi accadrà adesso?”, “Sarò in grado di affrontare la malattia?”.
Il modo di reagire al proprio stato di salute o di malattia, così come lo sviluppo, il decorso e la prognosi stessa della malattia oncologica sono influenzati dall’interazione di diversi fattori: di tipo biologico, psicologico e sociale. Ogni paziente vive e affronta la malattia in modo soggettivo e unico: si attiva un processo di adattamento alla nuova condizione fisica, che comporta una trasformazione radicale nella vita del paziente.
La comunicazione della malattia tumorale rappresenta uno degli eventi più stressanti che alcune persone si trovano a dover affrontare nel corso della loro vita, un cambiamento non solo fisico ma anche mentale: cambia il modo di percepire e sentire il proprio corpo, cambia la percezione che si ha del mondo, cambiano le relazioni sociali e interpersonali. Si tratta di una fase molto delicata e difficile sia per il paziente che per i suoi familiari: di fronte alla parola “cancro” la primissima reazione è avvertire un senso di confusione, sbandamento, un vero e proprio shock. Il cancro è una parola che evoca emozioni angoscianti, rimanda a uno scenario altamente catastrofico nell’immaginario collettivo, ad una “condanna a morte”.
I sentimenti suscitati sono molto intensi, come un senso di irrealtà, diniego, incredulità, disorientamento, rabbia. In seguito diverse domande invadono la mente del paziente: “Perché è successo proprio a me?”, “Cosa mi accadrà adesso?”, “Sarò in grado di affrontare la malattia?”.
Il modo di gestire la “crisi emotiva” generata dalla diagnosi medica, l’atteggiamento di fronte all’evento spesso traumatico influenzerà il tipo di adattamento psicosociale alla malattia. L’atteggiamento e lo stile di coping utilizzato andranno ad influenzare non solo la qualità di vita successiva alla diagnosi, ma anche la compliance ai trattamenti medici e il decorso biologico della malattia (Putton et al., 2011).
Vi sono infatti comportamenti più adattivi e altri meno adattivi nell’affrontare la propria condizione di salute.
Pilowsky (1978) parla di “comportamento abnorme di malattia” sottolineando come la percezione, la valutazione e di conseguenza i comportamenti attuati in relazione al proprio stato di salute possano essere inappropriati e maladattivi, nonostante ci sia stata da parte del medico una adeguata spiegazione sulla natura della malattia, e sia stato definito un adeguato percorso di cure, basandosi sugli aspetti biologici, psicologici, sociali e culturali. Il comportamento abnorme di malattia include sia condizioni caratterizzate da una affermazione della malattia, ad esempio l’ipocondria o i sintomi di conversione (Pilowsky, 1990), sia la minimizzazione o negazione dei sintomi (Pilowsky, 1978).
Il coping rappresenta una modalità cognitivo-comportamentale con il quale un individuo affronta un evento stressante e le sue conseguenze emozionali. La capacità di far fronte ad una crisi esistenziale dipende da diversi fattori: dal tipo di patologia (sintomi e decorso), dal livello di adattamento precedente alle situazioni di malattia, dal significato della minaccia esistenziale, da fattori culturali e religiosi, dall’assetto psicologico e dalla personalità, dall’istruzione e da eventuali disturbi psichiatrici presenti (Putton et al., 2011).
Tra i pazienti oncologici sono state rilevate diverse strategie di coping nell’affrontare lo stress legato alla malattia neoplastica. Le principali strategie individuate da Burgess (1988) sono:
– Hopelessness/helplessness, caratterizzato da elevati livelli di ansia e di depressione, dall’incapacità di mettere in atto strategie cognitive finalizzate all’accettazione della diagnosi, dalla convinzione di un controllo esterno sulla malattia;
– Spirito combattivo, contraddistinto da moderati livelli di ansia e di depressione, da numerose risposte comportamentali attraverso le quali il paziente cerca di reagire positivamente e costruttivamente alla situazione, dalla convinzione di un controllo interno sulla malattia;
– Accettazione stoica, con bassi livelli di ansia e depressione, attitudine fatalistica, dalla convinzione di un controllo esterno della malattia;
– Negazione/evitamento, in cui appaiono del tutto assenti sia le manifestazioni ansioso-depressive, sia le strategie cognitive, nella convinzione da parte del paziente di un controllo sia interno che esterno della malattia.
La percezione del controllo che si ha sulla malattia o più in generale sugli eventi di vita stressanti è un fattore importante nel determinare lo “stile di coping” messo in atto e ha una grande influenza sulla salute e sul decorso della malattia. Le persone possono sentire di avere un controllo interno o esterno sugli eventi:
– I soggetti con un locus of control interno sentono di poter esercitare un controllo sugli eventi, credono in se stessi e in ciò che si prefiggono. Nei confronti delle malattie reagiscono in termini risolutivi e in prima persona, sono propositivi e collaborano con l’equipe medica. Sembra essere un fattore protettivo per la salute in generale e elemento positivo per il decorso della malattia.
– I soggetti con locus of control esterno reagiscono in modo passivo agli eventi, non si sentono responsabili né sentono di avere un controllo su quanto gli accade, tendono a dare la colpa agli altri. Questo atteggiamento sembra essere un fattore di rischio per la salute in generale e anche per il decorso delle malattie.
La percezione del controllo di un evento, insieme alla desiderabilità, sono quindi fattori fondamentali nella valutazione cognitiva di uno stressor: più gli eventi sono percepiti come indesiderabili e incontrollabili maggiore sarà la probabilità di percepire quell’evento come stressante e maggiori saranno le probabilità di ripercussioni negative sulla salute (Grandi et al., 2011).
Tra le strategie di coping maggiormente utilizzate dai pazienti oncologici nell’affrontare l’impatto emotivo della malattia, la negazione/evitamento si riscontra in modo rilevante proprio durante la fase diagnostica della malattia e risulta associata a bassi livelli di stress emozionale (Watson et al., 1984). La negazione di malattia è stata definita come un meccanismo di difesa che permette di prendere le distanze da una realtà minacciosa e preoccupante, “un rifiuto conscio o inconscio di una parte o di tutto il significato di un evento per allontanare la paura, l’ansia o altri affetti spiacevoli” (Hackett et al. 1968). Un paziente può negare la diagnosi, la prognosi o la gravità della malattia, oppure può ignorare o dimenticare quello che il medico gli ha riferito con la diagnosi, oppure rifiutare di aderire al trattamento proposto. Secondo Breznitz (1983) la negazione che si attiva in risposta ad uno stimolo minaccioso per la propria salute determina un certo grado di distorsione della realtà e può riguardare diversi aspetti o parti di essa.
Esistono quindi sette tipi di negazione che si articolano lungo un continuum graduale:
1. La negazione del significato personale della minaccia percepita;
2. la negazione dell’urgenza;
3. la negazione della vulnerabilità o della responsabilità;
4. la negazione delle emozioni correlate;
5. la negazione del significato affettivo;
6. la negazione della presenza di un’informazione minacciosa,
7. la negazione di ogni tipo di informazione.
Quale funzione ha la negazione di malattia sul decorso della patologia oncologica? Un aspetto molto interessante e dibattuto dagli studiosi riguarda il ruolo o la funzione che assume la negazione sul decorso dei disturbi medico-internistici in quanto a seconda della fase di sviluppo della malattia in cui si trova il paziente la negazione può avere un valore positivo o negativo, in relazione al contributo che può dare al miglioramento o al peggioramento della condizione medica. Dagli studi presenti in letteratura emerge come il meccanismo difensivo svolga un ruolo adattivo nelle fasi iniziali della malattia perché protegge il paziente dalla paura, dallo sconforto che si provano di fronte alla diagnosi medica.
In studi condotti su donne con cancro al seno si rileva un’associazione positiva tra la negazione degli effetti della malattia (ovvero tutti i cambiamenti e le conseguenze negative che comporta la malattia oncologica) e livelli inferiori di sofferenza emotiva (Meyerowitz et al., 1983) nonché minori livelli di ansia e disturbi dell’umore (Watson et al., 1984). La negazione quindi attraverso una “distorsione” della realtà, nascondendo a se stessi la presenza del cancro, aiuta a ridurre il senso di sopraffazione (Moyer et al., 1998), di disperazione, di paura, di impotenza che si provano al momento della diagnosi medica, contribuendo a preservare un’immagine positiva di sé e l’autostima (Livneh, 2009).
Se ci soffermiamo a pensare a quante volte ci è capitato nella vita quotidiana di rifiutare, negare una notizia, un’informazione o un evento che non avremmo mai voluto sapere nel tentativo di difenderci dalle emozioni negative e allontanare così dalla nostra coscienza un pensiero doloroso che ci crea sofferenza, possiamo effettivamente comprendere perché la negazione della malattia oncologica ha un effetto positivo sul benessere psicologico del paziente. Ma approfondendo ulteriormente tali studi emerge un altro dato interessante, ovvero la correlazione tra negazione di malattia e maggiore sopravvivenza tra i pazienti oncologici (Greer et al., 1979; Butow et al., 1999).
Nello studio longitudinale di Greer et al. (1990), condotto su donne con carcinoma mammario, ad un follow-up di 5, 10 e 15 anni, la negazione di malattia risulta essere la risposta psicologica che si associa ad una più lunga sopravvivenza e a meno recidive rispetto ad un atteggiamento di accettazione o di mancanza di speranza, che si associano invece ad una prognosi peggiore. Nello studio di Butow et al. (2000) le pazienti che utilizzano la negazione come strategia di difesa hanno un cancro meno aggressivo e meno grave con una minore probabilità di metastasi, sperimentano meno sintomi fisici e una migliore qualità della vita. Il motivo che spiega tale associazione rilevata non è però del tutto chiaro: tra le diverse ipotesi avanzate ve ne è una secondo la quale la negazione potrebbe avere un’influenza positiva in modo indiretto, ovvero negare di avere una malattia tumorale protegge il paziente dall’esperire sentimenti negativi di depressione o demoralizzazione, sentimenti che inficiano negativamente sulla prognosi della malattia (Fava et al., 2007). Di conseguenza le persone saranno anche più inclini ad instaurare relazioni interpersonali, a condividere e ricevere supporto sociale, fattori positivi di protezione non solo per la salute psichica ma anche per l’evoluzione della patologia oncologica (Butow et al. 2000; Brajkovic et al., 2013 ).
Gli studi sopra citati dimostrano quanto sia importante, nell’affrontare un percorso di riabilitazione oncologica, considerare non solo la condizione clinica del paziente ma anche i fattori psicologici, culturali e sociali che influenzano il decorso di un disturbo medico e contribuiscono in modo rilevante a determinarne l’evoluzione. Il modello biopsicosociale di Engel (1977) sottolinea l’importanza di superare la prospettiva strettamente medica e di considerare anche il ruolo degli eventi di vita stressanti, la vulnerabilità individuale alla malattia, il comportamento di malattia, le esperienze di vita, il modo di percepire, valutare e rispondere al proprio stato di salute. Bisogna anche sottolineare che il meccanismo difensivo della negazione in alcuni casi può determinare la messa in atto di comportamenti e atteggiamenti che vanno a peggiorare la condizione di salute: trascurare i sintomi e il loro significato, non rispettare l’aderenza alle terapie mediche, ritardare nel tempo la consultazione medica rendono più sfavorevole la prognosi della malattia oncologica (Wool et al., 1986).
La tempestività della diagnosi di cancro e la compliance (aderenza) al trattamento medico sono determinanti nell’aumentare le probabilità di una risoluzione positiva della malattia oncologica, per questo è necessario assistere psicologicamente il paziente sin dal momento della diagnosi, come già si sta facendo in diversi ospedali italiani dove sono presenti psicologi che affiancano il medico.
La negazione o il diniego potrebbero compromettere l’aderenza del paziente alle prescrizioni mediche, ai farmaci, agli esami di laboratorio, ai controlli clinici e tutto ciò ha un a grande rilevanza clinica: la paura, le pressioni sociali, il senso di responsabilità ma anche la cultura di appartenenza sono tutti fattori che potrebbero essere collegati con la negazione di malattia (Phelan et al., 1992).
Cosa può fare lo psicologo per aiutare il paziente ad affrontare la malattia? La “sindrome psiconeoplastica” (Guarino, 1994) riguarda una serie di dinamiche psicologiche profonde, scaturite dalla diagnosi di cancro, e può presentarsi come una costellazione di sintomi psicopatologici la cui intensità dipende dall’interazione di diversi fattori: la personalità del paziente, le esperienze passate, l’età, le relazioni interpersonali presenti e passate, la presenza di un contesto sociale e familiare supportivo, la gravità e il tipo di tumore stesso. I sintomi psicopatologici maggiormente presenti, come precedentemente visto sono: senso di paura e stress, ansia, depressione, alterazione immagine di sé e del corpo, aggressività, rabbia, ostilità, senso di colpa, di invidia, di ingiustizia e uso massiccio del meccanismo di difesa della negazione e rimozione.
Lo psicologo clinico può fare molto all’interno dell’équipe medica riconoscendo i bisogni del paziente e aiutandolo ad affrontare il grande percorso di cambiamento fisico e psicologico che dovrà inevitabilmente affrontare con la malattia (www.psiconcologia.info). In una prima fase di sostegno psicologico il paziente viene aiutato a elaborare il trauma conseguente alla diagnosi di tumore e a sostenere il “peso della malattia”:
– contenere l’ansia e le emozioni negative mantenendo un equilibrio psicologico;
– mobilitare meccanismi di difesa adeguati;
– favorire la comunicazione e l’espressione delle emozioni negative.
Il modo migliore di aiutare il paziente ad affrontare e superare lo shock iniziale sarà quello di rispettare i tempi soggettivi di accettazione della diagnosi medica, sostenendo e accogliendo le paure, i timore, i dubbi iniziali del paziente. Ogni persona ha un proprio modo di reagire e affrontare la malattia che deve essere compreso e rispettato lungo tutto il percorso di cura, in quanto l’adattamento alla malattia richiede tempo e risorse personali. Il paziente una volta superata la fase iniziale di disorientamento potrà avviare un percorso di elaborazione/integrazione della malattia nella propria esperienza di vita, fino ad arrivare ad una piena consapevolezza e accettazione della patologia.
In questa fase lo psicologo potrà aiutare il paziente a gestire la malattia, a incoraggiare l’espressione e la comunicazione delle emozioni coinvolgendo anche i familiari, a sviluppare modalità più adattive di affrontare la malattia, a dare un senso a quanto accaduto, a ridare un senso di speranza e ottimismo verso il futuro.
ARTICOLO CONSIGLIATO:
La meditazione Tong Len e il paziente oncologico
BIBLIOGRAFIA:
- Butow, P. N., Coates, A. S., e Dunn, S. M. (1999). Psychosocial predictors of survival in metastatic melanoma. Journal of Clinical Oncology, 17, 2256-2256.
- Butow, P. N., Coates, A. S., e Dunn, S. M. (2000). Psychosocial predictors of survival: metastatic breast cancer. Annals of Oncology, 11, 469-474.
- Brajkovic, L., Bras, M., Djordjevic, V., e Radic, I. (2013). Breast cancer: quality of life and importance of psychological support-Croatian sample. Psychotherapy and Psychosomatics, 82, 13-14.
- Fava, G. A., Fabbri, S., Sirri, L., e Wise, T. N. (2007). Psychological factors affecting medical condition: a new proposal for DSM-V. Psychosomatics, 48, 103-111.
- Grandi, S., Rafanelli, C., e Fava, G. A. (2011). Manuale di Psicosomatica. Roma: Il Pensiero Scientifico.
- Greer, S., Morris, T., e Pettingale, K. W. (1979). Psychological response to breast cancer: effect on outcome. The Lancet, 314, 785-787.
- Greer, S., Morris, T., Pettingale, K. W., e Haybittle, J. L. (1990). Psychological response to breast cancer and 15-year outcome. The Lancet, 335, 49-50.
- Hackett, T. P., Cassem, N. H., e Wishnie, H. A. (1968). The coronary-care unit: an appraisal of its psychologic hazards. The New England Journal of Medicine, 279, 1365-1370.
- Livneh, H. (2009). Denial of Chronic Illness and Disability Part I. Theoretical, Functional, and Dynamic Perspectives. Rehabilitation Counseling Bulletin, 52, 225-236.
- Meyerowitz, B. E., Watkins, I. K., e Sparks, F. C. (1983). Psychosocial implications of adjuvant chemotherapy. A two‐year follow‐up. Cancer, 52, 1541-1545.
- Moyer, A., e Levine, E. G. (1998). Clarification of the conceptualization and measurement of denial in psychosocial oncology research. Annals of Behavioral Medicine, 20, 149-160.
- Phelan, M., Dobbs, J., e David, A. S. (1992). ‘I thought it would go away’: patient denial in breast cancer. Journal of the Royal Society of Medicine, 85, 206-207.
- Pilowsky, I. (1978). A general classification of abnormal illness behaviours. British Journal of Medical Psychology, 51, 131-137.
- Pilowsky, I. (1990). The concept of abnormal illness behavior. Psychosomatics, 31, 207-213.
- Putton, A., & Fortugno, M. (2011). Affrontare la vita. Roma: Carocci.
- Sarno, P. (2009). La sindrome neoplastica. Prevenzione Tumori, 6/7. Consultato il 23 marzo 2015, su http://www.prevenzionetumori.it/
- Watson, M., Greer, S., Blake, S., e Shrapnell, K. (1984). Reaction to a diagnosis of breast cancer relationship between denial, delay and rates of psychological morbidity. Cancer, 53, 2008-2012.
- Wool, M. S. (1986). Extreme denial in breast cancer patients and capacity for object relations. Psychotherapy and Psychosomatics, 46, 196-204.
 INTRODUZIONE ALLA PSICOLOGIA (14)
INTRODUZIONE ALLA PSICOLOGIA (14)