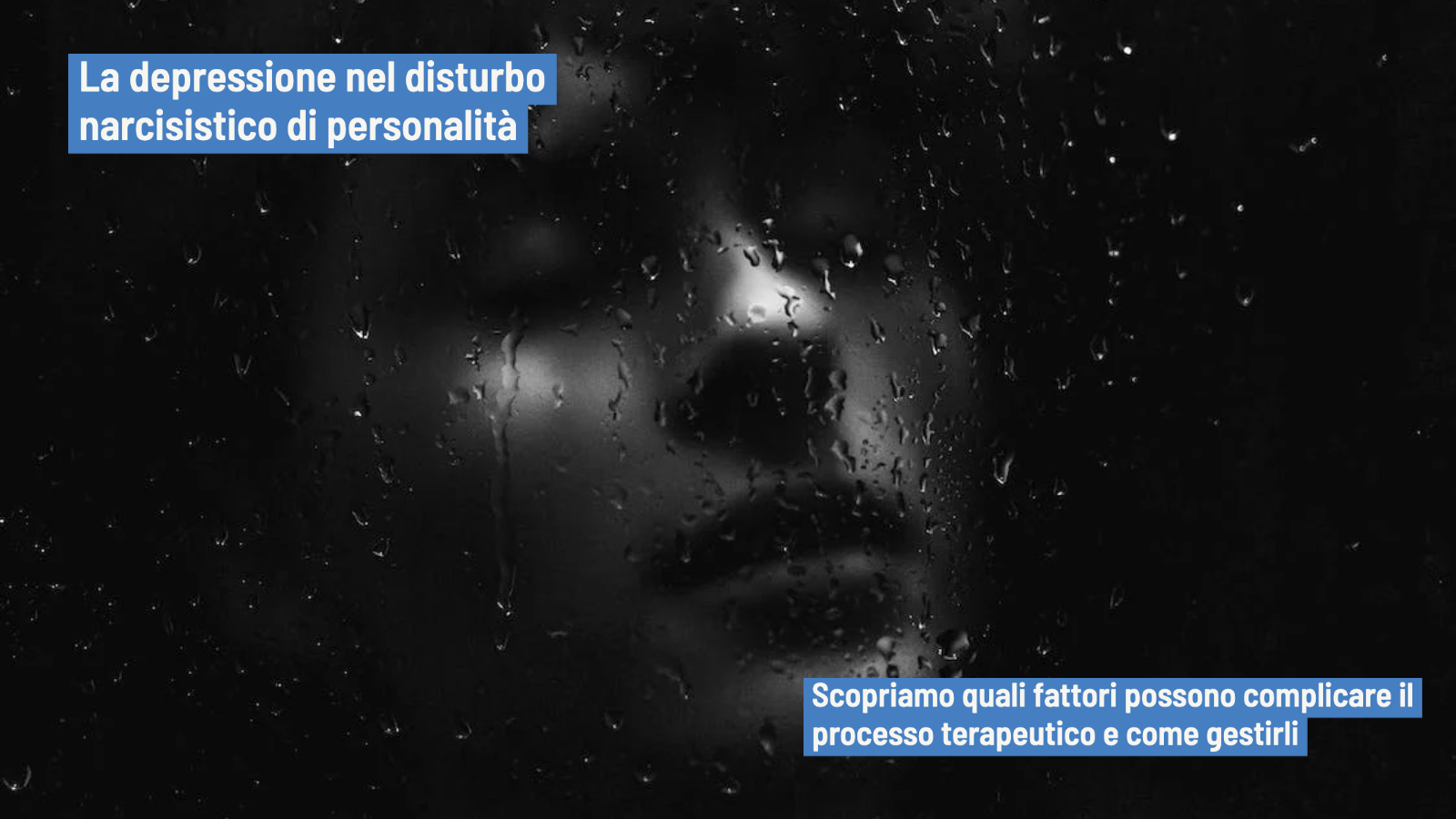La revisione di Fjermestad-Noll e colleghi (2019) analizza le comuni difficoltà e le differenze metodologiche nelle psicoterapie per i pazienti con depressione e disturbo narcisistico di personalità. Per la sua buona riuscita, il trattamento dovrebbe mirare alla cura della sottostante patologia narcisistica, così da ottenere spontaneamente la remissione dei sintomi depressivi.
Nei casi di co-occorrenza di sintomi depressivi e disturbo narcisistico di personalità, la sintomatologia depressiva ha una forma che riflette direttamente il funzionamento personologico sottostante: fluttuazioni nell’autostima e disregolazione emotiva sono i segni dell’autocritica che questi pazienti si rivolgono a causa di standard perfezionistici non soddisfatti, insieme a sentimenti di vergogna e fallimento. La convinzione di avere un potenziale non reclamato, di fatto, può esporre a vulnerabilità depressiva, specie nei soggetti dalla presentazione narcisistica più vulnerabile (covert) (Tritt et al., 2010). Visto che il trattamento di questi pazienti può essere complesso per i terapeuti, la revisione di Fjermestad-Noll e colleghi (2019) si è posta l’obiettivo di fornire una panoramica dei fattori che possono complicare la psicoterapia e dei punti in comune e non fra i diversi modelli terapeutici, così da migliorare la risposta al trattamento e prevenire la ricorrenza depressiva.
I fattori di complicazione al processo terapeutico
Le variabili che tendono a complicare comunemente il percorso dei terapeuti con i pazienti narcisisti affetti da depressione sono principalmente tre:
1. Identificare la patologia narcisistica
Identificare la patologia narcisistica, anche se mascherata dalla sintomatologia depressiva (Miller et al., 2012; Gabbard 1989, 2009; Erkoreka e Navarro, 2017), è fondamentale per consentire il processo terapeutico.
I clinici potrebbero essere portati a misinterpretare i sintomi della manifestazione più sensibile (covert) come indicatori di una depressione maggiore (errore che non sussiste con la tipologia grandiosa/overt, perché ben rappresentata dai criteri diagnostici), senza considerare il fatto che sentimenti di inadeguatezza, vuoto e inferiorità sono dominanti nel narcisista in condizione di vulnerabilità.
Si riscontra una certa convergenza tra i modelli psicoterapeutici rispetto all’importanza di riconoscere la patologia narcisistica: la tradizione psicoanalitica e psicodinamica trovano nella diffusione identitaria il cuore della patologia narcisistica, mentre la Terapia Metacognitiva Interpersonale, considerando il funzionamento narcisistico fluttuante fra i poli della grandiosità e della vulnerabilità, ammette il possibile presentarsi della depressione (Dimaggio et al., 2008).
2. La resistenza al trattamento
La specifica resistenza narcisistica al trattamento (Almond, 2004; Gabbard, 2009) può complicare il processo terapeutico stesso.
I pazienti narcisisti resistono alla terapia distanziandosi dagli affetti negativi, avendo l’illusione di controllare il senso di vulnerabilità. Anche se all’inizio del percorso d’aiuto possono sembrare collaborativi, presto si perderanno nei propri pensieri e ignoreranno la presenza del terapeuta, fino a che questo sperimenterà i primi sentimenti di irritazione e noia. In questo modo, tali individui sopprimono la potenziale dipendenza nei confronti del terapeuta, complicando la creazione di un’alleanza.
3. Altri fattori psicologici
Fattori psicologici come la vergogna, il perfezionismo e l’aggressività durante il trattamento possono complicarne il processo.
La vergogna rappresenta la fase in cui il paziente diventa consapevole dell’incompatibilità fra l’immagine di sé reale e l’immagine di sé ideale, e dunque sperimenta delusione. Essa, emergendo dalla coscienza delle proprie fantasie megalomani, avrebbe la funzione di proteggere il soggetto dalla frustrazione di non essere riuscito a raggiungerle (Broucek, 1982).
I narcisisti sono sensibili alla critica esterna perché vissuta come una minaccia ai loro standard perfezionistici. Portando la riluttanza a riconoscere i primi limiti, tale perfezionismo crea difficoltà nel costruire un’alleanza positiva col terapeuta.
L’aggressività si presenta in risposta a rifiuto o critica, generando rabbia narcisistica nel paziente (Dimaggio e Attina, 2012). Può prendere la forma di comportamenti sadici o masochistici che migliorino temporaneamente la coesione del sé, scongiurando l’offesa contro la parte grandiosa (ad esempio, esprimendo ostilità o pretese di perfetta corrispondenza nei confronti del terapeuta) (Ornstein, 1998).
Comunanze e differenze nelle psicoterapie
I punti in comune e le differenze che caratterizzano i metodi terapeutici applicati alla depressione nei pazienti narcisisti si possono sintetizzare come segue.
1. Costruire un’alleanza con il paziente
Dato che i pazienti narcisisti possono interrompere prematuramente il trattamento, è importante costruire un’alleanza terapeutica su due fronti: da un lato riconoscere la patologia di personalità come il target terapeutico, dall’altro prestare attenzione al rischio di reagire in modo eccessivo al funzionamento grandioso del paziente. È bene che il terapeuta si ricordi che dietro la presentazione grandiosa del soggetto c’è una fragilità di fondo; il paziente, infatti, potrebbe non essere in grado di esplorare i sentimenti di vergogna, aggressività e perfezionismo frustrato fino a che non si sente accettato dal proprio terapeuta (Ronningstam, 2012; Dimaggio e Attina, 2012; Kernberg et al., 2008). Queste considerazioni risultano trasversali alla tradizione psicoanalitica, psicodinamica e metacognitiva (Dimaggio et al., 2006).
2. Lavorare con transfert e controtransfert
Nei pazienti narcisisti e depressi dominano transfert idealizzati e negativi in continua alternanza fra loro (Kernberg et al., 2008). D’altro canto, la più comune reazione controtransferale include la sensazione di sentirsi svalutati, incompetenti, timorosi di offendere (con i pazienti covert), ammirati o annoiati (Gabbard, 2009).
In psicoanalisi, il transfert e il controtransfert sono la base per le successive interpretazioni (Weiner e White, 1982), nella terapia psicodinamica precedono interventi di chiarificazione e confrontazione tesi a riconoscere le parti scisse del paziente (Kernberg et al., 2008), nella Terapia Metacognitiva Interpersonale essi sono sfruttati per far riconoscere al paziente la propria limitatezza (DiMaggio et al. 2006) e nella Schema Therapy sono oggetto di lavoro per guarire gli Schemi Maladattivi Precoci che popolano la relazione terapeutica (Seavey e Moore, 2012).
Discussione e conclusioni
La principale difficoltà del lavoro di revisione di Fjermestad-Noll e colleghi (2019) è stata riconoscere i molteplici spunti che le tradizioni psicoanalitica e psicodinamica hanno maturato sulla tematica depressiva nei pazienti narcisisti e, parallelamente, la scarsa letteratura da parte dei modelli cognitivo-comportamentali.
Rispetto a quanto considerato, è possibile credere che i sintomi depressivi dei pazienti narcisisti abbiano un’origine personologica che è bene comprendere da subito al fine di costruire un’alleanza terapeutica che limiti il rischio di drop-out: sfidare l’immagine disfunzionale che il paziente ha di sé e degli altri sarebbe un intervento troppo confrontativo, mentre andrebbero preferita la validazione e il supporto. Anche se i diversi approcci differiscono rispetto ai metodi, convergono nel ritenere che la patologia narcisistica ponga le sue radici nell’infanzia e debba essere curata con empatia nella sua ciclica resistenza al trattamento.