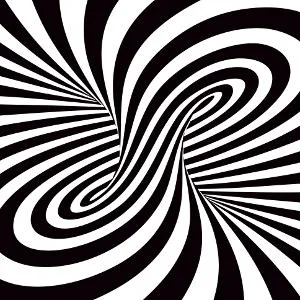
E’ stato grazie a questa esperienza che ho imparato a conoscere i cicli interpersonali, solo intuiti durante la formazione e sui libri, non perché fossero spiegati male ma semplicemente perché per capire come la relazione possa peggiorare un disturbo psicopatologico è necessario esserci dentro, sbatterci la testa, ed impararlo dalle reazioni che proprio quel determinato paziente, non altri, ti attiva.

Si ok ma cosa si intende per cicli interpersonali? Per Safran e Segal sono “il modo in cui la relazione con l’altro attiva circuiti che rinforzano la patologia a causa dei segnali- in prevalenza non verbali, automatici ed emozionali- che i pazienti scambiano con i loro partner in interazione” (Safran e Segal; 1990). Di fatto sono strategie che il soggetto mette in atto per evitare di vivere stati per lui estremamente dolorosi ma che hanno il solo risultato di attivare nell’altro proprio i comportamenti temuti, che quindi confermeranno le credenze centrali. Questo vale per ogni relazione significativa e quindi assume particolare importanza in quella terapeutica dove il paziente altro non farà che costruire la relazione in base alle uniche modalità che conosce.
Tornando alla mia personale esperienza clinica, la paziente aveva uno schema di sé come persona non amabile e uno schema di sé con l’altro come criticata se avesse mostrato i proprio bisogni; a causa di questo schema interpersonale in cui sono presenti emozioni dolorose la paziente metteva in atto una strategia – “non mi espongo, vengo incontro all’altro” – che le garantiva di non attivare quei temi estremamente delicati. Nella nostra relazione successe però proprio questo: il suo accondiscendere con me, il mio sottolineare più le mie esigenze che le sue, di fatto confermava una credenza per lei centrale “i miei bisogni non hanno valore”.
Con disturbi nell’asse II, quando cioè vi sono presenti deficit metacognitivi, i cicli diventano elemento clinico di grande rilievo proprio per la difficoltà del paziente a riflettere sui propri, ed altrui, stati mentali. Può quindi accadere ad esempio che il paziente non si renda conto che la propria visione del mondo sia frutto dei propri schemi, dei propri personalissimi occhiali, ma la tratti come un dato di realtà.
Cosa possiamo fare quando siamo dentro un ciclo interpersonale?
Intanto dare importanza alle nostre reazioni emotive con quel determinato paziente. Questo vale in generale come regola per muoversi nella relazione con chi presenta aree relazionali problematiche . Una volta identificato cosa proviamo con il paziente potremmo chiederci se questo sia simile a ciò che prova il paziente o le persone che sono in relazione con lui. “L’obiettivo è di riuscire a collocarsi mentalmente in modo contrario alla tendenza spontanea che emerge dall’interazione con il paziente” (Dimaggio, Semerarai, 2007). Con la mia paziente questo ha voluto dire restituirgli la sua modalità di costruire le relazioni e mostrarle come lei, giustificata dal timore di poter vivere emozioni estremamente dolorose, portasse di fatto l’altro a comportarsi proprio come temeva. Dopo quel momento estremamente importante il nostro percorso fu focalizzato nella direzione di costruire una relazione terapeutica che potesse darle la possibilità di esprimere i propri bisogni, cercando quindi di disconfermare quella credenza centrale che di fatto giustificava l’entrata in cicli disfunzionali.
BIBLIOGRAFIA:
- Safran, J. e Segal, V.Z. (1993) Il processo interpersonale nella terapia cognitiva, Feltrinelli
- Dimaggio, G. e Semerari, A. (2007) I disturbi di personalità. Modelli e trattamento, Laterza


