Amy Cuddy: come il Linguaggio Corporeo definisce te stesso (TED Talk)
– FLASH NEWS –
Amy Cuddy: come il tuo Linguaggio Corporeo definisce te stesso (TED Talk)
LEGGI GLI ARTICOLI SU: EMBODIED COGNITION
LEGGI GLI ARTICOLI SU: POSTURA
Di seguito, la trascrizione del testo del video:
Voglio cominciare offrendovi una tattica di vita gratuita senza tecnologica, e tutto quello che richiede è questo: che possiate cambiare la vostra postura per due minuti. Ma prima di offrirvela voglio chiedervi di fare ora un piccolo controllo del vostro corpo e di quello che fate col vostro corpo. Quanti di voi in qualche modo si rendono più piccoli? Magari vi rannicchiate, incrociate le gambe, magari incrociate le caviglie. Qualche volta incrociamo le braccia così. Qualche volta ci apriamo. (Risate) Vi vedo. (Risate) Voglio che prestiate attenzione a quello che state facendo. Ci torneremo tra qualche minuto, e spero che se imparate ad aggiustare un po’ questa postura possiate cambiare in maniera significativa la vostra vita.
Siamo veramente affascinati dal linguaggio del corpo e siamo particolarmente interessati al linguaggio corporeo di altre persone. Sapete, siamo incuriositi da — (Risate) un’interazione impacciata, o un sorriso, o uno sorriso sprezzante, o magari un goffo ammiccamento, o magari una cosa come una stretta di mano.

Narratore: Qui arrivano al numero 10 e guardate questo fortunato poliziotto che stringe la mano al Presidente degli Stati Uniti. Oh, ed ecco che arriva il Primo Ministro del — ? No. (Risate) (Applausi) (Risate) (Applausi)
Amy Cuddy: Quindi una stretta di mano, o l’assenza di una stretta di mano possono farci parlare per settimane e settimane. Anche la BBC e il The New York Times. Quindi ovviamente quando pensiamo al comportamento non verbale, o linguaggio del corpo — ma noi scienziati sociali lo chiamiamo non verbale — è un linguaggio, quindi pensiamo alla comunicazione. Quando pensiamo alla comunicazione, pensiamo alle interazioni. Quindi cosa comunica il vostro linguaggio del corpo? Cosa vi comunica il mio?
E ci sono molte ragioni di credere che questo sia un corretto modo di vedere. Gli scienziati sociali hanno passato molto tempo ad osservare gli effetti del nostro linguaggio corporeo, o il linguaggio corporeo di altre persone, sui giudizi. Formuliamo giudizi affrettati e deduzioni dal linguaggio corporeo. E quei giudizi possono prevedere risultati veramente significativi come chi assumiamo o chi sosteniamo, a chi chiediamo di uscire. Per esempio, Nalini Ambady, un ricercatore alla Tufts University, mostra che quando le persone guardano un video senza audio di 30 secondi di reali interazioni tra paziente e medico, il loro giudizio sulla gentilezza del medico predice se il medico verrà citato in giudizio oppure no. Non ha molto a che vedere col fatto che il medico sia o meno incompetente, ma se quella persona ci piace e come interagisce. Ancora più radicale, Alex Todorov a Princeton ci ha mostrato che i giudizi sui visi dei candidati politici in solo un secondo predice il 70% del Senato americano e i risultati delle elezioni a governatore, perfino — andiamo sul digitale — gli emoticon utilizzati bene nelle negoziazioni online possono portare a raggiungere maggiori risultati da quella negoziazione. Se usati male, sono una cattiva idea. Giusto? Quindi, riguardo al linguaggio non verbale, pensiamo a come giudichiamo gli altri, come loro giudicano noi e quali sono i risultati. Eppure, abbiamo tendenza a dimenticare l’altro pubblico che viene influenzato dal linguaggio non verbale, ossia noi stessi.
Siamo anche noi influenzati dal linguaggio non verbale, i nostri pensieri e i nostri sentimenti e la nostra fisiologia. Di quale linguaggio non verbale sto parlando? Sono una psicologa sociale. Studio i pregiudizi e insegno in una business school competitiva, era quindi inevitabile che mi interessassi alle dinamiche di potere. Mi sono particolarmente interessata alle espressioni non verbali di forza e dominio.
E quali sono le espressioni non verbali di forza e dominio? Beh, ecco quali sono. Nel regno animale, sono quelle relative all’espansione. Ci si rende più grandi, ci si allunga, si prende spazio, in sostanza ci si apre. Parliamo di apertura. E questo vale nel regno animale. Non è limitato ai primati. E gli esseri umani fanno la stessa cosa. (Risate) Lo fanno sia quando hanno una forza consolidato, sia quando si sentono forti in un quel momento. E questo è particolarmente interessante perché ci mostra veramente quanto antiche e universali siano queste espressioni di forza. Questa espressione, nota come orgoglio, è stata studiata da Jessica Tracy. Mostra come le persone nate con la vista e quelle non vedenti dalla nascita lo fanno quando vincono una competizione fisica. Quando attraversano la linea di arrivo e hanno vinto, non importa se non hanno mai visto nessuno farlo. Fanno così. Braccia in alto a forma di V, il mento leggermente rialzato. Cosa facciamo quando ci sentiamo impotenti? Facciamo esattamente l’opposto. Ci chiudiamo. Ci richiudiamo. Ci facciamo piccoli. Non vogliamo entrare in contatto con le persone attorno a noi. Quindi ancora una volta, sia gli animali che gli umani fanno la stessa cosa. E questo è quello che accade quando mettete insieme la forza e l’impotenza. Quello che abbiamo tendenza a fare quando parliamo di forza è essere complementari al linguaggio non verbale degli altri. Se qualcuno è veramente forte nei nostri confronti, tendiamo a farci piccoli. Non lo rispecchiamo. Facciamo l’opposto di quello che fa.
Osservo questo comportamento in classe, e cosa noto? Noto che gli studenti MBA mostrano veramente un’ampia serie di atteggiamenti di forza non verbali. Ci sono persone che sono delle caricature di individui alfa, che entrano in una stanza, si dirigono al centro prima che la lezioni cominci, come se volessero veramente occupare lo spazio. Quando si siedono, si allargano. Alzano la mano in questo modo. Ci sono altre persone che si ripiegano virtualmente quando entrano. Non appena entrano, lo vedete. Lo vedete nei loro visi e nei loro corpi, si siedono sulla sedia e si fanno piccoli e fanno così quando alzano la mano. Noto un paio di cose sull’argomento. Uno, non vi sorprenderò. Sembra sia collegato al sesso. Le donne hanno tendenza a fare così molto più degli uomini. Le donne si sentono cronicamente meno forti degli uomini, quindi non sorprende. Ma l’altra cosa che ho notato è che sembra che sia anche collegato al livello di coinvolgimento degli studenti e al livello di partecipazione. Ed è veramente importante in una classe di MBA, perché la partecipazione conta per metà del voto finale.
Le business school si confrontano con questa differenza di valutazione a seconda del sesso. Ci sono queste donne e questi uomini ugualmente qualificati e si ottengono poi queste differenze di valutazioni, e sembra che sia in parte attribuibile alla partecipazione. Ho cominciato a chiedermi — ok, ci sono qui queste persone che partecipano. È possibile spingere queste persone a fingere e portarle a partecipare di più?
Con la mia principale collaboratrice Dana Carney, a Berkeley, volevo veramente sapere se si poteva fingere pur di riuscire. Per esempio farlo per un po’ di tempo sperimentare un risultato comportamentale che vi faccia sembrare più forti? Sappiamo che il linguaggio non verbale determina cosa gli altri pensano e provano nei nostri confronti. Ci sono molte prove. Ma la nostra domanda era: il linguaggio non verbale guida il nostro modo di pensare e sentire noi stessi?
Ci sono prove che sia così. Quindi, per esempio, sorridiamo quando siamo felici, ma anche, quando siamo costretti a sorridere tenendo una penna tra i denti in questo modo, ci fa sentire più felici. Funziona in entrambi i sensi. Quando si tratta di forza, anche lì funziona in entrambi i sensi. Quando vi sentite forti, è più probabile che facciate così, ma è anche possibile che quando fingete di essere forti, è più probabile che vi sentiate effettivamente forti.
La seconda domanda era — sappiamo che le nostre menti cambiano i nostri corpi, ma è anche vero che i nostri corpi cambiano le nostre menti? E quando dico menti, nel caso dei forti, di cosa sto parlando? Sto parlando di pensieri e sentimenti e quelle cose fisiologiche che creano i nostri pensieri e i nostri sentimenti, e nel mio caso, sono gli ormoni. Guardo gli ormoni. Quindi, come sono le menti dei forti rispetto ai deboli? Non sorprende che le menti dei forti tendano ad essere più assertive, più sicure e più ottimiste. Sentono veramente di poter vincere anche in giochi di fortuna. Tendono anche ad essere capaci di pensare in modo più astratto. Ci sono tante differenze. Corrono più rischi. Ci sono tante differenze tra i forti e i deboli. Fisiologicamente ci sono differenze anche su due ormoni chiave: il testosterone, che è l’ormone dominante, e il cortisolo, che è l’ormone dello stress. Quello che scopriamo è che i maschi alfa più forti nelle gerarchie di primati hanno testosterone alto e cortisolo basso, e i leader forti ed efficaci hanno anche loro testosterone alto e cortisolo basso. Questo cosa significa? Pensando alla forza, la gente tende a pensare solo al testosterone, perché è collegato al dominio. Ma in realtà, la forza ha anche a che vedere con la reazione allo stress. Volete un leader con molta forza, dominante, con testosterone alto, ma molto reattivo allo stress? Probabilmente no, giusto? Volete una persona che sia forte, assertiva e dominante, ma non molto reattiva allo stress, una persona distesa.
Sappiamo che nelle gerarchie di primati, se un maschio alfa deve subentrare, se un individuo deve assumere improvvisamente il ruolo di maschio alfa, nel giro di pochi giorni, il testosterone di quell’individuo sale in maniera significativa e il suo cortisolo scende in maniera significativa. Abbiamo questa prova, che il corpo può dare forma alla mente, almeno a livello di viso, e anche che il cambio di ruolo influenza la mente. Cosa succede se assumete un ruolo? Cosa succede se lo fate in maniera discreta, come questa piccola manipolazione, questo piccolo intervento? “Per due minuti”, dite, “Voglio stare così” e vi farà sentire più forti.
Questo è quello che abbiamo fatto. Abbiamo deciso di portare le persone in laboratorio e condurre un piccolo esperimento e queste persone adottano per due minuti una postura di forza elevata o una postura di forza limitata e vi mostrerò cinque posture, anche se ne hanno assunte solo due. Eccone una. Un altro paio. Questa è stata soprannominato “Wonder Woman” dai media. Eccone un altro paio. Potete stare in piedi o seduti. E questi sono le posture di forza limitata. Vi ripiegate, vi fate piccoli. Questo è una postura di forza molto bassa. Quando vi toccate il collo, vi proteggete veramente. Questo è quello che accade. Arrivano, sputano in una provetta, per due minuti diciamo, “Devi fare questo o questo.” Non guardano le immagini delle posture. Non vogliamo che sappiano del concetto di forza. Vogliamo che abbiano la sensazione di forza, giusto? Per due minuti fanno questo. Poi chiediamo loro, “Quanto forte ti senti?” su una serie di elementi, poi diamo loro l’opportunità di scommettere, e poi teniamo un altro campione di saliva. Tutto qui. Questo è tutto l’esperimento.
Questo è quello che scopriamo. Nella tolleranza del rischio, ossia la scommessa, quello che scopriamo è che nella postura di forza elevata, l’86% di voi scommette. In postura di forza limitata solo il 60% ed è una differenza abbastanza significativa. Questi sono i risultati in termini di testosterone. Dalla situazione di partenza quando arrivano, nelle persone con molta forza aumenta di circa il 20% e nelle persone con poca forza si riduce di circa il 10%. Di nuovo, in due minuti si ottengono questi cambiamenti. Ecco i dati del cortisolo. Nelle persone con forza elevata subisce una riduzione del 25% circa e nelle persone con forza limitata aumenta di circa il 15%. Due minuti portano a questo cambio ormonale che configura il vostro cervello ad essere assertivo, fiducioso e a proprio agio, o molto reattivo allo stress e con la sensazione di essere spento. Abbiamo avuto tutti quella sensazione, giusto? Sembra che il linguaggio non verbale determini davvero il modo di pensare e sentire noi stessi, non sono solo gli altri, siamo anche noi. Il nostro corpo cambia la nostra mente.
La domanda successiva è se può una determinata postura di pochi minuti cambiare veramente la vostra vita. Questo avviene in laboratorio. È un piccolo esperimento di un paio di minuti. Dove si può veramente applicare tutto questo? E ce ne siamo preoccupati, ovviamente. Pensiamo veramente che quello che conta è dove vogliamo utilizzare queste situazioni di valutazione come situazioni di minaccia sociale. Dove venite valutati dai vostri amici? Gli adolescenti vengono valutati a tavola. Per qualcuno parlando ad un consiglio di classe. Potrebbe essere durante una presentazione o durante una conferenza come questa o durante un colloquio di lavoro. Abbiamo deciso che quello in cui la maggior parte della gente si poteva riconoscere perché l’ha vissuto fosse il colloquio di lavoro.
Abbiamo pubblicato queste scoperte e i media ci si sono buttati e dicono, ok, questo è quello che fate ad un colloquio di lavoro, giusto? (Risate) Siamo inorriditi e abbiamo detto, mio Dio, no, no, no non è quello che intendevamo. Per diverse ragioni, no, no, no, non lo fate. Non si tratta di voi che parlate ad altre persone. Si tratta di voi che parlate a voi stessi. Cosa fate prima di andare ad un colloquio di lavoro? Fate questo. Giusto? Siete seduti. Guardate il vostro iPhone — o il vostro Android, non voglio fare un torto a nessuno. Guardate i vostri appunti, vi rannicchiate, vi fate piccoli, quando in realtà quello che dovreste fare forse è questo, in bagno per esempio, giusto? Fate questo. Trovate due minuti. Questo è quello che vogliamo testare. Ok? Portiamo le persone in laboratorio e assumono posture di forza elevata o limitata, affrontano un colloquio di lavoro molto stressante. Dura 5 minuti. Vengono registrati. Vengono anche giudicati e i giudici sono formati per non dare riscontri non verbali, e sembrano così. Immaginate che questa sia la persona che vi intervista. Per cinque minuti, niente, ed è peggio che essere interrotti. La gente lo odia. È quello che Marianne LaFrance chiama “stare nelle sabbie mobili sociali.” Questo fa veramente schizzare il vostro cortisolo. Questo è il colloquio di lavoro che abbiamo fatto loro provare, perché volevamo veramente vedere cosa succedeva. Abbiamo poi questi programmatori che guardano i video, ce ne sono quattro. Sono all’oscuro delle ipotesi. Sono all’oscuro delle condizioni. Non hanno idea di chi assume quale postura, e finiscono per guardare questa serie di filmati, e dicono, “Oh, vogliamo assumere queste persone” — tutte le persone con posture di forza — “non vogliamo assumere queste persone. Valutiamo anche queste persone più positivamente in maniera complessiva.” Ma cosa li guida? Non si tratta del contenuto del discorso. Si tratta della presenza che portano al discorso. Anche noi, perché li valutiamo su tutte queste variabili collegandole alle competenze, come per esempio: Quanto è strutturato il discorso? È buono? Quali sono le sue competenze? Nessun effetto su queste cose. Questo è ciò che viene influenzato. Questo tipo di cose. In sostanza le persone portano se stesse. Portano se stesse. Portano le loro idee, ma come se stesse, senza residui. Questo è quello che guida l’effetto o che media l’effetto.
Quando racconto queste cose alla gente, che i nostri corpi cambiano la nostra mente e la nostra mente può cambiare il nostro comportamento e il nostro comportamento può cambiare i nostri risultati, mi dicono, “Mi sento falso”. Giusto? Così ho detto, sii falso finché ce la fai. No — non sono io. Non voglio arrivare lì e sentire di essere falso. Non voglio sentirmi un impostore. Non voglio arrivare lì e avere la sensazione di non doverci essere. E tutto questo mi suonava familiare, perché voglio raccontarvi una breve storia sull’essere un impostore e sentire di non dover essere qui.
A 19 anni sono stata coinvolta in un brutto incidente d’auto. Sono stata catapultata fuori dall’auto, sono rotolata diverse volte. Sono stata catapultata dall’auto. E mi sono risvegliata con un trauma cranico in riabilitazione, sono stata espulsa dall’università, e ho saputo che il mio Q.I. era precipitato di due deviazioni standard, il che è stato molto traumatico. Conoscevo il mio Q.I. perché ero stata valutata come intelligente, ed ero stata etichettata come bambina prodigio. Quindi lascio l’università, continuo a cercare di tornarci. Dicono, “Non finirai l’università. Puoi fare altre cose, ma per te non funzionerà.” Combattevo veramente con questa cosa e devo dire che farsi portare via un’identità, la vostra identità principale, che nel mio caso era l’essere intelligente, farsela portare via, non c’è niente che vi lasci più impotenti. Mi sentivo completamente impotente. Mi sforzavo di continuo, e sono stata fortunata, e mi sforzavo, e sono stata fortunata e mi sforzavo.
Finalmente mi sono laureata. Mi ci sono voluti 4 anni in più dei miei compagni, e ho convinto qualcuno, la mia consulente e angelo, Susan Fiske, di prendermi, e così sono finita a Princeton, ed avevo la sensazione di non dover essere lì. Sono un impostore. E la sera prima del discorso del primo anno — il discorso del primo anno a Princeton è un discorso di 20 minuti a 20 persone, tutto qui — ero così spaventata di farmi scoprire il giorno dopo che l’ho chiamata e le ho detto, “Rinuncio.” E lei, “Tu non rinunci, perché ho scommesso su di te, e tu rimani. Tu rimani e farai in questo modo. Farai finta. Farai qualunque discorso ti si chiederà di fare. Semplicemente lo farai ancora e ancora, anche se sei terrorizzata e paralizzata e avrai un’esperienza extra-corporea, finché non arriverai a quel momento in cui dirai, “Oh mio Dio, ce la sto facendo. Tipo, sono diventata questo. Ce la sto veramente facendo.” Ed è quello che ho fatto. Cinque anni di scuola di specializzazione, un po’ di anni, prima alla Northwestern, poi mi sono trasferita ad Harvard, sono passata ad Harvard, non ci penso più molto, ma per molto tempo ci ho pensato, “Non dovrei essere qui. Non dovrei essere qui.”
Alla fine del mio primo anno ad Harvard, una studentessa che non aveva mai parlato in classe per un semestre intero, a cui avevo detto, “Guarda, devi partecipare altrimenti fallirai”, è venuto nel mio ufficio. Non la conoscevo per niente. E mi ha detto — è arrivata completamente sconfitta e mi ha detto: “Non dovrei essere qui.” E quello è stato il mio momento. Perché sono successe due cose. Primo, mi sono resa conto, oh mio Dio, non mi sento più così. Capite? Non lo risento più, invece lei sì, e capisco quella sensazione. E secondo, lei deve essere qui! Può fare finta, può diventarlo. Quindi ho detto, “Sì che devi! Devi essere qui! E domani farai finta, ti farai forte e, sapete, farai –” (Applausi) (Applausi) “E entrerai in classe e farai il miglior commento in assoluto.” Capite? E ha fatto il miglior commento in assoluto, e la gente si è girata con quell’espressione, oh mio Dio, non avevo neanche notato che fosse seduta lì. (Risate)
È tornata da me mesi dopo e mi sono resa conto che non solo aveva finto fino a farcela, aveva finto fino a diventarlo. Era cambiata. Quindi voglio dirvi, non fingete fino a farcela. Fingete fino a diventarlo. Sapete? Non è — Fatelo abbastanza finché lo diventate e lo interiorizzate.
L’ultima cosa con cui vi voglio lasciare è questa. Minuscole modifiche possono portare a grandi cambiamenti. Quindi in due minuti. Due minuti, due minuti, due minuti. Prima che affrontiate la prossima situazione stressante di valutazione, per due minuti, provate a fare questo, nell’ascensore, in bagno, alla scrivania a porte chiuse. Questo è quello che volete fare. Configurate il vostro cervello per essere all’altezza della situazione. Fate aumentare il testosterone. Fate scendere il cortisolo. Non uscite da quella situazione con la sensazione di non aver mostrato chi siete. Uscite da quella situazione con la sensazione di aver detto chi siete e di aver mostrato chi siete.
Voglio prima chiedervi, di assumere la postura di forza, ma voglio anche chiedervi di condividere la scienza, perché è semplice. Non è una question di ego. (Risate) Mettetelo da parte. Condividetelo con la gente, perché le persone che possono usarlo di più sono quelle senza risorse e senza tecnologia, senza status e senza potere. Datelo a loro perché lo possano fare in privato. Hanno bisogno del loro corpo, della loro privacy per due minuti, e può cambiare in maniera significativa i risultati della loro vita. Grazie. (Applausi) (Applausi)
LEGGI GLI ARTICOLI SU: EMBODIED COGNITION – POSTURA
REFERENCES:
- Cuddy A. (2012). Your body language shapes who you are. TED Talks. Ted Global October 2012. Distributed under Creative Commons License



 PRENDERE APPUNTI
PRENDERE APPUNTI


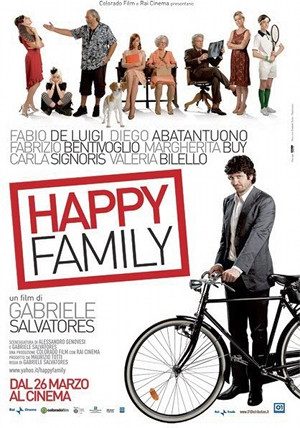


 In Treatment S01E13. Dopo le tempeste di Laura e Alex l’incontro con Sophie è un sollievo, un tempo lento dopo i drammatici scontri del lunedì e del martedì
In Treatment S01E13. Dopo le tempeste di Laura e Alex l’incontro con Sophie è un sollievo, un tempo lento dopo i drammatici scontri del lunedì e del martedì
 Monografia ACT #6 – Un processo fondamentale dell’ Acceptance and Commitment Therapy è ciò che viene chiamata la Mancanza di contatto con i propri valori.
Monografia ACT #6 – Un processo fondamentale dell’ Acceptance and Commitment Therapy è ciò che viene chiamata la Mancanza di contatto con i propri valori.


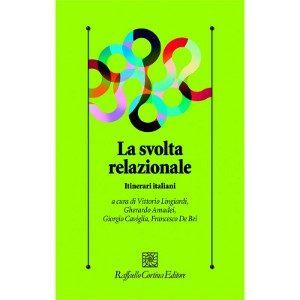
 Psiche & Legge #7: Alienazione Mentale: Nelle precedenti rubriche mi sono soffermata sul reo. Con l’appuntamento odierno l’attenzione è rivolta alla vittima.
Psiche & Legge #7: Alienazione Mentale: Nelle precedenti rubriche mi sono soffermata sul reo. Con l’appuntamento odierno l’attenzione è rivolta alla vittima.
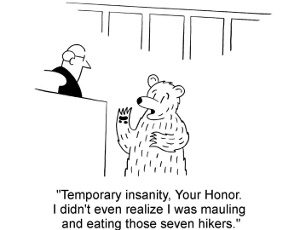
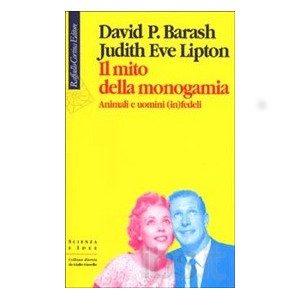
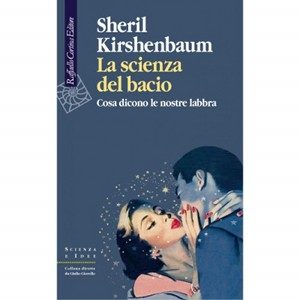
 La dismorfia muscolare: “preoccupazione cronica di non essere sufficientemente muscolati“.
La dismorfia muscolare: “preoccupazione cronica di non essere sufficientemente muscolati“.




 Stress Post Traumatico & OCD – possono combinarsi quando un paziente che ha subito un grave trauma tenta di alleviare la sofferenza con rituali ossessivi. Il caso di Albert.
Stress Post Traumatico & OCD – possono combinarsi quando un paziente che ha subito un grave trauma tenta di alleviare la sofferenza con rituali ossessivi. Il caso di Albert.

 Aprassia Ideativa – Quando la macchinetta del caffè diventa problema: Breve Panoramica e chiave di lettura diversa dell’Aprassia Ideativa.
Aprassia Ideativa – Quando la macchinetta del caffè diventa problema: Breve Panoramica e chiave di lettura diversa dell’Aprassia Ideativa.

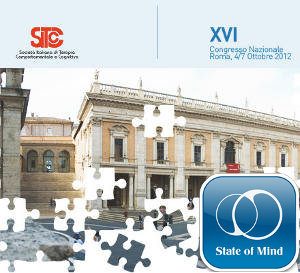
 AVVIARE IL COLLOQUIO – Nei primi momenti si possono ricevere informazioni e avere le prime impressioni
AVVIARE IL COLLOQUIO – Nei primi momenti si possono ricevere informazioni e avere le prime impressioni